|
|
Val Marchirolo |
 |
|
Naturale proseguimento della Valganna, la Val Marchirolo è contornata dai monti Castelvecchio (617), La Nave (990), Mezzano (932), Sette Termini (972), a sinistra, e il monte Marzio (875) a destra. Il nome attribuito alla valle deriva probabilmente da Marka, segno, confine. Da un documento del 1491 si rileva l'esistenza nel fondovalle di un vasto prato detto marchirolo, in prossimità di vari campi ad curtem, che lasciano supporre una curtis locale e confinante con quella di Lavena. Nel 1870 venne rinvenuta, all'incrocio della strada proveniente da
Marchirolo con quella di Ardena, una tomba di incinerato databile alla
fine della prima età del ferro. Il passaggio di altre popolazioni è
comunque testimoniato dalla toponomastica locale: Lavena (acqua
lacustre), Dovrana (torrente) e Tresa (fiume precipita). A Marchirolo sono venute alla luce due tombe con monete di Graziano e Valentiniano II (367-392 d.C.), una sulla strada per Cugliate all'incrocio con la via Gaggio e l'altra in località Roncaglia. L'ingresso principale della valle fin quasi alla fine del medioevo, era situato nella località Raglio di Cunardo, alla confluenza delle strade provenienti dalla Valganna, dalla Valcuvia e dalla Valtravaglia. Si proseguiva poi per Taverne, risalendo quindi per Cugliate per evitare le zone paludose della Baraggia, raggiungendo Marchirolo, l'incrocio di Arbizzo, Cadegliano, Pontecchio ed infine il ponte sul fiume Tresa, in direzione dei passi alpini. Ad eccezione di Marchirolo e Lavena che rientravano nei possedimenti del Monastero di Ciel d'Oro di Pavia, tutta la valle venne assorbita dal Contado del Seprio, che giungeva per altro sino a Bellinzona. Nel 1196 con la fine delle ostilità tra comaschi e milanesi, la valle passò sotto la giurisdizione della pieve di Valtravaglia. Nel 1438, il duca di Milano Filippo Maria Visconti concesse in feudo
tutta la pieve di Valtravaglia, e quindi anche la Val Marchirolo, a
Rusca Franchino, conte di Lugano e Signore di Locarno. Con l'estinzione
del ramo legittimo dei Rusca, nel 1583 il feudo passa ai Conti Marliani
fino al 1784, e poi ai Conti Crivelli fino al 1797, quando furono
soppressi i diritti feudali da parte della Repubblica Cisalpina. |
|
 |
I centri della Val Marchirolo sono Cunardo, Cugliate Fabiasco, Marchirolo, Marzio, Cadegliano Viconago, Lavena Ponte Tresa. |
Valganna |
 Cottini-Viola "Varese terra di colori" Ediz. Lativa |
|
Il fondovalle, costituito dalla vasta piana delle Comunelle è solcato dal torrente Margorabbia, immissario ed emissario dei due laghetti di Ganna e Ghirla prima di sfociare nel lago Maggiore all'altezza di Luino. La fitta vegetazione boschiva di ontani, salici, frassini, betulle, conferisce a tutta la valle e al lago di Ganna in particolare una intensa colorazione verde. Dopo Ghirla la valle si apre e si fonde nella conca di colline che dà vita alla Val Marchirolo.
|
|
|
|
Dal 1984, a tutela della ricchezza di flora e fauna, la zona attorno al lago di Ganna è stata dichiarata Riserva naturale orientata. Di particolare interesse è l'antro delle Gallerie (o grotte della Valganna), nel monte Cuseglio. L'origine e la destinazione di questa intricata serie di cunicoli (rifugi preistorici, difese liguri in funzione antiromana o cava di materiale edile utilizzate dai frati per l'abbazia di S. Gemolo) è tuttora controversa. All'uscita della valle, salendo verso Induno Olona, sorge la fabbrica di birra Splùgen-Poretti, iniziata nel 1877 (architetti Alfred e Richard Bihl) e completata con l'edificazione della villa padronale progettata da Ulisse Stacchini. Un famoso esempio di architettura industriale liberty. La valle ha come unica municipalità il Comune di Valganna che comprende le località di Boarezzo, Ganna, Ghirla, Mondonico.
|
|
|

|
Originatasi per escavazione fluvio-glaciale, si presenta tuttora come una valle profondamente incisa con i centri abitati posti in posizione elevata sulle colline circostanti. Il fiume che la attraversa, l'Olona, è stato definito Fiume Civiltà, per l'antico e proficuo legame tra le sue acque e gli abitanti del territorio dove scorre, dalla Rasa fino alle porte di Milano, passando per Legnano e schivando appena la città di Busto Arsizio. Il paesaggio appare ancor oggi molto diverso. Alla destra orografica del fiume corrisponde una zona ricca di colture e di boschi, mentre a sinistra prevale la brughiera.
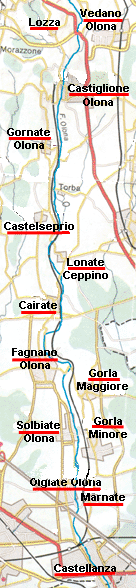
|
L'Olona fu artefice indiscusso dello sviluppo economico delle popolazioni della valle. Fin dal X secolo si moltiplicarono lungo il corso dell'Olona i mulini, protetti dalle varie torri e case fortificate poste sui cigli della valle e dominanti l'antica strada delle obbedienzierie. Nel 1608 si contavano sulle sponde dell'Olona 116 mulini, con una forza complessiva di 463 rodigini; fra questi vi erano anche un maglio da rame, un follone o gualchiera per i panni e diversi torchi da olio. Le acque del fiume facilitarono il sorgere di numerosi altri insediamenti di tipo preindustriale: concerie, sbianche per la lavatura della tela (tela olona), segherie per il legname e marmo (specialmente sul torrente Bevera). Verso la metà del XIX secolo crebbero lungo il corso dell'Olona cartiere, filande di cotone e seta, tintorie, sbianche, fornaci, industrie meccaniche. Le vecchie ruote venivano man mano sostituite dalle moderne turbine, in grado di sfruttare meglio la corrente del fiume. Il territorio percorso dall'Olona è una delle zone più significative della Lombardia, ricco di storia, che ci porta a ritroso dai vecchi stabilimenti dismessi, veri e propri monumenti di archeologia industriale, ai mulini da grano alle vicende del Contado del Seprio. Lo sviluppo industriale della zona ha inferto però un grave danno all'ambiente inquinando il fiume, che da tempo è ormai uno dei corsi d'acqua più inquinati. Eppure ancora nei primi decenni di questo secolo vi si faceva il bagno e si pescava. Ora è in atto un'azione di recupero degli edifici dismessi e una tardiva opera di bonifica con la costruzione di depuratori e collettori. Esempio illustre di questo recupero urbanistico è il Cotonificio Cantoni di Castellanza divenuto sede dell'Università Carlo Cattaneo. Lungo la valle dell'Olona sorgono i comuni di Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Cairate, Castelseprio, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Castiglione Olona, Lozza, Vedano Olona.
|
Valceresio |
 |
|
Dapprima chiusa, poi via via sempre più aperta, è da sempre la via di collegamento più veloce per il Canton Ticino. Modellata nel corso dei secoli dai ghiacciai, è circondata dal monte Minisfredo (m 1012), dal Poncione di Ganna ( m 993), dal monte Piambello (m 1129), dal monte S. Elia (m 665), dal monte Orsa (m 993) e dal monte Pravanello (m 1045). I reperti conservati al Museo dei Fossili di Besano e al Museo di Storia Naturale di Induno testimoniano l'evoluzione geologica della Valceresio e la presenza sul territorio dei dinosauri. La prima presenza umana è invece attestata al neolitico (500-2800 a.C.) dai resti di palafitte rinvenuti ad Arcisate in località Cattafame, nei pressi di una zona umida. L'espansione romana che acquisì la valle alla provincia della Gallia Cisalpina, si concentrò soprattutto lungo il corso della Bevera, a Induno, Arcisate, Cantello, Ligornetto. Le tribù insubriche che la popolavano divennero cittadini romani sotto Giulio Cesare, in cambio di alcuni anni di servizio militare nelle legioni. Al termine del periodo di arruolamento, vennero iscritti alla tribù romana degli Oufentini, divenendo liberi cittadini romani e proprietari delle loro terre. |
|
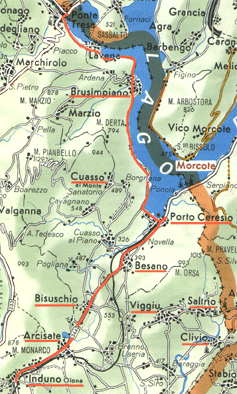
|
I centri più importanti furono sicuramente Arcisate e Induno
Olona, punti di arrivo delle vie di comunicazione che arrivavano dal
Verbano e dal Ceresio. Da qui transitava il rame estratto a Baveno e
Maccagno, l'argento della Martica, lo stagno, il ferro, l'ambra e l'oro
degli Elvezi. Nel medioevo, inserita nella Pieve di Arcisate, la valle fece parte del
Contado del Seprio e rivestì un importante valore strategico quale via di
comunicazione verso il nord Europa. Fanno parte della Valceresio i comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù.
|
Valcuvia |
 |
|
Situata nel cuore del Varesotto, è una valle ampia e aperta,
cosparsa di centri abitati nascosti tra boschi di faggi e castagni. E'
attraversata dal torrente Boesio che si getta nel Lago Maggiore a Laveno.
I monti che la circondano sono a sud il massiccio del Campo dei Fiori
(m. 1226), a nord il Sasso del Ferro (m. 1062) e i monti Nudo (m. 1295),
della Colonna (m. 1203) e San Martino (m. 1087). In una pergamena del 712 in cui sono elencati i possedimenti in Valcuvia del monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia sono citate diverse località della Valcuvia : Calariate (Caravate), Azemondo (Gemonio), Cuvigl (Cuveglio), Olino (Orino), Aci (Azzio). Nel 1196 passò sotto dal controllo di Como a quello di Milano e
quindi dei Visconti. Nel 1450 Francesco Sforza la concedeva in feudo a
Pietro Cotta. Nel 1728 i Cotta cedettero il feudo della Valcuvia a
Giulio Visconti Borromeo d'Arese. Alla sua morte il feudo passò a
Antonio Litta che ne aveva sposato la figlia. Tra il 1820 e il 1830 venne bonificata la vasta palude che si
stendeva tra Cavona e Cuveglio. |
|
 |
I centri della Valcuvia sono: Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Masciago Primo e Rancio Valcuvia |
|
La vallata, ampia e boscosa, è percorsa dal torrente Margorabbia e circondata a destra dal gruppo de I Bedeloni, tra cui svetta il monte Sette Termini (m 972) e a sinistra dalla dorsale del monte Pian Nave (m 1058). E' il naturale proseguimento della Valcuvia e della Valganna verso il Lago Maggiore. Il nome Valtravaglia sembra derivare da un composto con "valle", come "trans valles", "trans vallem", "inter valles", da confrontare con un antico "Travaglum", riportato dal Codex Diplomaticum Longobardorum ma non identificato, e con il monte "Trevalie". |
|
|
I centri principali sono Montegrino Valtravaglia, Brissago Valtravaglia, Grantola, Mesenzana. |
Nel 1513 venne occupata dagli Svizzeri, che la resero all'imperatore Carlo V in cambio di Mendrisio con la pieve di Balerna Da qui in avanti la storia della Valtravaglia si identifica con la storia della Lombardia. Nel 1805, venne inserita nel dipartimento del Lario con capoluogo Como. Nel 1927 venne attribuita alla neocostituita Provincia di Varese. Alcune località in riva al Lago Maggiore, come Porto Valtravaglia,
hanno mantenuto l'antico attributo a testimonianza dell'appartenenza
alla Pieve medievale, pur trovandosi geograficamente al di fuori della
vallata. La Valtravaglia è attraversata dalla provinciale Luino-Vergiate e fino agli anni Cinquanta Valtravaglia anche dalla tramvia che univa Luino a Varese. Di questa linea di comunicazione rimane qualche testimonianza del tracciato, qua e là ancora riconoscibile, e alcune stazioni, a volte in ottimo stato di conservazione, come quella di Molino d'Anna. |
Gli unici due centri di questa vallata ricca di boschi e di pascoli sono Dumenza,
da cui prende il nome, con le sue frazioni, Trezzino, Runo, Due Cossani,
Stivigliano e Agra.
E' attraversata dal rio Colmegnino le cui acque hanno alimentato uno
stabilimento tessile, molti molini e quel maglio in cui fu fabbricato il
cannone, un fascio di verghe cerchiate, con cui Cannobio si difese dai battelli
austriaci nel 1859.
Il monte Gradisea (m 1057) la separa dalla Valle Veddasca, il monte Lema
(m 1620), il più alto della provincia di Varese, segna il confine con la vicina
Svizzera. Dal Monte Lema con una bellissima escursione, per lo più sul crinale
elvetico, si raggiunge il Monte Tamaro (m. 1961) con splendidi scorci sul Lago
Maggiore. Escursioni più facili conducono al monte Clivio, al Colmegnino, al
Rogorio e al Bedea, per non parlare di quelle agli alpeggi Pradecolo, alpe Prato
Bernardo, Pian di Runo e prato Fontana.


|
La Val Veddasca occupa la parte più settentrionale della provincia
di Varese e si presenta ancor oggi come una valle solitaria e selvaggia,
dove notevoli sono le testimonianze della cultura rurale prealpina. La
storia degli insediamenti umani nella valle è molto antica, dimostrata
dal ritrovamento di graffiti preistorici. |
|
|
|
|
| Oltre alla rigogliosa vegetazione, altro elemento caratteristico della vallata sono le sue case, addossate le une alle altre e realizzate interamente in pietra. Di pietra sono le mura, di pietra i tetti, di pietra i portali e i davanzali delle finestre. Di pietra sono le fontane e i lavatoi, di pietra gli acciotolati e i sagrati delle chiese. Il legno è utilizzato unicamente nei balconi, scuri, quasi bruciati dal tempo e dal sole. Sono paesi che spesso sono rimasti isolati per le pessime vie di comunicazione e dove l'unica strada sicura e percorribile era rappresentata dalle antiche mulattiere. | |
|
Dal passo della Forcora, una mulattiera scende anche alla riva orientale del lago Delio, che alimenta la sottostante centrale idroelettrica di Ronco Valgrande. Tutte le chiese dei cinque nuclei abitati conservano torri campanarie di origine romanica. Da segnalare, lungo la strada che conduce al Passo della Forcora, fuori Campagnano, la chiesa di San Martino dal cui sagrato si gode un vasto panorama sul lago Maggiore; a Graglio, celato dal bosco che lo circonda, il santuario della Madonna di Penedegra, in origine.dedicato a S. Giuseppe ma rinominato dalla devozione popolare, con un lungo porticato anteriore e uno strano tiburio circolare. |
|
