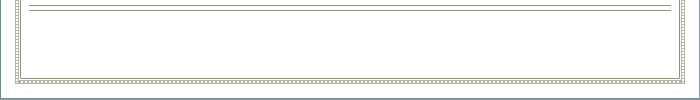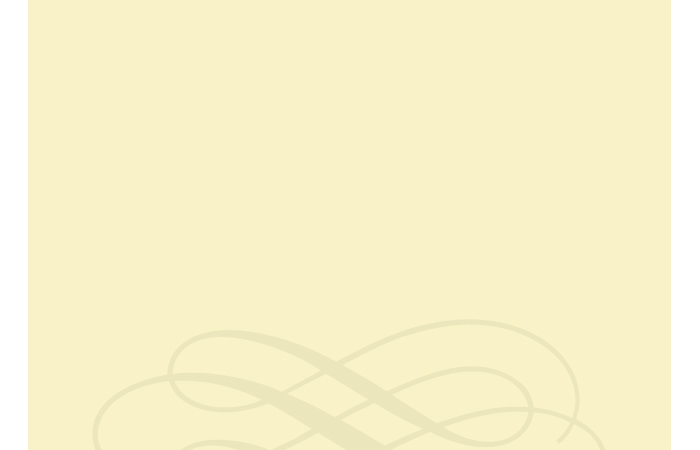
pp. 19-20
A motivo di cotanta varietà, è evidente, non rare negli autori antichi le elencazioni dei salsamenta (presso Oribasio, per esempio, o presso il già ricordato Difilo di Sifnio) verisimilmente poco costosi se di qualità comune o addirittura scadente (22), venduti al contrario a prezzo sostenuto nelle qualità più pregiate e rare (23): significativo al riguardo un episodio della vita di Catone riferito da Polibio, nel quale il Grande Vecchio lamenta non senza motivo il lusso dilagante presso i Romani: «E una smodata intemperanza riguardo a tali faccende si era impadronita dei giovani così che molti han comprato l'amore di un fanciullo per un talento, molti un vaso di pesce salato del Ponto per trecento dracme. Per questi motivi anche Marco, sdegnato, arringò una volta il popolo, dicendo che potrebbero riconoscere l'andare in peggio dello Stato da ciò, quando si scoprissero i giovani dabbene e i vasi di pesce salato messi in vendita a un prezzo maggiore, rispettivamente, dei terreni e dei guidatori di una coppia di buoi o di cavalli» (24).
Lo sdegno catoniano è condiviso da Plutarco: «E certo anche si vende a un prezzo più caro di tutti il piatto di mare: dunque Catone, non per esagerazione ma secondo verità concionando in pubblico contro la mollezza e il lusso della città, disse che a Roma si vendeva un pesce più caro di un manzo, e che mettevano sul mercato un vaso di tarichos a un prezzo quale non potrebbe ricavare un'ecatombe squartata di pecore, con un bue per prima vittima» (25)
-
pp. 59-60
-

Non poche dunque, né trascurabili le notizie elianee (se veritiere o meno, poco importa) sulle creature del mare variamente domesticate. Svettano tuttavia (e non può non essere così) gli strambi racconti sulla murena "amica", che in qualche modo vengono a smentire (o comunque decantare) la vulgata di perversa voracità, addirittura di antropofagia del dentuto pesce a sdemonizzare la quale, per altro, interviene già il sagace Archestrato, fine conoscitore di ittiche usanze, con l'escamotage di riconoscerla pratica comune a tutti, o almeno alla più parte dei pesci: «Nella città di Torone (122) è cosa buona del cane carcario acquistare le parti addominali, una volta svuotate: poi arrostisci, con granelli di comino e sale generoso. Nient'altro, o cara testolina mia, esternamente ci devi aggiungere, tranne che olio verde. E dopo che si sono cotte già, presentale tutt'uno con una salsa aromatica. Il resto lo puoi cuocere in una casseruola, né con acqua né con aceto mai queste parti devi mettere, ma soltanto versarvi olio sufficiente, e granelli di comino seccato, e insieme foglie aromatiche. Cuoci su carbone, senza avvicinare alla fiamma e muovi continuamente, che non ti sorprendano a bruciare. Ma pochi tra gli uomini mortali conoscono tale piatto divino, né vogliono cibarsene quelli che anima sciocca quanto una locusta albergano in sé e son davvero percossi nella mente , perché belva feroce, divoratrice di uomini. Ma il fatto è che il pesce tutto quanto ama carne umana, quando gli capita: per cui chi blatera tali sciocchezze convien di conseguenza che passi ad una dieta vegetariana, e seguendo il filosofo Diodoro vada con lui in astinenza pitagoreggiando» (123).
Un brano (e una ricetta) stupefacenti anzi che no: e infatti a suo tempo come ricorda debitamente Degani destarono l'entusiasmo del celebre Veronelli, inducendolo a scrivere: «"Preferisco Archestrato, il greco autore di questa ricetta, a tutti gli Apicii (124) che ci hanno impestato con il loro 'garum' e derivati" (125); e di qui egli ha tratto lo spunto per i suoi "Spiedini di scampi alla Archestrato"» (126)

Oltre alle creature marine già in precedenza celebrate, tra i pesci che ricorrono nell'impagabile parodia gastronomica taluni altri meritano speciale attenzione.
È il caso innanzi tutto, se non altro per la loro non frequente comparsa, dei ricci di mare (già qui incontrati nella favolosa ricetta oraziana sulla murena) (1). A stare alle antiche testimonianze, numerose sono le proprietà e dunque le possibilità di utilizzo di tali echinodermi. Tanto per esemplificare, le applicazioni in medicina sono attestate vuoi da Ippocrate (cui si rifà Galeno) per la terapia dei disturbi femminili o di altre afflizioni: «Alcuni mangiano i ricci di mare sia nel vino mielato sia nella salsa di pesce, prima di pranzo, per purgare il ventre» (488. 9) vuoi da Plinio nella preziosa Storia naturale: «I ricci di mare pestati con le loro spine e bevuti nel vino guariscono dai calcoli» (32. 9); «I ricci di mare pestati ancor vivi e bevuti nel vino dolce arrestano i flussi»; «La cenere del guscio dei ricci di mare cura le piaghe» (32. 10) (2).
Per quanto attiene invece ai loro comportamenti o caratteristiche in genere, alcune indicazioni provengono ancora da Plinio: «Raccontano che essi presagiscano la furia del mare e che l'attendano afferrati dei sassolini bloccando con il peso la propria mobilità; non vogliono che l'ondeggiamento consumi, sfregando, gli aculei. E quando i marinai vedono ciò, subito ormeggiano le imbarcazioni a più ancore» (nat. 9. 31); «I ricci di mare che si aggrappano (scil. agli scogli) o si zavorrano con la sabbia sono segni di tempesta» (18. 87). Del tutto analogo, a dire di Claudio Eliano, il procedere di seppie e calamari: «Le seppie e i calamari mangiano servendosi di due proboscidi: non è infatti sbagliato chiamarle "proboscidi", dal momento che il loro uso e la loro forma giustificano tale nome (3). Quando il mare è agitato dalla tempesta e dai cavalloni, questi animali si avvinghiano saldamente alle rocce con queste protuberanza, come se fossero ancore, e rimangono inamovibili e protetti contro le onde; se poi subentra la bonaccia, si staccano dagli scogli e tornano a nuotare liberamente, dopo aver appreso una lezione tutt'altro che disprezzabile, cioè il modo di sfuggire a una tempesta e salvarsi dai pericoli» (4).
Ma c'è dell'altro. Infatti così testimonia Claudio Eliano, che annovera i ricci tra i «testacei» (11. 37) comprendenti altresì ostriche, porpore, buccini, strombi e palinuri: «Il flusso delle onde fa rotolare lontano dalle loro tane i ricci e, sospingendoli verso la terraferma, li scaglia con grande violenza fuori del mare. Poiché essi temono questa evenienza, quando si accorgono che le onde schiumeggiano e stanno per diventare più alte e più gonfie, raccolgono coi loro aculei delle pietruzze, tutte quelle che possono portare, e se ne servono come zavorra che rende più difficile il rotolamento e così non subiscono i guai di cui hanno paura» (7. 33); «Se una persona fa a pezzi dei ricci ancora vivi dentro il loro guscio e che protendono gli aculei, e poi li abbandona dopo averne gettato qua e là per il mare i frammenti, questi di nuovo si uniscono e si riattaccano, riconoscendo quelli di loro appartenenza; quando si sono così ricomposti, riprendono a crescere tutti assieme. Questa capacità di ritornare interi come prima è veramente una straordinaria peculiarità della loro natura» (9. 47); «Il riccio marino è un rimedio efficace per lo stomaco; è di aiuto a coloro che soffrono da tempo di disappetenza e provano ripugnanza per ogni genere di cibo; è anche un diuretico, secondo quanto dicono coloro che se ne intendono. Se poi lo spalmiamo sul corpo di un malato di scabbia, il riccio di mare lo guarisce dalla malattia. Se viene bruciato con le sue stesse valve, le ceneri possono purificare le piaghe venute e suppurazione» (14. 4)