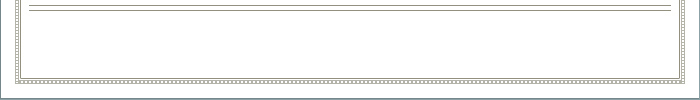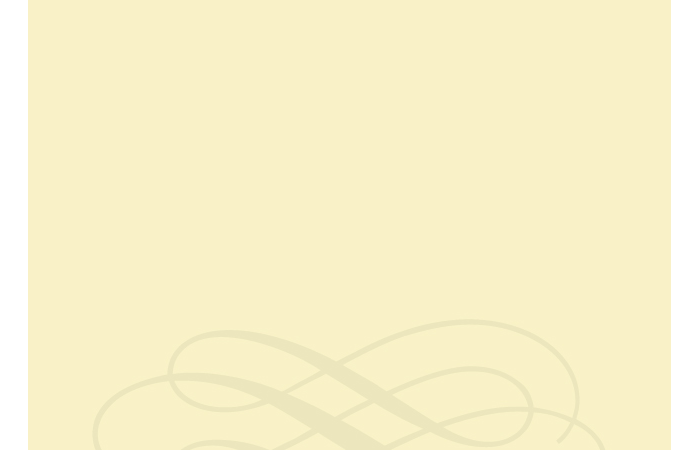
pp. 35-36
Con ogni probabilità, To the Lighthouse è il romanzo più autobiografico di Virginia Woolf (2).
Il suo primo intento, com'è risaputo, è di scrivere un libro sul padre (3) - ma forse, dopo tutto, non sarà un ritratto del padre, sarà qualcosa di molto più lento e più vasto: forse si tratterà, per l'autrice, di scomporre le proprie emozioni. Viene così in primo piano la figura della madre, Julia Stephen (4), impersonata dalla signora Ramsay. Senza dubbio centrale è il riconoscimento della figura materna e del suo duplice messaggio: l'adesione all'idea vittoriana della polarizzazione e relazione tra i generi - di cui essa rappresenta sia la conservazione sia la legittimazione, al punto di scendere in campo contro il suffragio femminile - e l'alto prezzo che tale adesione comporta, vale a dire una profonda, incolmabile insoddisfazione. Un riconoscimento, quello virginiano, che è altresì «segno di con-fusione e di domanda di identità da parte della figlia, domanda di identità che muovendosi in un costante bisogno di verità ("unless I am myself I am nobody", se non è se stessa, se non si pone all'ascolto, ogni volta, di nuovo, tra tutte le voci interne, di quella più sua, non si sente nessuno), necessariamente è domanda che assume come dato di partenza il proprio essere donna» (5).
pp. 105-106
L'unica a uscirne illesa dunque, Elena di Sparta, «seminando l'incendio e la strage. Non sorrise a nessuno. Non mentì con nessuno». Donna stupenda e inafferrabile, «degna del mare» e, soprattutto, degna della dea «che non soffre - Afrodite sovrana: «Là balzò dalla schiuma quella che non ha nome, l'inquieta angosciosa, che sorride da sola» (p. 78).
Un'Elena ancora una volta implacabile e indefettibile: ma proprio per questo degna dei fiumi di sangue versati dagli Atridi - «grassi tiranni» nella pungente definizione del Castore pavesiano (In famiglia p. 161). I quali «hanno posto la loro lussuria nell'abbraccio violento, nello schiaffo e nel sangue», perciò «di una donna che è docile e vile non sanno che farsene. Hanno bisogno d'incontrare occhi freddi e omicidi, occhi che non s'abbassino. Come le buche feritoie» (pp. 162-163). In una parola, conclude Castore, «hanno bisogno della vergine crudele. Di quella che passa sui monti. Ogni donna che sposano è questo, per loro. Le imbandivano i figli, le scannavano figlie ... POLIDEUTE. Sono cose passate. CASTORE. Le faranno ancora, Polideute» (p. 163).
Come si vede, al di là delle insormontabili differenze di tempo e di spazio, determinante per Elena resta ovunque il motivo dell'incorrotta bellezza. Così già presso alcuni autori della classicità che preferiscono sottolineare, della Divina, più inconsueti aspetti, azzardosamente salottieri. In ambito latino, per esempio, l'Ars amatoria di Ovidio guarda a Elena come a una stupenda e altrettanto frivola dama di corte, dedita, è inevitabile, a piccanti giuochi adulterini, vieppiù incoraggiati dalla tacita compiacenza del marito: «Mentre le era lontano Menelao, per non giacersi sola, Elena bella trovò una notte tiepido rifugio nelle braccia dell'ospite. E stupisci tu, Menelao? Te ne andavi solo, e poi lasciavi l'ospite e la sposa sotto lo stesso tetto! Tu abbandoni, pazzo che sei, la timida colomba nell'artiglio del falco, il pieno ovile lasci al lupo dei monti! Elena è pura, nessuna colpa ha verso te l'amante. Ciò ch'egli fa è ciò che tu faresti, che chiunque farebbe. Tu lo spingi, dandogli il tempo e il luogo, all'adulterio. E che mai d'altro può voler la donna se non piegarsi a ciò cui tu l'induci? E che potrebbe far d'altro? Lontano è il suo sposo da lei; vicino l'ospite bello, non rozzo, ed ella che ha paura, tanta paura di giacersi sola! Se la veda l'Atride; per mio conto Elena assolvo; approfittò soltanto d'un comodo, benevolo marito» (66).
pp. 155-156
In effetti, qui, il monarca tebano «possiede la convinzione di essere nel giusto con la medesima intransigenza di Antigone: come lei, rifiuta la mediazione, la compromissoria accettazione dell'ambiguità del reale. Egli ignora che, nel magma che sta oltre le categorie della ragione umana, ogni verità incorpora il suo contrario; nel nome della sovranità che spetta alla legge scritta dello stato, Creonte sfida la legge degli dèi che parla nelle usanze degli uomini» (90). Irriducibile allora la presa di posizione di entrambi: Antigone è «donna e giovane; rivendica il diritto individuale di aderire ai propri princìpi; il suo pensiero è rivolto al mondo dei morti e alla legge che lo governa; la sua verità sono gli dèi. Creonte è maschio, e vecchio; ritiene che la dimensione dell'uomo sia lo stato; ogni suo atto sta dalla parte di chi è vivo; l'uomo è la misura unica delle sue decisioni. Ognuno dei due è catafratto in un proprio sistema, imposto dai dati obiettivi dell'anagrafe e dai fattori soggettivi delle convinzioni» (91): il che fa sì che essi conoscano e mettano in pratica una sola forma di confronto - la violenza (92) - che nega le ragioni dell'altro e che, superfluo dirlo, appartiene tanto alla tracotanza di Creonte quanto alla fierezza di Antigone: mostrando appunto essa, nella sua algida solitudine (93), una determinazione così pervicace, così orgogliosa, così assoluta da tradire - meglio, da snaturare - il suo esser donna, da violare cioè quelle che, per gli/le Ateniesi del suo tempo, sono le ineludibili leggi "naturali" della femminilità, con insistenza richiamate dalla prudente quanto a(nti)eroica sorella Ismene: «Siamo donne, ricordalo, non possiamo batterci con gli uomini; chi ci governa è più forte e noi dobbiamo piegarci a quest'ordine e ad altri, ancora più penosi. Ai morti, chiedo perdono. Obbedirò a chi tiene il potere, sono costretta a farlo. Agire oltre i propri limiti, è follia» (p. 22).