
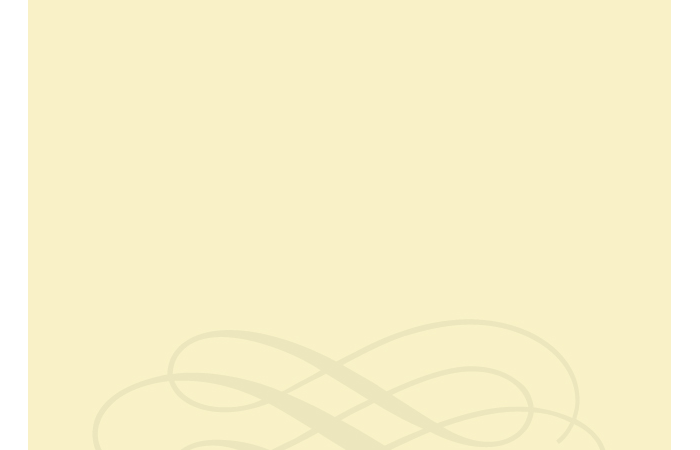
-
pp. 134-138
-

Iside, dunque. Divinità colma d'amore e per amore del pari dolente – cui sopra tutto si addice il nero, funebre simbolo di dolore e di lutto: al punto che, sovente, le sue statue proprio di nero si abbigliano – e tuttavia, al tempo stesso, inossidabile sposa-sorella per cui tramite, inaudito portento, il morto Osiride genera un figlio postumo. Ciò, perché l'ineffabile dea è capace «di una forza d'amore che vince le leggi della natura ed è esso stesso la vita. Iside è antitetica e complementare a Osiride». Nè, d'altra parte, solo il suo compagno è un grande dio: lo è anche Oro, suo figlio: e appunto Iside è «madre di dio», ovvero «archetipo di una gloriosa posterità. Ma la sua dimensione femminile include qualcosa di più: essa è anche l'unica dea ad amare il suo sposo divino di un amore umano, nella dedizione e nel sacrificio. La loro coppia rappresenta l'ipostasi perfetta del destino degli uomini, nella polarità della vita e della morte» (20). Entrambi infatti sono «innamorati al punto di unirsi nell'oscurità del grembo materno ancor prima di nascere» (356a): e, secondo taluni, frutto dell'intempestiva unione nasce Arueris – chiamato Oro il vecchio dagli Egiziani e Apollo dai Greci. Quanto a Osiride, esso durante il suo regno subito «fece mutare agli Egiziani il loro genere di vita povera e selvatica, li istruì nella coltivazione dei campi, fissò delle leggi, e insegnò loro a onorare gli dèi. Poi percorse tutta la terra d'Egitto e la civilizzò: e non ebbe bisogno di armi, perché riuscì ad attirare quasi tutti con l'incanto della persuasione, con la parola unita al canto e a ogni tipo di musica, tanto che i Greci credettero di identificarlo con Dioniso» (356b) – il quale, è il caso di ricordarlo, viene anzi tutto adorato come emblema della fertilità. E questo, tra l'altro, spiega le frequenti statue di Osiride di tipo antropomorfo e itifallico – precipui simboli di fecondità e di potere vitale – non di rado rivestite di abiti color rosso fiamma, in ossequio alla concezione per cui «il sole rappresenta la sostanza visibile del bene, che è essenza puramente intelligibile» (371f).
Iside, vedova affranta – nella più tarda versione del mito (21) protagonista di molti episodi relativi allo sposo-fratello: anzi tutto la desolazione per la sua morte, perfidamente ordita, assieme a un certo numero di congiurati, da Tifone/Seth. Il quale, misurato di nascosto il corpo di Osiride, costruisce un'arca delle sue dimensioni, bellissima e sontuosamente ornata, quindi la esibisce «nella sala del banchetto. Tutti la guardarono ammirati e allora Tifone promise, come in un bel gioco, che l'avrebbe data in dono a quello che ci stesse dentro sdraiato proprio di misura. Uno dopo l'altro provarono tutti, ma nessuno ci entrava davvero esattamente; venne poi il turno di Osiride, e quando si sdraiò dentro, subito i congiurati si precipitarono a chiudere il coperchio, lo saldarono all'esterno con i chiodi e ci versarono sopra piombo fuso. Poi trasportarono l'arca al fiume, e la abbandonarono alla corrente perché arrivasse al mare attraverso la bocca Tanitica (22): per questo gli Egiziani anche adesso chiamano questa bocca "odiosa" e "abominevole"» (356c). Venuta a conoscenza del lugubre evento, la misera sorella «si tagliò una delle sue trecce e indossò una veste da lutto, là in quel paese che da allora fino a oggi si chiama Copto» (23). E – precisa Plutarco – «alcuni ritengono che questo nome significhi "privazione", perché presso gli Egiziani il nostro verbo "privare" si dice koptein» (24). Quanto a Iside, da quel giorno «vagabondò senza meta, senza saper dove cercare, chiedendo notizie a tutti quelli che incontrava» (356d-e). Venne poi fortunosamente informata che la bara, sospinta fuori dal mare nei pressi della fenicia Byblo, «con l'aiuto delle onde era dolcemente approdata in un prato di erica» (357a): ma soltanto dopo una serie di vicissitudini riuscì a caricarla su una nave; poi, giunta in un posto isolato, la aprì, «abbandonò il suo viso su quello di Osiride e si mise a baciarlo, piangendo» (357d); quindi depose la preziosa arca in un luogo «fuori mano. Ma Tifone, mentre andava a caccia di notte, la scoprì per caso, illuminata dalla luna; riconosciuto il corpo di Osiride, lo fece in quattordici pezzi e lo disperse» (25). Ed ecco nuovamente Iside alla disperata ricerca, traversando le paludi su una zattera di papiro e costruendo una tomba per ogni pezzo che riusciva a trovare; non ritrovò tuttavia il membro virile, «perché era stato gettato per primo nel fiume (26), e lì l'avevano mangiato il lepidoto, il fagro e l'ossirinco, proprio quei pesci, cioè, tanto aborriti dagli Egiziani. Al posto del vero membro, Iside ne fece uno finto, e rese sacro il fallo, a cui anche ora gli Egiziani dedicano molte feste» (358a; b) (27). Infine la dea «si unì a Osiride anche dopo la sua morte, e partorì un figlio prematuro e rachitico negli arti inferiori, Arpocrate» (358c; e) – come viene denominato Oro ancora fanciullo, raffigurato talvolta in grembo alla madre, o stante nudo con una treccia laterale e il dito sulla bocca, ovvero, in epoca greco-romana, assumendo l'aspetto di un Eros ricciuto, talora anche con attributi di Eracle e di Dioniso, con molte varianti (28).
pp. 148-150
Come si vede, nella pagina di Borges il protagonista smentisce con forza la sua prigionia – pur soffrendo, del prigioniero, tutte le angosce: la noia, l'estraneità, il desiderio – non realizzabile se non nel giuoco (insaziato) dell'immaginazione – di condividere la vita, di poter essere compreso, dunque liberato. Attende infatti un redentore, Asterione, un salvatore benefico che lo riscatti dall'oppressione dell'esistenza – ovvero dell'insopportabile casa, con i suoi infiniti corridoi e le sue infinite porte: «Tutte le parti della casa esistono molte volte, qualunque luogo di essa è un altro luogo. Non ci sono una cisterna, un cortile, un abbeveratoio, una greppia; sono quattordici [sono infinite] le greppie, gli abbeveratoi, i cortili, le cisterne. La casa è grande come il mondo; o meglio è il mondo.Tuttavia, a forza di percorrere cortili con una cisterna e polverosi corridoi di pietra grigia, raggiunsi la strada e vidi il tempio delle Scuri e il mare. Non compresi, finché una visione notturna mi rivelò che anche i mari e i templi sono quattordici [sono infiniti]. Tutto esiste molte volte, quattordici volte; soltanto due cose al mondo sembrano esistere una volta sola: in alto, l'intricato sole; in basso, Asterione. Forse fui io a creare le stelle e il sole e questa enorme casa, ma non me ne ricordo» (pp. 58-59).
Già mostro orrifico per antonomasia, il Minotauro di Borges diventa allora una creatura dotata di sensibilità più che umana. E pensa; rimugina; si addolora; si sfinisce correndo a precipizio, quasi falena impazzita; si sdoppia per dimenticare il proprio stato; si infligge torture atroci : «Come il montone che s'avventa, corro per i corridoi di pietra fino a cadere al suolo in preda alla vertigine. Mi acquatto all'ombra di una cisterna e all'angolo di un corridoio e gioco a rimpiattino. Ci sono terrazze dalle quali mi lascio cadere, finché resto insanguinato. In qualunque momento posso giocare a fare l'addormentato, con gli occhi chiusi e il respiro pesante (a volte m'addormento davvero; a volte, quando riapro gli occhi, il colore del giorno è cambiato). Ma, fra tanti giochi, preferisco quello di un altro Asterione. Immagino ch'egli venga a farmi visita e che io gli mostri la casa» (p. 58).
Ed ecco, limpida come cristallo, la duplice catastrophe, reciprocamente "liberatoria" – dove, però, il già "umano" Teseo è solamente un eroe freddo e inconsapevole (indifferente) della (alla) propria crudeltà: «Ogni nove anni entrano nella casa nove uomini, perché io li liberi da ogni male. Odo i loro passi o la loro voce in fondo ai corridoi di pietra e corro lietamente incontro ad essi. La cerimonia dura pochi minuti. Cadono uno dopo l'altro, senza che io mi macchi le mani di sangue. Dove sono caduti restano, e i cadaveri aiutano a distinguere un corridoio dagli altri. Ignoro chi siano, ma so che uno di essi profetizzò, sul punto di morire, che un giorno sarebbe giunto il mio redentore. Da allora la solitudine non mi duole, perché so che il mio redentore vive e un giorno sorgerà dalla polvere. Se il mio udito potesse percepire tutti i rumori del mondo, io sentirei i suoi passi. Mi portasse a un luogo con meno corridoi e meno porte! Come sarà il mio redentore? mi domando. Sarà un toro o un uomo? Sarà forse un toro con volto d'uomo? O sarà come me? – Il sole della mattina brillò sulla spada di bronzo. Non restava più traccia di sangue. "Lo crederesti, Arianna?" disse Teseo. "Il Minotauro non si è quasi difeso"» (p. 59).
Da tutto ciò, inevitabile, la presa d'atto del narratore che la realtà non è mai come ci si aspetta, che la vita riserva sorprese assai amare, che il dolore accomuna tutti gli esseri, che d'altro canto l'eroismo non appartiene solo ai catalogati "eroi". Disillusa conclusione, è evidente: la quale, pur nelle inevitabili, palesi diversità, si (ri)specchia nell'eccelsa rivisitazione del genovese Giorgio Gazzolo (2) – dove il Minotauro, chiarisce lo stesso autore, campeggia quale "immagine risalita dal buio dell'Es".
pp. 212-215
Cotali dunque gli esempi – stellari – offerti dalla produzione letteraria latina. Per quanto concerne, invece, l'universo poetico della Grecità, sia pure in tutt'altra temperie e momento storico si possono richiamare parecchi epigrammi dell'Antologia Palatina (54) – e, in special modo, tutta una serie di brani mirabilmente composti da Meleagro di Gàdara (Transgiordania, ca. 140-60 a. C.) (55), nei quali con particolare insistenza agisce la tematica del «simulacro amoroso nelle sue diverse accezioni e valenze – simulacro onirico, mentale o immagine materialmente prodotta, sotto forma di ritratto o di statua» (56) – di maniera che la pulsione erotica risulta, ancora una volta, strettamente legata al vedere (57) e l'immagine (concreta, palpabile, o magari solamente pensata) diviene fondamentale, ineludibile matrice d'amore.
Così, tanto per esemplificare, sul predominio erogeno dell'immagine visiva assai eloquente suona il meleagreo epigramma 60 (58) del dodicesimo libro (59): «Se guardo Terone, vedo l'universo; ma se vedo tutto e lui non c'è, è il contrario: il nulla» – al quale offre brioso contrappunto un più tardo epigramma di Paolo Silenziario (secolo VI d. C.): «Chi è morso da un cane rabbioso, dicono che ne veda l'immagine nell'acqua. Forse in me Eros furioso affondò dentro il suo dente affilato e spinse nel delirio la mia anima: nel mare vedo la tua amata immagine, nel gorgo dei fiumi, nella tazza di vino» (60).
Analogo motivo si svolge – e si fa più complesso – in un altro brano di Meleagro, l'epigramma 84 del dodicesimo libro: «Amici, soccorso! Sbarcavo dal mare e in terraferma avevo appena mosso il primo passo che Eros (61) feroce mi trascinò qui e come mostrando la via con una torcia mi folgora con l'amabile bellezza di un giovinetto. Io seguo i suoi passi, e cercando di prendere quella dolce forma modellata nell'aria (62) dolcemente la bacio. Scampato al mare amaro dovrò sulla terra varcare l'onda di Cipride, molto più amara di quella?» (63). Oppure nel 127 del medesimo libro: «Vidi Alessi in mezzo alla strada, a mezzo del giorno, nella stagione che viene recisa la chioma alle messi. Due fuochi mi arsero: quelli di Eros, attraverso gli occhi del giovinetto, e quelli del sole. Ma a questi la notte procurò riposo, quelli nei sogni riarsero per l'immagine bella. Il sonno che agli altri scioglie le pene a me ha dato una pena, modellando nella mia anima un fuoco di viva bellezza».


