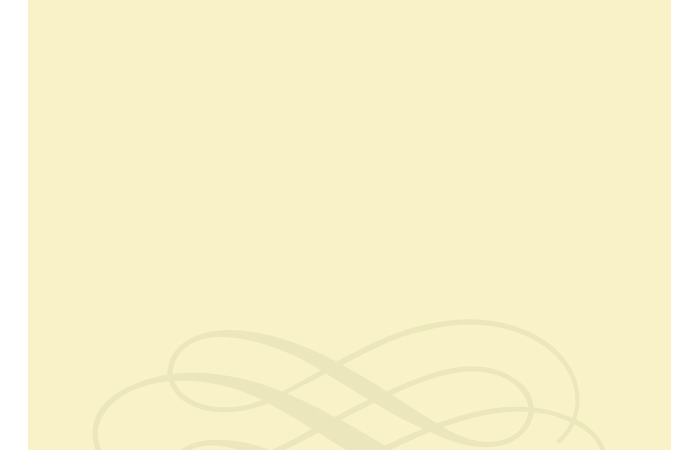
Letizia Lanza, Poesie soffocate.
Qualche storta sillaba. L’obiettivo ideale di Montale e di Contini di una poesia che si riducesse (anzi no, concentrasse) tutta in qualche storta sillaba si svelò non raggiunto agli autocritici occhi di Montale che scoprì qualche decennio dopo di aver scritto gli Ossi ”ore rotundo”. Altro che qualche storta sillaba.
Qui leggendo questo aureo libretto di Letizia Lanza vien fatto di ripensare a quei programmi, di fare poesia con la non-poesia, programmi falliti almeno in parte per la contingente congiuntura dannunziana (cui, come ha dimostrato Mengaldo, malgrado le intenzioni Montale non riuscì a sottrarsi) e l’ineliminabile petrarchismo melodioso cantabile che pesa sulla poesia italiana da cento anni almeno prima di Petrarca: colpa forse di Jacopo da Lentini.
E qui nel libretto di Letizia Lanza dal titolo eloquentemente programmatico Poesie soffocate, le sillabe sono più che storte, sono dichiaratamente “sillabe di vuoto / incerto inauscultabile / bar-bar / del cuore”, in un sforzo riuscito di piegare il linguaggio, che sia pure entro certi limiti è la proiezione materializzata delle strutture logiche della mente, alle più profonde non-ragioni di una “sbalestrata mente / ondivaga” che ha il sapore di una emotività ancestrale, mettendo in moto un processo di contraddizioni non dialettiche e non dialettizzabili, che del resto in qualche modo si avvicinano per la loro ragion d’essere ai paralogismi e alle antinomie della kantiana critica: “Rabbercio parole, / accatto suoni - / oziosi brandelli”.
Se qualcuno si aggira ancora fra le impervie strade della metafisica ponendosi tra altri ardui problemi, come quello della quadratura del cerchio o quello del moto perpetuo o quello dell’uovo e della gallina, quello dell’essenza della poesia, se sia questa essenza nella forma o nel contenuto, nel significante o nel significato, qui trova una risposta esauriente. L’accurata elaborazione della materia fonica che gioca sapientemente più sulle consonanti che sulle vocali (“ansia irruenta” … “ crepitanti singhiozzi” … “rabbia ribalda”… “esaspero vana esistenza” …), ma che dalle vocali, normale strumento di melodia lirica, sa trarre strutture di angoscia tenebrosa (“a riveredereavere veridico” … “un rivivere pusillo” … ) si spalma sul significato o più spesso lo produce svolgendo funzione di forma simbolica. E il significato appare allora sotto forma di pensiero poetante che disarcionato dalla struttura concettuale si affida allo stato d’animo profondo. Tema fondamentale “Inaridìo nihilo”attorno a cui ruota un più vicino giro di concetti riassunti nei versi “esaspero vana esistenza / di stremato fascino”. A ben vedere sono cinque parole ognuna delle quali costituisce una tesi: il centro è la vanità dell’esistenza (ma è da definire separatamente il “vano” e “l’esistere”; il fascino è la problematica gnoseologica, la possibilità di conoscere quell’esistenza, possibilità stremata non solamente dai limiti della pura ragione, ma da una esasperazione che li restringe ulteriormente.
Attorno a questo tema orbita tutta la complessa tessitura di questo insieme di testi. Un certo fenomenismo (“parvenze di vita”), la caducità del vivere (“un momento breve / come l’occaso”), il convenzionalismo (“rivesti l’anima di ragioni”), il Dasein (“frantumo di vita”), i momenti di gioia (“felicità felina”…. “e il cuore ride”), e di “stolta gelosia”, l’angoscia (“lamenti teneri / di morte”), la solitudine (“crepitanti singhiozzi / in solitudine / bruma”).
E ognuna di queste indicazioni (indigitamenta) si lascia analizzare e scomporre in infinite e indefinite parti, in una struttura a-concettuale, che riconduce alla produttività del linguaggio usato scomposto creato e ricreato.
Bruno Rosada