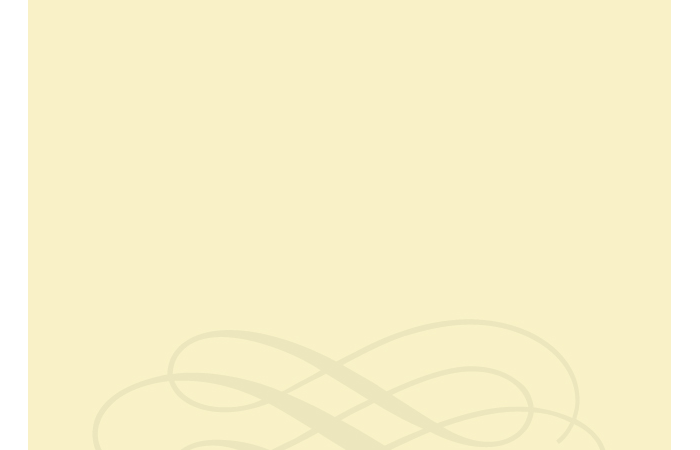
Letizia Lanza, Levia gravia 204-2005 (Poligrafica, Venezia 2006); Tracce (CFR Poiein, Piateda 2012)
di Giorgio Linguaglossa
Tutta interna ad una campitura stilistica illibata e desueta la scrittura poetica di Letizia Lanza incede a rallentatore, indugia su alcuni particolari minimi del “quadro”, introduce delle minime “variazioni”, delle “deviazioni” ma resta pur sempre prigioniera del recinto post-lirico quale hortus conclusus, una sorta di spazio stilistico che si è aperto in questi ultimi due tre decenni: una sorta di territorio esentasse, una zona di franchigia fiscale e stilistica dove è possibile operare con contaminazioni del “poetico” con l’“impoetico” e/o con l’“extraestetico”. Letizia Lanza vede la poesia come un luogo separato dalle correnti dei linguaggi della media-sfera. Pensiero corretto se intendiamo che c’è sempre una “separazione” tra il linguaggio poetico e tutto ciò che sta all’esterno di esso. Letizia Lanza interpreta questo concetto come “incomunicabilità” e impermeabilità tra il poetico e l’impoetico.
Se la forma di abolizione del mondo quaternario, cibernetico e combinatorio, è l’implosione, all’interno della minima entropia dei microcosmi affettivi, all'interno degli istituti stilistici corrisponde l’assottigliamento dei flussi di resistenza e l'innalzamento delle maree “interne” ed “intime”, così consuete e familiari alla recente poesia da esser divenute una moda. Ma la Lanza resiste come può alle logiche dell'implosione linguistica e stilistica, con tutte le sue capacità di intellettuale nutrite da «glaucoantiche memorie», «plumbei reperti»; preferisce un discorso poetico frutto di distillazione, di «sillabazioni stente», una «scrittura strabica», adotta un lessico desueto, «scampolerìe lise spente», «lubrico gaudio».
Dai rappresentanti della poesia femminile del tardo Novecento Letizia Lanza rifiuta l'eredità della camera con vista della poesia ridotta a teatro, messinscena del “privato”. Non è un caso che un'altra linea della poesia femminile degli ultimi vent’anni (da Giovanna Sicari con Sigillo del 1985, Maria Rosaria Madonna con Stige del 1992 fino a Maria Marchesi con Evitare il contatto con la luce del 2006), abbia privilegiato più la metafora che non la metonimia, più il discorso traslato, più il “taglio” sulla tela che non il discorso del “privato”, al contrario della generazione precedente che aveva privilegiato gli aspetti privato-gastronomici, ironici, desublimati e caricaturali del “quotidiano” con un linguaggio più vicino possibile al “vissuto”. In difformità a questa linea ascendente stilistica, la poesia di Letizia Lanza elegge la via della rarefazione lessicale e stilistica, una “fissità formulare”, il massimo risparmio di combustibile lessicale e energetico. È la linea discendente della più alta poesia femminile dell’epoca della transizione dalla affluent society a quella della stagnazione e recessione (economica, stilistica e spirituale): là dove al basso tasso di inflazione dell’economia monetaria dell’epoca della stagnazione, corrispondeva un incremento della detassazione degli istituti stilistici, e quindi un incremento delle scritture (de-territorializzate e denaturate) e delle tematiche piccolo-borghesi (con adozione di un idioletto privato, da cui un concetto privatistico del fare poetico), con conseguente effetto di deriva dei tematismi e dei privatismi in chiave ludico-ironica, ludico-iconica e scettico-urbana e consentanea derubricazione in chiave minimalista del discorso poetico. È da precisare, al contrario, che la più consapevole poesia femminile della crisi, già dagli anni Novanta imbocca la via opposta della detassazione intensiva (diretta e indiretta) degli istituti stilistici pregressi, sceglie l’elezione del genere della poesia-confessione ad alto consumo di combustibile stilistico: dove la lingua “privata” è funzione di una posizione di “autenticità”, di contro all’uso sconsiderato e acritico di idioletti e post-lingue “privatissime”, di tematiche privatistiche (tipiche di una certa clericatura del poetico), proprie di una cultura che nel frattempo andava al macero della propria irrilevanza culturale, che scriveva in una sorta di “superlatino” commestibile e comprensibile da Gorizia a Linguaglossa, e traducibile nelle esperienze denaturate di ogni latitudine.
La poesia di Letizia Lanza segna dunque una discontinuità, una opposizione alla deriva di «digitilandia»; prosegue, con i suoi mezzi, la tradizione della migliore poesia femminile della generazione scomparsa: espelle il “privato” (non si sa più quale privato dopo il diluvio delle scritture privatistiche!), pagandone il relativo dazio, affonda il salvagente dell’“io”: torna indietro, ricomincia daccapo, da antichista qual è, dalla sillabazione primaria. Del resto, non è proprio di ogni generazione ricominciare daccapo, dal punto in cui la precedente aveva dichiarato forfait
da Tracce
Sembra quasi un sorriso
questo giorno
che già cede alla sera –
e il sole scende
alla montagna bruna
e il cuore ride,
immerso in questa luce.
Fugge l'attimo breve –
come il tramonto.
*
fantasmi opachi
in falcea luna –
a filo di mare.
E brilla alla risacca –
morbida.
Lamenti teneri
di morte
ad avvinghiare l'anima:
larvale sogno eterno.
*
Varchi di pensiero –
esili stelle –
a barattare
atomi di eterno.
Parvula –
antropica
mens.
*
Sbregolante frastuono –
ridda atrobiliare d'impulsi.
Mondo vacuo.
*
Rabbercio parole,
accatto suoni –
oziosi brandelli.
Scampolerie lise spente –
a intreccio di trame
pauloaracniche.
Sagitta la ricerca –
e svaga e sbircia
crinali chiari.
Si arrende poi –
pulsione (s)finita.
*
Vergo pagine
righe
parole.
Frango il silenzio
con sillabazioni stente.
Scrittura strabica
di sangue:
vana esultanza
poematica?