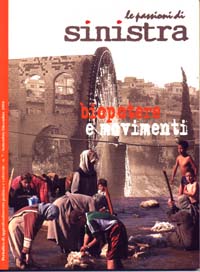La politica, la forma-partito e i neutrini |
La grande rimozione
Nello “Schema di governo conservatore”, consegnato(1) a Reagan nel 1980, si sosteneva - per assicurare il mantenimento dei privilegi dell’élite economica, disturbata dalle turbolenze della fine degli anni Sessanta e Settanta - un “fascismo amichevole”, ispirandosi alle tesi della “Trilaterale” che parlava della necessità di una “democrazia più moderata” e di un ritorno della popolazione allo stato di apatia e passività ante ’68. La mondializzazione è il processo che rende concreto questo obiettivo.
Dopo la fase di teorizzazione, l’abbandono unilaterale dei cambi fissi nel 1973, e il secondo shock petrolifero del 1979, la tappa decisiva, per la realizzazione di questo progetto, è compiuta negli anni Ottanta con la liberalizzazione del settore finanziario americano, che apre la via alla sua globalizzazione tramite le banche, le società d’intermediazione, i fondi speculativi e i fondi pensione, che dominano i flussi finanziari mondiali. Grazie a ciò il sistema statunitense ha avuto accesso al risparmio di tutto il mondo. In breve l’introduzione di un mercato libero mondiale dei capitali era indispensabile alla salute economica e finanziaria del primo debitore mondiale. Il passivo netto americano nel 2000 era pari a 1, 5 trilioni di dollari, pari al 20% del Pil.
Con la mondializzazione dei mercati, nata e guidata da una serie di decisioni americane, l’impresa mentre rompe i compromessi sociali territoriali, si dà propri strumenti di governo e di controllo, che segnano la natura e i caratteri dello Stato immateriale delle transnazionali. Tale Stato impone la liberalizzazione dei mercati, la distruzione dello stato del benessere, lo scardinamento della legislazione del lavoro, la disoccupazione strutturale di massa, la compressione delle dinamiche salariali. Dovrebbe dunque essere evidente a tutti che il neoliberismo è un programma politico, la mondializzazione una costruzione sociale.
Anche se si annuncia periodicamente da parte delle autorità istituzionali che la mondializzazione porterà il paradiso in terra, dovunque si guardi, la disoccupazione e la precarietà continuano ad essere di massa; il ristagno o il declino economico, la sofferenza sociale, l’incertezza sul futuro, la rovina di intere economie nazionali, la criminalità economica(2), le guerre, sono elementi costitutivi delle politiche iperliberiste ovunque prevalenti, e esibiscono il macroscopico fallimento congiunto dell’iniziativa privata e del suo governo. Non vi è una globalizzazione buona e una cattiva, ma occorre acquisire politicamente, oltre che teoricamente, il fatto che la globalizzazione è ciò che è, perché è stata pensata per determinare gli esiti che presenta.
Il problema viene dall’incapacità di trarre conclusioni di tipo politico sulla globalizzazione e sul “pensiero unico”.
L’idea che si percepisce, guardando il dibattito sviluppatosi dopo i risultati elettorali (Europa, amministrazioni locali), evoca un sentimento di angoscia e di paura, che non sono stati emotivi fondamentali dell’uomo in generale, bensì riflettono la società del capitale con la crisi permanente quale condizione normale, dove le guerre sono il prodotto principale. Il minaccioso (compreso il terrorismo) non è in nessun luogo, è creato come sfondo d’attesa di qualcosa di negativamente imprecisato, utile perciò a occasionare e fondare la paura da tutte le parti.
Il pericolo non si trova esclusivamente sul terreno materiale della mondializzazione, dove ci sono guardiani istituzionali, cortigiani, aedi, un blocco economico-sociale che ostacola e ostacolerà qualsiasi azione indesiderata; la paura vera viene dal constatare che in ampi settori del centrosinistra si ha un rimosso dell’esperienza fatta finora, come vissuto della globalizzazione, il che costituisce una sostanziale passività al liberismo. A Rutelli (e non solo) vorremmo consigliare la lettura di questa poesia: “E se c’è tanta miseria sulla terra è grazie a te fratello, se siamo affamati, sfiniti, se siamo scorticati a sangue spremuti come l’uva per donare il nostro vino, arriverò al punto di dire che è colpa tua? No. Ma c’entri molto, fratello” (Nazim Hikmet, Il fronte del rifiuto).
Questa rimozione, oltre a condizionare i percorsi politici segnati dalla sottomissione al monopensiero liberista, non tiene minimamente conto che oggi emerge un segno autoritario in nome della competitività e della libertà dell’impresa. Su questo assioma si costruisce la società dell’esclusione che investe non solo il mondo della produzione ma tutto il sociale-storico. Dunque il segno autoritario nella vita quotidiana non parte da una manovra reazionaria in senso classico interna cioè al sistema politico, ma è iscritto nei processi materiali del capitale mondiale.
L’incapacità di una riflessione sulle macerie sociali, ambientali, culturali, economiche prodotte dal neoliberismo, e di metterle in discussione, rende il quadro pericoloso perché da un lato significa accettarlo e perpetuarlo, e, dall’altro evita di considerare come il sistema sia pervaso da una costitutiva pulsione autoritaria.
1) E’ il prodotto della controffensiva ideologica conservatrice, promossa dai poteri economici con la mobilitazione di una rete di migliaia di professionisti ed intellettuali,
2) Il Pil delle attività criminali supera ampiamente i 1.000 miliardi di dollari annui, ossia il 20% del commercio mondiale (Le Monde Diplomatique, aprile 2000). Un miliardo di dollari al giorno vengono riciclati attraverso finanziarie e banche. Lo stesso FMI valuta la massa di denaro sporco tra i 590 e 15000 miliardi di dollari pari dall’1% al 5% del Pil mondiale (cfr. Financial Times 24.9.1999). Alla tolleranza zero per la piccola delinquenza corrisponde la repressione zero contro la grande criminalità finanziaria.
3) M. Raffaelli, Manifesto 28.11.2002.
4) Faenza è la prima città con un piano regolatore ecosostenibile, diventato operativo nel 1998.
Nello “Schema di governo conservatore”, consegnato(1) a Reagan nel 1980, si sosteneva - per assicurare il mantenimento dei privilegi dell’élite economica, disturbata dalle turbolenze della fine degli anni Sessanta e Settanta - un “fascismo amichevole”, ispirandosi alle tesi della “Trilaterale” che parlava della necessità di una “democrazia più moderata” e di un ritorno della popolazione allo stato di apatia e passività ante ’68. La mondializzazione è il processo che rende concreto questo obiettivo.
Dopo la fase di teorizzazione, l’abbandono unilaterale dei cambi fissi nel 1973, e il secondo shock petrolifero del 1979, la tappa decisiva, per la realizzazione di questo progetto, è compiuta negli anni Ottanta con la liberalizzazione del settore finanziario americano, che apre la via alla sua globalizzazione tramite le banche, le società d’intermediazione, i fondi speculativi e i fondi pensione, che dominano i flussi finanziari mondiali. Grazie a ciò il sistema statunitense ha avuto accesso al risparmio di tutto il mondo. In breve l’introduzione di un mercato libero mondiale dei capitali era indispensabile alla salute economica e finanziaria del primo debitore mondiale. Il passivo netto americano nel 2000 era pari a 1, 5 trilioni di dollari, pari al 20% del Pil.
Con la mondializzazione dei mercati, nata e guidata da una serie di decisioni americane, l’impresa mentre rompe i compromessi sociali territoriali, si dà propri strumenti di governo e di controllo, che segnano la natura e i caratteri dello Stato immateriale delle transnazionali. Tale Stato impone la liberalizzazione dei mercati, la distruzione dello stato del benessere, lo scardinamento della legislazione del lavoro, la disoccupazione strutturale di massa, la compressione delle dinamiche salariali. Dovrebbe dunque essere evidente a tutti che il neoliberismo è un programma politico, la mondializzazione una costruzione sociale.
Anche se si annuncia periodicamente da parte delle autorità istituzionali che la mondializzazione porterà il paradiso in terra, dovunque si guardi, la disoccupazione e la precarietà continuano ad essere di massa; il ristagno o il declino economico, la sofferenza sociale, l’incertezza sul futuro, la rovina di intere economie nazionali, la criminalità economica(2), le guerre, sono elementi costitutivi delle politiche iperliberiste ovunque prevalenti, e esibiscono il macroscopico fallimento congiunto dell’iniziativa privata e del suo governo. Non vi è una globalizzazione buona e una cattiva, ma occorre acquisire politicamente, oltre che teoricamente, il fatto che la globalizzazione è ciò che è, perché è stata pensata per determinare gli esiti che presenta.
Il problema viene dall’incapacità di trarre conclusioni di tipo politico sulla globalizzazione e sul “pensiero unico”.
L’idea che si percepisce, guardando il dibattito sviluppatosi dopo i risultati elettorali (Europa, amministrazioni locali), evoca un sentimento di angoscia e di paura, che non sono stati emotivi fondamentali dell’uomo in generale, bensì riflettono la società del capitale con la crisi permanente quale condizione normale, dove le guerre sono il prodotto principale. Il minaccioso (compreso il terrorismo) non è in nessun luogo, è creato come sfondo d’attesa di qualcosa di negativamente imprecisato, utile perciò a occasionare e fondare la paura da tutte le parti.
Il pericolo non si trova esclusivamente sul terreno materiale della mondializzazione, dove ci sono guardiani istituzionali, cortigiani, aedi, un blocco economico-sociale che ostacola e ostacolerà qualsiasi azione indesiderata; la paura vera viene dal constatare che in ampi settori del centrosinistra si ha un rimosso dell’esperienza fatta finora, come vissuto della globalizzazione, il che costituisce una sostanziale passività al liberismo. A Rutelli (e non solo) vorremmo consigliare la lettura di questa poesia: “E se c’è tanta miseria sulla terra è grazie a te fratello, se siamo affamati, sfiniti, se siamo scorticati a sangue spremuti come l’uva per donare il nostro vino, arriverò al punto di dire che è colpa tua? No. Ma c’entri molto, fratello” (Nazim Hikmet, Il fronte del rifiuto).
Questa rimozione, oltre a condizionare i percorsi politici segnati dalla sottomissione al monopensiero liberista, non tiene minimamente conto che oggi emerge un segno autoritario in nome della competitività e della libertà dell’impresa. Su questo assioma si costruisce la società dell’esclusione che investe non solo il mondo della produzione ma tutto il sociale-storico. Dunque il segno autoritario nella vita quotidiana non parte da una manovra reazionaria in senso classico interna cioè al sistema politico, ma è iscritto nei processi materiali del capitale mondiale.
L’incapacità di una riflessione sulle macerie sociali, ambientali, culturali, economiche prodotte dal neoliberismo, e di metterle in discussione, rende il quadro pericoloso perché da un lato significa accettarlo e perpetuarlo, e, dall’altro evita di considerare come il sistema sia pervaso da una costitutiva pulsione autoritaria.
La politica oggi rispecchia un’assenza di vita, poiché nega ogni possibilità di progetto ai giovani e meno giovani, toglie il futuro, costringe ad essere precari nel lavoro ed a vivere in una sorta di eternizzazione del presente propria della globalizzazione. Ma che tipo di società si prospetta se non c’è futuro? Non può essere che una società segnata dalla violenza, dalla instabilità, dalla sofferenza. E non determina un’apertura al vivere tra confini, pendolari tra culture, bensì uno sradicamento permanente che rischia di immobilizzare i giovani come “figli per sempre”: oggi l’adolescenza è una “protesi indossabile ad oltranza”(3). La politica è così segnata dall’assenza, dal non dare parola alla vita quotidiana, ai desideri, ai bisogni. Non so se la politica possa affrontare il tema della felicità, ma so che nelle sue forme egemoni ha a che fare con il dolore. La maggioranza delle sofferenze umane è, infatti, determinata proprio dalle decisioni della politica.
Una delle maggiori cause, se non la principale, della vittoria della destra, è da ricondurre al fatto che le forze politiche del precedente governo di centrosinistra, non hanno saputo, voluto o potuto ricostruire un diverso rapporto tra governati e governanti: coloro che non contavano hanno continuato a non contare, considerati come un pacco in giacenza, in un angolo d’una sperduta stazione. Sono come i neutrini, particelle subatomiche, che interagiscono assai poco con la materia: un neutrino proveniente dallo spazio cosmico ha quasi la certezza di attraversare tutta l’atmosfera e tutta la Terra senza praticamente essere rilevato.
Proprio quando la persona si avverte più come un oppresso che come arricchito da quanto gli sta intorno e la politica lo abbandona, con il Movimento pezzi consistenti della società prendono nelle proprie mani i fili del futuro di tutti/e: un cammino e un progetto per riunificare vita e politica. “Un nuovo mondo è possibile” è l’anti-coro rispetto ai media che riducono la politica a ripetizione amministrativa, a istituzione svuotata.
Il movimento, aggregazione di ciò che sta sorgendo, come il principio-speranza di Block, ha il suo orizzonte in un contenuto intenzionale, è capace di correggere e di precisare in maniera concreta la direzione del sognare, in quanto lavora nel presente, sul presente con l’orizzonte del futuro. Il Movimento parla del senso dell’agire, parla della passione, parla delle relazioni, parla della vita reale. Per questo è una via che può relegare nella preistoria del mondo la storia del sopruso, dello sfruttamento, della violenza, della guerra. E’ vero che la consapevolezza dei guasti prodotti non intacca di per sé le centrali operative dell’ordine mondiale neoliberista, anche se ha inferto importanti sconfitte. Come è vero che confutazioni non sono possibili senza l’ausilio di alternative e che mettere a punto un modello di sviluppo radicalmente diverso da quello oggi vincente delle destre liberiste e pseudo modernizzatici, non si inventa di colpo, ma comunque con il Movimento comincia ad emergere la possibilità di un nuovo mondo da praticare, un’altra società da costruire. Questo non è solo un modo per restaurare una democrazia in crisi, ma pone il problema di organizzare in modo nuovo e collettivamente, nello spazio pubblico, l’esercizio dell’avere, del potere, del sapere, interroga i partiti nella loro organizzazione e cultura politica.
La forma partito
La politica hard-tech, simile al metodo ‘duro’ perseguito da alcune scienze, cerca l’esatto senza avvicinarsi al complesso (la complessità significa possibile biforcazione, cioè comportamento molteplice), cerca di stabilire la quiete, e crede di realizzarla nella prevedibilità costitutiva propria di un sistema deterministico. Al contrario, in un sistema dinamico sappiamo che una piccolissima fluttuazione di un elemento (o di una regola) che avvenga anche in una regione periferica del sistema, può avere ripercussioni enormi su una zona centrale e in tempi molto brevi. L’adattività dei sistemi dinamici permette loro di adeguarsi al proprio contesto, registrare note rilevanti ed includerle fra gli elementi propri, trasformandole in fattori attivi del proprio sviluppo.
Il variabile, il non prevedibile specifico del sistema dinamico rende possibile un’analogia con un sistema di reti. Se il soggetto viene collocato all’incrocio di numerose reti, ogni punto è il vertice di una rete di rapporti, a cui affluiscono nuclei di desideri, di bisogni intertraducibili, ponti tematici tra discipline, tra tematiche, tra bisogni, tra linguaggi. Sui ‘ponti’ passano fasci di vite e dunque il riconoscimento reciproco della consistenza della propria ricerca, anche delle risposte parziali, in divenire. Spostare l’attenzione sulla relazione tra soggetti significa conferire autorevolezza alla rete, ai suoi snodi, anche problematici, agli spazi-tra.
Il Movimento dischiude l’accesso all’area problematica della forma partito poiché un partito che voglia dialogare con esso dovrebbe interrogarsi sulla propria forma e modalità proprio perché interagisce con un sistema dinamico, e, per farlo, non può rimanere nel proprio determinismo, che ha causato e causa rituali, cristallizzazioni nei comportamenti, soffoca dibattiti e svolgimento di conflittualità nella polarità amico-nemico. Per superare questa mancanza di ascolto, dovuta al dominio della verticalità e della gerarchia, il rapporto tra il movimento e i partiti deve essere segnato dalla relazione, pratica politica propria dei femminismi.
La relazione è una modalità che indica un diverso rapportarsi, tra culture, tra soggettività, e tende a definire comunità in termini non egemonici. Posizionandosi all’interno di questo tipo di relazione, nella complessa cartografia della produzione e riproduzione, l’intreccio con gli altri si realizza in uno spazio “TRA”: si diventa così sensibili ai confini, agli spostamenti, ai mutamenti, ai desideri, altrimenti invisibili alle mappe delle appartenenze codificate, senza il rischio di percepire l’appartenenza come un rischio di scomparsa nell’anonimato, come una forma di omologazione qualitativa (Bougleux). La riuscita del “viaggio” nel programma, dipenderà soprattutto da questo tipo di relazione dove le identità multistratificate in formazione mettono in crisi il concetto di gerarchia: tra paesi, popoli, culture, generi, classi, individui.
Essendomi soffermato soprattutto sulla diversa modalità di relazione, e, all’interno del partito, fra partiti e fra movimento e partiti, mi limito ad accennare alla necessità di un programma che non si focalizzi sul come vincere ma sul cosa fare una volta al governo. Se si governa o ci si oppone senza avere un progetto complessivo e un’idea globale di convivenza, si può solo essere ricacciati indietro (Vezio De Lucia, 1993), perché prevarranno le ragioni della politica tradizionale e quindi della conservazione degli interessi in gioco. Le abrogazioni di una serie di leggi, sul mercato del lavoro, sulla scuola, sulla giustizia, sullo stato sociale, sono la precondizione per segnare una discontinuità rispetto alle politiche liberiste e riconquistare lavoro, salari, conoscenza, futuro, diritti. Ne derivano tre cardini: l’aumento dell’occupazione; la redistribuzione dei redditi e dei poteri, senza consentire che lo stesso lavoro sia compensato diversamente nei paesi dell’Europa o all’interno di uno stesso Stato; infine una politica fiscale che cessi di gettare il peso delle entrate dello Stato e degli Enti locali sui soli lavoratori dipendenti. Comunque credo vada ricordato che il “senso” del fare di un governo esiste solo se rinvia ad un progetto politico, ad una concezione della società di cui il programma è solo una particolare e parziale concretizzazione nel tempo.
La questione ambientale e politica locale
Nella necessità di dare “senso” al programma, a fronte del dilagare suicida del “tutto mercato”, le politiche locali non sono marginali, inerti, disancorate dagli obiettivi principali, poiché agire sui servizi, sull’uso del territorio, sui piani regolatori, significa operare sulle “condizioni locali di produzione” (J. O’Connor), e quindi è strategico. Infatti il “locale” spesso è la forma con cui il “globale” si “mette al lavoro”. Sotto i colpi della delocalizzazione e del ridimensionamento produttivo, del ripiegamento delle politiche pubbliche e della corsa alla privatizzazione, molti degli scempi degli ultimi anni sono ascrivibili alla cultura trionfante della “deregulation”, che manifesta i suoi effetti anche sui centri minori, emergendo ovunque modalità di gestione della città ricalcate sul modello dell’impresa. In questo quadro è comprensibile che l’Ente Locale aderisca integralmente agli interessi consolidati, e che i fondi e le risorse a disposizione trovino nella destinazione pro-business la loro sola collocazione. Così le amministrazioni diventano sempre più liberiste sul terreno sociale ma interventiste sul piano dell’economia e dei mercati.
L’operazione più significativa, come critica diretta alle ragioni dell’economia vigente e allo stesso impianto concettuale che vi presiede, può essere la messa in campo di una politica locale che sostituisca al territorio-fabbrica il territorio-società. Come mi pare sia emerso chiaramente nel numero monografico di questa rivista su “Saperi e Territorio” (n. 5, gennaio/aprile 2004), c’è il problema ineludibile di una diversa pianificazione urbanistica, sociale e culturale delle aree urbane, affinché si cominci ad agire sulle cause e non sugli effetti dei vari degradi. La nuova stagione dei diritti deve comprendere il diritto alla città.
Come deve essere pensata la città in questa prospettiva, pur in presenza di diverse linee di frattura che concorrono a determinare la crisi della dimensione urbana? Gli urbanisti territorialisti dello sviluppo locale autosostenibile sono convinti che, per avanzare critiche praticabili e compiute agli scenari di mondializzazione, nel conflitto tra “globale” e “locale”, si deve assumere il locale quale prospettiva strategica per promuovere una nuova sostenibilità ambientale. Su questa linea poniamo la questione della qualità del vivere urbano. Orientarsi strategicamente sulla qualità urbana significa che l’Ente Locale non s’identifichi come semplice accompagnatore degli interessi economici bensì intervenga per rompere la spirale di impoverimento e di esclusione che segna le città. Una politica per la riqualificazione e ristrutturazione urbana contro la periferizzazione sociale e culturale, significa - rivoluzionando le priorità di bilancio - cercare di distribuire sul territorio qualità sociale: anche la città non è una società per azioni. Non vi sarà nuova qualità del vivere se non si esce dalle logiche capitalistico-speculative e se non si accetta l’idea che lo spazio – di per sé risorsa finita come qualsiasi altra risorsa ambientale – debba essere salvaguardato dalle amministrazioni pubbliche. Ma non basta
Al di là delle grandi catastrofi (Chernobyl, Bhopal, Seveso), con i fenomeni macrobiologici, i mutamenti climatici, la crescente desertificazione, la riduzione della fascia di ozono, è la stessa vita quotidiana ad essere soggetta a un progressivo deterioramento, direttamente legato al degrado dell’ecosfera. Questo si configura come un “secondo sfruttamento” dei cittadini, diverso da quello classico, iscritto nel rapporto capitale-lavoro, ma che risale alla medesima causa: la distruzione della natura appartiene alla logica del medesimo sistema economico e sociale. Come abbiamo una natura depredata, spogliata, inquinata così abbiamo uomini e donne depredati, spogliati, inquinati. Il sistema economico capitalistico è distruttivo ecologicamente e socialmente.
All’attuale città che produce rifiuti, inquinamento, dissipazione e sprechi di risorse non rinnovabili, distruzione di ambiente naturale, occorre sostituire una città del riuso, del recupero, del rinnovamento urbano, ossia una città caratterizzata per la quota sempre più bassa di materia ed energia destinata al proprio mantenimento. Al modello aziendalistico dell’Ente Locale che si manifesta concretamente nella pratica della concertazione che esalta gli interessi economici più forti, va contrapposta l’idea della città come organismo vivente biologico ed ecologico. La questione ambientale impone la fine dei consumi di suolo e l’abbandono della concezione riduttiva del verde urbano inteso come occasionale, anonimo e inutile arredo urbano, per passare alle acquisizioni della biologia dei sistemi viventi che indicano come il verde assolva funzioni vitali per la produzione di ossigeno, per assorbire l’inquinamento acustico, per abbattere le polveri, per temperare il micro clima(4).
Il risanamento della città non passa solo operando sul cambiamento dei nostri modi di consumare per produrre meno rifiuti, ma ciò che occorre è un vero e proprio mutamento paradigmatico. Mettere al centro la città a misura di vita, significa tradurre in politica ciò che la cultura urbanistica ed ecologica hanno elaborato, vuol dire la riconversione ecologica della città che investe non solo i modi di vivere e consumare ma anche le modalità dell’edificare e/o ristrutturare gli edifici pubblici e privati secondo i criteri dell’edilizia bio-compatibile (bioarchitettura), tenendo presente come gli elementi della natura siano potenti alleati contro inquinamento atmosferico e acustico e contro lo spreco di energia. Una strategia dunque che va oltre i metri cubi di cemento e dove i valori ambientali come vettori, diffusori di qualità, possono liberare i cittadini e le stesse attività economiche dalla rendita fondiaria che li soffoca. Tutto questo ha nel verde il suo asse primario.
Le ragioni per procedere in questo modo stanno nel ridurre l’impatto sulla biosfera “locale”. La crisi ambientale e la questione climatica, che mette a rischio migliaia di esseri umani, non sono solo una questione estiva che riguarda gli anziani (del resto invisibili per il resto dell’anno) e non risolvibile con le risibili soluzioni dei supermercati e delle caserme dei Vigili del fuoco. Il riscaldamento locale è dovuto all’urbanizzazione intensa e continua. Rinfrescare le città è il problema poiché sulle aree coperte in prevalenza da cemento e asfalto si forma la cosiddetta “isola di calore”, che surriscalda l’aria rispetto alla campagna circostante. Uno studio scientifico (2002) dell’Agenzia federale per l’ambiente Usa, dimostra che piantare 10 milioni di alberi a Los Angeles, permetterebbe di ridurre la temperatura estiva di 4 gradi. Le strategie di riforestazione urbana sono le prime da mettere in atto per produrre brezza termica anche in assenza di vento. Nelle conoscenze dell’ambientalismo scientifico vi sono dunque gli elementi per dei veri e propri piani per la riduzione del caldo in città.
Nell’incertezza del presente ci sono tante ragioni per lottare ancora, vi sono infinite ragioni per volere e cercare un vivere diverso. Al di là delle date anagrafiche, i colori dell’arcobaleno, seppure possano apparire i colori della lontananza, tratteggiano il contenuto di futuro, il non ancora-divenuto ma già presente nella società. Vogliamo vivere in maniera diversa. Vogliamo, pretendiamo che questa vita, che è l’unica che ci è data, sia degna di essere vissuta. E’ richiesta giusta e umana. Ecco, la politica deve diventare umana: ci riusciremo.
1) E’ il prodotto della controffensiva ideologica conservatrice, promossa dai poteri economici con la mobilitazione di una rete di migliaia di professionisti ed intellettuali,
2) Il Pil delle attività criminali supera ampiamente i 1.000 miliardi di dollari annui, ossia il 20% del commercio mondiale (Le Monde Diplomatique, aprile 2000). Un miliardo di dollari al giorno vengono riciclati attraverso finanziarie e banche. Lo stesso FMI valuta la massa di denaro sporco tra i 590 e 15000 miliardi di dollari pari dall’1% al 5% del Pil mondiale (cfr. Financial Times 24.9.1999). Alla tolleranza zero per la piccola delinquenza corrisponde la repressione zero contro la grande criminalità finanziaria.
3) M. Raffaelli, Manifesto 28.11.2002.
4) Faenza è la prima città con un piano regolatore ecosostenibile, diventato operativo nel 1998.
| |
|
settembre - dicembre 2004