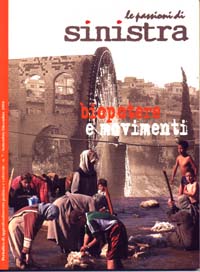Curr,
curr tradtor. Curr, curr latr, svergognet, facc d’carnval
|
Chi potrà
mai essere sicuro di riuscire a dimenticare niente per sempre? La penna
nuova il primo giorno di scuola, i racconti della pescaia, l’orlo
del vestito a giromanica appena sollevato sulle ginocchia bianche della
signora Nellì, la libraia amica di mia madre o la carezza esitante
con la mano sudata del tabaccaio sottocasa, lo sguardo svogliato di
una donna sposata riflesso nel finestrino opaco di un treno diretto
a Venezia, coperto di impronte e di indicibili desideri, i due teli
della tenda della camera da letto di mia madre che si incrociavano smossi
da un filo di vento nei pomeriggi di luglio e agosto mentre un moscone
testardo e chiassoso sbatteva contro le persiane socchiuse. Non riusciremo
a dimenticare le illusioni irrazionali o le gioie solitarie dei primi
anni. Soprattutto non dimenticheremo anche il più insignificante
atto che divenne la causa di un dolore o di una sofferenza che nessuna
forma di cognizione e temperanza potrà con il tempo e la distanza
cancellare.
Come un virus o una malattia silente coveranno in chissà quale
tenebra remota ed impervia, pronti ad affiorare e a riproporre con maggiore
angoscia il medesimo sgomento, nonostante il susseguirsi di ulteriori
vicende.
Avevo previsto
la possibilità che se ne accorgesse naturalmente, ma avere dieci
anni e sentirsi nella testa la pressione dell’idea fissa che avrei
potuto prelevare degli spiccioli dalla cassettina della signora Nellì,
mi assicuravano la forza necessaria per compiere quel gesto che già
io stesso consideravo riprovevole, ma per il quale non provavo alcuna
vergogna. Avrei finalmente potuto comprarmi subito una gabbia e un cardellino
senza ricorrere a mia madre, che si sarebbe opposta perché lei
non voleva nulla del genere in giro per la casa. Non pensavo al castigo
che avrei potuto ricevere nel caso la signora mi avesse scoperto. Ma
se fossi stato attento nessuno se ne sarebbe accorto, se invece fosse
successo, quella signora dai modi gentili, che parlava sempre piano
e sottovoce come se stesse leggendo un libro, che si vestiva, adesso
mi viene in mente, come Virginia Woolf, lei che aveva dimestichezza
solo con la sua solitudine e i libri, con la testa tra un’edizione
Longanesi de I fiori del male e la disperazione per uno strappo
all’ultima pagina di un sillabario di Goffredo Parise, chissà,
in fondo per poche centinaia di lire non ne avrebbe fatto una tragedia,
anzi. Invece soltanto per quattro monete da cento lire quella donna
si trasformò in un mostro indecente.
Apparve sulla soglia del negozio con il vestito ancora rappreso sul
davanti, agitando le braccia come se le avessero rubato tutto l’oro
e l’argento che possedeva. Prima di allora non era mai capitato
di averla sentita parlare in quel modo, pronunciando parole strane,
frammiste a bestemmie e guaiti. Per tutta la corsa non mi girai mai
per guardarla, ma sentivo dietro di me la sua voce rabbiosa. Come le
urla di un animale appena ferito.
- Curr, curr, tradtor. Curr, curr latr, svergognet, facc d’
carnval.
Dietro desiderio, per altro insistente, di mia madre, ero stato preso in qualità di ragazzo dalla signora Nellì che aveva una piccola libreria nella piazzetta dell’Angelo. Mi limitavo a spostare da qui a lì ì pacchi che ci venivano consegnati dagli spedizionieri oppure sbrigavo all’esterno modeste faccende sempre per conto della signora. Ogni tanto con qualche cencio di vecchi strofinacci spolveravo tra le scansie degli scaffali, togliendo e rimettendo al loro posto blocchi di pochi libri alla volta. Consideravo tutto questo una specie di incarico particolarmente impegnativo e di responsabilità, giacché la signora non smetteva mai di dire di stare sempre attento con i libri e di far sì che non ne cadesse mai uno per terra.
- Pensa di avere nelle mani delle tazzine di porcellana.
Era la
frase che mi sentivo dire tutte le volte che prendevo o riponevo un
libro sugli scaffali di legno che ormai avevano perso la lucentezza
e in varie parti recavano vistose spaccature. Il colore del legno si
era abbrunito con il tempo, rendendo ancor di più l’intero
ambiente cupo come certe sacrestie anguste e umide dove si avverte una
specie di sacralità più tangibile degli altari perché,
se l’onnipotenza di Dio è dappertutto, è più
facile che si trovi prima che tra i calici e gli ostensori, tra i libri,
i soldi spiccioli e la felicità di possedere un cardellino.
Mi ero trovato in quel posto perché mia madre e quella rimbambita
della signora Nellì si conoscevano fin dai tempi della loro giovinezza
e visto che mia madre non si sarebbe mai sognata di andare un paio di
ore al giorno al mare nei mesi più caldi dell’estate, come
facevano tutte le donne della sua età, preferiva mandarmi dalla
sua affettuosa amica dell’infanzia per tenermi in mezzo
ai libri. Lei invece trascorreva le sue giornate annodando fili al tombolo
o leggendo qualche libro. In questo modo mi sono mancate molte cose
di quella età, a cominciare dall’amicizia e dai giochi.
Devo dire che in quel negozio traevo anche momenti di svago, ma soprattutto
cominciai ad appassionarmi alle storie inventate e fantastiche scritte
nei libri. Tutte le volte che potevo sfogliavo i libri con le grandi
illustrazioni a colori degli animali o gli atlanti. Mi piacevano soprattutto
gli uccelli e avevo una particolare preferenza per i cardellini e i
canarini. A quella età è difficile intuire la crudeltà
perpetrata ad uno sfortunato essere rinchiuso in una cella di pochi
centimetri. Io provavo un piacere infinito nell’osservare il mio
cardellino andare avanti e indietro, saltando da un dondolo all’altro
della gabbia. Si è indotti a credere che il loro cinguettio sia
un mirabile e melodioso canto quando è più probabile che
sia soltanto il lamento di un’anima impazzita.
Nei giorni di particolare afa, avendo il sole proprio davanti all’ingresso
della libreria, la signora Nellì abbassava sulla vetrina una
tenda di tela colorata a strisce bianche e gialle per fare ombra. In
tal modo si formava un ambiente ancor più rilassato. Se durante
la mattina non era entrato nessun cliente, la signora si distendeva
su una poltroncina addossata ad una scrivania che fungeva da bancone;
così si lasciava andare dolcemente a qualche minuto di assopimento.
Chiudeva gli occhi e con le braccia abbandonate sui braccioli della
poltrona si addormentava.
Teneva le gambe piegate, leggermente divaricate. Nel momento di sedersi,
per il caldo, innalzava appena un po’ più sopra delle ginocchia
l’orlo del vestito, così che quel gesto naturale e il pallore
delle sue membra la rendevano per me molto attraente e desiderabile.
Ogni tanto apriva gli occhi, si guardava intorno e constatato, seppure
nel dormiveglia, che tutto era al suo posto, riprendeva il respiro del
dormiente. In quei momenti, con circospezione, temendo sempre che potesse
svegliarsi all’improvviso, mi piaceva avvicinarmi e guardarla.
Mi abbassavo davanti alle ginocchia per vedere se da sotto il vestito
sollevato trapelasse qualcosa. Ma con molta delusione constatavo che
vi era soltanto il buio. Tornavo al mio abituale posto, riprendevo il
libro che avevo lasciato aperto sullo sgabello oppure continuavo a pulire
tra gli scaffali.
Quella
mattina di fine luglio, erano già passate le undici, ebbi la
sensazione che il suo sonno fosse un po’ più profondo delle
altre volte. Nella piazzetta non passava nessuno. Mi avvicinai a lei
e non ebbi nessun dubbio che fosse proprio addormentata. Quasi in punta
di piedi, andai dietro la scrivania, affondai le dita nel cassetto rimasto
come al solito semiaperto, così non feci nessun rumore, e presi
quattro monete da cento lire. Non pensavo a ciò che stavo commettendo.
Ero soltanto felice di possedere la somma intera per comprare quello
che desideravo. Ritornai al mio sgabello, mi sedetti perché volevo
che al suo risveglio mi trovasse al mio posto con un libro tra le mani.
Il tutto avvenne in pochi attimi. Con la mano sudata cercai di infilare
le monete nella tasca dei pantaloni, ma in quel frangente una mi sfuggì
dalle dita, cadde, rotolò un paio di volte su se stessa, poi,
come guidata dal demonio, si riaddrizzò e prese la corsa dirigendosi
proprio verso i piedi della signora Nellì.
Il rumore del metallo caduto in terra e successivamente l’urto
della moneta provocarono il suo risveglio. Aprì gli occhi, si
guardò prima ai piedi, poi – intuendo che cosa era potuto
accadere – si risolse a me che cercavo ormai disperato di infilare
le altre monete nella tasca.
- Svergognato, che cosai hai fatto? Hai rubato i miei soldi? I soldi
dei miei libri, hai rubato i miei soldi.
Si alzò e cominciò a urlare, inveendo con inaudita crudeltà
verso di me.Con un balzo fui fuori dalla libreria. Mi misi a correre
come un pazzo e nonostante mi allontanassi sempre di più da quella
zona, sentivo chiaramente la voce della signora Nellì e le sue
imprecazioni. Ladro, svergognato, peccatore, ma non capivo perché
faccia di carnevale.
Era stata mia madre una volta, associando le parole ad un dolce sorriso, a dirmi che quella macchia dal colore di ciliegia, grande proprio quanto una moneta da cento lire, e collocata sulla guancia sinistra come lo sbuffo di un batuffolo di cipria, era il desiderio di quel frutto saporito durante la gravidanza. Naturalmente non potemmo che ridere tutti e due per questo racconto. Le disse che io però consideravo quel segno una distinzione, una goccia di colore che indicava la mia inclinazione all’armonia e alla bellezza. All’arte ed in particolare alla melodia. In ogni caso non avrei mai pensato che potesse trasformarsi in uno scherno ingiurioso che mi avrebbe perseguitato anche dopo quell’episodio con la signora Nellì.
Il tempo,
le stagioni, i luoghi, le persone, gli incontri, gli abbandoni, gli
affetti, i tradimenti, il giorno e la luna, la trasgressione e l’ovvio,
l’ignoto e l’apparenza, l’oltraggio e il desiderio, le
parole e il silenzio, la musica e il caos, non passano invano. Se hanno
causato paure e risentimenti, non si trasformeranno in quiete, invece
se sono stati occasione di momenti di incanto non vi è in nessuna
parte certezza che così rimarranno fino alla fine.
Lo spavento e l’ansia, la fuga, l’abbandono, la melodia e
il desiderio, da allora per me corrono sempre insieme a una moneta da
cento lire che sfugge di mano, intraprende un percorso imprevedibile
e poi s’arresta con ogni probabilità dove il male ha già
aperto gli occhi e schernisce l’innocenza.
Non credo di averlo fatto per nascondere la macchia sul volto, ma al
Conservatorio tutti mi conoscevano con il volto adornato da una barba
bianca e fitta come quella di Brahms. Beatrice non mi ha mai visto in
faccia senza barba, così quando un giorno ha cominciato con le
mani ad accarezzarmi mettendo le dita tra la barba, ha scoperto la macchia
color ciliegia e ha gridato con allegria e la sua consueta esuberanza:
Ei, faccia di carnevale. Senza barba sembreresti una maschera.
Rideva, rideva, rideva incapace ormai di dire soltanto un’altra
parola.
Ho sentito aumentare la pressione del sangue e le mani hanno cominciato
a sudare. La risata di Beatrice si stava trasformando in guaiti, il
suo aspetto si stava deformando. Davanti a me c’era ora una pazza
che urlava. Anch’io non riuscivo a parlare. Non avevo la forza
di fermarle le mani con le quali cercava di scoprire la macchia tra
i lunghi peli della barba, si stringeva al mio collo, poi si allontanava,
sbatteva i pugni sul cuscino. Che cosa mi stava capitando?
Mi sono alzato dal letto e sono fuggito. Correndo. Da allora non ho
più rivisto Beatrice.
Ci sono delle volte che mi chiedo invece che cosa abbia pensato di me mia madre negli ultimi giorni di quell’estate, vedendomi passare tutto il tempo a guardare il cardellino chiuso nella sua gabbia di fili di ferro zincato. Così come del resto faccio anche adesso.
| |
|
settembre - dicembre 2004