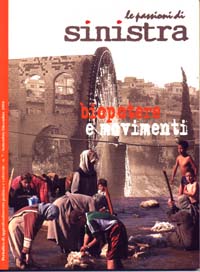“Che
cos'è la verità?”
|
In
diverse occasioni è capitato di sottolineare che alle guerre
ed alle spese per armamenti si può porre fine soltanto facendo
venir meno il flusso di risorse finanziarie e, quindi, di ricchezza,
che, attraverso i sistemi bancari e le altre istituzioni finanziarie,
pervengono dal mondo intero agli apparati affaristico-militari e soprattutto
a quello controllato dalle multinazionali statunitensi.
Come noto, infatti, il complesso militare e quello spionistico –
o di intelligence, come si preferisce denominarlo - degli USA sono di
gran lunga i più potenti e costosi del mondo a livelli, da decenni
non paragonabili a quelli degli altri paesi, ormai perfino se considerati
nel loro complesso.
In pratica, non solo le risorse di uomini d’affari e finanzieri,
ma anche quelle di umili risparmiatori, lavoratori e pensionati, per
lo più inconsapevoli, vengono distolti dall’acquisto e dalla
produzione di beni e servizi atti al soddisfacimento dei bisogni quotidiani,
per essere impiegate nella fabbricazione e nel traffico di armamenti
e, più in generale, nel mantenimento e nella espansione dei complessi
affaristico-militare-spionistici.
L’azione dei pacifisti e di quanti si oppongono alla globalizzazione
degli affari da parte delle multinazionali può essere quindi
realmente efficace solo se indirizzata al sabotaggio del debito pubblico,
in particolare di quello statunitense, e delle emissioni azionarie ed
obbligazionarie delle imprese di armamenti.
Non esiste un altro mezzo efficace e non è presuntuoso o velleitario
affermarlo.
Non è, a rigore, neanche una affermazione semplicisticamente
classificabile come di sinistra o, men che mai, di destra, perché
tanto lineare ed ovvia da rasentare la banalità.
Se affermazioni di questo genere appaiono temerarie o estremistiche
o ingenue o faziose o utopistiche e, quindi, non rigorose né
“scientifiche”, ciò accade per il fatto che esse sono
assai rare ed isolate nel dibattito politico ed economico corrente.
Da ciò, l’opinione pubblica trae l’erronea convinzione
che si tratti di opinioni e posizioni, magari un po’ balzane, di
una qualche esigua minoranza.
Questa convinzione è del resto rafforzata dal fatto che l’azione
presentata come l’unica efficace e risolutiva non venga presa in
seria considerazione né proposta o anche solo richiamata dai
tanti che hanno assunto il ruolo di guida delle opposizioni e di critica
e denuncia del potere politico, militare, affaristico e finanziario
dominante nell’età contemporanea.
Un tale comportamento appare inquietante, dal momento che semmai si
arriverà ad una situazione di pace stabile, questo potrà
accadere solo se ai fabbricanti e trafficanti di armamenti verranno
meno le risorse per continuare la loro attività, dato che –
sembra di poter capire – è proprio con le armi che si fanno
le guerre.
Non è da escludersi che i guru dell’opposizione possano
talvolta essere interessati all’esercizio della loro abilità
dialettica e quindi alla valorizzazione della propria produzione intellettuale
ed alla demolizione delle tesi di avversari e concorrenti, più
che alla soluzione dei problemi.
Per altro verso, l’opinione dei non addetti ai lavori è
negativamente e pesantemente condizionata dalla scarsa familiarità,
diffidenza ed avversione non solo verso gli argomenti e gli strumenti
dell’economia e della finanza, ma anche nei confronti delle discipline
economiche in generale.
Del resto, queste ultime, anche o soprattutto presso le classi colte,
spesso vengono considerate né carne né pesce e collocate
in una specie di limbo, in quanto ritenute prive delle caratteristiche
distintive sia delle discipline umanistiche che delle scienze esatte.
Non ci sarebbe da meravigliarsi, pertanto, se da una qualche indagine
di opinioni, dovesse risultare che la gente comune, colta o incolta,
sia oscuramente convinta che in materia economica e finanziaria tutte
le opinioni possano ritenersi legittime e che, conseguentemente, le
scelte di schieramento siano più che altro da ascrivere a motivi
di telegenicità di un qualche personaggio particolarmente abile
a simulare e dissimulare passioni davanti alle telecamere.
Per lo più i non addetti ai lavori non immaginano neanche lontanamente
che anche per le discipline economiche, come per le altre scienze esiste
un corpus di nozioni e proposizioni su cui c’è concordanza
pressoché generale nella comunità degli economisti.
Nell’ambito di tale comunità, soprattutto la scuola istuzionalista
si è dedicata ad analizzare la genesi, la struttura ed il funzionamento
delle istituzioni economiche, monetarie e finanziarie ed i comportamenti
ed i moventi degli uomini d’affari e delle imprese.
Questa scuola di pensiero, la cui fondazione viene fatta risalire alla
pubblicazione nel 1924 dell’opera The trend of economics
di Rexford Tugwell, ha come riconosciuto precursore il grande sociologo
ed economista Thorstein Veblen e come esponenti di rilievo, fra gli
altri, John Galbraith, Oliver Williamson, Ronald Coase, Douglass North,
James Buchanan, Friedrich von Hayek.
Non si può legittimamente affermare di conoscere il pensiero
economico del Novecento se non si conoscono i risultati del lavoro di
ricerca di questi studiosi, come degli esponenti di altre correnti teoriche,
che pure hanno contribuito ad elaborare quel complesso di teoremi e
proposizioni in cui la generalità degli economisti si riconosce.
In particolare, l’opera degli economisti istituzionalisti, sia
di destra che di sinistra, ha smontato molti dei miti del pensiero economico
tradizionale, dimostrando fra l’altro come la prassi degli affari
ed il profitto siano in contrasto e si reggano proprio sulla violazione
delle regole della sovranità del mercato, della libera concorrenza
e dell’iniziativa privata, di cui pure gli imprenditori si dichiarano
i portabandiera.
A puro titolo di esempio, si riportano alcune citazioni da un’opera
di Ronald Coase, premio Nobel 1991 per l’economia, risalente agli
anni trenta ed entrata stabilmente nel corredo teorico di ogni economista
degno di questo nome, che evidenziano il contrasto fra la natura e la
logica operativa dell’impresa e le regole del mercato e del meccanismo
dei prezzi:
“l’impresa è una istituzione centralizzata e retta
da principi gerarchici alternativi al mercato cui si ricorre quando
i costi di transazione diventano troppo alti”;
“… il funzionamento di un mercato ha un costo …, creando
un’organizzazione e permettendo a una certa autorità (un
“imprenditore”) di allocare le risorse, vengono risparmiati
i costi del mercato.”
“Queste, dunque, sono le ragioni per cui organizzazioni come le
imprese esistono in un’economia di scambio in cui viene generalmente
ipotizzato che la distribuzione delle risorse è “organizzata”
dal meccanismo dei prezzi. Un’impresa, quindi, è costituita
da un sistema di relazioni che nascono quando la destinazione delle
risorse dipende da un imprenditore.”
Per lo più, per ovvie ragioni, la gente comune e i non addetti
ai lavori non conoscono i risultati della evoluzione delle discipline
economiche del Novecento, così come in genere non conoscono i
progressi dell’astronomia e dell’astrofisica contemporanee.
E tuttavia, politici, politologi e mass media per lo più non
rinunciano ad influenzare ed indirizzare le idee della pubblica opinione,
con affermazioni, punti di vista e schemi teorici che hanno la stessa
validità ed attualità, mutatis mutandis, della teoria
geocentrica o delle convinzioni aristoteliche sulla forma della Terra.
Ma la mancanza di conoscenza e di interesse e talora il disprezzo per
le discipline economiche sono tali da non consentire in molti casi neanche
di padroneggiarne i fondamenti e rudimenti più elementari.
Per dirne una, gli stessi lavoratori e pensionati che sono vittime di
quelle particolari rapine di stato, che in Italia vanno sotto il nome
di riforme previdenziali, così come politici, politologi, sindacalisti
e mass media che pretendono di rappresentarne gli interessi ed esprimerne
le posizioni, hanno per lo più dimostrato di non conoscere veramente
la natura ed il funzionamento di un sistema previdenziale.
In particolare - si parla ovviamente di quanti fra loro siano in buonafede
– essi non sono stati in grado di capire e spiegare, in occasione
dell’ultima cosiddetta riforma, che le pensioni non fanno parte
della spesa pubblica, ma sono un semplice giro contabile del valore
attualizzato dei contributi versati dagli assicurati e dai loro datori
di lavoro.
Quando si è cercato di spiegare come e perché rapportare
le pensioni al totale della spesa pubblica o al prodotto interno lordo
sia un puro e semplice raggiro, si è andati a cozzare contro
il più solido dei muri di incredulità e scetticismo.
La solidità di quel muro si comprende, se si considera che la
rapina e l’inganno in materia di previdenza sono stato storicamente
praticati ed avallati, in tempi diversi, da tutte le forze politiche
e sociali, e che nessuna di esse vuole precludersi la possibilità
di ripetere lo stesso genere di “giochetto”, magari anche
in tempi ragionevolmente ravvicinati.
L’ipotesi della buona fede non può reggere, evidentemente,
nei confronti degli economisti, almeno non per quelli preparati e competenti.
Va invece tenuto in debito conto che per gli economisti, come fra i
politici, i politologi, gli storici ed i cultori di altre cosiddette
scienze umane, per lo più non vale la regola di dire sempre ciò
che si pensa essere vero, ma soltanto ciò che si ritiene opportuno
o utile o in linea con i fini e gli interessi della propria fazione
o del proprio datore di lavoro.
Accade, perciò, che, nei convegni e dibattiti, davanti al pubblico
o, ancor più, davanti alle telecamere, gli economisti siano reticenti
su argomenti sgradevoli e forzino le proprie convinzioni ed acquisizioni
teoriche, fino a sostenere tesi destinate magari ad essere totalmente
rinnegate al buffet o mentre ci si sciacqua le mani nel bagno.
In simili occasioni è capitato di sentire in camera caritatis
direttori generali e presidenti di banche affermare del tutto spontaneamente,
senza essere stati in alcun modo provocati, il carattere intrinsecamente
fraudolento delle istituzioni bancarie e finanziarie dell’era moderna
e contemporanea.
Non si tratta del resto di punti di vista campati in aria ma ricavati
da questa gente direttamente dalla propria prassi quotidiana, oltretutto
in linea con quanti, come Marc Bloch, hanno rilevato come le caratteristiche
distintive del sistema capitalistico moderno possano qualificarlo come
“un regime che morirebbe in caso di una verifica simultanea di
tutti i conti”.
Del resto, il numero e le dimensioni dei recenti scandali finanziari
sembrano confermare in pieno l’esattezza della definizione.
Per ciò che concerne specificamente la fabbricazione ed il traffico
di armamenti e, a maggior ragione, le guerre, gli economisti, purché
sani di mente e competenti, sanno bene che tali attività distruggono,
non producono ricchezza.
Essi sono altrettanto consapevoli che gli affari ed i profitti si possono
fare sia producendo che distruggendo ricchezza.
Le risorse che vengono girate alle multinazionali delle armi dai governi,
finanziandosi con il debito pubblico, costituiscono nello stesso tempo
lo strumento ed il bottino della distruzione di ricchezza.
Questo malloppo viene pagato tramite la emissione di titoli del debito
pubblico, che devono essere collocati sui mercati finanziari, ossia
venduti a qualcuno, che in cambio di quella carta creata dal nulla dia
denaro sonante.
L’entità di queste emissioni può essere ovviamente
tale da richiedere un massiccio ricorso ai mercati finanziari esteri
e, quindi, anche al denaro appartenente a risparmiatori, lavoratori
e pensionati di altri paesi.
Questo, nel caso degli Stati Uniti, ha comportato una notevole svalutazione
del dollaro, in particolare nei confronti dell’euro; rispetto a
questa moneta, infatti, il dollaro ha perso un terzo del suo valore,
dal momento che attualmente con un euro si acquistano circa 120 centesimi
di dollaro, mentre prima della ultima formidabile escalation delle spese
militari se ne acquistavano circa 90.
Gli economisti sanno benissimo che le cose sono andate in questo modo
e non altrimenti.
Eppure, è tutt’altro che infrequente sentir affermare da
molti di loro che la svalutazione è frutto delle manovre monetarie
della Federal Reserve statunitense e delle alchimie del presunto mago
Greenspan, che in tal modo avrebbe inteso favorire le esportazioni e
scoraggiare le importazioni negli USA.
Si tratta di una bugia dalle gambe cortissime.
Nessuno sa meglio di quegli stessi economisti che la bilancia commerciale
statunitense mai o rarissimamente ha raggiunto deficit così elevati
come nell’ultimo periodo, corrispondente e successivo alla recente
svalutazione del dollaro.
Un economista serio e competente sa bene che economia ed affari sono
cose assai diverse.
Sa anche perfettamente che il prodotto interno lordo (PIL) di una nazione
è un indicatore del volume d’affari non della ricchezza.
Vale la pena di ribadire che nel conteggio del PIL rientra tutto ciò
che viene fatturato, sia per la produzione che per la distruzione di
ricchezza.
È appena il caso di rammentare che si fatturano anche colpi di
stato, omicidi, stragi, brogli elettorali, corruzioni ed altre attività
illecite e criminali, ovviamente contabilizzate in voci di spesa per
evidenti ragioni necessariamente assai vaghe.
Per le ragioni esposte, nulla vieta che, proprio mentre la nazione sta
andando a rotoli, il volume degli affari e quello dei profitti siano
particolarmente elevati.
Già nel 1776 nella Ricchezza delle Nazioni, Adam Smith ammoniva
che “la quota del profitto non aumenta con la prosperità
né diminuisce col declino della società” e che, “al
contrario, è per natura bassa nei paesi ricchi e alta in quelli
poveri, ed è sempre massima nei paesi che vanno più in
fretta verso la rovina”.
Si può credere, pur con qualche difficoltà, che una parte
consistente o anche maggioritaria degli economisti contemporanei pensi
in buona fede che il padre fondatore si sbagliasse o, almeno, esagerasse
nell’esprimere quelle convinzioni.
Ciò che, invece, non è assolutamente credibile è
che essi non abbiano dubbi o riserve mentali quando celebrano i risultati
e le prospettive dell’economia americana.
Bisogna dire, al riguardo, che anche il più scalcinato degli
economisti o un qualunque ragioniere sa che la ricchezza è data
da ciò che si possiede meno i debiti, non da ciò che si
è prodotto in una unità di tempo, che – si vorrà
dare atto – solo per un arbitrio ritenuto necessario a fini contabili
e statistici viene convenzionalmente rapportata ad un anno.
Inoltre, anche la variazione di ricchezza relativa ad una unità
di tempo non è data dal prodotto o dal fatturato, ma dalla differenza
fra ricavi e costi, ossia, in altri termini, fra ciò che si è
prodotto e ciò che si è distrutto.
E, come noto, nulla assicura che tale differenza debba essere necessariamente
positiva, cosicché la ricchezza può sia aumentare che
diminuire nell’unità di tempo.
Nel caso degli Stati Uniti, contestualmente alla colossale distruzione
di ricchezza connessa alla escalation della spesa per armamenti e per
le guerre, oltre che per il mantenimento e l’espansione dell’apparato
militare e del pletorico e costosissimo complesso spionistico, il debito
pubblico ha registrato negli anni dell’amministrazione Bush un
altrettanto deciso incremento.
Oltre a ciò, si deve considerare che debito privato, deficit
pubblici e disavanzi della bilancia commerciale hanno pure raggiunto
livelli inquietanti.
Non si può che restare sconcertati nel constatare quanto pochi
siano gli economisti che hanno il coraggio di affermare la più
semplice delle verità, che essi conoscono benissimo, ossia che
l’economia statunitense è in pieno sfacelo e che il principale
responsabile di tale catastrofe è la politica imperiale del suo
complesso affaristico-militare.
Questo apparato, per sua stessa natura, è il nemico più
potente, implacabile e mortale di tutti i popoli della terra e dello
stesso popolo statunitense.
Suo scopo non è in alcun modo la tutela del benessere, della
ricchezza, della democrazia e della sicurezza di quel popolo ma l’arricchimento
personale, familiare ed amicale dei propri esponenti – non a caso
il professor Krugman lo definisce “crony capitalism” ossia
capitalismo dei compari – senza alcuna vera preoccupazione per
l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle stesse
imprese controllate, che, infatti, ben spesso vengono depredate e fatte
fallire.
Valutazioni del tipo appena esposto possono apparire eccessive o estremistiche
o faziose.
A maggior ragione, perciò, vale la pena di considerarle seriamente
e di metterle alla prova.
A tale scopo, si può provare ad adottare coerentemente quel principio
plurimillenario che esorta a considerare gli atti anziché le
parole o, meglio, gli effetti pratici più che quelli teorici
delle idee e dei principi strumentalmente sbandierati e non solo nel
campo dell’economia e della finanza.
| |
|
settembre - dicembre 2004