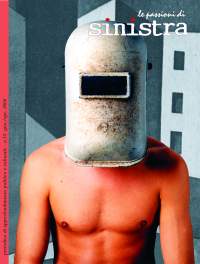Differenze, precarietà, femminilizzazione del lavoro. L’emergere di nuova soggettività |
Il concetto di differenza - o meglio di differenze - ha, più di quanto possa sembrare a prima vista, molto a che vedere con la produzione di nuova soggettività nel presente, poiché ha a che vedere con i paradigmi produttivi attuali.
Facciamo un breve passo indietro e partiamo dal termine “precarietà”. Esso può avere due tipi di significati, solo apparentemente in contraddizione perché in realtà concorrono entrambi alla formazione del senso comune di questo concetto. Da un lato, evoca immagini come instabiltà, labilità, fragilità, termine, rischio, bilico, dall'altro, accenna a un'idea di trasformazione, rimessa in discussione, di possibilità, di “divenire”, di futuro.
Entrambi questi campi semantici e concettuali sembrano suggerire l'esistenza di un soggetto nomade, rizomatico, in perenne modificazione, perennemente diverso da se stesso, l'esistenza, cioè, di un nuovo “meticciato”: non casualmente, la precarietà è infatti una categoria che attraversa, che è trasversale a tutte le professioni, a tutti i mestieri, a tutte le condizioni, a tutti gli status. Il soggetto precario è un soggetto che non ha punti fermi, ed è perciò obbligato a tracciare continui percorsi di senso e a costruire infinite narrazioni, mai in modo aprioristico. Quando pure parliamo del profilarsi di un'“identità precaria” - nel senso di un “comune sentire”, di un “sentimento” condiviso dai molti - dobbiamo avere ben chiaro che non si tratta più, in nessun modo, di quell'identità unica e omologante - per bisogni e rivendicazioni - a cui ci ha abituato il passato fordista, ma viceversa parliamo di un soggetto resistente all'assimilazione e all'omologazione, così come a modalità dominanti di rappresentazione di sé, da cui deriva infine una sorta di irrappresentabilità del soggetto precario. E' un soggetto che non può prestarsi a un unico modello normativo e a un'unica narrazione, è un soggetto che non ha una sola appartenenza, ma ha una moltitudine di appartenenze.
Per cercare di delineare i contorni della nuova soggettività nel lavoro/nella vita con la quale ci obbliga a confrontarci il sistema di accumulazione flessibile, dobbiamo partire dunque con il negare una sostanza stabile alla soggettività. Si intende, con questo, che va rivisitato non solo il concetto di “classe” - unica, omogenea - ma anche quello di “genere” se esso viene interpretato come un'essenza, una conformità, un unicum. Il soggetto in questione non ha un'essenza perché è la ribellione contro ogni essenza, contro la nozione stessa di essenza. Penso quindi a una soggettività nonostante il soggetto, nella scia del “divenire molteplice” di Deleuze. Si tratta di un soggetto che è “molti”, che è diverso da se stesso. Sia chiaro: è comunque un soggetto che diviene io a contatto con il tu. E in questo senso si può parlare però di un “prendere corpo biopolitico della moltitudine”, di una versione riveduta e corretta della ri-composizione di classe.
Torniamo allora laddove eravamo partiti: le differenze naturalmente implicite in questi soggetti sfaccettati, nomadici e irriducibili a uno diventano oggi fattore produttivo. Al centro dei nuovi processi produttivi c'è infatti l'irriducibile singolarità del percorso di lavoro o non lavoro di ognuno di noi. Differenze e singolarità diventano oggetto del paradigma produttivo nel presente. Dal punto di vista strettamente formale - vale a dire contrattuale - il sistema attuale trae il massimo beneficio dall'esistenza di una moltitudine di figure, frammentate sul territorio, che non hanno punti di contatto tra loro, per le quali la caratteristica più saliente è costituita dal darsi del proprio status come unico e che infatti viene costruito sulla base della contrattazione individuale. Dal punto di vista di contenuto quello che effettivamente interessa al capitalismo informazionale è l'estrazione dell'essenza dell'individuo, singolarmente intesa, come portato di processi unici che sono il risultato di un'accumulazione di esperienze, culture, competenze, abilità, sensibilità proprie del singolo individuo.
Dicendo questo non si vuol certo negare che il paradigma produttivo attuale punti alla standardizzazione delle conoscenze che, a questo scopo, rende sempre più codificabili e oggettivabili, per ridurle, cioè, a qualche cosa di immediatamente trasmissibile. Questa tendenza mira a trasformare la conoscenza in un fattore alienabile, perfettamente separabile dai suoi produttori (si veda l'università, ma anche l'informazione, la cultura in senso lato). Si vuole segnalare però, di converso, che si assiste all'assimilazione, dentro il processo produttivo, di connotati emozionali ed esperienziali singolari che fanno le differenze tra individui, che sono un portato imprescindibile delle singolarità. Intendo con ciò quello che intende Gorz nel suo ultimo libro L'immateriale- Conoscenza valore e capitale. Il lavoro immateriale nel presente si basa innanzitutto “sul sapere come esistenza storica, su capacità espressive, cooperative che non si possono insegnare, su una vivacità della messa in opera dei saperi che fa parte della cultura quotidiana, sulla capacità di reazione e di improvvisazione. Un sapere cioè che non può essere interamente insegnato né ridotto a una conoscenza formalizzabile”.
La produzione di tali atti necessari all'economia informazionale, ci dice Gorz, implica necessariamente una parte di produzione e di dono di sé, conserva il marchio della persona che lo esercita perché non può - per quanto sforzo venga e verrà prodotto in questo senso - prescindere dai soggetti, dalle singolarità e dalla loro differenza.
Da tutto questo discorso possiamo trarre due considerazioni principali. La prima: più la differenza diventa un portato imprescindibile dei nuovi modelli produttivi e di controllo sociale, più essa perde dirompenza, significato e valore simbolico. Oggi la differenza è funzionale all'accumulazione capitalistica e perde tendenzialmente il proprio valore antagonistico primigenio in quanto si punta a trasformarla in elemento interno ai processi di valorizzazione capitalistica. Questo processo spiega, tra l'altro, la creazione di nuove gerarchie tra donne e, per esempio, una certa tendenza alla complicità e all'omologazione del genere femminile all'interno dei processi di produzione contemporanei. In questo senso l'elemento nomadico e il richiamo all'alterità interno al concetto stesso di differenza ci può aiutare, purché si sia consapevoli di questo crinale scivoloso: la differenza smette di essere tale quando dimentica il suo elemento dinamico costitutivo. Se si vuole la salvaguardia perenne dell'Altrove è necessaria la riproposizione in divenire del meccanismo incoercibile dell'eccedenza di cui è intrinsecamente portatatrice.
La seconda: se la forza del capitale informazionale contemporaneo che è quella di piegare le essenze esperienziali individuali dentro i bisogni della produzione, proprio questa capacità può trasformarsi nel suo limite. Nel senso che il tentativo del capitale contemporaneo di operare l'intera reificazione dell'individuo dentro i processi produttivi mostra, sin dalle premesse, una falla poiché non può prevedere in tutto e per tutto la sua standardizzazione. Come abbiamo detto - il sapere delle individualità non è infatti del tutto trasmettibile fuori dal circuito dell'esperienza. In questo preciso punto può prendere corpo un'eccedenza che diventa il soggetto stesso di nuove strategie di sottrazione e di liberazione.
Il processo di femminilizzazione del lavoro
Ricapitolando, si può ritenere che 1) il soggetto precario sia nomade - vale dire esso tende a sottrarsi a tutte le omologazioni possibili, quelle che vengono previste, di norma, per un ipotetico soggetto unico (l'operaio, il maschio, l'uomo occidentale...); 2) il paradigma produttivo attuale non possa prescindere dalla messa a valore dei portati esperienziali delle singolarità. Si vogliono ri-sottolineare entrambi gli elementi perché essi spiegano il motivo per cui, oggi, ci si trovi di fronte a quello che va sotto il nome di “processo di femminilizzazione” del lavoro cioè a dire di “lavoro che si femminilizza”.
Le capacità relazionali e i saperi cooperativi ed emozionali non codificati, e trasmissibili solo attraverso pratica, per via esperienziale, sono infatti elementi particolarmente marcati nel vissuto delle donne, per via culturale.
Non basta: le donne da sempre sono state costrette a operare decostruzioni, vale a dire spostamenti, disidentificazioni, sovversioni del dispositivo sociale vigente e a provare ad agire una interrogazione critica sul senso delle identità assegnate socialmente. Esse stesse sono nomadi.
A questi aspetti fondamentali si aggiunge, e non va dimenticato, il carattere oblativo del lavoro femminile. La donna è, da sempre, all'interno del contesto lavorativo e non solo, il paradigma perfetto del soggetto sociale dominato funzionale all'entrata e all'uscita nel mercato del lavoro secondo le esigenze produttive e sociali del momento. Condensa inoltre, in un unico corpo, la possibilità di avere un ruolo produttivo e riproduttivo insieme, presenta cioè il vantaggio di costituire un immenso risparmio di costi per il capitale a scapito, solamente, dello sfruttamento intensivo di se stessa. Se esiste insomma una modalità storica che riassume la capacità di sfruttamento totale della persona da parte del capitalismo, ebbene questa è incarnata dal genere femminile. Si è trattato e si tratta di un'appropriazione indiscriminata di fatica, di tempo, di possesso del corpo, della stessa conoscenza dei soggetti interessati. La modalità dello sfruttamento della forza lavoro delle donne ha inoltre in sé forti aspetti di non valore sociale, di flessibilità infinita, di non visibilità e un'adattività del proprio tempo estrema.
Per tutti questi motivi, ritengo di poter sostenere che la figura del precario sociale oggi è donna, meglio ancora se migrante. Lungi dal costituire una possibile forma di liberazione dal modello, comunque opprimente, del lavoro fordista, la flessibilità attuale si configura essenzialmente come una produzione permanente di fragilità e instabilità (lavorativa e psicologica), in condizioni di frammentazione sul territorio e di un'ampissima pluralità e variabilità delle condizioni di lavoro che rendono difficile ogni aspetto ricompositivo. Il modello d'organizzazione del lavoro attuale, precario, adattivo, integrato con piccoli lavori di servizio, lavoro saltuario, lavoro nomade, fatto di prestazioni a domicilio, si presenta cioè, nei suoi tratti salienti, di contenuto, come modalità storica del lavoro femminile. E contemporaneamente proprio la realtà eccedente di questa condizione di sfruttamento complessivo/intensivo dell'esistente, può assurgere a metafora delle nuove forme di oppressione, sussunzione, violenza cui pare condannata gran parte dell'umanità ovunque, indipendentemente dal genere. Capire il significato della femminilizzazione del lavoro vuole dire illuminare l'aspetto del lavoro incessante (in termini di tempo e in termini di coinvolgimento emotivo), del lavoro nomade (mobilità, globalizzazione) e del lavoro domesticato (chiuso tra le pareti domestiche, frammentato, invisibilizzato), ovvero il perché le donne rappresentino un modello imprescindibile per gli obiettivi del capitalismo attuale, come viene riconosciuto anche da Donna Haraway.
Ruoli assegnati
In questo quadro, è interessante guardare nel concreto ad alcuni aspetti prototipici, “di contenuto”, del lavoro femminile contemporaneo. La figura della lavoratrice del sesso e quella della badante hanno tra loro più elementi di contatto di quanto possa sembrare a un primo sguardo distratto. Alcune inchieste agite in ambito di movimento in Spagna dalle Precarias à la deriva, hanno mostrato - utilizzando una griglia di indicatori non consueti per la normale ricerca sociologica e/o antropologica ma tanto più efficaci - come la capacità di ascolto, di dono di sé, il carattere oblativo del lavoro, la messa in gioco di elementi emozionali e corporei siano aspetti ambivalenti, pertinenti a entrambe le categorie. La sottolineatura di questo legame trasversale tra badanti e sexworkers ci parla, in fondo, proprio di una differenza al lavoro che si radica in elementi immateriali, esperienziali, non immediatamente codificabili e trasmettibili, che sembrano costituire il nuovo oggetto della sussunzione e della reificazione imposte dal capitale contemporaneo.
Entrambi questi lavori attengono oggi, in modo ampio, al settore della cura. Il lavoro di riproduzione sociale fino a ieri parte dei doppi, tripli ruoli femminili non retributi, oggi viene, sempre più frequentemente, appaltato all'esterno della famiglia, ad altre donne, per molte concause. Prima fra le altre, la domanda di manodopera femminile per impieghi produttivi - in crescita costante, negli ultimi decenni, in Europa Occidentale - cui fa da interfaccia, come si diceva, l'obbligo alla migrazione a cui vengono sottoposte milioni di altre donne, provenienti da altri Paesi del mondo, dal Sudamerica al Nord Africa, dall'Asia all'Est Europeo, dietro la spinta delle guerre, dei conflitti e dell'impoverimento delle risorse connesso alle politiche imperiali. Il capitale guarda oggi al settore della cura come a un nuovo terreno di profitto, all'interno di una strategia di diversificazione ed espansione di un mercato saturo su altri fronti e in presenza di una forte crescita della domanda di questo genere di servizi. Si va dalla riproduzione biologica vera e propria - uteri e materiale biologico in affitto e/o in vendita -, al sesso, all'ascolto, all'accudimento di bambini, anziani, abitazioni.
Un settore paradigmatico non solo per quegli aspetti immateriali, esperienziali, singolari, affettivi, che mette a valore ma anche perché oggi impiega quasi interamente donne migranti. Si può leggere l'intero processo ricordando il principio dei vasi comunicanti: le donne europee vengono istradate nell'ambito dei lavori di produzione dell'economia informazionale contemporanea, dove verranno richieste di usare quelle capacità individuali, relazionali, che sono frutto di cultura ed esperienza non immediatamente trasmissibile, dovranno applicare al lavoro esterno la dilatazione del tempo che erano abituate a destinare ai figli e alla riproduzione, dovranno fare esperienza dell'ufficio nomade o della domestication dell'ufficio. Dall'altro lato, le donne migranti adempiranno ai ruoli riproduttivi e di cura che le sorelle occidentali non possono più svolgere. Il calo demografico della popolazione autoctona europea si spiega anch'esso come uno degli effetti di questa compensazione, di questo perverso circuito indotto. Si snodano così, sotto i nostri occhi, silenziose e fondamentali per la sopravvivenza, quelle che vengono definite, ormai da più parti, “le catene mondiali dell'affetto”.
A guisa di conclusione
Un elemento che sembra chiarito anche all'interno delle inchieste che, in questi anni, sono state portate avanti sulle soggettività emergenti è che “precarietà” non è sinonimo di “flessibilità”. La precarietà incarna, in divenire, una promessa interessante di trasformazione e di futuro ma noi, oggi, stiamo facendo le spese con i suoi aspetti devastanti di individualizzazione del rapporto di lavoro, di frantumazione di ogni ambito collettivo di resistenza, di ansia, di angoscia, di incapacità/impossibilità a proiettarsi in un domani. Vite precarie nel senso dato da Judith Butler, dunque. In senso complessivo, dunque, nel lavoro, nella politica, negli affetti. Vite precarie, per ora, soprattutto nel senso di fragile nudità, non certo di potenza.
Aggiungo una seconda riflessione, su questo aspetto. Ho avuto modo di vedere una ricerca pubblicata sul numero di marzo di Feminist economist, una rivista Usa d'ambito accademico radical, Orari flessibili, potere e salari, la quale dimostra, dati alla mano, che negli Stati Uniti, nell'ambito del lavoro, indipendentemente dalle richieste, gli unici che godono di veri orari flessibili sono i maschi banchi e con posizioni di potere. In fondo, non è una vera scoperta: chi detiene le leve del comando ha, da sempre, goduto di queste libertà. Ma va sottolineato che questa analisi conferma che mentre la domanda di maggiore flessibilità da parte delle donne (e degli uomini) da decenni aumenta esponenzialmente, il capitale si è attrezzato e ha tradotto tale richiesta - che in epoca fordista finiva per tradursi, vistosamente, in un aumento dell'assenteismo - nell'attuale precarietà che lungi dal liberare tempo, ci ha incatenato di più.
Infine, per tornare alle donne. Esse hanno storicamente ottemperato alle necessità dell'ambito della produzione come di quello della riproduzione, in un unico corpo. Oggi, letteralmente, incarnano la caduta delle barriere tra i due ambiti e interpretano, con ciò, magistralmente, la richiesta dei processi estensivi dello sfruttamento che non pongono più confini all'appropriazione di ogni sfera della vita.
Ci dobbiamo applicare a ragionare dunque su un nodo: mentre il lavoro di riproduzione diventa oggetto di valorizzazione da parte del capitale non ne abbiamo mai fatto un vero obiettivo delle nostre battaglie. Tra i grandi beni comuni dell'umanità il principale è la capacità di generazione biologica, eppure viene sempre dimenticato.
E' necessaria una nuova rivisitazione/rivalutazione del ruolo della riproduzione sociale. Il lavoro gratuito e invisibile delle donne è storicamente indispensabile al funzionamento dell'economia. Il lavoro di riproduzione delle donne, ma anche i beni “gratuiti” della natura, formano la base invisibile dell'economia, di cui ci si appropria e che si sfrutta per contribuire all'accumulazione dei profitti. Un parallelo è così stabilito tra lo sfruttamento della natura, del lavoro di riproduzione delle donne, il processo storico dello sfruttamento coloniale. Un nuovo argomento si aggiunge, tra altri possibili, alle ragioni deontologiche in difesa del reddito di esistenza.
gennaio 2006