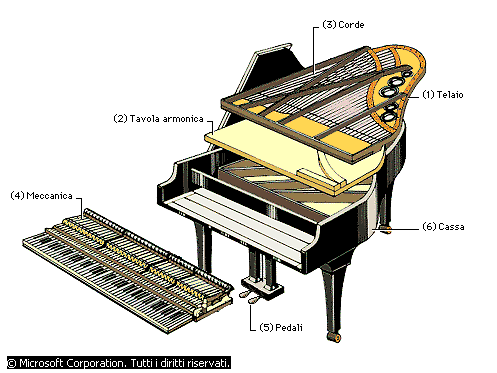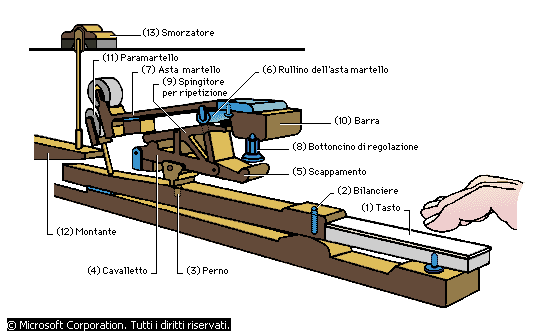Struttura articolo
PREMESSA
PRIMO
PERIODO DI EVOLUZIONE DEL PIANOFORTE
STRUTTURA
MODERNA
MECCANICA
DELL'AZIONE
PIANISTI
FAMOSI
PREMESSA
Strumento cordofono a tastiera, derivato dal clavicembalo e dal
clavicordo; il principio dei martelletti che percuotono le corde e vengono
azionati dalla tastiera sembrerebbe provenire dal dulcimer. Lo strumento
differisce dai suoi predecessori proprio a causa della presenza di martelletti
che, percuotendo la corda con maggiore o minore intensità a seconda della forza
impressa dalle dita ai tasti, permettono di dar vita a un sensibile effetto di
"piano" e "forte". Per questa ragione il primo modello di
cui si abbia notizia (1709), costruito dal fiorentino Bartolomeo Cristofori,
ritenuto appunto l'inventore del pianoforte, fu detto "gravicembalo col
pian e forte". Oggi sono conosciuti solamente due suoi strumenti: il primo,
datato 1720, è conservato presso il Metropolitan Museum di New York; mentre
l'altro, risalente al 1726, si trova presso il museo di Lipsia, in Germania.
PRIMO
PERIODO DI EVOLUZIONE DEL PIANOFORTE
Il momento più importante nello
sviluppo dello strumento si ebbe in Germania nel 1725, quando Gottfried
Silbermann di Friburgo, fabbricante di organi, adottò il sistema meccanico
inventato da Cristofori. Forse il contributo più rilevante fu dato da Johann
Andreas Stein di Augusta, che perfezionò il sistema di scappamento favorendo lo
sviluppo degli strumenti della scuola viennese amati da Mozart e preferiti da
numerosi compositori tedeschi della fine del XVIII e degli inizi del XIX secolo.
Intorno al 1760 diversi costruttori si trasferirono dalla Germania a Londra
dando inizio alla scuola inglese che, con John Broadwood e altri, si dedicò al
potenziamento dello strumento. Il francese Sébastien Erard fondò invece la
scuola del suo paese nell'ultimo decennio del Settecento, e nel 1823 creò il
doppio scappamento, in uso ancora oggi. A partire da questi anni, costruttori di
tutte le nazioni europee si impegnarono per perfezionare il pianoforte. Gli
strumenti costruiti in passato e quelli oggi provenienti dalla Germania e dagli
Stati Uniti sono considerati generalmente fra i migliori esemplari. Vanno
ricordati in particolare i pianoforti creati da Karl Bechstein e dai suoi
discendenti, e dagli statunitensi Steinway e Chickering. Sono degni di nota
anche i pianoforti austriaci Bösendorfer.L'estensione dei primi pianoforti era,
come nei clavicembali, di quattro o al massimo cinque ottave. L'ambito fu poi
gradualmente esteso, fino a raggiungere più di sette ottave. Venne inoltre
potenziata la struttura dello strumento, affinché questo potesse sopportare
l'accresciuta tensione delle corde. Uno strumento di Bösendorfer possiede una
ulteriore estensione nel registro grave, raggiungendo così un ambito di otto
ottave.
STRUTTURA
MODERNA
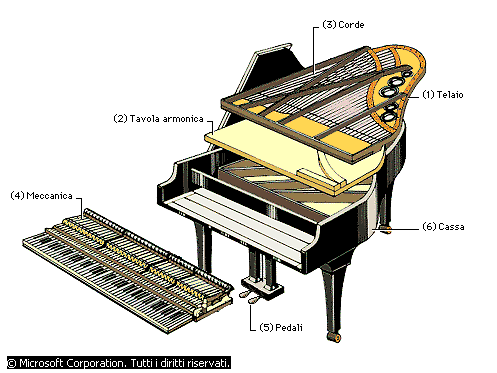
Il pianoforte moderno è composto
da sei parti fondamentali (nella descrizione che segue i numeri si riferiscono
ai relativi numeri fra parentesi presenti nel diagramma della struttura di un
pianoforte). 1) Il telaio è solitamente in ferro. Nella parte posteriore è
sistemato il raccoglitore delle corde, mentre al principio è posta la cordiera,
dove sono sistemate le caviglie, attorno alle quali vengono fissate le corde per
essere poi intonate. 2) La tavola armonica, una sottile tavola di legno che si
trova sotto le corde, rinforza il suono vibrando al momento dell'emissione delle
note. 3) Le corde, in lega d'acciaio, variano in diametro e in lunghezza dal
registro acuto a quello grave. Alle note più acute sono assegnate due o tre
corde intonate all'unisono. Le corde più gravi sono singole e rese più pesanti
da un sottile rivestimento di rame. 4) La meccanica è l'insieme delle parti che
permettono ai martelletti di colpire le corde (vedi oltre, il funzionamento
della meccanica). La parte più in vista della meccanica è la tastiera, sulla
quale l'esecutore agisce direttamente con le dita. I tasti bianchi, che
corrispondono alle note naturali, sono ricoperti d'avorio o di plastica, mentre
quelli corrispondenti alle note alterate, neri, sono d'ebano o anch'essi di
plastica. 5) I pedali sono leve manovrate dai piedi. Il pedale di risonanza, o
"del forte", solleva tutti gli smorzatori, lasciando vibrare
liberamente le corde percosse anche dopo la ricaduta del tasto. Il pedale
"del piano", o sordina, avvicina i martelletti, oppure sposta la
meccanica a destra o a sinistra, in modo che il martello colpisca una sola delle
corde corrispondenti al tasto premuto; in entrambi i casi il risultato è una
riduzione dell'intensità sonora. Alcuni pianoforti possiedono un terzo pedale,
posto al centro, che sostiene solo le note che vengono suonate in un determinato
momento. L'uso dei pedali contribuisce a variare con sfumature la qualità del
timbro dello strumento. La maggior parte dei pianoforti verticali possiede un
pedale che, se premuto, interpone una striscia di feltro fra le corde e i
martelletti, ottenendo in questo modo un suono attutito. 6) I pianoforti, in
base alla loro forma, possono essere a coda, verticali o rettangolari. Quest'ultimo
modello è caduto in disuso da tempo, soppiantato dal pianoforte verticale. I
pianoforti a coda sono costruiti in diverse misure e vanno dal gran coda da
concerto, lungo fino a 290 cm, al quarto di coda o piccola coda, che raggiunge i
150 cm. Nel pianoforte
verticale le corde sono tese appunto verticalmente o in diagonale dall'alto al
basso dello strumento. Nei pianoforti verticali e nei piccoli a coda, le corde
sono generalmente sovrapposte: le corde del registro grave incrociano infatti
diagonalmente quelle alte, in modo da distribuire uniformemente la tensione e da
occupare meno spazio. La tensione delle corde in un pianoforte a gran coda può
raggiungere le trenta tonnellate; in un pianoforte verticale circa quattordici.
MECCANICA
DELL'AZIONE
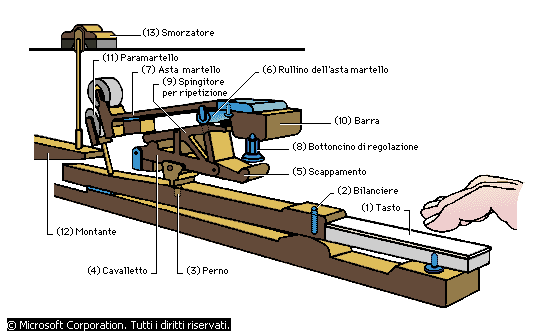
La caratteristica fondamentale che
distingue il pianoforte dagli altri strumenti a tastiera è che il martelletto,
una volta colpita la corda, ricade indietro, grazie al meccanismo dello
scappamento, anche se il tasto che lo ha lanciato non torna in posizione di
riposo; inoltre, quando il tasto viene premuto, un blocchetto di legno rivestito
di feltro (smorzatore) si solleva, ricadendo quando il tasto viene lasciato
dall'esecutore e andando così a soffocare la vibrazione della corda. Lo schema
che segue mostra più dettagliatamente questo movimento. I numeri fra parentesi
si riferiscono a quelli del diagramma relativo alla meccanica di un pianoforte a
gran coda.Il tasto (1) del pianoforte è una leva imperniata su un bilanciere
(2). Quando si preme il tasto, la parte posteriore, o coda, si solleva e il
perno (3) mette in movimento il cavalletto (4), che è incernierato.
L'estremità libera del cavalletto si alza, portando con sé un elemento a L, lo
scappamento (5) e lo spingitore per ripetizione (9). Lo scappamento aziona il
rullino (6) di feltro fissato all'asta del martello (7); così il martelletto si
solleva. Il movimento verso l'alto dello scappamento si arresta quando
l'estremità sporgente di questo tocca il bottoncino di regolazione (8). Il
martello prosegue la sua corsa staccandosi dallo scappamento e colpisce le
corde. Anche lo spingitore (9) si solleva e resta sollevato finché il tasto non
viene rilasciato.
Il martello ricade, ma non
completamente: viene arrestato dal rullino dell'asta del martello (6) che
colpisce lo spingitore (9) sollevato. Lo scappamento (5) può così tornare in
posizione di riposo sotto l'asta del martello parzialmente sollevato.
Contemporaneamente, il paramartello (11) impedisce che il martello rimbalzi
contro le corde.Se il tasto viene parzialmente rilasciato, il martello si muove
libero dal paramartello e lo spingitore per ripetizione rimane sollevato. Se si
preme nuovamente il tasto parzialmente rilasciato, lo scappamento (5) può
spingere di nuovo il rullino (6) e l'asta del martello (7) verso l'alto. Questo
sistema permette la rapida ripetizione di una nota senza che il tasto e il
martello debbano ritornare nella posizione originaria.
Intanto, la coda del tasto ha
sollevato anche il montante (12) che stacca lo smorzatore (13) dalle corde
corrispondenti al tasto. Quando il tasto viene rilasciato, anche parzialmente,
lo smorzatore ricade sulle corde e ne blocca la vibrazione.Quando il tasto è
del tutto libero, tutte le parti del meccanismo ritornano alla loro posizione
originaria a causa della gravità. Contrariamente a ciò che avviene nei
pianoforti a coda, nei pianoforti verticali non tutte le parti del meccanismo
possono tornare a riposo sfruttando la gravità, poiché la meccanica è
disposta verticalmente e non orizzontalmente. Per questo motivo nella meccanica
dei verticali sono previste piccole strisce di stoffa che riportano nella
posizione originaria alcune parti del meccanismo.
PIANISTI
FAMOSI
Il pianoforte è stato da sempre
uno strumento per virtuosi. Fra i compositori che suonavano i loro brani su
questo strumento nel corso del XVIII e XIX secolo possiamo annoverare Mozart,
Beethoven, Chopin e Liszt. La pianista tedesca Clara Schumann si dedicò
principalmente alle composizioni del marito, Robert Schumann. La fine del XIX
secolo fu dominata dalla figura di Anton Rubinstein, compositore ed esecutore
russo, e agli esordi del XX secolo numerosi virtuosi dettero vita a tournée in
Europa e negli Stati Uniti. Fra questi musicisti possiamo ricordare il polacco
Ignace Paderewski e i polacchi naturalizzati statunitensi Josef Hoffmann e
Arthur Rubinstein. Nel periodo fra le due guerre, i pianisti più noti furono
Sergej Rachmaninov, l'austro-statunitense Artur Schnabel, l'inglese Myra Hess, i
tedeschi Walter Gieseking e Wilhelm Backhaus, e il brasiliano Guiomar Novaes.
Dopo il secondo conflitto mondiale, si ricordano i russi Emil Gilels, Sviatoslav
Richter e Shura Cerkassky, che ritornarono a esibirsi nei paesi occidentali e
negli Stati Uniti. Altri celebri virtuosi furono il cileno Claudio Arrau, che
possedeva un repertorio piuttosto ricco, Rudolf Serkin, musicista e insegnante
di origine ceca, e il virtuoso russo-statunitense Vladimir Horowitz. Si
ricordano inoltre l'austro-inglese Alfred Brendel, il cui approccio da studioso
ha sollevato diverse controversie di ordine estetico; il canadese Glenn Gould,
le cui registrazioni di Bach hanno avuto un grandissimo successo; il pianista di
origine russa Vladimir Akenazy; gli italiani Arturo Benedetti
Michelangeli e Maurizio Pollini, il rumeno Radu Lupu e l'argentina Marta
Argerich. Infine, tra i numerosi pianisti jazz si vogliono qui menzionare Keith
Jarrett e Michel Petrucciani. Negli ultimi decenni, molti concorsi
internazionali fungono da trampolino di lancio per giovani e promettenti
artisti.