Racconti
di
Umberto
Di Stilo
Fra' Benedetto
(Click
su [n°]
per andare automaticamente alle note e poi su
Torna al testo
per riprendere la lettura dal punto di partenza)
Quando Angela Godano si accorse di aspettare il
quinto figlio, non ebbe il coraggio di comunicano al marito.
Per alcuni giorni si chiuse in un completo mutismo e, lei
che solitamente aveva modi garbati e gentili con tutti,
divenne scorbutica ed irascibile. Le dava improvvisamente
fastidio anche il rumore del Metramo che, sonnacchioso e
lento, scorreva in prossimità della sua abitazione e che,
in altre circostanze, le era sembrato la dolce nenia di un
eterno innamorato.
Il suo pensiero era fisso al figlio che doveva
nascere ed al modo come rendere partecipe il marito di
quella nuova maternità.
Sapeva che il suo Filippo, uomo fondamentalmente
buono e la cui educazione aveva profonde radici cristiane,
non avrebbe fatto drammi alla notizia che la famiglia
stava per aumentare e che, anzi, avrebbe atteso il frutto
del loro amore come un vero dono di Dio.
Era innegabile, però, che un’altra bocca a
cui badare avrebbe accentuato la già precaria situazione
economica della famiglia.
Quelli, infatti, erano anni difficili per tutti
i galatresi giacché il lavoro era abbastanza scarso e le carestie si succedevano l’una all’altra.
A
peggiorare la situazione, inoltre, erano intervenute
inique disposizioni del Feudatario il quale, noncurante
della crisi economica generale, aveva aumentato il focatico
e varie altre gabelle, sicché quei pochi ducati che
costituivano il modesto reddito familiare, non erano
sufficienti neppure a pagare i vari tributi feudali.
Mastro Filippo Manicà, conciapelle per
tradizione familiare, alla vigilia delle sue nozze con
Angela, figlia unica del defunto Jacopo Godano, aveva
ricevuto in dote dal padre una piccola conceria nella quale
le pelli fresche ed appena scorticate dalle capre e dalle
mucche, attraverso un primitivo ma efficace sistema di
trattamento a base di calce viva e di foglie e bacche di
mortella ben essiccate, venivano trasformate in cuoio.
I due figli maggiori, Giacomo - di appena dieci anni - e Andrea, - di sette - aiutavano il genitore nella
conduzione artigianale di quella piccola conceria. Non che
i bambini potessero e sapessero fare molto, riuscivano, però,
a rendersi utili svolgendo tutti quei piccoli lavori per i
quali non era richiesta né grande esperienza, né molta
abilità.
E, cosa assai più importante, cominciavano ad avviarsi, così, a quel tipo di lavoro che avrebbero poi
svolto nella vita, visto che, per antica tradizione,
tranne rarissime eccezioni, i figli continuavano sempre il
lavoro dei padri.
Per questo di generazione in generazione
l’arte della concia fu sempre molto diffusa a Galatro ed
il commercio delle pelli conobbe periodi abbastanza
fiorenti, tanto è vero che, quando mastro Filippo aveva
all’incirca l’età del suo figliolo primogenito e già
lavorava nel calcinaio paterno, il Principe Massimiliano
II
per poter aprire una vera e propria scuola di conceria nella
sua Praga, trasferì in quella città una nutrita colonia di
artigiani galatresi da tutti ritenuti i più esperti in
quell’arte.
Adesso i tempi erano cambiati ed anche se gli artigiani galatresi continuavano a primeggiare in quel
mestiere
antico e particolare, mancavano le richieste di merce
finita, non c’era più la commercializzazione delle pelli
e le concerie lavoravano a singhiozzo.
Da qui scaturivano le preoccupazioni economiche
della moglie di mastro Filippo che la nascita di un altro
figlio faceva accentuare.
Aveva da poco superato i trent’anni ma
nonostante le quattro maternità, Angela Godano era ancora
fresca come una diciottenne.
Sul volto conservava il roseo verginale messo
ben in evidenza dal nero degli occhi e dai corvini capelli
pettinati a corona e
raccolti sulla nuca.
Come tutte le donne della sua condizione
sociale, vestiva gonna ampia, ricca di sottilissime pieghe,
e aderenti corpini i quali, nonostante i vari rattoppi
avessero, spesso, alterato le misure originarie, le
modellavano, facendolo
risaltare in modo assai evidente, un seno dalle forme ancora
perfette.
Quella donna, fresca e bella, orgoglio di
mastro Filippo che lavorava come un dannato dall’alba al
tramonto per cercare di non farle mancare nulla, suscitava
invidia nelle giovani dell’intero quartiere le quali,
quando la incontravano al fiume impegnata a fare il bucato,
piegata davanti ad una delle numerose grosse pietre che,
qua e là, emergevano dall’acqua, non mancavano di
guardarla
con occhi particolarmente curiosi, quasi volessero scoprire
il segreto di tanta genuina bellezza.
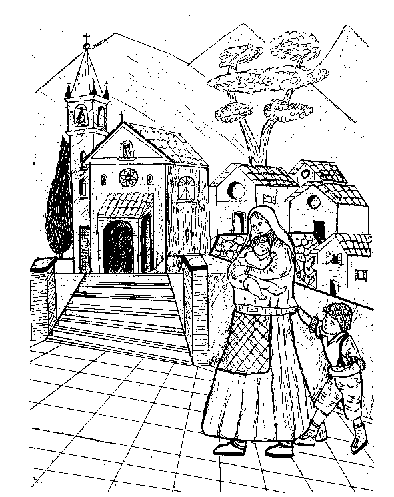
Una mattina Angela si fece coraggio e, dopo
aver riassettato alla buona la sua modesta casetta, con
Maria Itria, la figlia di quasi tre anni, in braccio e
Nicola, il terzogenito di appena cinque anni, come sempre
aggrappato alla gonna, si diresse verso la vicina chiesa
di Santa Maria della Valle.
Sentiva che aveva bisogno di aiuto. Doveva assolutamente chiedere consiglio al suo padre spirituale,
l’anziano cappuccino fra' Ottavio da Castelvetere.
Percorse le stradine del quartiere in preda ad
un’ansia indicibile.
Dalle casette che, appiccicate l’una contro
l’altra e realizzate in fila, quasi per vicendevole
protezione, delimitavano le viuzze tutte cosparse di
pozzanghere, ogni tanto uscivano bambini coperti soltanto da
miseri stracci e, non di rado, anche animali domestici.
Qua e là gruppi di galline razzolavano libere
lungo la stradina affossando il becco nel fondo tufaceo reso
morbido dalle recenti piogge, alla ricerca di vermiciattoli
o, più semplicemente, dei rari avanzi di cibo che la sera
precedente da qualche famiglia erano stati buttati fuori.
Dopo aver percorso alcune stradine che incrociandosi fra di loro davano origine ad un vero e
proprio dedalo, Angela giunse in una piazzetta angusta,
dal fondo acciottolato e, in alcune zone, anche tappezzato
da fitti ciuffi d’erba.
Su un intero lato della piazza si affacciava la
grande chiesa il cui basso porticato, nelle giornate di
pioggia, rappresentava il posto ideale per il riparo dei
cittadini.
Costruita solo da alcuni decenni, Santa Maria
della Valle aveva la struttura di una basilica.
In alto, al centro della facciata, poco sopra
il grande rosone realizzato con alcune diecine di colonnine
di marmo, in una nicchia era stata sistemata in modo ben
visibile una statua benedicente della Madonna.
La facciata, opera di maestranze specializzate appositamente fatte arrivare dalla vicina Messina, era
stata costruita in granito e mattoni, provenienti - questi
ultimi - dalle fornaci di contrada Ceramidìo, con
moltissimi elementi decorativi in marmo bianco.
Accanto, alta e snella, svettava la torre
campanaria con in cima tre grossi bronzi.
La giovane mamma, in preda a mille pensieri, varcò l’ampio portale granitico e, dopo aver spinto la
pesante e massiccia porta realizzata con spesse tavole di
noce e ricca di artistici altorilievi riproducenti scene
della passione di Gesù, appena dentro, istintivamente,
immerse
la punta delle dita della mano destra nell’acqua benedetta
dell’acquasantiera a forma di conchiglia fissata su una
colonna, e si segnò in fretta.
Era già stata
ultimata la serie delle messe, che quotidianamente
venivano celebrate davanti ai vari altari dislocati nelle
tre navate del tempio o nelle varie cappelle padronali, e la
chiesa appariva deserta.
Inoltre, essendo la giornata quanto mai
nuvolosa, l’interno del tempio era in totale penombra.
Attraverso i vetri policromi degli ampi finestroni, infatti,
il sole penetrava soltanto nei giorni luminosi
dell’estate, stagione ancora molto lontana.
Sui vari altari le tremule fiammelle delle
poche candele rimaste accese creavano aloni di quella
fioca luce che è caratteristica delle chiese.
Davanti all’altare maggiore, un trittico
marmoreo di raffinata bellezza ove, in mezzo a quelle di
San
Giovanni Battista e di
San Giovanni
Evangelista, era posta
la statua della Madonna della
Valle, pendevano accese anche
le due lampade votive ad olio alla fornitura del quale,
per antica tradizione, dovevano provvedere gli abitanti
del quartiere.
Il tempio, dopo i canti e le laudi che qualche
ora prima erano stati innalzati al Creatore, era piombato
nel più assoluto silenzio. Un silenzio che invitava al
raccoglimento.
Un anziano sacerdote era inginocchiato innanzi
all’altare del Santissimo.
Non fu necessario che la donna lo chiamasse. Il piccolo Nicola, infatti, correndo da una parte all’altra
della chiesa aveva rotto quell’atmosfera di profonda pace
attirando la sua attenzione.
- Padre Ottavio, devo parlarvi. - Disse Angela Godano, stringendo la figlioletta al petto, quando gli fu
vicina. E poi: - Consigliatemi, Vi prego... -
- Vieni, figliola, apri il tuo cuore a Dio.
Dimmi: cos’è che ti turba? - Chiese il cappuccino con
voce suadente e serena.
- Padre, aspetto il quinto figlio e coi tempi
tristi che stiamo vivendo ed il pochissimo lavoro che c’è,
non so se comunicare la cosa a mio marito con sconforto
oppure se conviene dirglielo con la gioia che comporta la
nascita
di un altro figlio...
- Certo che questo quinto figlio non lo vorrei
proprio... Siamo già in troppi!... -
- Sia Benedetto il frutto del tuo seno... -
Recitò il padre cappuccino con voce decisa e chiara, quasi
per interrompere quel dissennato discorso che stava per
fargli
Angela. Poi aggiunse: - Va’, torna a casa, figliola, e
stasera, quando il tuo sposo rientra dal lavoro, accoglilo
con un sorriso sulle labbra e digli che nella vostra
famiglia
il Padre Celeste ha voluto aggiungere ancora un frutto del
vostro amore. Va’, figliola, e ricordati che per ogni
figlio che nasce la Provvidenza è sempre più concretamente
vicina. Va' - concluse fra’ Ottavio - e che tuo figlio sia
Benedetto! -
Adesso ad Angela sembrava di percepire un lontano
ma melodioso coro d'angeli. Dalle canne dell’organo,
infatti, quasi come per miracolo, il delicato motivo di un
canto gregoriano si spandeva per tutta la chiesa
contribuendo
a rendere più sereno l’animo della giovane madre che,
tenendo i figli per mano, assai distesa, lasciava il
tempio per tornare a casa.
I mesi della gravidanza passarono in fretta.
Ai multicolori e delicati fiori della primavera
fecero seguito gli abbondanti e saporiti frutti
dell’estate e, poi, anche quelli dell’autunno.
In quest’ultimo periodo le donne del
quartiere Santa Maria aiutavano di buon grado Angela nelle
fatiche domestiche.
Giunse anche il freddo dicembre e man mano che
si avvicinava il giorno del parto la giovane donna era
sempre più al centro delle attenzioni delle sue vicine di
casa. Queste, infatti, sapendo che Angela da qualche anno
aveva perduto la madre e che in tutta la sua parentela non
c’era una sola donna che potesse starle vicino per
aiutarla in quei momenti di trepidante attesa, face vano a
gara, nell’ammirevole intento di potersi rendere utili ed
evitarle tutti i lavori pesanti che, quasi quotidianamente,
doveva affrontare nell’ambito della famiglia.
Sicché c’era chi provvedeva al bucato e chi,
a turno, non si sottraeva all'incombenza di andare al
mulino a macinare il grano per poi procedere alla
panificazione della farina ottenuta.
Mastro Filippo, da parte sua, trascorreva in
casa quasi l’intera giornata, seduto accanto al focolare
in compagnia dei figli e della moglie per la quale aveva
mille
premure ed alla quale si sostituiva volentieri anche
nell’assistenza dei cibi in cottura.
D’altra parte, in quel periodo, le continue
piogge gli impedivano di lavorare nel calcinaio giacché
essendo esso all’aperto, come la maggior parte di quelli
esistenti alla periferia del paese, lungo la riva sinistra
del Metramo, era impossibile procedere alla calcinazione
delle pelli.
Nella chiesa di Santa Maria della Valle ed in
quella parrocchiale di San Nicola, - così come in tutte le
altre chiese del villaggio - già da alcuni giorni erano
stati celebrati i sacri riti del Natale allorché in un
pomeriggio in cui la furia degli elementi sembrava volesse
lasciare, ancora una volta, il suo segno sulle povere
abitazioni del paese, Angela informò il marito che il
momento era giunto.
Mastro Filippo con scuse assai banali accompagnò
in casa di vicini i suoi quattro figli e, subito dopo, chiamò
quelle due donne che da tempo si erano dichiarate disposte
a prestare l’aiuto e l’assistenza necessaria alla
partoriente.
Il vento fischiava tra gli olivi che maestosi
si ergevano sulla bianca collina di Orbellico e piegava i
rami spogli dei gelsi che numerosi e fitti crescevano
negli orti lungo il letto del Metramo e del Fermano
torrenti che, avendo aumentato a vista d’occhio la loro
portata d’acqua, costituivano una seria minaccia per tutti.
A tratti, inoltre, al vento si univano violenti
rovesci di pioggia che facevano peggiorare la già precaria
situazione dei fiumiciattoli che, più o meno
pericolosamente, scorrevano tutti nei pressi dei vari
quartieri in cui era diviso Galatro.
In quel pomeriggio di fine dicembre, Angela,
nel mettere al mondo la sua quinta creatura - nonostante il
trambusto creato da comare Ortensia e da comare Serafina,
le due vicine di casa che erano andate ad assisterla e ad
aiutare Donna Ofelia, l’ostetrica del paese - riusciva a
percepire nettamente il rumore cupo dell’acqua del Metramo
che veloce, e più minaccioso che mai, fluiva verso il mare.
Ed aveva paura.
Non tanto per sé, quanto per il figlio che,
sempre più prepotentemente, sentiva nascere dalle sue
visceri.
- Gesù mio - pensava tra un dolore e l’altro
del travaglio - aiutami a mettere al mondo questa creatura
e preservala da ogni male. -
Il rombo assordante di un tuono impedì a
mastro Filippo che, trepidante, nella stanza accanto a
quella della moglie, provvedeva a mantenere vivo il fuoco su
cui bolliva un pentolone d’acqua, di percepire il primo
vagito, subito sfociato in pianto, della sua creatura a
cui la madre, ricordando le parole che circa nove mesi prima
aveva pronunciate l’anziano fra’ Ottavio, volle che le
venisse imposto il nome di Benedetto.
* * *
Per i componenti la famiglia Manicà non era cosa insolita, dopo
il tramonto, dover andare a trovare Benedetto che lungo le
viuzze del rione si attardava a giocare insieme con un ben
assortito gruppo di suoi coetanei o, cosa assai più
probabile, andarlo a chiamare nella chiesa del convento ove,
spesso, si recava ad assistere alle sacre funzioni dei
vespri per poi intrattenersi ad ascoltare l’anziano Padre
cappuccino che, insieme ad altri frati, nell’angusta ma
ordinata sacrestia raccontava ai piccoli fedeli le parabole
di Gesù e vari episodi del vecchio e del nuovo testamento.
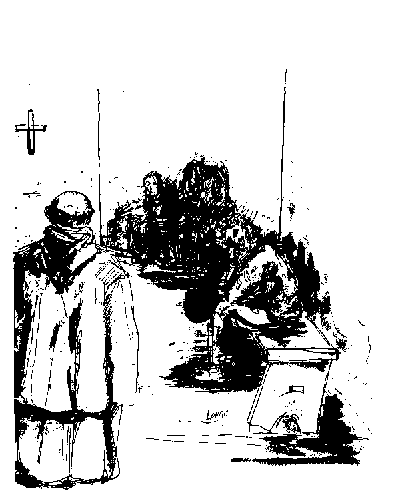
Benedetto, più di ogni altro componente il ben
assortito gruppetto, subiva il fascino di quei racconti e,
seduto su una panca, coi gomiti poggiati sulle ginocchia e
le guance tra le palme delle mani, ascoltando attentamente,
non staccava lo sguardo dal serafico ed espressivo volto
del Padre Guardiano.
Benedetto era un bambino assetato di sapere per
cui voleva conoscere tutto fin nei più piccoli particolari
chiedendo sempre e non stancandosi mai di ascoltare
Stava in silenzio, attento a quel racconto,
finché il padre, stufo di aspettare che rientrasse a casa,
andava a cercarlo e, irrompendo in sacrestia, troncava
bruscamente quei momenti di completo interesse del ragazzo
per le sacre scritture e per la storia dei santi e di San
Francesco in particolare.
E mentre il Padre Guardiano ed i suoi
confratelli assecondavano quell’interesse, mastro
Filippo ripeteva ogni sera, con tono monotono e palesemente
canzonatorio: - Mi raccomando, istruitemelo bene il
giovanotto, cosi da grande lo faremo Vescovo! -
- Non dipende, certo, né da me tantomeno da
voi. - Replicava il cappuccino.
Poi, alzando lo sguardo al cielo ed allargando
le braccia: - Ma se questo è il volere del nostro Padre
Celeste, sia fatta la Sua volontà...! -
-
Si...
si... Vescovo e Papa... - borbottava mastro Filippo che,
intanto, preso il figlio per mano, guadagnava l’uscita
seguito, subito dopo, da tutti gli altri ragazzi, suoi
vicini di casa.
Benedetto, contrariamente ai suoi fratelli, non
era nato per fare il conciapelle. Il calcinaio del padre,
grazie anche alla solerte ed esperta collaborazione dei
fratelli Giacomo ed Andrea, ormai adulti, si era ingrandito
di parecchio e le vasche per la concia si erano
moltiplicate.
D’altra parte, in vista dei matrimoni dei
propri figli, mastro Filippo, secondo una ormai secolare
tradizione, aveva dovuto pensare alla dote da dare ad ognuno
di loro. Benedetto, però, non voleva saperne della concia
delle pelli e la mattina quando il padre ed i fratelli, dopo
averlo tirato a forza giù dal letto, cercavano di indurlo
ad andare con loro in contrada “Cocinara” per aiutarli
nel lavoro, trovava mille scuse per restare a casa e,
spesso, si rincantucciava in un angolo e scoppiava in un
pianto dirotto affermando che non andava ad aiutarli e ad
apprendere
il mestiere perché lo strano e nauseabondo odore emanato
dalle pelli gli faceva venire il voltastomaco.
E piangeva fino a quando la mamma, mossa a
compassione, interveniva per convincere il marito ed i figli
a lasciarlo con lei.
A casa, però, restava ben poco.
Appena,
infatti, si accorgeva che il padre ed i suoi fratelli,
svoltato l’angolo, scomparivano in fondo alla stradina
della piazza, salutava la mamma e, cosi come ormai
puntualmente si ripeteva da diversi mesi, si dirigeva al
di là del Metramo ove, nel quartiere di San Nicola, più a
monte della chiesa parrocchiale omonima, in una zona ricca
di verde e soprastante l’intero abitato, da poco meno di
un decennio i padri cappuccini, col contributo di tutti i
cittadini e con le elemosine raccolte nei paesi della zona,
su un terreno che gli stessi galatresi avevano appositamente
acquistato da Don Robino Minniti, da mastro Petruccio
Ritorto e dalla signora Giulia Giuliano, avevano costruito
il convento della “Sanità”.
[1]
A quel tempo i monaci presenti a Galatro non
erano in numero sufficiente ad occupare le sedici celle
realizzate nel nuovo monastero.
C’era, però, un Padre Guardiano, Fra’
Carlo da Nao, che ben coadiuvato da tre confratelli
sacerdoti e da altrettanti laici professi, era riuscito a
creare attorno al nuovo convento un alone di interesse, di
simpatia e di profonda spiritualità da richiamare
quotidianamente, nell'annessa chiesetta dedicata a Santa
Maria della Sanità, un gran numero di fedeli, per la
maggior parte giovani e ragazzi. Tra questi Benedetto
Manicà era il più assiduo. Frequentando il convento ben
presto apprese a leggere ed a scrivere e, sotto la guida
paziente, saggia ed illuminata del Padre Guardiano, poté
accostarsi con profitto anche allo studio delle lettere ed
alle prime nozioni di teologia. Il ragazzo, dotato di viva
intelligenza e spinto da un interesse sempre crescente,
apprendeva in fretta.
Man mano che andava avanti nello studio, inoltre, nel suo animo
prendeva sempre più consistenza la determinazione di
intraprendere la via del sacerdozio. Questa sua decisione
ben presto dovette parteciparla al padre che, per quanto
credente, inizialmente rifiutava l’idea che suo figlio
assecondando una sincera vocazione, potesse avviarsi alla
vita ecclesiastica o, peggio, monastica.
Non così, invece, la madre che, dimostrando
forte tempra e facendo propria una spicciola filosofia
paesana,
quasi meccanicamente andava ripetendo che quanto è
stabilito da Dio non può essere ostacolato dalla volontà
dell’uomo.
Aveva circa diciotto anni Benedetto quando, già
novizio, per completare gli studi di teologia, su
indicazione
dei cappuccini galatresi che, a detta di loro stessi,
avevano ormai ben poco da insegnargli, varcò il portone del
seminario vescovile di Mileto.
Dalla lettera di credenziali redatta dal padre guardiano del convento e sottoscritta dal parroco, il
vescovo mons. Giovan Mario De Alessandris, uomo assai dotto,
apprese che il giovane Benedetto aveva fatto dell’obbedienza,
nonché dell'osservanza delle Regole e degli Statuti
claustrali, il suo fondamento di vita.
Negli anni di Mileto, Benedetto fu sempre
esempio per tutti i seminaristi
e quando, nel maggio del 1590, dopo che mons. Marco Antonio
del Tufo gli impresse il sacramento dell'ordine sacerdotale
ritornò nella sua Galatro, per il seminario fu una grande
perdita.
Andò
subito ad aiutare, nella delicata quanto difficile opera
di apostolato, i cappuccini e,
dopo una breve permanenza tra i confratelli che
sull’altipiano di Cubasina da diversi decenni abitavano
il vecchio ed ormai cadente “Sant’ Elia” già per
secoli cenobio basiliano, prese parte alla vita monastica
del convento della “Sanità”.
La presenza di Fra’ Benedetto diede subito lustro
ed importanza al convento galatrese. Inoltre le spiccate
qualità umane, la disponibilità verso gli altri, la
dolcezza nei modi, ben presto fecero di Lui il monaco più
conosciuto e più
apprezzato dell’intera provincia cappuccina.
Alto come una pertica e di fisico assai
asciutto, appariva ancora più magro quando, smesso il
saio, in compagnia di alcuni confratelli ed in osservanza al
principio del “prega e lavora”, scendeva nell’orto
limitrofo al Fermano per effettuare umili lavori di
campagna. Quando si spostava da un quartiere all’altro
del paese era sempre attorniato da frotte vocianti di
ragazzi che lo seguivano volentieri e per i quali il buon
Benedetto aveva sempre una raccomandazione da fare o una
parabola da raccontare.
Incarnava in modo assai completo lo spirito di fraternità e di povertà di San Francesco ed era sempre
accanto al letto dell’ammalato, al capezzale del
morente, a chi avesse bisogno di un aiuto materiale, oltre
che spirituale.
Sapeva di medicina, di astronomia e di scienze
e non di rado, preparando e somministrando decotti e tisane
a base di erbe, riusciva a curare ammalati gravi ed a
frenare violente emorragie. Era dotato, insomma, di qualità
e di capacità che non sono prerogativa degli esseri
umani.
Predicatore forbito, tenne più volte il
pulpito della cattedrale di Mileto ed al Capitolo di
Nicotera andò ad illustrare alcuni importanti trattati
teologici.
Come predicatore fu invitato anche nei piccoli paesi in occasione della Quaresima, della festa del Santo
Patrono o dei Santissimi Apostoli.
Usava un linguaggio facile perché tutti
capissero il suo discorso.
A tal proposito spesso ricordava che suo padre, nel giorno della
festa, quando dopo la solenne cerimonia di mezzogiorno
tornava a casa, era solito sottolineare, quasi
sempre brontolando, che a causa delle troppe frasi latine
con le quali era stato arricchito il discorso del
predicatore, non tutto quello che aveva ascoltato era stato
per lui accessibile e, quindi, di facile comprensione.
La permanenza di Fra’ Benedetto nel convento
galatrese si protrasse per diversi anni; in questo periodo
fu sempre vicino ai bisognosi, ai poveri ed ai bambini e
personalmente
somministrò il viatico ai suoi genitori.
Prima in quello di Galatro e poi in altri
conventi, fu maestro dei novizi, incarico che svolse con
assoluta dedizione ed altrettanta umiltà prodigandosi a
dimostrare coi fatti, prima ancora che con le parole, come
l’obbedienza, per chi ama e vuole servire fedelmente
Dio, sia la più importante delle qualità.
Nel 1608 fu nominato Guardiano del convento di
Grotteria e in tutta quella zona acquistò ben presto fama
di essere dotato di poteri soprannaturali per cui i fedeli
guardavano a lui come ad un nuovo Poverello di Assisi.
Tra un prodigio e l’altro il tempo volava e
le sue primavere, fra’ Benedetto, cominciava a mostrarle
tutte. Già qualche pelo della fluente barba era diventato
bianco ed anche in testa mostrava qua e là spruzzi di
candida neve.
Quel che colpiva maggiormente, della figura del
frate galatrese, però, era lo sguardo dolce e penetrante ad
un tempo. Così penetrante da riuscire a leggere nelle
coscienze delle persone che gli si trovavano davanti.
Leggeva nell’animo dei fedeli che lo avvicinavano e
prim'ancora che essi avessero esposto i loro problemi, egli
dava la più rassicurante delle soluzioni, sempre accompagnata
da un sorriso e, non di rado, anche da una paterna pacca
sulle spalle.
Per potergli parlare da tutti i villaggi della valle del
Torbido, quotidianamente, giungevano al convento diecine
di fedeli, molti dei quali, su modeste cavalcature,
portavano ammalati da fargli visitare o, più semplicemente, venivano a pregarlo di intercedere per loro
presso
il feudatario del luogo che li immiseriva sempre più col
continuo aumento dei pesi sul macinato.
Grazie al suo carattere dolce ed alla sua
completa disponibilità verso il prossimo, il cappuccino
galatrese ben presto divenne il punto di riferimento per
tutti i credenti della zona.
Ovunque si parlava di lui per cui ben presto i Marchesi di Grotteria chiesero ed ottennero, da Roma, che
fosse proprio lui il loro confessore ordinario.
E fra’ Benedetto accettò quel nuovo incarico
con la sua solita umiltà.
Sicché in più d’una circostanza, sentendosi
sempre indissolubilmente legato ai più bisognosi, approfittò
di quell’incarico di fiducia che gli apriva le porte
dell’abitazione marchesale, prim'ancora che l’animo
dei suoi nobili proprietari, e con opportuni consigli ed
ammonizioni, riuscì ad intercedere concretamente in
favore della popolazione le cui difficoltà di vita erano
completamente sconosciute all’interno di quel palazzo nel
quale, per contro, il benessere si toccava a piene mani.
I discorsi pacati e convincenti dell’umile
cappuccino galatrese riuscivano a smuovere principalmente il
cuore della marchesa la quale, in più d’una occasione,
ordinò ai suoi domestici che provvedessero ad effettuare
della beneficenza distribuendo alle famiglie del villaggio
abbondanti razioni del frumento e
dei cereali che annualmente venivano ammonticchiati
nei granai del palazzo.
Altre volte Fra’ Benedetto corse a sedare le
lotte tra famiglie, riuscendo ad evitare che quegli atti di
violenza potessero avere serie e
luttuose conseguenze.
Svolgeva la sua cristiana missione di amore tra
le famiglie di Grotteria, villaggio che, abbarbicato su un
costone di montagna, era abitato quasi interamente da
contadini e da pastori. Umile gente che aveva trovato nello
smilzo cappuccino il sincero amico, il medico appassionato
e scrupoloso nonché il paziente confessore.
*
* *
Il caldo afoso appiccicava addosso ai
contadini, impegnati nei duri lavori stagionali, i loro
laceri e miseri
indumenti;
le cicale frinivano sugli olivi e sui fichi delle vaste
campagne circostanti il villaggio; le rondini, come
impazzite dal sole cocente, volavano basse sfiorando le cime
degli alberi e disegnando sui tetti delle abitazioni
complicati ghirigori, poi, garrendo come non mai, in cerca
di refrigerio si allontanavano imboccando la direzione
della montagna, ricca di fitte faggete e, più in cima, di
pini e di abeti.
Era da poco passato mezzogiorno.
Madido di sudore, dopo aver percorso lo stretto
sentiero che dal paese, tra fitti ciuffi di gialla ginestra
e cespugli di erica, conduceva fino in cima alla collina,
Serafino,
uno dei servi della casa marchesale, bussava ripetutamente
e concitatamente alla porta del vecchio convento.
- Padre Benedetto, padre Benedetto... -
chiamava. E quando da dietro lo spioncino della grande porta
intravide il volto rugoso del vecchio frate Agesilao,
prima che questi potesse chiedere cosa volesse, l’ansante
Serafino riprese a dire: - C’è assoluto bisogno
dell’intervento di Padre Benedetto... Deve scendere
subito in paese. . . E improvvisamente morto il marchesino
Agazio... -
Donna Livia Grillo, marchesa di Grotteria, dalle sue nozze col
nobile Giovan Giacomo Cicala di Gerace, aveva avuto un unico
figlio, Agazio, che ora, giunto all’età di circa dieci
anni, era deceduto in seguito ad improvviso e grave
malore. Non c’era stata malattia né altre avvisaglie che
avessero potuto far presagire
il luttuoso evento. La cosa era stata tanto repentina che
la sventurata mamma non aveva neppure fatto in tempo a
ricorrere
a qualche urgente rimedio, né aveva potuto far intervenire
un medico.
Agazio si era alzato dal letto allegro come un
usignolo. Poi un leggero quanto improvviso dolore al ventre
seguito prima dallo intorpidimento di un braccio e poi da
febbre altissima, aveva messo in allarme, quella mattina, la
marchesa che, nel volger di pochi minuti, e prima che
potesse rendersi conto di quanto stava accadendo, si venne
a trovare col cadavere del figlio tra le braccia.
- Aiutami, mamma!.. .Aiutami!.. Mi sento soffocare... - le diceva il giovanissimo Agazio mentre gli
occhi, già luminosi e grandi, si spegnevano sempre più.
Nessun aiuto poté dare alla sua creatura Donna Livia che,
in quel caldo mattino di agosto, improvvisamente si vide
crollare il mondo sotto i piedi.
La notizia di quella disgrazia, nel volger di
pochi minuti, fece il giro del villaggio sicché,
lentamente, gli abitanti si strinsero attorno alla
sventurata madre che straziata dal dolore piangeva la
morte del figlio. La giovane marchesa non sapeva darsi pace
e, tra le lacrime, chiamava per nome il figlio, lo
carezzava e, mentre il volto esangue diventava sempre più
freddo, lo pettinava facendo passare le dita della mano
tra quei capelli di seta. Inoltre, tra un singhiozzo e
l'altro, decantava le doti e le buone qualità del ragazzo.
Il pianto accorato della mamma commosse tutta
la servitù e gli amici che nel frattempo, in gran fretta,
erano giunti al palazzo per partecipare al lutto.
Ben presto la stanza si riempì di umile gente
e le pareti risuonarono del pianto accorato della marchesa
a cui, subito fecero eco moltissime altre donne. Più volte
Donna Livia perse i sensi e svenne accanto al letto su cui
giaceva esanime la sua creatura.
La meridiana fissata sul muro esterno del
palazzo marchesale indicava che da tempo era già trascorso
il mezzogiorno allorché, mentre i gemiti ed i singhiozzi in
quella grande stanza echeggiavano sempre più,
improvvisamente
la folla che si era via via radunata davanti a quel
lettino-catafalco, si aprì in due ali per lasciar passare
Fra’ Benedetto che difilato ed ansimante arrivava dal
convento.
Tra l’unanime curiosità l’anziano
cappuccino si avvicinò al cadavere, lo toccò, gli passò
più volte la mano sulla fronte e poi, inginocchiatosi ai
piedi del letto, brevemente si raccolse in preghiera.
Pregavano, adesso, anche le donne presenti
nella stanza che, per non disturbare il frate, sembrava
volessero trattenere anche il respiro.
Tra esse c’era chi, assorta nella preghiera,
col volto tra le mani, aveva piegata la testa verso il
pavimento fatto di tavole; chi, chinata in avanti fino a
disegnare col corpo un arco, con la mano destra chiusa a
pugno si percuoteva il petto, quasi a rendere più sentita e
più partecipata la propria preghiera.
Anche Donna Livia aveva smesso di piangere e seguiva
attenta i movimenti dell’anziano cappuccino. Furono
attimi interminabili.
Poi, alzatosi quasi di scatto, Fra’ Benedetto
si avvicinò alla Marchesa e in modo quanto mai deciso e
con tono di rimprovero, le chiese:
- Perché piangete per morto il Marchesino, se
egli è vivo? -
Donna Livia che, impietrita dal dolore, ormai
da alcune ore, stava sprofondata su una poltrona accanto
al corpo del figlio, nel sentir quelle parole, si girò e,
con sorpresa, gli rispose: - Come mai affermate che è vivo,
o Frate, se io ormai da ore lo vedo qui, davanti a me,
esanime e freddo, e come morto lo veglio? -
Fra’ Benedetto si accostò, quindi, ancor di
più al letto, fiatò forte in prossimità della bocca del
morto e poi, scuotendo il cadavere: - Agazio!... Agazio!...
- esclamò - In nome di Dio svegliati e ritorna in braccio
a tua madre che ti piange! -
Adesso nell’ampia stanza diecine di persone avevano fissi gli occhi su quel corpo che nella rigidità
della morte stava disteso sul bianco lettino. E tutte
rimasero sbalordite dalla meraviglia allorché ebbero la
fortuna di vedere Agazio aprire gli occhi, atteggiare le
labbra ad un sorriso e subito dopo tendere le braccia in
avanti ed alzarsi a stringere la mamma in un abbraccio che
la rasserenava.
Il silenzio che nella stanza ed in tutto il
palazzo aveva regnato profondo sin dall’apparire
dell’anziano cappuccino galatrese, fu allora rotto da
uno spontaneo quanto altissimo grido: “Miracolo!
Miracolo!”.
E nel pronunciar quelle parole tutti
istintivamente caddero in ginocchio davanti a Fra’
Benedetto che, intanto, imboccava la porta d’uscita per
far ritorno al convento.
Agazio tornò subito ai suoi giuochi preferiti
giacché tra lo stupore generale nulla ricordava di quel suo
temporaneo viaggio, e breve permanenza, nel mondo
dell’al di là.
Sull’altare maggiore della chiesa dei
Cappuccini di Grotteria, per iniziativa della Marchesa Donna
Livia, un dipinto - raffigurante San Francesco che presenta
alla Vergine Maria il resuscitato fanciullo ridente e
gioviale - ha testimoniato nei secoli lo straordinario
avvenimento che ha avuto per protagonista l’umile frate
galatrese.
Successivamente Fra’ Benedetto, che per gli innumerevoli
miracoli operati si guadagnò l’appellativo di Taumaturgo,
fu chiamato dai principi di Maida che lo vollero come loro
confessore, sicché pur se ormai avanti negli anni ed un po'
acciaccato nel fisico, il cappuccino si trasferì nel
convento di quel villaggio.
Fu instancabile servitore di Dio ed anche se
gli anni e le precarie condizioni fisiche aggravate dai
continui digiuni avrebbero dovuto sconsigliarglielo,
l’umile cappuccino volle svolgere la sua missione di
fede e di amore andando a predicare il Vangelo non solo tra
i cittadini di Maida ma anche tra quelli dei casali di
Jacurso, di Cortale, di Curinga...
Aveva superato i settant’anni soltanto di
qualche primavera allorché nel novembre del 1637
[2],
in una notte in cui, esattamente come quando venne alla
luce, la violenza dell’acqua e la furia del vento
sembravano volessero squassare la terra, il sant’uomo si
spense serenamente a Maida, tra il rimpianto generale dei
suoi confratelli coi quali, fino alla fine, volle essere
vicino con l’esempio e coi suoi illuminati ammaestramenti.
Quella notte i sacri bronzi di tutte le chiese
di Galatro, inspiegabilmente da sole e tutte insieme, con
un lungo ed argentino scampanio a festa, svegliarono i
cittadini
del luogo, quasi per annunciar loro il ritorno al Padre
Celeste dell’umile e santo Fra’ Benedetto.