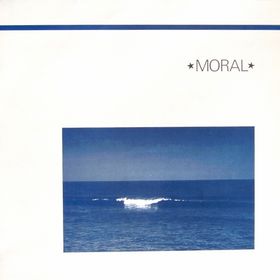M
Madder Rose- Bring It Down (Seed, 1993)
Madder Rose è un quartetto formatosi nei primi anni '90 a (New York?) Los
Angeles, capitanato dalla cantante Mary Lorson e dal chitarrista Billy Coté.
Nei quattro lavori all'attivo ad oggi, il gruppo ha proposto un suggestivo,
rimarchevole esempio di pop-wave introspettivo, con frequenti saliscendi umorali.
La chitarra è sovente in primo piano, alterna brani urgenti, con qualche richiamo
allo stile di Blake Babies e10.000 Maniacs a ripiegamenti pensosi.
Timbri policromi e incisivi, tonalità accese di strumenti. La voce-coscienza
afflitta della Lorson, in perenne brama di serenità ed equilibrio esistenziale,
completa essenzialmente il quadro.
L'esordio “Bring It Down” è l'album più calibrato, quello che fa conoscere
ed apprezzare il gruppo. Col seguente e celebrato “Panic On” (Atlantic, 1994)
forma un dittico significativo per l'indiepop; esemplari fantasie strumentali
e favori melodici.
Si realizza una coerenza tutta particolare, diremmo esclusiva, nel corpo dell'album,
nella promiscuità tra frenesie epilettiche (chitarra spesso nevrotica su “beautiful
john”,”swim”,”lay down law”, “altar boy”, “razor pilot”) ed arie taciturne,
fosche e misteriose (la splendida “while away”, “lights go down”, “waiting
for engines”, e la dolce, velvettiana serenata “pocket fulla medicine”).
Fossero nate dieci anni dopo, Rickie Lee Jones e Karla Bonoff avrebbero composto
canzoni come queste.
THE MAGNETIC FIELDS
Attivo dalla fine degli anni ottanta e apparentemente lontano dalla sala d’incisione da qualche tempo, Stephin Merritt non s'è mai realmente fermato. Comporre canzoni è per lui un’urgenza imprescindibile, una necessità fisiologica.
Una musica, la sua, tutta ritorni, vagabondaggi vissuti e ripensati, crepuscolo, notte. Musica della memoria, memoria del quotidiano che si nutre di discorsi amorosi.
Da principio col suo quattro piste casalingo, poi sempre più organizzato per ottenere esattamente ciò che cerca in/da una composizione, tra arrangiamenti orchestrali, sezione d’archi, clavicembalo, violoncello, polke, musica da circo e cabaret.
In Merritt lirismo ed enfasi saranno sempre fedeli subordinati a un senso dimesso e pudico.
I suoi numerosi progetti musicali comprendono opera solista, Magnetic Fields, 6ths, Future Bible Heroes, Gothic Archies. Prolificità e assoluto genio artigianale a braccetto.
Ad oggi compongono Magnetic Fields anche Sam Davol violoncellista, John Woo a chitarra e banjo e sitar elettrico, Claudia Gonson pianista e percussioni, piano, clavicembalo e voce aggiunta.
Distortion (2008)
Distorsione come accento, risalto, esasperazione risoluta di toni, di timbri scomodi. Ma anche ostensione, esposizione divertita di un uomo, un uomo comune (come da copertina testimonianza).
Nell’allegoria del distorsore di suoni, l'alterazione e la traduzione di ricordi, al solito, per conviverci meglio cantandoli, marcandoli in elegia.
“Sempre abile a giocare con le proprie carte, coi propri spettri amorosi, Merritt. Quanto può aver pianto, quanto può ancora piangere, quest'uomo?”
Questo vecchio commento vale certo anche per questo nuovo viaggio-ritentiva al vespro, nel personale luna park mnemonico di Merritt, popolato di juke-box, immagini di film ed ombre di vite percepibili al solo autore.
Il quale torna ad accompagnarsi e a farsi raccontare talvolta da una voce muliebre, come nei primi dischi: sostegno spirituale e carezzevole, voce alle paroledel suo libro di vita.
California Girls e si dipinge tutta un'immagine, un'ideale, quarant'anni di immaginario e quarant'anni di devoti.
Nella fattispecie è il sunto, l'essenza, emblema, monumento, l'anelito cui ruota intorno implacabile il satellite, l'arte di Magnetic Fields. Apre simbolicamente l'album, un album sul tema della *distorsione* tutto volge e assume le forme, più esasperatamente che altrove, di dolente reminiscenza, di strazio interiore.
Lo stato d'animo è ben indicato dall'accentuazione strumentale e da quella voce effettata che comunica allo stesso autore da chissà quale anfratto del cuore, un passato *distorto* e idealizzato, candido, gioioso, innocente, ma nebuloso.
Qui accorre un istinto di salvezza proteggendo l'autore in una ripulsa bugiarda (e tanto più patetica), verso l'ideale sempre agognato. Il refrain recita nostalgicamente: ..."I hate california girls" tra muri di suono spectoriani (le sue Madeleine, i personali flagelli sentimentali di Merritt), ma quest'odio è un trucco, non è che una disperata menzogna, un disperato voler respingere il proprio supplizio amoroso che continuamente si rigenera canzone dopo canzone, disco dopo disco.
The Wayward Bus
(1991 Merge)
Se "69 Love Songs" è il monumentale atto che qualche anno
fa rivelò al mondo Magnetic Fields (e che già in molti posseggono)
sarà forse più opportuno rivangare i fasti di lavori anteriori
e insospettabilmente precursori di una scena che recupera l'arte di Phil Spector
e Brian Eno addentrandoli in un synt-pop tirato a lucido.
The Wayward Bus è il secondo album del pioniere musicologo Stephen
Merritt, ancorchè privo del suo apporto vocale filigrana (al posto
di Merritt canta, qui e sul precedente, Susan Anway).
Questo album del 1991 anticipa i successivi capolavori Holiday e The Charm
Of The Highway Strip.
The Wayward Bus preannuncia il potenziale artistico e la cifra poetica di
un grandissimo autore contemporaneo.
Disincanto, memoria e sogno. Uno scrigno di gemme nostalgiche e passionali
dall'aura incontaminata e idilliaca, che rifulgono nel proprio peculiare,
forbito simbolismo e nella levigata brillantezza degli arrangiamenti. Senza
smarrire, per magia, un senso autenticamente confidenziale. Dalla appassionante
mistura voce-strumenti in “when you were my baby”, all'emozionante
melò “Candy” (ripresa poi dagli Holiday nel memorabile
Ep “Cafè Reggio”); dai tormenti di “the saddest story
ever told” e “old orchard beach” incappando in “summer
lies”…
“i” (Nonesuch, 2004)
Dopo
il triplo e per molti definitivo “69 Love Songs” del 1999, il nuovo
album di Stephin Merritt coi Magnetic Fields torna ad un formato ideale, più
consono a un ascolto intero: una quarantina di minuti, più o meno. Sempre
una festa di arrangiamenti complessi e compressi, di passioni fredde dal tempo,
di colori malinconici euforici, di forme e citazioni lontane, affascinanti
e calibrate. Idealmente dirette e intorpidite dalla voce e identità
“magnetica” del nostro.
Sortilegio d'una prosa che tutto convoglia, tiene e rilascia.
Questo “i” è gravido di quindici anni di attività alle spalle, fa tesoro dei
cammini del nostro. Eppure ci sembra gli piaccia tornare a rimirare i luoghi
limpidi della giovinezza, reinventandoli incontaminati, decantando nuovamente.
Un flusso sensoriale, mnemonico che si rievoca e rifrange su note, strumenti,
apparecchi digitali, sempre in morbida evidenza.
Se un referente con Merritt va fatto, va fatto con Merritt medesimo.
Ed ecco affiorare parvenze della miracolosa sint(esi)-pop armonica di album
come “Wayward Bus” (1991), e “Holiday” (1993); realtà e fiaba, memoria rivissuta
e gioco come condizione esistenziale.
La musica che emana e ispira una balera deserta alle prime luci dell'alba,
un circo abbandonato immerso nei colori del tramonto.
Allo stesso tempo percepiamo nuove distanze tra queste note, nella
solita, inestimabile qualità dimessa del linguaggio del nostro.
Le dolci ferite viscerali esaminate impassibilmente a freddo da Merritt
posseggono una credibilità unica, che altri avrebbero mascherato dietro improbabili
inconsulte rabbie e rancori, compromettendo il senso memoriale e confessionale
del progetto.
Sempre abile a giocare con le proprie carte, coi propri spettri amorosi, Merritt.
Quanto può aver pianto, quanto può ancora piangere, quest'uomo?
È d'altronde un gioco psicologico, di monologhi interiori, ostinato e rischioso,
rivelatore, scomodo. Rimestare tra i ricordi, la speranza di scaraventarli
fuori da sè, sopprimerli.
Se la musica altrove è cambiata, le liriche di Merritt, tutte allegorie, simbolismo
e realtà quotidiana, ci sono sempre parse orizzontali, bloccate in
un istante eterno. Ci arrestano con loro, e immobili perdiamo lo sguardo su
orizzonti vaghi e lontani.
Musica circolare, impermeabile agli agenti atmosferici, inscalfibile alle
ferite, alle lacrime: si è ipotizzato che l'autore fosse un eccellente ipocrita,
ma ci si è arresi, persuasi di fronte a tale ostinazione, la nuda cronaca
esistenziale.
Imbarazza l'incantevole linea melodica di “I die”, un esile soffio di voce,
violoncello e tastiera (altrove, clavicembalo); “i don't believe you”, è un
brano costruito in pratica su un ritornello. Ma quanto è ammaliante.
Dignità e compostezza assieme a fruibilità e immediatezza, senza frattura,
senza contraddizione. Il mistero di Magnetic Fields si ravviva ancora.
“I'm Tongue-Tied” e “In an Operetta” ricostruiscono atmosfere Novecento europeo,
cabaret decadente, in tre minuti scarsi.
Niente dedica alla Luna, tra i titoli dei brani. Ma il riferimento può estendersi
a tutto l'album, se si vuole. Un lavoro certamente più confidenziale e custodito
di un “Get Lost” (1995).
Il mal di Luna comunque sottende la sbornia after-hours di “Infinitely
Late at Night” e “Is This What They Used to Call Love?”. Rara proprietà d'incanto,
grado di stupire del sinodo di mis(t)ero e quotidiano sulle “I Wish I Had
an Evil Twin”, “If There's Such a Thing as Love”. “I thought you were my boyfriend”,
è alloro per i gruppi synt-pop prediletti in gioventù dall'autore. E ancora,
il banjo e il violoncello su “Irma”, il congedo “It's Only Time”, dalla memoria
di Merritt ora, fatalmente, alla nostra.
Ennesimo gran lavoro di Magnetic Fields.
Malfatti-Wittwer - Thrumblin' (1976)
In duetto per FMP assieme al successivo “Und?”, “Thrumblin’” è realizzato a Berlino nel ‘76 ed è opera di Radu Malfatti (al trombone) e Stephan Wittwer (a chitarra acustica e elettrica).
I due presentano musica decisamente spiazzante a tratti ostile per l’epoca, jazz impercettibile, rudimentale e dissonante, ovvero una piece art-avant fatta di fantasia, squilibrio, improvvisazione assoluta.
Caos e manipolazione segnica a base di duetti tromba-chitarre; tentativi di coabitazione coatta, a base di micro strutture agitate, convulse, rovesciate e dimenanti anche in spazi appena percettibili, tipo una manciata di secondi (quasi a torcere, stramazzare, far esalare l'ultimo respiro allo strumento).
E rispettivi, ovvi contraltari statici più cerebrali, la cosiddetta ‘ricognizione’. Tutto nella dimostrativa suite “Abendländische Kulturangst” di 18 minuti.
Note-elettroni, scagli(at)e secondo la maniera dadà di uno Steve Beresford (a differenza dei quali adoperava con meno pudore, ogni oggetto che in casa producesse un suono significante, simbolico). Microchirurgia pre-Matmos praticata con strumenti a fiato o a corda anziché nastri e tastiera.
MARSCHMALLOW COAST Seniors & Juniors
(1999) In questo esordio Andy Gonzales alias Marschmallow Coast mostra predilezione
per una musica melodica dai toni bassi, acustico, a volte cameristici. Nessun
tipo di ricercatezza, nessun trucco da svelare, solo ambienti semplici ed
essenziali, estremamente rarefatti, diafani.
Quattro e otto piste, pianoforte e basso, qualche strumento a fiato isolato.
Il desiderio è di fare musica libera, mimetica, che perda peso, diventi
tutt'uno con i luoghi circostanti.
Quest'opera per Kindercore può ricordare a volte e nelle intenzioni
gli abbozzi e i tratteggi dolci e bucolici di un Camoufleur dei Gastr del
Sol, o i primi Ep dei Grandaddy. Ma ancor più, si evoca costantemente
l'esordio solista omonimo di Paul McCartney, che era lavoro intenzionalmente
dimesso, semplice, casalingo e francamente sentimentale come pochi prodotti
sino allora: una sorta di reazione insofferente di Paul verso il carico lavoro
di studio dei produttori Phil Spector e George Martin.
Se nella prima parte "Seniors & Juniors" mostra un ambiente
indubbiamente pop, in seguito si può parlare di cameristica e finanche
contemporanea, sia pure composta e arrangiata ironicamente e con mezzi propri
rimediati; con una caratteristica voce nasale e atonale. Sfizioso l'artwork
realizzato con dei personaggi e animali in collage bidimensionale stile South
Park, che ritrae in tinte pastello ambienti domestici e scolastici. I luoghi
formativi sono richiamati spesso dai cantautori pop statunitensi di questa
generazione per omaggiare identificando, la propria nostalgia e il proprio
candore.
Nei lavori seguenti, come "Ride the Lightning", sempre piuttosto
incisivi melodicamente, si fanno più maturi e professionali negli arrangiamenti
e nei timbri, il progetto di Gonzales viene paradossalmente a perdere qualcosa
di quella personalità peculiare originaria e "involontaria" che marcava suoni e luoghi. Gli resta, fortunatamente, un notevole, inconsueto
istinto melodico.
Mate - Sol de Medianoche (Siesta 2005)
 Alberto Matesanz, cantautore veterano delle scene indie, insegue per la propria nuova creatura Mate direttive Serge Gainsbourg, Blueboy, La Buena Vida, Ibon Errazkin.
Alberto Matesanz, cantautore veterano delle scene indie, insegue per la propria nuova creatura Mate direttive Serge Gainsbourg, Blueboy, La Buena Vida, Ibon Errazkin.
Da un'intervista (per “clubcultura.com”) Matesanz così parla del suo disco: “(…) tiene una atmósfera que el oyente apreciará fácilmente. He tratado de envolver la melodía de la voz con guitarras, en un principio, guitarras eléctricas con ecos que crearan una sensación espacial; luego he añadido guitarras rítmicas acústicas, más cálidas, como contrapunto.”
Alberto Matesanz (coinvolto tuttora assieme a Blanca LaCasa anche nel progetto Plastic d'Amour per Siesta), pubblica a nome Mate il proprio nuovo esordio “Sol de Medianoche”: una delicata ed emotiva prova cantautorale istintivamente acustica (voce e chitarra), rimpolpata da strumenti elettrici (chitarre “dreampop”) congiunti a fini arrangiamenti classicisti (piano, violoncello, flauto traverso, orchestrazioni).
E'certo questa una ammirevole abitudine, quasi costitutiva del pop ispanico in madrelingua (La Buena Vida, Le Mans, El Joven Brian, Serpentina...), che da stagioni ormai s'ammanta col fascino dell'emotività più viscerale e verista e non si preclude cronache di tormenti che percepiamo assai verosimili.
“Sol de Medianoche”, a mò di biografia 'onirica' (come definisce lo stesso Alberto), satura dei colori glauchi dell'alba, idealmente porta avanti quel discorso, oscillando tra racconti di memorie tragiche e autodifese ironiche. Il “sole” del titolo simboleggia stagioni trascorse ad ascoltare la propria anima solitaria, galleggiando su pensieri e nostalgie ossessive, a volte macigni sul corpo e sullo spirito spenti e tormentati.
La veste armonica, impeccabilmente pop, smussa, mitiga e addolcisce; modifica per far accettare nella forma questa materia, una Bastiglia della memoria.
In canzoni luminose come “cada vez que amanece ”, “esperando a que pase”, “balsa de piedra”, “noticias”, si trova anche un rimedio, forse un escapismo, rimedio taumaturgico ove comprendersi e assistersi.
Estremi d'emozione per trovarsi, estendersi. Stendere le pieghe del dolore, farle placide in una nuova e serena prospettiva. (agosto, 2005)
Memphis - I Dreamed We Fell Apart (Paper Bag Records, 2004)
 Formatisi nel 2001, a Vancouver Canada, Memphis sono il progetto parallelo di Torquil Campbell, leader di Stars, assieme a un amico della Nord Carolina, Chris Dumont, voce, tastiere, melodica, missaggio e “carousel operator in Central Park”.
Formatisi nel 2001, a Vancouver Canada, Memphis sono il progetto parallelo di Torquil Campbell, leader di Stars, assieme a un amico della Nord Carolina, Chris Dumont, voce, tastiere, melodica, missaggio e “carousel operator in Central Park”.
Memphis è un vero gruppo e non un side-project, come ribadiscono i due musicisti mentori redivivi, Torquil e Chris.
Artefici di un solo presentente Ep del 2001, “A Good Day Sailing”, per anni vanamente inseguito nei negozi indie musicali romani, prima di capitolare, questo duo ha bissato oggi, anzi nel 2004, col primo Lp “I Dreamed We Fell Apart”.
Complice forse un aria d'indolenza e disadattamento, vivo e ottundente, che domina ogni mese di Gennaio, quest'album mi risulta il parto più benefico e favorevole di Torquil Campbell, il più maturo e multicolore, delicatamente maculato.
In parole povere, aspettare a lungo Memphis valeva la pena.
“Ho sognato…” cita il titolo... finalmente. Prigionieri dei propri pensieri, esanimi in notti senza fine, in abissi senza uscita, i Memphis trovano in sè una grande forza espressiva, e la volontà di raccontarla. Crediamo davvero alla pasta onirica di questa materia, sgorgata e impressa con naturalezza attraverso la musica.
"I Dreamed”…è uno stranito Luna park di luci fioche e irreali, che sprigionano contrasti di vive, pullulanti, dolci melodie. Chitarre, sax, harmonium, violino (di Yurika Mok), samples e tastiere, turbini di battiti impalpabili accentuano la morbidezza delle ritmiche meccaniche.
Un songwriting senza tempo appena contestualizzato, quanto basta a far brillare un tappeto “evergreen” già acceso e appariscente.
Da uno sgardo sul web, tra i comparabili a Memphis ho letto il nome Death Cab for Cutie, il che potrebbe in effetti solleticarne i tanti fan, spingendoli verso questo disco bellissimo.
Ascoltiamo oggi “the second summer”, come in una cabina di treno che allontana e porta via. Siamo alla stessa distanza di tempo che separa due estati, passata e futura, stregati da questa enfasi semplice e vibrante di fragili voci e pulsante elettronica.
Ogni tanto, ancora qualcuno oggi tira fuori da una canzone malinconie irresistibili, come “For Anyone Eighteen” (con pregevole coda di flauto di Eric Hove) e “On the Last Day of School” (voce caldissima su effetti di temporale), o anche la lontananza e isolamento che dilata “Lullaby for a Girl Friend Or Happy Trails”: è il ricorrente mitigarsi di questi desideri che fa innamorare e stringersi alla musica pop.
Altrove, la melodia svapora con indescrivibile dolcezza in meandri e nebulose di tastiere elettriche, che sommergono e ovattano il mondo con grande sensualità.
Se “Into the Wild” e “Love Comes Quickly” restituiscono ambienti congeniali a Stars, il soave crooning folktronico con ondeggi di sax su "Nada", le rifrangenze di “East van” e dell'interludio “Hey Mister, Are You Awake?” mimano mai sopite seduzioni Saint Etienne.
E noi, inermi e impressionati… restiamo sul posto, incantati dal sogno.
MERCURY REV
All is dream (2001)
I Mercury Rev sono unanimemente considerati
una delle band più importanti dell'odierna scena rock. Il loro quinto lavoro
costituisce l'ennesimo avvicinamento, forse quello definitivo, verso l'appropriazione
del suono ideale.
Dapprima era un rock conflittuale e squilibrato, ad animare le loro prime
opere, due tra i principali, veri capolavori della musica rock degli anni
novanta: Yerself Is Steam del 1991 e Boces del 1993. Una miscela
fortemente personale, inquieta, ricca, nevrotica, lisergica e ipnotica oltre
ogni descrizione, che può a ragione paragonarsi ai Pink Floyd dell'epoca Barrett,
e ancora, Cro Magnon, United States Of America, Red Crayola.
Dal successivo, ancora memorabile, See You On The Other Side (1995),
la band virava a favore di un pop quasi prevalentemente sinfonico e barocco,
ancora piacevolmente disordinato ed impressionista, ma sicuramente più gioioso
e caldo, diretto, un tripudio che evoca scenari mistici ed estatici, molto
vicini, musicalmente, a visioni e idee che si possono avere del Paradiso.
Una mutazione che ha non poco in comune con i colleghi ed ex compagni Flaming
Lips.
Dall'abbandono del cantante David Baker, l'indomani della pubblicazione di
Boces, il canto era stato affidato a Jonathan Donahue, uno dei due chitarristi
e principale compositore della band. Una voce versatile, più equilibrata,
armonica ed accattivante rispetto all'incoscienza e all'istinto che animavano
le performances di Baker.
Nel penultimo Deserter's Songs (1998) Donahue diverrà sempre più crooner
dandy decadente e nostalgico, perfetto accompagnatore dell'esercito della
strumentazione di cui i Mercury Rev fanno ormai uso: violini, clavicembali,
trombe, mellotron, corni, organi hammond, xilofoni, arpe, una sezione d'archi
e soprano femminile; insomma una vera e propria orchestra.
Sin dall'incipit di dark is rising, che inaugura il nuovo disco All Is Dream,
l'ascoltatore è prepotentemente trasportato in un mondo intensamente fantastico,
onirico. Si palesano, echeggiano visioni e incanti d'ogni genere e forma. “in my dreams i'm always strong”, afferma, con lusinghe, Jonathan:
un invito a credere nelle proprietà salvifiche, redentrici, del potere dell'immaginazione.
All is dream, dream is all.
Nonostante un registro musicale quasi completamente mutato, va riconosciuta
ai Mercury Rev lo stesso gusto melodico, la stessa abilità demiurgica, l'aria
festosa, contemplativa, la creatività lunatica e surreale di cui disponevano
agli esordi, e che oggi in ben pochi hanno l'ardire di concepire e realizzare.
Ogni composizione di All Is Dream è meticolosamente pensata nella sua realizzazione:
non rischia mai d'apparire ponderosa, eccessivamente solenne, strabordante,
arrestandosi nell'istante immediatamente precedente, vanificando ogni rischio
di autoindulgenza, artefazione o trucco; insomma, rivelando una struttura
minimalista che favorisce la sospensione dell'incredulità.
Ennesima prova di forza di Dave Fridmann, bassista del gruppo e geniale produttore
tra i più stimati da mezzo mondo del rock indipendente.
Lincoln's eyes comunica perdita, senso di freddo. Sobbalziamo nell'accorgerci
che la voce smarrita ed affaticata del narratore è divenuta la nostra. Il
calore di nite and fog, il vibrato nietzchiano della sega con l'archetto,
manifesta scenari ove rifugiarci.
A volte interviene, tra una sterzata e l'altra, deus ex machina, la semplicità di una suadente ninna nanna come drop in time, la delicatezza benedetta
di un piano come quello di spiders and flies, toccante brano lirico
che s'immerge per sempre in abissi ardenti attraverso un fade-out di infinito,
irraggiungibile, anelito.
Conclude hercules, che omaggia Robert Wyatt e i Rev stessi di dieci
anni fa, rivelando una strumentale giostra vorticosa e pirotecnica nella propria
coda.
Strange Attractor (2008)
In molti sanno della vicenda di “Strange attractor”, il nuovo disco dei Mercury Rev edito il 30 settembre scorso assieme a “Snowflake Midnight” ma messo a disposizione gratuitamente in rete, previa iscrizione alla mailing list del gruppo.
Ciò che offre l’album non si scosta, prevedibilmente, dal limitrofo, citato “Snowflake Midnight”: uno straniante salto nel buio in un cinematico cosmo digitale che ha spiazzato buona parte dei fans del gruppo.
Tutto si può dire di Jonathan Donahue e soci fuorchè vivano di rendita. La band di Buffalo, agli esordi un ventennio fa, non potrebbe apparire più distante da questo recente duetto. Ciò nonostante, la matrice originaria è quella medesima alma psichedelica sempre fedele, che tutto muove.. e quella inesausta ricerca di spiritualità, anelito mai sopito.
I Mercury Rev nel 2008 sono un trio (J. Donahue, Grasshopper e Jeff Mercel, l’ex socio David Fridmann alla co-produzione), un combo in rinnovata metamorfosi (..So Unpredictable, imprevedibili, citando uno dei loro titoli recenti), che sembra ringiovanire come Dorian Gray, immergendo la propria epopea in celestiali armonie elettroniche dagli effetti cromatici inusitati e dalle complesse architetture all'avanguardia. Una materia sonica rinnovata e multiforme, trasognata ed enfatica, che i Mercury Rev stessi hanno rinverdito in autonomia e in portentoso equilibrio, disco dopo disco, ieri come oggi.
Comune denominatore alle diverse età dei Rev resta il talento, lo slancio e il passo di estetiche assolutamente moderne; il saper convertire abitudine in bellezza, assuefare in una nuova tensione allucinante e spirituale. Trovare una comunione possibile tra diverse forze, condensare reale e ciò che ne è avulso, come facevano i surrealisti.
“Strange Attractor” è un intenso, rigenerante tuffo in estesi panneggi di psichedelia elettronica, in tastiere retrò in Technicolor, il cui effetto atmosferico spirituale incontra componenti onirici; sin dal brano d’apertura “Love Is Pure”, rinviandosi brano per brano, senza soluzione di continuità.
“Strange attractor” nel proprio titolo confessa la propria suggestione fatale.. un’ostinata volontà che persuade a navigare con gli occhi, per ignoti percorsi astrali o simbolici. Si mostra come assestamento monomaniacale di “Snowflake Midnight”, nel graduale svelarsi di reami lastricati in tenue, malioso vintage digitale dai toni cristallini, con corredo di chitarre sublimi e orchestrali affabulati (“Fable of a Silver Moon”, “Pure joie de la solitude”, “In My Heart, a Strange Attractor”).
Le utopie e i traumi del vissuto dialogano ancora con noi, nel levigato splendore tecnologico del presente. Ne scaturiscono collage musicali costantemente ibridi, permeati di altre immagini e textures multiformi (l’affascinante “Nocturne for Norwood”, in enigmatica chiusura d'album), tali da far assuefare in esse. La forza di gravità si annulla, la materialità è prosciolta, l’emotività è a nudo.
Questo tripudio strumentale, per paradosso enfatizza profondi silenzi, delimita luoghi interiori.
Un massimalismo che mima silenziosi cori angelici nel continuo, magico mostrare e scambiare elementi dall’informe groviglio cosmico digitale. Intrigante al punto da preferirsi ai vocalizzi concreti di Jonathan nel precedente album, un Icaro quasi in ostruzione all’artificio di spazi e tempi evocato dagli strumenti, ai loro complessi giochi di prestigio.
Non è la prima volta che Mercury Rev si cimentano in un’opera prevalentemente strumentale, c’era stato ad esempio il suggestivo trip ambient-psyche pubblicato a nome Harmony Rockets (“Paralyzed Mind of the Archangel Void”, 1995 Beggars Banquet), un concept surreale sulla persistenza lacerante della memoria.
“Strange attractor” nello specifico raccoglie brani intenzionalmente lasciati non..incompleti ma sospesi, come dichiara Jeff Mercel, tastierista e batterista del gruppo, “open ended”, come il finale di alcuni film, tesi verso una soluzione “probabile”, eventuale.. e non certa; fatta immaginare all’ascoltatore, estendendosi nella sua mente.
Un lavoro catartico per il gruppo, un’autoanalisi liberatoria a vent’anni dalla propria costituzione e resa omaggio, non si dimentichi, a chiunque, il quale ricavandolo dalla rete potrà apprezzare nuovi impulsi, volute e mutazioni di questa formazione "…So Unpredictable".
MERZ
Moi et Mon camion (2008)
Un incipit di lesto, leggero fingerpicking che fa tornare alla mente un eremo di Penguin Cafe Orchestra di Simon Jeffes, inquadra e allestisce un acuto senso di rimpianto in un leit-motiv che non è altro che un passionale, rapinante, dolente anelito angelico.
È la piccola, traumatica magia ordita da Conrad Lambert sulla title-track del terzo atto di Merz, “Moi Et Mon Camion” che apre ed estende una strada virtuale senza argini, senza limiti.
Questa sedante pasta astrale tornerà sovente sul declivio a estasiare e sbigottire, letteralmente (“silver moon ladders”, “cover me”, “the first and last waltz”), lampeggiando celeste qua e là secondo capriccio, rischiarando a giorno un’opera la cui costante maestria si colloca e si misura in un equilibrio soprannaturale di ingredienti.
Un talento autentico e insolito nel dosare, intimare il proprio flusso emotivo candido, tenue e pregnante, senza che esso soverchi despota affogando, come in tanti autori, in un lamento-flusso flebile, vuoto e narciso, estinguendo una lucida, costosa razionalità e le proporzioni umane del discorso.
Esaltando fogge e sfumando contorni in un certosino e sofisticato vivaio di minuzie, Lambert si parte ancora, inconsolabile e solitario, senza piantare radici, traversando, percorrendo l’atmosfera nel suo veicolo corazzato di glassa amara e salsa, residuo di lacrime; tanto più coriacea e inscalfibile in sé quanto più innanzi procede intrepido e senza panico.
Si può concedere un paio di stop a grill antidepressivi ‘fuori percorso’, senza mai annacquare (“shun”, “lucky man”), del resto cauterizzati all'istante non appena la pasta si rimmerge in quel talamo con l’alma notturna sconfinata e materna, aspirando miraggi soffiati nel vento, nucleo e nodale del discorso.
Struggente immagine di irreversibilità delle cose, di scomposta bellezza sfiorita; di coscienza e disinganno sottile che allerta e ferisce. Riecheggia l’alito Drakeiano, e Mark Oliver Everett e Fred Cornog, non a caso altre “anime senza impronte”..
Microdisney - Everybody Is Fantastic (1983, Rough Trade)
“I Microdisney vivevano della strana distonia fra musiche compitissime, seppur scarne di Sean O'Hagan, e le parole di grande impatto (e cattiveria) di Cathal Coughlan”.
Questa impeccabile, sintetica descrizione è di Alessandro Calzavara.
Essa, opportunamente sottratta alla cattività di Google, è ben connotativa: il duo irlandese Microdisney fu tra i primi tra 1982 e '84 a ordire uno scontro devastante tra gioco pop e cruda realtà sociale.
Il senso di straniante iperrealismo di liriche scomode, disturbanti, incendiarie, s'accompagna come nulla fosse a funzionali partiture melodiche, va detto ancora parecchio acerbe, del giovane Sean O'Hagan che ritroveremo poi in High Llamas, demiurgo dello studio di registrazione, impareggiabile emulo di Brian Wilson e Van Dyke Parks.
I'll wreck my social life/They'll disinfect my chair and/Claim some uncivil rights. (...) There's nothing wrong with me/I am just wonderful/I've got pop songs to keep me calm/And faithful friends like you.
("Rack")
Gli strali lirici di Coughlan (dall'89 anima di Fatima Mansions) a braccetto con tastiere syntpop, assimilabili per forma agli esordienti coevi The The o agli Smiths di lì a poco.
“Everybody Is Fantastic” può inserirsi tra gli esempi di immarcescibile indiepop '80, pertanto passibili di riscoperta.
MIGALA - Arde (2001)
Migala, più
che un semplice gruppo di musicisti è un ensemble di romantici, nostalgici
visionari, suggestionati dalle più svariate contaminazioni artistiche: poesia,
cinema, pittura.
Ogni brano del loro terzo album, Arde, è dotato di uno spirito che sa farsi
veicolo di memoria, immagini e rappresentazioni; contenitore di emozioni e
tradizioni.
I testi di Abel Hernandez e occasionalmente Diego Yturriaga sono interpretati
o recitati con densa partecipazione, rendendo ogni momento infinitamente ricco
di anelito misterioso e intensità assoluta, che spesso difettano in analoghi
rappresentanti dai quali Migala ha tratto ispirazione. Un deciso passo avanti,
quindi.
La musica si fa gravida d'immagini, segni e visioni rivelatrici che a volte
sfumano nella nebbia, a volte avanzano con vigore e sembrano aggredirci per
il grande bagliore, energia vitale, e si espandono a macchia d'olio, su una
immensa tela immaginaria, dai confini non stabiliti; a realizzare un mosaico,
un panorama variopinto, dai richiami complessi, che brilla di colori vividi,
scintillanti, così reali da sembrare in movimento.
MIRAH - Advisory committee (2002)
Ideale fratello (o sorella) minore, intimista, dello smarrimento, e dell'alienazione
rurale di "The Glow pt.2" di
Microphones, uno dei capolavori del 2001, il cui autore (Phil Elvrum) è
qui a dirigerne gran parte. Secondo disco di Mirah, più compiuto e
maturo del
precedente. Elvrum e la protagonista più altri collaboratori si alternano
a ogni sorta di strumento. Certi innesti elettronici vocali e strumentali
filigranati ingentiliscono e smussano, personalizzano il progetto. Ambienti
autunnali, oscuri e desolati, riflessi del proprio intimo spoglio,
nei quali la protagonista ritratta sprofondata sul proprio letto inerme, debole,
sembra confondersi fino ad annullarsi."We found the way we found the
streets, directions sweat under the sheets".
MORAL
And life is... (1983, 84)
Un album segnato da un macerante senso di rimpianto, percorso in ogni traccia da un’inestinguibile emorragia passionale.
Tormento è l’esatta cifra stilistica, il tratto quadrante di Moral, fugace trio d’autori danese vissuto il lasso d’una stagione.
Una squilibrante tristezza trapela lenta e si insinua inesorabile nelle maglie di suono, l'apice nella straziante elegia ‘dance of the dolls’, autentico turbine emozionale in cui l’alma muliebre oppressa si divincola e sospira sconsolata, in un mimo di pianto.
Una scevra architettura synt e la rigida essenzialità strumentale accentuano il fondo di solitudine e favoriscono l’empatia. Il canto ‘stream’ triste e spontaneo, conturbante e misterioso di Hanne Winterberg è il continuum, il tratto più tipico con la sua ansia montante; un richiamo costante d’ineluttabile e transeunte che condensa l’emozione e catalizza l’ attenzione.
I Moral furono una claustrofobica e terminale reincarnazione di Young Marble Giants, un volgere arreso e dannato all’eterno cospetto di una risacca. Una gelida espiazione dal torrido eremo di Sant’Elena.
MR. FINGERS
Introduction (1992)
Un’inebriante pienezza di sensi soul, r&b convoglia e sfocia nell’oceano house più mite e concreto che sia dato.
Morbido e stralunato, “Introduction” volge e cospira, lastrica strade, protende vene e arterie, l’oceano si ricongiunge al cielo terso. Una luce radiante appare dopo un vortice disperso.
Disorientante, imperturbabile lignaggio, “Introduction” semplifica accrescendo intensità. Un “killing me softly” nella tangibile e testarda malinconia dell’interprete, il colore dominante che dissolve costante, lieve e grave, su ardenti azzurre landscapes di tastiera. Che versa e scoppia in cori muliebri spasmodici, folgorante addizione, mimo di frenesie metropolitane e intense solitudini; di aneliti infiniti sospesi, di follia e non già disperazione.
Quest’opera commovente sino al disarmo, sino al disturbo (“what about this love?”), ricava e anima colori accesi e umori cupi in un gioco tormentoso e insoluto di seduzione e distruzione. Smalti da un’argilla sonica attinta da modernissimi segni ‘cool generation’ inglese, da echi e memorie struggenti di nebbie blues, funk e disco, che echeggiano e vessano in profondi recessi un’anima lacerata, ostaggio del rimpianto.
Introduzione, ingresso, biglietto sola andata, coercizione fatale, resa ultima, soffice veleno. Senza uscita o soluzione.
Back to Love (1994)
Non male, ci sono brani come la splendida Angel Eyes, con quelle schiarite quasi Steely Dan, anche se la magia 'stardust' del precedente album così munificamente elargita pare un pò essersi dissolta al sole torrido che evocano molti passi di questo bis-solo di Fingers.
Un onesto soul-pop (di house pura ce n’è davvero poca ma non certo un disco da boy band come ho letto), che tradisce però nei momenti in cui serviva il colpo d’ala decisivo (‘I Care’?). Comunque Fingers rimane un artista unico e geniale.
(Fabio R., 2009)
MR WRIGHT
Ovvero Kevin Wright (ex Always) and review, Alec Dippie e Toby Robinson. La
musica é una miscela poetica di depressione e disincanto, senza l'esibizione,
il profluvio orchestrale, il dandysmo d'altri.
The Fancy Man (1999)è l'ideale prosecuzione
di un disco dei Pulp o di Divine Comedy, e a volte sembra che Mr Wright sappia
mettere a fuoco un malcontento restandone al di fuori, ma senza distacco,
non costruendo necessariamente concept. Dei lavori pubblicati a proprio
nome il capolavoro é senza dubbio rappresentato dal detto The Fancy Man, impeccabile gioiellino cantautoriale contro.
Music Improvisation Company (Ecm 1005)
1969-70. Un quartetto formato da Evan Parker al sax soprano, Hugh Davies a synt, Derek Bailey alla chitarra più Jamie Muir alle percussioni.
Chi conosce le gesta di ciascuno dei protagonisti ben può vagheggiare questa musica, a maggior ragione quando si rimarca il precetto: Because any written score or even verbal arrangements are taboo, the group relies exclusively on spontanious actions and reactions among all four players.
E ancora: no tonality, no repitition, no melodic continuity, no periodicity, no system.
Eppure questa musica pare dar vita a un organismo. In tutta la durata dell'album, si assiste all'equivalente di un magma stagflazionato in milioni di microparticelle-lapilli (sax e percussioni). Emancipazione assoluta degli strumenti rispetto al contesto eppure concorrenti entro il contesto, ubiquità in note che spruzzano via, molecolari, una sorta di tappeto estatico, abbozzato con grande abilità dalla complicità sotto cute dei quattro, nell'happening sonoro.
Mystic chords of memory- s-t (Rough Trade, 2004)
 Il nuovo progetto del polistrumentista Chris Gunst omaggia nel nome Abramo
Lincoln, propone un folk-pop informale e bizzarro, di ispirazione psichedelica,
marcatamente melodico come altrove (Beachwood Sparks, All Night Radio, Tyde)
ma decisamente più spontaneo, imprevedibile, libero da schemi. Chris è assistito
da Ben Knight a chitarra e canto, Jen al basso e Scott Coffey al violino.
Il nuovo progetto del polistrumentista Chris Gunst omaggia nel nome Abramo
Lincoln, propone un folk-pop informale e bizzarro, di ispirazione psichedelica,
marcatamente melodico come altrove (Beachwood Sparks, All Night Radio, Tyde)
ma decisamente più spontaneo, imprevedibile, libero da schemi. Chris è assistito
da Ben Knight a chitarra e canto, Jen al basso e Scott Coffey al violino.
E'indubbiamente una stagione prolifica
per la folk-psichedelia pop. Tutta una serie di album stanno variamente recuperando
il respiro una stagione lisergica perduta nelle nebbie dello spazio e del
tempo.
Questo "Mystic chords of memory" è fatto di melodiche emulsioni fatte in casa
a base di corde, armonica, tastiere, samples; serene armonie vocali e naturalmente,
effetti d'ambiente. La sensazione è vorticosa, penetrante.
Una condizione immersiva e densa, che tende ad annullare ogni residuo
artificioso, senza quasi "trucco" e costrizione, spingendo a identificarsi
con naturalezza, sprofondando con gli astanti nella georgica (immaginaria?)
landscape.
Un verbo affine a quello diffuso da Glenn Donaldson coi suoi numerosi progetti
(Skygreen Leopards, Birdtree, Child Readers), le cui quiete, sottilmente ansiose
esplorazioni visionarie, e le colorazioni armoniche subconscie e magmatiche
tornano qui, assieme a consonanze Syd Barrett e Nick Drake.
Albe raggianti e innocenti come "golden dome" e "open end", spazianti pulsazioni
folk pop senza età come "berry creek falls", "like a lobster", e "sure, bert"
cercano appassionatamente un dialogo libero di energie e meccaniche, euritmie
di elementi, un'armonia panica concatenante ("pi and a bee").
Difficile non invaghirsi.