C
CALIGARI A Full Moon Postcard
Caligari è il progetto di Dennis C.Kane voce, chitarra e compositore
dei brani, assieme a Gene Diotalevi bassista, Della Leffler
a tamburi e tastiere e Dave Svrjcek e Bill, percussioni e drum
machine.
A Full Moon Postcard è la summa artistica raccogliendo brani editi
da Ep cassette Caligari, Routine, Muffled Conversations, Resolution, Magnetic,
più inediti.
Il loro sound ripercorre il pop rock degli anni ottanta britannici con cadenze
incalzanti di basso e chitarra e più di una suggestione creativa derivata
dal Kraut Rock e cosmici tedeschi.
Corposi organismi psichedelici, trame ricche e complesse, atmosfere ariose
e cariche di tensione, profonde e avvolgenti, a volte tenebrose e inquietanti,
predispongono un particolare senso di attesa e di sospensione.
Straordinaria in questo senso la space-suite di Curtains going down
e Resolution #1. Si rianimano spiriti new wave Killing Joke, Cure,
Teardrop Explodes.
Si odano brani sorprendenti come It's out of my hands, Lose all intimacy,
Soma, Real life, Ocean, Psyche, Cast.
(agosto 2003)
Cardinal
(Flydaddy/Dedicated, 1994)
 Uno sposalizio artistico destinato a non durare, quello tra Richard Davies, chitarrista ex Moles e il polistrumentista Eric Matthews.
Uno sposalizio artistico destinato a non durare, quello tra Richard Davies, chitarrista ex Moles e il polistrumentista Eric Matthews.
Fu incontro fulminante incendiatosi in dieci canzoni e un disco, che dunque più d'ogni altro ha mosso a rammarico, per la bellezza dell'atto creativo di due figure d'eccezione.
Cardinal fu il cospetto d'un risveglio: il pop più nobile d'impronta camerista (trombe, marimba, piano, organo) in mirabile colloquio con mitigate spartanità acustiche, budget irrisorio (da qui il ripiegamento su tastiere per alcuni arrangiamenti).
Sulla copertina, i due compositori avvolti in un luminoso biancore, coi volti accesi dal sole attraversano giardini di tradizione: Paul Simon, Brian Wilson, Cat Stevens, primi Bee Gees.
Un'immagine ottimista che evoca aspettative. Eppure quest'alba è già tramonto, è caldo e anche freddo.
Inquietudine e disillusione tutto intorno come presentissero la conclusione irrevocabile.
La solenne pacatezza melodica di Davies accentua in giusta misura toni patetici e dolenti. Pur solari, le sue composizioni s'annoverano tra le più struggenti e malinconiche del pop recente. Memorabile l'immediatezza di timbri vocali "noti", la condizione umana è osservata con compassione.
“If You Believe In Christmas Trees”, “big mine”, la beatlesiana “silver machines” ma il posto a presiedere lo merita la solenne inarrivabile dedica “you've lost me there”, in cui la vibrante partecipazione emotiva ricolma un baratro di angoscia.
Matthews si rivela all'altezza del compagno nei delicati panneggi di “dream figure” e “tough guy tactics”, che anticipano venture sortite soliste.
(feb. 2005)
CARETAKER
Persistent Repetition Of Phrases
La formula di questa musica viene spiegata nella pagina introduttiva del sito del gruppo, come meglio non si potrebbe: “Dusty and forgotten memories, echoes and vibrations from the past. Using as source, recordings from the 1920's and 1930's era of Ballroom music”.
Un viaggio inquieto attraverso detriti melodici, nei confini della memoria. Eppure, “Persistent Repetition of Phrases”, così come i precedenti lavori di The Caretaker, alias James Kirby (di cui citiamo almeno “Deleted Scenes / Forgotten Dreams” del 2007 e l'onnipotente settuplo “Theoretically Pure Anterograde Amnesia”), resta lungi dal chiarirsi in poche, pur significative parole. È sì, musica essenzialmente di sampler, loop, ma decontestualizzata, plagiata in un cupo romanticismo atmosferico, ricco di senso di presentimento. Si tratta di musica dissociata, appare dunque stranita ed estesa in vastità e viluppi d’ambient remoto e ovattato, finanche a lambire sfere soprannaturali.
Questa singolare situazione musicale volge a favorire un clima sospeso e sfumato, sottilmente angoscioso, atavico, senza nome, in grado di evocare mistero. Lo spazio è incerto, luminoso e astratto.
Le selezioni strumentali, apportate da Kirby setacciando remoti anonimi vinili d’anteguerra a 78 giri incantati su grammofoni gracchianti, offrono una magnetica seduzione in lente e avvolgenti spire in moto perpetuo. Un percorso spettrale, un viaggio addentrato in patologie mentali incurabili e crescenti, oscillando tra dimensioni diverse, tra anelli di perdizione.
Quasi come nel lucente e illusionista sfacelo progressivo delle “Disintegration Loops” di William Basinski, s’è dolcemente narcotizzati, spenti in maglie di suono di “rimosso”, come a vivere un “inferno circolare” tra illusione e realtà; un eterno ritorno fatale e forzato (“Rosy Retrospection”, “Long Term (Remote)”, la title track ecc.).
Un mito di Sisifo surrealmente rivisitato in “Haunted Ballrooms”, calato nella festa di fantasmi dell’Overlook Hotel, in “The Shining” (nel quale, a proposito viene detto al protagonista: "You’ve always been the caretaker!"). Silenziosi e soffusi movimenti orchestrali scandiscono fissati in ciclo, ciascuno per brano, con l’aggiunta sapiente e costante, sottile e ragionata di impercettibili varianti (di mixaggi, noise, screzi glitch di strumento... ”Unmasking Alzhiemer's”); a sancire il carattere esclusivo e particolare di ogni nuovo altro passaggio.
L’autore (noto anche come V/VM), il cui lavoro ha suscitato l’interesse di John Peel, è affascinato dalle strutture psichiche e dal processo mnemonico (un’autentica ossessione, come attestano mole e cadenza del suo lavoro); incuriosito dalla patologia mentale, in particolare l’amnesia e l’alzheimer. Nella propria arte cerca corrispettivi ideali, corti-circuiti atmosferici impressionistici che rimpiazzino il razionale, la capacità ritentiva, l’attività della mente “sana”; egli fissa, gela l’ambiente in perpetui incantati, invischiati, stregati in limbi di dannazione, anticamere dirette della demenza.
Sulla copertina, opera dell’artista Guy Denning, luce e ombra colpiscono un volto androgino intensamente assorto, accentuandone il turbamento e squarciando ogni certezza.
(28/12/2008)
Caroline - Murmurs - Temporary Residence 2006
Tra Okinawa, Giappone e la neo residenza californiana, ecco filtrare un altro ineffabile abbaglio cinetico.
Un'incantata e incantevole nuova protagonista di nome Caroline (e di cognome Lufkin) ascende a divampare luminose candele, promesse pop minimal digitali, nel Cd d'esordio “Murmurs”.
Dunque, mormorii melodici, “flou”, i suoi, dolcissimi e ineffabili, tale è il non peso che si percepisce via strumenti, acustici e numerosissimi di cui dispone la protagonista ('pianos, harps, bells, guitars, strings and hand drums' riferisce la pagina dedicata all'artista), abilmente camuffati in toni bassi quasi pulviscolo e senza ausili sovrastrutturali.
La musica quasi dissolve, retrocede a cellula in funzione dell'anima candida dell'artista, di una voce che sfalda e ricompone intorno ad ossessioni in soffice desolazione, mai narcisa o increspata. Quasi una Bjork bambina (ma il sito 'brainwashed.com' cita sapientemente Minnie Riperton), con un proprio risoluto misticismo 'twee', luminoso e incontaminato (“Everylittlething”, “I'll Leave My Heart Behind”), che descrive e allude, parlandoci immersa nel fiume solare della propria fantasia iperbolica.
Oltre a “Where's My Love” già singolo nel 2005 in copie limitate Temporary Residence, che solo un nonnulla in più concede a un'inalveata bendisposizione, si segnalano per avvenenza illesa il luccicante spleen nel lento incedere blue di “Bicycle”, lo strepitoso brano che inaugura l'album; poi a seguire gli impulsi e i percorsi di “Drove Me to the Wall”, “pink & black”, “All I Need”. (mar. 2006)
CASIOTONE FOR THE PAINFULLY ALONE-
Answering machine music (1999-2002)
Concepito nel 1999 e pubblicato tre anni dopo per la polimorfa TomLab,
sfruttando una coincidenza più opportuna di tempi e mode. Tra le nuove
forme d'arte musicale del nuovo millennio impera il glitch pop,
fenomeno dalle grandi potenzialità espressive, una maniera di descrivere
sensibile e umana, trasdotta dalla macchina. Ogni cosa in questo microcosmo
si può elaborare ancora, diversamente, si può tradurre in elemento
altro, si può associare al proprio opposto, continuativamente.
Casiotone propone una dozzina di micro sinfonie digitali acustiche zippate,
raggrumate anche in termini di durata, che non superano due quarti d'ora,
ma che espongono in maniera esaustiva e definita sentimenti di infelicità e di isolamento; traspare e regna una solitudine panica, costitutiva, da cui
non si pretendono escapismi o espiazioni.
Attraverso una maniera particolarmente toccante di disporre oscurità
e delicatezza, uno dei neo-pionieri più interessanti del genere inquadra
e descrive un acuto mal de vivre, disponendo queste nenie di un significato
peculiare. I suoni e i rumori appaiono come disposti in verticale, metafora
di barriere della comunicazione interindividuale, sembianti della "difficoltà" nell'ipocrisia e nella diffidenza reciproca.
(2002)
THE CAT'S MIAOW
Un
gruppo di neozelandesi votato al bozzettismo pop più impressionistico,
atmosferico, umorale, en plein air, inesorabilmente malinconico e languido.
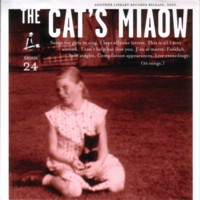
Spesso le canzoni risultano solamente abbozzi, inizi mozzati, della durata
inferiore al minuto e mezzo ma non rinunciano a una certa orecchiabilità.
Con questi ingredienti si é data luce a tutta una serie di ep e dischi
raccolta, che arrivano a contenere più di trenta canzoni l'uno, alcune
di esse rivisitazioni e variazioni sottili di altri brani. Quanto basta per
trasmettere un'emozione veloce, afferrare, percepire un sentimento passeggero
semplice e quotidiano, mai eccessivamente patetico, comunicarlo (già
un pò tradendolo) nell'attimo fuggevole in cui lo si vive. Questo può irritare ed eccitare allo stesso tempo.
A
ben vedere Cat's Miaow realizzano canzoni anzitutto per se stessi,
schiette autoanalisi, indagini interiori, un accorato intimismo imprescindibile
dall'abito minimalista che veste. Avrebbero ogni capacità di disporre
questi brevi interludi del formato canzone più rispondente e di acquisire
una notorietà (che presumibilmente temono), tuttavia ancora preservano
questa umile maniera, di cui possono ritenersi anche inventori.
Quello che si guadagna è un tipo di onestà che apparteneva a Belle And Sebastian dei tempi migliori della prima serie di immacolati dischi
ed ep (oltre ovviamente a un autore come Nick Drake). Una sincerità
effettivamente preziosa perché rara quanto efficace: la confidenza
nell'istante particolare, colta come fragile anima senza impronte (per
dirla con Luca Ferrari), l'innocenza e il candore in un rilievo fulmineo e
fatale, che ad altri sfugge, indagatori più prolissi.
(dic. 2002)
CHAMBERPOT
Il quartetto Chamberpot è fautore di un tipo di improvvisata mossa tra influssi free-jazz e gesti da camera.
Il gruppo nasce a Londra dal violinista Philipp Wachsmann, detentore della neonata etichetta Bead, assieme a Richard Beswick a oboe e oboe contralto (corno inglese), Simon Mayo al clarinetto e Tony Wren contrabbasso.
Le traiettorie musicali inquiete e vertiginose sprigionate da questo vinile, sono indicative del catalogo Bead (label ignorata per i pochi mezzi a disposizione, ferma alle stampe viniliche, sorta di Incus minore), quanto mai foriere di teoremi, impulsi e ipotesi di forma, aperta e sintetica, per l’improvvisazione di quegli anni straripanti, il cui flusso incede, ininterrotto e protervo ad oggi.
“Chamberpot” (Bead 2) privilegia i timbri di strumenti della famiglia di legni e cordofoni, costituendosi di dialoghi posati o schizoidi, fragili efficaci tensioni. Di reazioni e agoni simulati tra strumentisti, che spezzano ad esempio uno stridulo e capriccioso soliloquio di violino per sboccare in un dialogo acceso di clarinetto, o entro un fondo erratico di contrabbasso o ancora in densi panneggi d’oboe..
Oppure rovesciandosi assieme in ritmo convulso, saturando lo spazio della performance.
Accenti diversi e contraddittori, mimano agili, gravi, pieni o in singulti, spazi e tempi di mondo, in limpide ascese o in vorticose scalate, osservandosi come in estasi o scagliandosi in zuffe repentine, secondo struttura o in improvvisazione.
Che sia un brano unico (i 20’ del lato A), il cui complesso habitat è generato e perlustrato in più ipotesi, come magnetico flusso ininterrotto, o che siano forme spezzate dal respiro più contratto, di inequivoca terminologia ma d’ambito avulso e presunto, nervosamente avvertito (‘huge’, ‘new’, ‘scare’, ‘hits’, ‘city’, lato B).
 The Charlatans - Some Friendly (Beggars Banquet, 1990)
The Charlatans - Some Friendly (Beggars Banquet, 1990)
Questo quintetto di Norwich a base di strumenti retronuovi e voce e cori adamanto, ravvivò quello spirito acid-rock tipicamente anni sessanta e filosoficamente coagì col corrente movimento “Mad-chester”, indolente e narcotizzato, di fine ottanta.
Così, col suo pop intrigante, questo esordio “Some Friendly” dipinge la propria epoca come pochi altri dischi in circolazione.
Il retaggio di The Charlatans è chiaramente “Stonesiano” -Rolling Stones, Stone Roses-, ma affiorano anche talune consuetudini di Happy Mondays.
Il crooning accattivante di Tim Burgess è assiduamente assistito, imbevuto fino all'amalgama, dall'organo esotico tardopsichedelico e dalle tastiere sgargianti di Rob Collins (poi scomparso in un incidente stradale nel '96); dai trascinanti chitarrismi jangle più effetti wah wah funkizzanti di Jon Baker, da un efficace basso di Martin Blunt, memore a volte di lezioni nuorderiane, e dalla sezione ritmica di Jon Brookes.
I cinque compongono un'alchimia melodica surreale di raro trasporto, in grado di ispirare continue pulsioni estatico-danzerecce.
Se “White shirt” riverbera senza equivoco quella “Waterfall” capolavoro di Ian Brown e soci, sul riciclo dei floreali tribalismi pop straboccanti da “you're not very well”, "spronston green" e “believe you me” si baserà la supervalutata carriera di gruppi come Kula Shaker di Crispian Mills.
(primavera 2005)
CHEER-ACCIDENT Fear Draws Misfortune (2009)
Sorta di nuovo esordio targato Cuneiform per Cheer-Accident. Il leggendario gruppo di Thymme Jones è determinato come non mai e sfodera una prova di corposa, esuberante, smagliante creatività. Un mare magnum che scorre senza soluzione di continuità tra flutti prog-jazz, chitarre vulcaniche e percussioni marziali. Forme e organismi visibilmente RIO che non rinunciano alle scenografie da Chicago ’90, reticolato allestito in squame noise-rock, ora ariose ora oppressive; o le tipiche ascese in fade-in tra drumming motorio, nodi di chitarre, corni e ottoni, sequenze di piano cupo. Ovvero, quanto di originale e distintivo espresso in capolavori del passato come “Not A Food” (“Disenchantment”).
In quasi sei minuti di vibrante maelstrom strumentale, l’apertura “Sun Dies” è un mirabolante pezzo di bravura che modula un clima da cabaret tra orge di chitarre ispide, drumming in foia e chimere in straniti vocalizzi acuti che s’ergono su tutto. Fa eco il pastiche dadà frazionato in “The Carnal, Garish City”, mentre altrove l’espressionista “Blue Cheadle” volge e riduce le gamme cromatiche estendendo di contro i baccanali strumentali prima di sprofondare, con una bava di violino, nella eterna riconciliazione del fade-out.
In altrettanta brillantezza cala l’album, nel lungo totale surreale “Your Weak Heart”. Un bizzarro vagheggiare teso e paranoico, ora melodico e sonnambulo, malinconicamente sospeso sulle note di un tintinnante minimalismo, ora tragico e atonale; il tutto seguendo un’inesauribile immaginazione. Pattern sonico-mnemonici (piano, batteria, synth, chitarre, fiati) avvicendandosi paiono liquefarsi per poi ricostituirsi inopinatamente, nello sfondo di un dipinto di Dalì.
Aspirazione di molteplicità, anelito di un totale empirico attraverso la lente dell’assurdo/inconscio, ove mutuare fantasie e astrazioni, miniature rigogliose e traumatiche e cubismo sonico. Nuove percezioni ottenute anche grazie all’allargamento (camerista) del combo. Giochi che oscillano in una nuova luce fondendo i propri profili, in uno spazio figurativo in equilibrio tra contrappesi architettonici e intersecazioni di piani, che è vano sperare in un gruppo di quelle latitudini. (Fabio R., 2009)
The Chills - Submarine bells (Slash, 1990)
 Album chiave del pop neozelandese d'ogni età. Il quartetto Chills è capitanato dal chitarrista Martin Phillips, ex-Same, compositore e arrangiatore sulle orme dell'inglese Robyn Hitchcock e dei georgiani R.e.m., ma anche seguace delle primordiali formazioni "indie" pop-rock sbocciate nei primi '80 assieme alle correnti new-wave.
Album chiave del pop neozelandese d'ogni età. Il quartetto Chills è capitanato dal chitarrista Martin Phillips, ex-Same, compositore e arrangiatore sulle orme dell'inglese Robyn Hitchcock e dei georgiani R.e.m., ma anche seguace delle primordiali formazioni "indie" pop-rock sbocciate nei primi '80 assieme alle correnti new-wave.
Concepito nel 1989, “Submarine bells” è un vero e proprio knock-out melodico, forte di inni indiepop inauditi tra cui la straordinaria “Heavenly pop hit”; “Tied up in chain”, “Submarine bells”, “Effloresce & Deliquesce”, composizioni i cui artefici raccomandano di ascoltare a volume sostenuto, sì da sfoderare tutte le gradazioni e l'energia psichedelica di cui sono capaci.
I timbri di Chills, così riconoscibili ed equilibrati, scaturiscono dalle squillanti e sapide trame di chitarra di Phillips (“Don't Be - Memory”) e dalle tastiere evocative, talvolta ombrosamente wave, talvolta morbidamente vistose e barocche di Andrew Todd; introspezioni da autori folk che mimano organi e omologhi del softpop-psyche dei tardi anni sessanta (“dead web”).
Non manca qualche esempio di armonia più asciutta e aggressiva ritmicamente: valgano “Singing In My Sleep” e “The oncoming day”, alla causa.
Una raccolta intrigante tra varietà di registri eleganti e maestosi, lucenti e vivaci, come la “jellyfish” di copertina.
(estate, 2005)
Texas Working Blues
Può una tale, intransigente semplicità di forme corrispondersi un ottundente senso magnetico?
In questo "Texas Working Blues", secondo lavoro del 2008 concepito in magnifica solitudine (ma è già in arrivo il nuovo “Two Nights Film”), Christina Carter imbraccia la chitarra elettrica ed esplora e svela nuove inviolate intimità, attraverso la vecchia, torbida psichedelia in chiave indie, tra libera improvvisazione e schema.
L’autrice si riconsegna artisticamente agli sconfinati recessi rurali del blues texano, secondo la maniera di Loren Chasse e Glenn Donaldson, i due mentori dell’etichetta specializzata in sottobosco folk-ambient psyche “Jewelled Antler”.
Ed è come se voci e suoni prendessero vita e condizione in sé: questo album offre una miscela musicale continuamente estesa in molteplici e controverse fisionomie, dagli esuberanti risvolti cromatici.
Fermezza e trasporto, sottile acuto disagio e fragile equilibrio screziato di torpore marcano purissime le sortite di Christina, offerte a noi come illuminanti e suggestive sedute di autoanalisi.
In questo torrido e femmineo resoconto di sconosciute pulsioni della natura, di percezioni misteriche, di eterne fughe dall’ombra, si allertano gli stessi sensibili, liquidi panneggi da meriggio terso e surreale di Loren Connors: il giovane e malinconico innamorato, infuso dalla “musa” Kath Bloom, avvampa ogni luogo emozionale.
Quasi sottratte a quella stessa ispirazione (ad esempio, la panoramica inquieta di “Bird’s Nest”), le sei tracce di "Texas Working Blues" si svelano nella voce sfiorante e disperata di Christina, scandiscono albe irrisolvibili e vespri sprofondati in un’asfissiante eternità (“Pale Rose Cream”, “Dinner Plate of Dust”), nello stesso modo in cui l’artista surreale si immaginava dentro le proprie opere: null’altro, non più che macchie di colore dissolte e indistinte in embrionali luoghi desertici. Simbolicamente spossate dalla tenacia e dall’erosione della memoria.
Come trovandosi nell’isola di Ulisse, in cui la Carter recita una Circe straziata e tra i singulti, la chitarra elettrica figura e panneggia pattern solipsisti, luoghi ultimi d’espiazione e assieme anelito (il lamento sommesso di “The Outer Planet” vagheggia atmosfere esotiche e allerta un disagio straziante, torbido e malsano).
Il canto over-dub talvolta aggiunge fantasticamente sfondi narrativi, assieme attenua (o calca..?) solitudini e distanze (“Preserve Our Face”, “A Blind Eye”).
Si agitano parvenze opalescenti, mimo di ostinate, recondite solitudini (che simbolicamente l’autrice dedica e affida alla stagione estiva), incrollabili intimità che vagheggiano ineffabili aspirazioni e rimpianti.
Lavoro erogato in sole duecento copie hand-numbered in cassetta dall’ultra-indie label Blackest Rainbow (che già annovera in catalogo artisti del calibro di Talibam!, Pocahaunted, MV&EE, Sunburned Hand Of The Man); "Texas Working Blues" è già fuori stampa, affascinante quanto raro.
Ci si augura pertanto una sollecita ristampa digitale che trascenda velleità narcisistiche, cerchie privilegianti di pochi appagati fan.
Masque Femine
"Masque Femine" è un’opera sperimentale in cd-r a tiratura limitata (80 copie) e incisa in un paio di sessioni tra gennaio e febbraio 2008. Seconda emissione della Carter in quest’anno, dopo il trasognato e avvolgente “Texas Working Blues” (Blackest Rainbow), del quale costituisce ideale rovescio e completamento. Qui Christina esplora pudica e sfuggente, turbata e discreta, quasi in imbarazzo, recessi inviolati della propria intimità recondita.
Dagli auricolari parrebbe proprio accanto a noi, ma la sua voce, rotta e bisbigliante, piena di tensione emozionale rappresa, comunica da una distanza interiore, presa nelle spire di una solitudine incrollabile.
Un senso inerme d’abbandono è espresso dai fiochi ectoplasmi vocali, i soli a esprimere l'interprete in questo concept, escludendo qualche overdub, echi ambientali e rade pennate su accordi acustici (in cinque dei diciassette frammenti), con cui mestamente la Carter traccia, in forma di nenie tenere e cantilenanti sospiri, piccoli poemi autografi e standards jazz/blues.
Forme sottili e impronunciate, un po’ come realizzò Derek Bailey con la sua chitarra nei due album “Ballads”, 2002, e “Standards”, 2007 (entrambi per Tzadik).
Riletture libere e personalissime dunque, in questo cd-r per fan in cui l’autrice, mani sul cuore, si restituisce identità ed affermazione. Abbozzi elegiaci “di desiderio”, simbiotiche scoperte interiori che si richiamano a conforto, avvolte e assimilate da silenzio e desolazione.
Recessi e anamnesi di Patty Waters riaffiorano come virgulti nei repentini luccichii di “Quiet Nights”, ma soprattutto inclinazioni Jandek, altro texano e altro pallino della Carter, ogni dove, specie quello dei tre sperimentali e disturbanti lavori “a cappella”.
La voce della Carter esala flebile e nuda, a tratti rotta, piena di dignità, asservita a un blues quasi esiziale. È recita screziata d’amante smarrita e trascurata, nel suo esporsi non vagheggia che memorie, luoghi del passato in cui rimprovera a se stessa ingenuità e gioventù, diluendosi e scambiandosi, tra riverberi overdub, in un gioco di doppio (“All Alone”, “Blues Are Brewing”, “Looking Back”, ecc..), quasi comunicando oltre il tempo, ripristinando quel tempo, rivolgendosi a chi è assente.
A volte (“So Many Stars”) sollevandosi vibrante e tersa, “la voce” vince e passa l’eremo costretto, fugge il confino, il declivio, liberandosi. Rade, sporadiche, vibranti corde di chitarra a sostegno, quanto più evidenti su sfondi muti, presiedono gorghi ipnotici (“You Will Be My Music”), alleviando mestizie quanto possibile (“Last Night When We Were Young”). Ravvivano un po’ questo ambiente spettrale e smorzato, sospeso e precario
CHUZZLEWIT - Secret affinities (2001)
Greg Prickman è l'one man band che presiede
la sigla Chuzzlewit, ed è fautore di uno dei più brillanti esperimenti dreamy-pop
lo-fi del 2001.
Nessun particolare artificio si cela dietro la sua proposta musicale, la cui
mossa vincente risiede appunto nella semplicità, sincera e cristallina, trasparente
e brillante. Musica che sprigiona essenze agitate e rischiaranti, benefici
influssi, dolci tensioni e illusioni.
Secret Affinities ha quel che di incontaminato proprio degli esordi -nonostante
non si tratti di un vero e proprio debutto-, che inesorabilmente tende ad
affievolirsi con le pubblicazioni successive. Ma l'impressione con Chuzzlewit è che la propria cifra stilistica coincida esattamente con la propria essenza,
e che dunque ne resterà indivisibile, comune destino, imperitura ombra.
Istintivamente avvicinabile a gruppi naif come Cat's Miaow, Plush, o Picture
Center, è sin troppo facile lasciarsi sedurre da quest'opera che sa stringere
a sé attraverso la propria madrigale, idillica, voluttuosa prosa, fatta di
ricami acustici gentili e inconsistenti.
La voce di Greg, fragile e modesta, fuggitiva e lieve, si accontenta di canticchiare
unicamente per se stessa.
Stewart Murdoch dei Belle And Sebastian dovrebbe prendere esempio da gente
come Prickmann, e ricominciare da capo, ripercorrere un sentiero cercando
la propria identità, donata da quell'ispirazione profonda, preziosa e soave,
appannata dalle tentazioni offerte dal successo, dallo show-biz, che adesso
sembra custodita nelle mani di altri guardiani.
Gli apprendisti possono redimere i maestri: regalate a Stewart una copia di
questo disco.
(2001)
Palimpsestial
Palimpsestial raccoglie gli “unreleased recordings” di Chuzzlewit,
di stanza a Chicago, fra il 1995 e il 1999.
Plausibile premessa di Secret Affinities, il brillante esordio per
Alice In Wonder, Palimpsestial rimesta ombre indie psycho-wave statunitense.
L'interpretazione è per proponimento dimessa; una inflessione anemica come
esausta, trascina l'ascoltatore, sprofonda in una morbida trance.
Un “frastuono leggero” strumentale, penombra e turbinio ordito dal profluvio
di ipnotiche trame chitarristiche (per esempio la coda di There's a space
beside you, Narrow among the roofs), dalle tastiere e dai battiti elettronici
(Observatory walk).
Palimpsestial si mostra insieme organico, minimalista e livellato, con una
emotiva surreale essenza.
Una landa di tenui e dissolte armonie, fragili impressionismi, mosaici collaterali
profusi di siderali tremoli psichedelici, field recordings e delicati, onirici
mormorii vocali, ridotti quasi ad amniotici gorgheggi.
Con aggiunti echi ed effetti ambient, portano ad assuefazione narcotica.
(agosto 2003)
CIBO MATTO Viva! La Woman (1996)
La cosiddetta Shibuya scene, ancora
inesauribile in patria, ha ormai da tempo esaurito gli ultimi fuochi in occidente,
e i riflettori sono puntati altrove. Ciò non impedisce all'appassionato
di incorrere quanto vuole in questo territorio, che ha assunto ai suoi occhi
le sembianze d'un museo, sia pure continuamente aggiornato, e che rappresenta
la parte più soleggiata, più rassicurante, la più facilmente
identificabile e docile dunque esportabile, del pop giapponese.
Un florilegio di fantasia, colori, sonorità, abiti, che appaiono come
un tutto identico, quasi a rinverdire, a bissare in un altro ambiente e cultura
i fasti che furono dello Swinging London negli anni sessanta.
La musica delle Cibo Matto è una perfetta riproduzione dei dettami Shibuya-kei. Questo duo femminile impertinente e vanesio esegue un equilibrato
e divertente amalgama trip-pop -definizione, questa, più giovane di
loro: di qui la sensazione di aver precorso un genere- con aggiunta di messinscene
comiche e trovate surreali.
Questo lavoro risulta il più riuscito della loro produzione, ed è giocoso sin dal titolo.
Una raccolta di filastrocche e nenie da fiera per teenager di ogni età,
riprodotte con una strumentazione analogica-giocattolo e corredata di liriche
e gag vocali che più che altro inducono al riso e alla spensieratezza,
e che nella loro consapevole autoironia si fanno ben preferire a simili esponenti
europei o statunitensi del tutto privi e, al tempo sopravvalutati oltre ogni
comprensione.
Allo stesso livello porremmo il seguente ep Super Relax, con una godibile
versione di un grande classico di Antonio Jobim, "aguas de março".
Negli ultimi anni novanta le due Cibo Matto hanno dato vita a numerosi progetti
paralleli, tra i quali spicca una collaborazione per il sassofonista John
Zorn nel suo Taboo and Exile e il lavoro con il supergruppo Butter 08 (s/t, Grand Royal, 1996), un riuscitissimo misto in bassa fedeltà di
Jon Spencer, Pixies e Stereolab.
(nov. 2001)
CLINIC (1999)
 Questo
primo omonimo Lp raccoglie come è uso recente i primi 3 ep
licenziati dal gruppo, per l'etichetta Domino.
Questo
primo omonimo Lp raccoglie come è uso recente i primi 3 ep
licenziati dal gruppo, per l'etichetta Domino.
Non è un lavoro lungo ma talentuoso. Riproduce i primi vagiti di un
gruppo che garantiva inclinazione e capacità di sintesi davvero insoliti.
Questi tre misteriosi sabotatori di new wave ed elettronica dal volto mascherato
e dagli equivoci abiti nucleari sviluppavano un senso della profondità sordo, claustrofobico e arcano nella propria creazione musicale, che si riallaccia
a Kraftwerk e Suicide e omaggia i primi esploratori elettronici. Particolari
sincopati isterismi misti a ironia saranno fonte d'ispirazione per i nuovi
alchimisti wavers, da Liars a El Guapo, a Gogogo Airheart.
Ogni canzone è una illuminante perla citazionista, da Spector a Lou
Reed (le strepitose I.p.c. subeditors dictate our youth e D.p.),
dai menzionati Suicide a primi Stereolab (Porno, Monkey on your back).
Cinefilia, aggressione, scherno, ambiguità, lascivia, oscurità,
cripticismo. Clinic contiene germi solo parzialmente espressi dagli Lp che
seguiranno.
(2002)
Clor (Regal, 2005)

Capitanati dal cantante e chitarrista Barry Dobbins e dall'altra chitarra Luke Smith, i britannici Clor si propongono come l'ennesima (ma interessante) rilettura dei suoni new wave, a suon di drum machines, chitarre, basso e 14 sintetizzatori. Un misto di Tubeway Army, Kraftwerk, Devo, Magazine, attraverso il filtro minimalista indie degli ultimi vent'anni.
Dall'estate scorsa Clor sono impegnati in una tournee britannica ed europea che proseguirà fino al 2006.
Nella sempre fertile tribù di infusi new-wave, il gruppo Clor recupera un senso estraneo e depistante. Più che se stessi preferiscono infatti mostrare la propria musica: un impatto e impasto shockante sulle prime, di elettronica, new-wave e pop minimale in parti uguali.
Sin dalla copertina iconica new-wave, artificio sistematizzato di colori e forme pure, di caratteri e linee rette trasversali su superficie bidimensionale, agiscono privazione e senso informale in contrasto estetico.
Similmente la musica, smaltata ma acuminata è efficacemente costruita tanto su un alone di mistero quanto sullo sfavillio “irritante” che richiama sin dai propri antesignani.
Sin dal proprio ingresso, l'album affonda in un magma di pulsazioni di tastiera alla Kraftwerk e nella wave deviata di Devo, ma con un approccio, uno spirito indie rock.
I sensi “robotici” le danze isteriche dei gruppi di sopra si coniugano poi istintivamente in Clor assieme a uno spiccato senso guitar-pop, che indora la pillola favorendo oltremodo orecchiabilità e gradevolezza. Ed ecco allora l'approdo a tutta una serie gemme pregiatissime, tra forme wave, dance, pop e funk, come “Good Stuff”, “Love+Pain”, “Outlines”, “Stuck in a Tight Spot”, “Magic Touch”, "Garden of Love".
Lo sfolgorio minimale senza risalto e un gusto per la riproduzione “seriale” congenito, fanno poi di Clor il più titolato successore a un altro misconosciuto, indimenticabile omonimo: “Eiffel Tower” (1999), dell'one man band new yorkese Ben Wheelock, vero capolavoro di mimetismo '80's a riprova dell'inarrestabile, duttile appeal di questa ricetta mimetica e semplice, attraverso tempo, continenti e generi musicali.
Come per l'Eiffel Tower o per i sempre britannici Clinic, Clor perseguono un gusto per il tacito immagine: spazio assoluto ai contenuti d'una musica già di per sè ambivalente e di grande impatto, impeccabilmente artificiale e stereotipa, piccante e trascinante, prepotentemente danzabile, minimale e tesa.
Un esordio di notevole fattura.
(settembre, 2005)
cLOUDDEAD s-t (2001)-
 Un
definitivo, solenne, memorabile mosaico musicale con maschera hip hop. Complesso
e astratto collage di deliqui tra citazionismo e innovazione pura,
surrealismo, stratificazioni elettroniche, vastissime aperture e dilatazioni
cosmico-ambientali, orgiastiche trance psichedeliche in loop, campionature
su straniate e invasate declamazioni rap "floating in space".
Un
definitivo, solenne, memorabile mosaico musicale con maschera hip hop. Complesso
e astratto collage di deliqui tra citazionismo e innovazione pura,
surrealismo, stratificazioni elettroniche, vastissime aperture e dilatazioni
cosmico-ambientali, orgiastiche trance psichedeliche in loop, campionature
su straniate e invasate declamazioni rap "floating in space".
Indubbiamente il lavoro più gravido e pesante dell'anno, peso inteso come
spessore, gloria, premonizione.
Progetto nato dall'incontro di tre artisti della fertilissima, aperta
ensemble statunitense Anticon: Dose One, Why? e Odd Nosdam, divisi tra musica
e studio di produzione.
Clouddead contiene i lavori realizzati in quattro anni di pubblicazioni in
10 pollici.
Nella rigonfia nube di cLOUDDEAD ogni genere rock e non rock entra
fatalmente in collisione, in unione, il solenne e il lirico in contatto col
barbaro, il decadente e il tribale.
L'obiettivo di questi tre artisti è infatti quello di "non porsi limiti" e
lasciare l'ispirazione libera di vagare, fluttuare, tornare gravida di suggestioni.
Sotto l'ispezione di questa lente musicale ogni cosa va a deformarsi, smisurarsi,
somigliare al proprio diverso, e si avventura in un territorio inconosciuto,
oltre e altrui, non tornando più. La materia acquisisce un senso alterato,
ironico e deviato, presagisce violenza e paranoia, e sa trasmettere emozioni
dolorose ed euforiche nello stesso tempo. (dic. 2001)
CLUB 8 - Summer songs (2002)
Club 8 non smettono di registrare con frequenza fisiologica. Eppure la loro
urgenza di comunicare cose semplici con semplicità non smette di meravigliare.
Ogni nuova pubblicazione non va avanti, piuttosto a fianco, un altro tassello
del domino.
Un dialogo, quello tra la trasparente voce di Karolina e i minimali strumenti
di Johan che da sempre produce un connubio artistico di provata piacevolezza
e seduzione.
Club 8 sono meno ingombranti di Sundays, meno aerei di Cat's Miaow, più iridescenti di entrambi.
Nel caso di questo ep, cinque preziose perle di pop minimale e innocente,
tra le quali svetta la tenue meraviglia di You and me. Canzoni evanescenti
come l'aria, che non restano mai dentro, ma di cui si ha sempre bisogno.
(2002)
CLUE TO KALO Come Here When You Sleepwalk
(2003 Leaf)
Clue To Kalo è l'alter ego musicale di Mark Mitchell. Un altro corriere
sentimentale, un altro passionale sintetico a costellare il giovane firmamento
elettro pop, aggiungendosi a smaglianti paesaggisti del calibro di Domotic,
Dntel, Monogram.
Come Here When You Sleepwalk è un lavoro dalle cromature eteree e impalpabili,
che esprime umori fragili e vulnerabili.
Un'elettronica che immerge, un insieme virtuale che sembra materializzarsi
e farsi reale.
Sulla copertina “filtrata” una ragazza (o una donna, difficile definire l'età)
percorre in bicicletta una strada di campagna. La stessa dimensione del desiderio,
nostalgico-utopico è presente nella musica come nella grafica.
Si sogna, per lo più. Si vuol rivivere in mondi accoglienti e cortesi,
a misura d'uomo, dove luminosità e candore risiedono nella ingenuità e nella
purezza di ciascuno.
Un'elettronica umana e impressionista, dai tratti sensibili, che avverte e
comunica tali particolari disposizioni dell'animo. Che percepisce ogni emozionalità nell'atmosfera e la amplifica come riverbero sull'acqua.
(mag. 2003)
COLOR FILTER- Sleep In A Synchrotron (1998)
 Color
Filter è l'alter-ego del giapponese Ryuji Tsuneyoshi (chitarra, programming),
artefice di un eletro pop drum'n'bass di qualità dolce e intima, evanescente
e sognante, tanto nelle tessiture vocali quanto negli strumenti.
Color
Filter è l'alter-ego del giapponese Ryuji Tsuneyoshi (chitarra, programming),
artefice di un eletro pop drum'n'bass di qualità dolce e intima, evanescente
e sognante, tanto nelle tessiture vocali quanto negli strumenti.
"Sleep In A Synchrotron" è un piccolo
tesoro nascosto, un incontro luminoso il cui ascolto può risvegliare una giornata.
Un lavoro di elettro pop passionale e fecondo, la cui sfumata veste corporea è diffusa da un'elettronica di soprannaturale gentilezza e grazia, come glassa,
dimessa ma dinamica, cortese e mai tiranna.
Le mescolanze di colori caldi e freddi delle tastiere evocano un dolce senso
di oppressione. Un cromatismo opaco, tinte rubino, vespertine tonalità riverberate
nel paesaggio fluviale di copertina.
Le vibranti, avvolgenti luministiche atmosfere strumentali ordite da Tsuneyoshi
(chitarra e piano, teneramente) trasmettono un senso di splendore della luce;
distesa di voci e melodie intrise di ineffabile calore, partecipazione emotiva,
tenerezza.
Fondamentale a questo proposito l'apporto delle muse Yuki Nishimura e Aiko,
proveniente da Advantage Lucy: idillio immerso in una natura inviolabile e
misteriosa, avvolta nella penombra.
Affabulazione che ha quale tramite innocenze malinconiche, inquietudini di
spirito sottilmente, dolcemente tragiche.
Si accresce la consapevolezza nell'ascoltatore, ormai persuaso, sedotto dalla
poesia di accensioni lucidamente risvegliate nella memoria, come "children
of summer", "let me sleep"; o la deliziosa rivisitazione club di "satellite
of love" di Lou Reed.
E ancora, l'esotismo drum'n'bass modello Saint Etienne di "sad sky grey" e
dulcis in fundo il capolavoro nel sublime effetto di notturno "stars above
you", alfiere condotto al martirio ad espiare la troppa bellezza.
Un arte di induzione al sogno e alla fantasia più inconfessata e imbarazzante.
Ogni convinzione si fa relativa, si abbandonano false certezze e forze dell'abitudine,
ci si consegna spirito e corpo, senza più preoccupazioni e timori, e si vola
via.
(mag. 2004)
I Often Think in Music (2001)
Nel 1998 i giapponesi Color Filter pubblicarono
il proprio esordio a nome Sleep In a Synchrotron, da considerare come uno
dei lavori più struggenti e delicati che la musica pop abbia prodotto
in questi anni.
Praticamente conteneva ogni cosa di cui un disco pop deve disporre, sapienza
di scrittura, Doti di cui bisogna esser disposti, che raramente possono cogliersi
e inventarsi nella circostanza.
I Color Filter esprimono forze vibratorie che svelano bagliori, sia pure gelidi,
tenui, aerei, piuttosto che indicare occulto, fatuità, apparenze, illusioni.
Certa struggente vulnerabilità contenuta in Sleep In a Synchrotron
permane in questo I Often Think in Music, che provvede a metter più
a fuoco, a perfezionare, ordinare, alcune delle principali intuizioni già
espresse, pur se a volte una quale ingenuità resterebbe preferenziale.
A volte meno si cambia, giocando su affinità e sottili variazioni,
più le possibilità di successo si colgono. Dove, dunque, questo
disco appare una coda, una continuazione del precedente, e "si somiglia"
a Sleep In A Synchrotron, risulta estremamente illuminante, fascinoso, rivelatore.
Altrove, sia pure in misura minore, queste musiche assomigliano ad altri pur
validissimi esponenti di un dream pop elettronico più lezioso ma pur
sempre gradevolissimo, erede di una tradizione che risale agli anni ottanta
di esponenti più in vista, e si protrae con i vari, assai meno noti,
contemporanei, Monk & Canatella, Gentle People, Death Cab For Cutie.
Certo è che c'è bisogno dei Color Filter, e in maggiore istanza,
del pop giapponese, quale fucina di suggestioni e immagini ove pulsano emozioni
ed istinti peculiarmente primigenii ancora perfettamente integri e sinceri,
non ancora rielaborati e transgenizzati; scrigno segreto non rivelato, potenzialità ancora parzialmente espresse.
Musica straordinariamente priva di educazione, ma educazione come è intesa nel mondo occidentale, un accomodamento culturale; proprio per questo
pura ai nostri neuroni.
(2001)
CORNELIUS- Fantasma (1998)
Keigo
Oyamada alias Cornelius, è musicista e gestore di un'etichetta discografica,
la Trattoria (una sorta di El o Cherry Red nipponica con un debole per le
ristampe dei più rari gioielli pop occidentali), oltre che a comporre
e produrre per altri artisti.
Fantasma, l'opera che ha fatto conoscere e stimare in occidente questo
genietto, già idol in patria, vezzeggiato quanto il grande calciatore
Hidetoshi Nakata.
Fantasma, del 1998, è
disco esuberante, policromo ed esibizionista come pochi altri nel pop. Un
valido sviluppo delle intuizioni di artisti come Beck Hansen, nonché un enorme passo avanti rispetto ad altri autori, al cui cospetto si vedono
ridimensionare impietosamente le proprie fatiche. E' il caso, restando in
Giappone, degli Zoobombs, o dei Dob, che con La Loo La Roo (1996)
avevano realizzato un buon lavoretto con ingredienti simili ma che a confronto
si riduce a un piccolo esperimento embrionale.
Fantasma è il manifesto della "reinessance" pop giapponese,
più o meno la stessa importanza che ebbero Jean Luc Godard e Francois
Truffaut nella Nouvelle Vague per il cinema francese.
Questo disco "mattatore" manifesta in maniera ormai inconfutabile
l'approdo del Post Moderno in ambito pop, il gusto del melting pot, il potere
di una creatività irrefrenabile e dalle risorse pressochè illimitate.
Come in molti altri casi però, i molti imitatori, dinnanzi a siffatta
materia, non sapranno portare avanti il discorso.
Il fenomeno Cornelius si mostra attraverso una sequenza accattivante di brani
che sulle prime paiono avere poco a che fare l'uno con l'altro, ma che in
seguito, misteriosamente, mostrano molti tratti in comune, figli di culture
musicali differenti ma, insieme, anche della stessa.
In questi anni il disco non ha perso nulla del proprio potenziale, nonostante,
da allora, il mercato si sia riempito di parecchi inutili cloni.
Basti rievocare classici come new music machine, micro disneycal world
tour, count five or six e il gioiello citazionista, tra Wings e Beach
Boys, Chapter 8.
(nov. 2001)
Costin Miereanu - Luna Cinese (Cramps Crslp 6107)
Miereanu è un musicologo franco-rumeno di Contemporanea che nel 1975 ordisce uno dei più maliosi intrighi elettroacustici mai uditi, Luna Cinese.
Flusso fantasmatico e affascinante, delirio a occhi aperti tra parvenze, voci (muliebri), suoni digitali, effetti sonori di esterni, l'album si compone di due inquiete, vibranti piece una per lato vinile, di concrete musique (meglio definita ‘musica climatica' in un'altra opera dell'80-81).
Stuolo di tappeti di tastiera trasognata alla Ashey o Luc Ferrari (quello di Danses Organiques e Petite Symphonie Intuitive), e ancora, sonagli, strumenti a fiato diradati, persi lontano, nella nebbia, nell'inconscio, nella spazialità atmosferica.