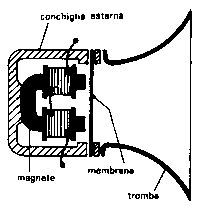
Trasduttore elettroacustico il cui compito è di trasformare vibrazioni elettriche varianti in frequenza ed in ampiezza in vibrazioni meccaniche, le quali, a loro volta, vengono ritrasformate in onde sonore mediante una membrana flessibile che comprime più o meno l'aria circostante. Gli altoparlanti sono costituiti da 3 parti principali: l'organo di produzione delle forze meccaniche, il diaframma (o membrana) e la struttura di controllo delle oscillazioni acustiche. A seconda del modo con il quale dalla corrente fonica si ottiene la forza meccanica che agisce sulla membrana gli altoparlanti si dividono in: altoparlanti ad armatura mobile, elettrodinamici ed elettrostatici.
ALTOPARLANTE AD ARMATURA MOBILE
L'altoparlante ad armatura mobile detto anche magnetico o a ferro mobile è il tipo più semplice: è formato da una lamina affacciata su un magnete permanente intorno al quale sono avvolte due bobine percorse dalla corrente fonica. In definitiva questo altoparlante è una cuffia telefonica di grandi dimensioni necessarie per irradiare una elevata potenza acustica. La corrente variabile che circola nelle due bobine poste alle estremità del magnete permanente, rinforza o diminuisce il flusso totale creato dal magnete e fa variare la forza di attrazione agente sulla lamina di acciaio facendola vibrare. La lamina oscillando imprime alle particelle di aria dello strato immediatamente adiacente un moto d'insieme e l'onda di pressione che ne consegue si propaga da questo ai successivi generando il suono. Per ottenere che l'energia meccanica conferita alla lamina si converta con un buon rendimento di energia acustica diffusa nell'ambiente, l'altoparlante è fornito di una tromba acustica; l'apparecchiatura è completata da una conchiglia che racchiude il magnete.
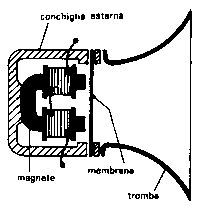
ALTOPARLANTE BILANCIATO
Più perfezionato del precedente è l'altoparlante di tipo bilanciato in cui si eliminano i fenomeni di distorsione del suono dovuti alla variazioni del traferro dell'elettromagnete (e quindi della sua forza di attrazione) in conseguenza del movimento della lamina. Il circuito magnetico è realizzato in modo da mantenere costante il traferro anche per ampi movimenti della parte mobile del sistema. Il magnete permanente possiede due espansioni polari di forma particolare tra le quali è disposta una ancorina mobile imperniata nel punto O. Due bobine sono avvolte in modo opportuno per creare polarità contraria alle estremità dell'ancoretta mobile e ad un estremo di quest'ultima è collegato rigidamente un cono di carta. La corrente fonica passando nelle due bobine crea un campo magnetico variabile nel quale è immersa l'ancorina; questa si magnetizza e le due estremità sono attratte o respinte dalle espansioni polari del magnete; il movimento si comunica al cono di carta tramite la barretta di collegamento; quest'ultimo irradia l'energia sonora nell'ambiente circostante.

ALTOPARLANTE A BOBINA MOBILE
L'altoparlante a bobina mobile presenta rispetto a quello a ferro mobile una migliore soluzione per trasformare in suono le correnti a frequenza acustica. Un forte magnete permanente di materiale speciale (alnico, alcomax, ecc.) crea un campo magnetico molto intenso nel traferro che esiste fra l'espansione polare esterna di forma anulare e la espansione polare interna di forma cilindrica; nel traferro è immersa una bobina formata da molte spire di filo di rame avvolte su di un supporto isolante. La bobina è collegata ad un cono di carta speciale insensibile agli agenti atmosferici e trattata con particolari vernici; inoltre un centratore, permettendo alla bobina movimenti in senso longitudinale ma non in senso trasversale, fa in modo che questa risulti sempre perfettamente centrata nel traferro e che non venga a contatto con le espansioni polari. Il cono, sul suo diametro maggiore, è centrato mediante un bordo flessibile che permette spostamenti solo in senso longitudinale; l'effetto del bordo completa pertanto quello del centratore impedendo i movimenti trasversali del cono. Un supporto metallico detto cestello funziona da supporto per il cono ed è fissato alla base contro la parte esterna del circuito magnetico che prende il nome di mantello. Se si applica alla bobina mobile una tensione si avrà un effetto elettrodinamico dovuto alla corrente che circola nella bobina stessa. Questa si sposterà in un senso o nell'altro secondo il senso della corrente ed il senso del flusso magnetico dovuto al magnete permanente. L'ampiezza dello spostamento dipende dall'intensità della corrente, dall'intensità del campo magnetico nel traferro, dal numero di spire che formano la bobina mobile e dalle caratteristiche meccaniche del sistema cono - bordo - centratore.
L'altoparlante a bobina mobile presenta, rispetto ai tipi precedenti, il grande vantaggio di avere la parte mobile molto leggera e di conseguenza essa può seguire facilmente l'eccitazione di correnti di frequenza elevata; oltre a ciò la grande libertà di movimento del cono e della bobina mobile favorisce il funzionamento alle frequenze più basse ed alle potenze più elevate (una maggior potenza acustica si ottiene con movimenti più ampi del cono). I limiti della buona riproduzione del suono sono determinati delle dimensioni del cono e di tutta la parte mobile e dall'introduzione magnetica nel traferro. Per ottenere un buon funzionamento entro limiti vasti in frequenza ed in ampiezza devono contemperarsi esigenze contrastanti facendo ricorso a soluzioni di compromesso fra la rigidità del sistema mobile, le sue dimensione ed il peso. E' oggi il più impiegato.
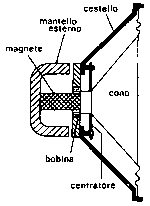
ALTOPARLANTE ELETTROSTATICO
L'altoparlante elettrostatico, a causa della sua delicatezza e dell'alta tensione necessaria per la polarizzazione ha impieghi limitati alle frequenza acustiche elevate; consiste in un condensatore costituito da due elettrodi. La membrana A, normalmente composta da un sottile foglio di metallo o di materia plastica metallizzata, costituisce uno degli elettrodi, ed è fissata alle estremità dei punti B e C. L'elettrodo posteriore B, realizzato con una piastrina metallica di un certo spessore, forma la seconda armatura e si trova a distanza minima dalla membrana. La tensione di polarizzazione applicata tra A e D crea una reciproca attrazione elettrostatica che tende ad avvicinare le due armature; dal momento che solo la membrana A è abbastanza flessibile, solo essa si inflette senza tuttavia toccare l'altro elettrodo. Al potenziale di polarizzazione in c.c. si sovrappone il segnale in c.a. che si somma o si sottrae a seconda della polarità. La membrana si avvicina alla posizione di riposo (posizione che assume in assenza del segnale e della tensione di polarizzazione) quando il segnale si sottrae alla d.d.p. di polarizzazione e si avvicina all'elettrodo fisso quando il segnale si somma alla d.d.p. di polarizzazione. L'altoparlante elettrostatico nono presenta frequenze di risonanza pronunciate nella gamma compressa tra 7 kHz e 20 kHz, gamma per la quale viene adottato.

CARATTERISTICHE DI UN ALTOPARLANTE
La bontà di un altoparlante è definita principalmente dalla caratteristica di impedenza e dalla curva di risposta. La caratteristica dell'impedenza è un diagramma che fornisce il modo di variare dell'impedenza della bobina mobile al variare della frequenza della corrente che l'attraversa. Per una determinata frequenza la curva raggiunge un massimo di corrispondenza del quale si manifesta il fenomeno di risonanza meccanica del sistema mobile. Tale frequenza è detta frequenza di risonanza dell'altoparlante e dipende dal peso del cono e della bobina mobile e dalla elasticità del bordo del cono e del centratore; in un buon altoparlante questo fenomeno deve essere ridotto al minimo e la frequenza di risonanza deve essere il più vicino possibile alla più bassa frequenza acustica che interessa. La curva di risposta esprime, in funzione delle frequenza della corrente inviata nella bobina, il valore della pressione sonora creata dall'altoparlante per un valore costante della corrente nella bobina mobile. Per un altoparlante perfetto questo diagramma dovrebbe essere rappresentato da una linea perfettamente orizzontale, in tutta la banda di frequenze foniche di funzionamento; l'altoparlante sarà tanto più buono quanto più la sua caratteristica di fedeltà si avvicinerà alla condizione ideale. Altra caratteristica di un altoparlante è la potenza massima che si può inviare nella bobina mobile senza che si manifestino distorzioni del suono irradiato.
Per poter riprodurre fedelmente le frequenze alte, un altoparlante dovrebbe avere un cono piuttosto piccolo (cui corrisponde una frequenza di risonanza piuttosto alta), mentre per la riproduzione delle frequenze basse le sue dimensioni dovrebbero essere notevoli. Quando si vogliono ottenere ottime prestazioni si preferisce adottare, in luogo di un solo altoparlante destinato a riprodurre con fedeltà tutta la gamma delle audiofrequenze, l'insieme di più altoparlanti, opportunamente disposti; alcuni di grandi dimensioni, adatti alla riproduzione delle frequenze basse, altri a quella delle frequenza intermedie ed altri ancora alla riproduzione delle frequenze alte. Naturalmente occorre inserire opportuni filtri, che provvedono ad inviare ad ogni altoparlante la parte di segnale che, come gamma di frequenza, gli compete.

Gli altoparlanti, a seconda del tipo di struttura adoperata per il controllo delle radiazioni acustiche, possono suddividersi in altoparlanti senza tromba e a tromba: in quelli senza tromba il diaframma trasmette direttamente l'energia sonora al mezzo elastico (aria); pertanto essi risultano sostanzialmente adirezionali. Negli altoparlanti a tromba l'energia sonora viene, invece trasmessa nell'aria mediante una tromba; essi presentano caratteristiche di ottima efficienza, di alta gamma di frequenza e offrono, inoltre, la possibilità di ottenere svariate distribuzioni direzionali. fra gli altoparlanti a tromba si distinguono quelli a tromba semplice, a tromba multipla, a canali multipli e gli altoparlanti a diaframma singolo e doppia tromba.
Viene definito carico acustico, il pannello o il box sul quale è montato l'altoparlante. La sua funzione è di separare l'emissione anteriore del diaframma da quella posteriore, ciò per evitare che i due movimenti in opposizione di fase tra loro, si annullino acusticamente.
Esistono diversi sistemi per separare le emissioni di un altoparlante: dai sistemi che schermano semplicemente le due emissioni a quelli più complessi dove una delle due emissioni viene sfruttata per rafforzare l'altra. Di seguito diamo una descrizione generica dei diversi principi di funzionamento.
Probabilmente è il sistema più semplice. E' costituito infatti da un pannello sul quale è fissato l'altoparlante che irradia su entrambi i lati. Le due emissioni sono separate dal pannello ed entrano in conflitto solo quando le semilunghezze d'onda della frequenza emessa diventa confrontabile con la dimensione minima del pannello. Al di sotto di tale frequenza si verifica una attenuazione progressiva e smorzata (circa 6 db/ott). E' evidente che più si vuole scendere a frequenze basse, tanto maggiori saranno le dimensioni del pannello. Le dimensioni non contenute di questo sistema costituiscono un ostacolo non indifferente alla sua diffusione.In considerazione delle sue particolari caratteristiche acustiche viene impiegato principalmente nell'alta fedeltà.

Il passo successivo nell'evoluzione dei sistemi per la riproduzione acustica e per certi versi anche il più rivoluzionario, è la sospensione pneumatica. In questo sistema l'altoparlante viene montato in un box completamente chiuso ed impermeabile al passaggio dell'aria. L'emissione posteriore del diaframma comprime l'aria contenuta nel mobile che funziona come una molla e che tende a riportare la membrana nella sua posizione di equilibrio. Con questo sistema si raggiungono due notevoli risultati, il primo è che le due emissioni non entreranno in conflitto a nessuna frequenza, e quindi l'estensione alle basse frequenze sarà determinata dalle caratteristiche specifiche dell'altoparlante e del box. Il secondo risultato è rappresentato dalla maggiore velocità di risposta ai transienti che rende la riproduzione delle basse frequenze molto simile alla dinamica reale.La risposta in frequenza tipica di una sospensione pneumatica mostra una salita (roll on) di 12 dB/ottava. Per contro in questo sistema il diaframma è chiamato a compiere escursioni molto significative che mal si conciliano con le elevate potenze impiegate nel settore professionale. La sospensione pneumatica è utilizzata principalmente nell'alta fedeltà. In ambito professionale la sospensione pneumatica può essere impiegata per isolare i mid-range o anche per la realizzazione di diffusori specifici per strumenti musicali.

Il bass reflex aggiunge un'altra importante caratteristica ai sistemi in box chiuso. In questa configurazione infatti, l'emissione posteriore del diaframma anzichè essere completamente assorbita e trasformata in calore dal materiale fonoassorbente, viene convogliata in un condotto comunicante con l'esterno. Questo permette di recuperare una parte di energia e di sommarla alla emissione anteriore. La frequenza alla quale si verifica la somma delle emissione (frequenza di accordo) è data dal rapporto tra le dimensioni del condotto (sezione e lunghezza) e il volume del box. E' da notare che alla frequenza di accordo il diaframma compie la minima escursione, questo consente di applicare alte potenze con distorsioni limitate. Per contro, al disotto della frequenza di accordo l'escursione aumenta notevolmente, e, sempre nel caso di alte potenze, ciò potrebbe causare problemi di tenuta meccanica dell'altoparlante. Per limitare questo rischio in molti casi viene impiegato un filtro attivo passa alto ad elevata pendenza (filtro subsonico) che attenua la prima ottava dello spettro audio (20/40 HZ). Dal punto di vista acustico, rispetto alla sospensione automatica, il bass reflex mostra un andamento a bassa frequenza più presente, anche in virtù della maggiore pendenza di salita (18 dB/oct). D'altra parte il bass reflex richiede maggior accuratezza nella progettazione ed in certi casi potrebbe risultare meno smorzato. Resta tuttavia uno dei sistemi di carico acustico più diffusi in assoluto sia nel settore professionale che nell'alta fedeltà.
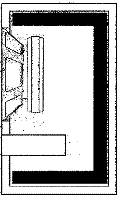
IL LABIRINTO O LINEA DI TRASMISSIONE
Anche il labirinto fa parte dei sistemi che sfruttano l'emissione posteriore del diaframma. In questo caso però è è l'intero box che realizza il condotto, nel senso che l'onda posteriore viene convogliata in un condotto di sezione almeno pari alla sezione dell'altoparlante e di lunghezza tale per cui all'uscita l'emissione si ripresenta in fase con quella anteriore. La frequenza alla quale le due emissioni si sommano in fase è legata alla lunghezza del condotto, che generalmente viene fatta coincidere con una frazione (1/4) della lunghezza d'onda della frequenza di risonanza in aria libera dell'altoparlante. Esistono diverse varianti e teorie realizzative circa questa tipologia di carico acustico che lo rendono particolarmente interessanti per gli autocostruttori. Le prestazioni acustiche di questo sistema possono essere assimilate a quelle di un bass reflex con un elevato fattore di smorzamento. In funzione delle difficoltà di realizzazione e degli ingombri non proprio contenuti, la linea di trasmissione è utilizzata quasi esclusivamente nell'alta fedeltà.

I sistemi di caricamento acustico visti finora possono essere definiti a radiazione diretta, cioè il diaframma dell'altoparlante irradia direttamente nell'ambiente circostante. Nei sistemi a tromba invece, tra il diaframma e l'ambiente viene interposto un dispositivo, la tromba appunto, che amplifica il rendimento dell'altoparlante ed in funzione delle sue caratteristiche geometriche consente di controllare la direttività dell'emissione. Strutturalmente la tromba è costituita da un condotto a sezione crescente che raccorda due superfici: la gola che è affacciata al diaframma dell'altoparlante e la bocca che è affacciata all'ambiente. La progressione della variazione di sezione del condotto dalla gola alla bocca è regolata da precise relazioni matematiche che definiscono la tipologia della tromba stessa: esponenziale, conica, iperbolica, ecc. Molto spesso per ovviare alla eccessiva lunghezza si usa ripiegare il condotto in più tratti. In relazione alle caratteristiche di alto rendimento ed agli ingombri non proprio contenuti i sistemi a tromba vengono impiegati in massima parte nel settore professionale, ma sono molti i loro estimatori anche nell'alta fedeltà.

Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non è prodotta direttamente dal diaframma dell'altoparlante, sono i sistemi passa banda. In questi sistemi il diaframma viene caricato su entrambe le facce, anteriore e posteriore, con volumi distinti. Esistono due tipologie di carico passa banda: il carico simmetrico dove un volume è in sospensione pneumatica e l'altro è un bass-reflex ed il doppio carico reflex dove entrambi i volumi sono reflex. Nel carico simmetrico l'emissione posteriore del woofer viene assorbita dal volume chiuso mentre quella anteriore viene filtrata dal condotto reflex. La relazione tra la frequenza di risonanza del box chiuso e la frequenza di accordo del reflex determinano la tipica risposta in frequenza a campana(passa banda). Le prestazione acustiche di questo sistema sono paragonabili alla sospensione pneumatica, si hanno cioè basse frequenze profonde e smorzate che lo rendono particolarmente indicato nella realizzazione di sub-woofer per alta fedeltà. Nel doppio reflex i volumi, anteriore e posteriore, sono dei bass-reflex. In questo modo vengono sfruttate le emissioni di entrambe le facce del diaframma. Distanziando opportunamente le frequenze di accordo dei due volumi è possibile ottenere una "campana" stretta ad alta sensibilità, oppure larga a sensibilità minore. Una caratteristica molto importante di questa tipologia di carico acustico è data dalla significativa riduzione dell'escursione. Come già visto nei sistemi reflex a radiazione diretta, in corrispondenza della frequenza di accordo si ha la minima escursione del diaframma. Essendoci in questo sistema due volumi accordati, ci saranno due frequenze in corrispondenza delle quali l'escursione è minima. Questo consente di applicare maggiori potenze e ridurre le distorsioni armoniche. Anche in questo caso è possibile applicare un filtro attivo ad elevata pendenza per limitare ulteriormente le escursioni alle frequenze ultra basse. Sulla base di queste caratteristiche i sistemi doppio reflex vengono vantaggiosamente impiegati nel settore professionale, principalmente per istallazioni in ambienti chiusi.

SISTEMI PER STRUMENTI MUSICALI
In funzione delle loro caratteristiche costruttive gli strumenti musicali riproducono un range di frequenze ben delimitato. Per questo i diffusori che provvedono alla loro diffusione sono specializzati per esaltare le caratteristiche timbriche e dinamiche dello strumento. Ad esempio la chitarra elettrica o lead guitar copre una zona di frequenze che va da circa 80 Hz fino a circa 5 KHz, il suo timbro è generalmente molto brillante e veloce ed il suo suono viene spesso alterato da effetti elettronici. Il diffusore che riprodurrà questo strumento dovrà avere quindi buone doti di velocità ed efficenza, con una risposta in frequenza non troppo profonda ed una estensione verso l'alto fino a circa 6 KHz. Ci sono diverse tipologie di carico acustico che possono soddisfare i requisiti di un diffusore per chitarra: dal box aperto posteriormente che produce una risposta molto presente nella ottava da 80 a 160 Hz, al box in sospensione pneumatica per ottenere un basso più acustico e morbido. Generalmente i diffusori per chitarra impiegano altoparlanti a gamma estesa da 10" o 12" usati in coppia o anche in gruppi di quattro. La chitarra basso invece ha una estensione leggermente diversa dalla chitarra, si spinge cioè più in basso in frequenza, il basso a cinque corde arriva a circa 30 Hz. Il diffusore che lo riprodurrà dovrà avere una buona estensione in basso con un ottimo smorzamento per modulare correttamente le note più basse. In questo caso viene generalmente utilizzato un caricamento a basso reflex con altoparlanti di grande diametro o gruppi di altoparlanti: l'uso di altoparlanti di grande diametro, 15" o 18", però limita l'estensione alle alte frequenze, per cui viene spesso abbinato al woofer, un medio (10") o più di uno (2 x 8"), per completare la gamma ridotta dallo strumento. Per quanto riguarda la diffusione delle tastiere, è preferibile impiegare diffusori full range,sia per l'ampia gamma di frequenze riprodotte (praticamente tutta la banda audio)
sia la grande serie di effetti disponibili. Si useranno quindi diffusori a più vie con una cura particolare alla linearità.
COLLEGAMENTO DI PIU' DIFFUSORI E IMPEDENZA COMPLESSIVA
Molto spesso per l'esigenza di sonorizzare grandi spazi aperti o per esibizioni live è necessario utilizzare diversi diffusori contemporaneamente. In questi casi collegando più diffusori tra loro, è molto importante verificare che l'impedenza complessiva (z) del sistema sia allineata alle specifiche degli amplificatori. Nelle specifiche tecniche degli amplificatori viene infatti dichiarata la potenza in funzione del carico (es. 500 W su 8 ohm), se l'impedenza complessiva dei diffusori è più alta di quella nominale la potenza erogata dall'amplificatore si riduce, se invece l'impedenza è troppo bassa l'amplificatore eroga più potenza ma aumentano anche i rischi di rottura degli altoparlanti o che intervengano i circuiti di protezione interni al finale stesso. Per ottenere la corretta impedenza complessiva esistono diversi modi di collegamento tra i vari diffusori: in serie; in parallelo; in serie/parallelo. Nel collegamento in serie l'impedenza totale sarà data dalla somma delle impedenze di tutti i diffusori. Nel collegamento in parallelo l'impedenza totale sarà data dall'impedenza di un diffusore diviso per il numero dei diffusori collegati: Il collegamento serie/parallelo mostrerà una impedenza che sarà data dalla somma delle impedenze dei diffusori in serie divisa per il numero dei rami in parallelo. Nell'impostazione dei collegamenti tra i diversi diffusori occorre fare qualche considerazione: è bene evitare di fare un collegamento solamente in serie, perchè nella malaugurata ipotesi che un diffusore si guasti, tutto l'insieme dei diffusori ammutolisce. Mentre se sono collegati in parallelo se uno si interrompe gli altri continuano a suonare, anche se con potenza diversa. Altra considerazione riguarda la lunghezza dei cavi di potenza , è sempre consigliabile che gli amplificatori si trovino più vicino possibile ai diffusori, nel caso però che ciò non sia possibile, è bene evitare di lavorare su impedenze complessive troppo basse (es. 2 ohm), perchè l'incidenza percentuale della perdita di potenza lungo la linea , vanifica l'aumento l'aumento di potenza disponibile nel finale.

Nella progettazione di un sistema di diffusione è importante sapere quanta potenza verrà inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non è costante su tutte le frequenze della banda audio ma si concentra maggiormente nella zona centrale della banda per decrescere agli estremi. Sulla base di questa considerazione è stato elaborato un segnale formato da infinite componenti con frequenza causale da 20 a 20.000 Hz (rumore Rosa) e di ampiezza tale da rispettare la distribuzione di potenza di un programma reale (pesatura !EC) (tab.2). IpotIzzando di alimentare il nostro diffusore con questo segnale standard e tenendo conto delle frequenze di crossover tra i vari altoparlanti possiamo valutare quanta parte della potenza erogata dal finale giunge ad ogni altoparlante. Alcuni si domanderanno come mai la somma delle percentuali è superiore a 100 (tab.4). La risposta è che la potenza non scende verticalmente a zero alla frequenza di taglio, ma continua ad arrivare all'altoparlante con una attenuazione che dipende dall'ordine del filtro (in questo caso 12 db/oct). Per fare un esempio esplicativo supponiamo di avere un amplificatore che eroga una potenza di 1.000 W con il quale pilotiamo un diffusore a tre vie gestito da un filtro che a frequenze di incrocio 400 e 2.000 Hz. Osservando la tab.3 vediamo che sul woofer arriveranno 476 W, sul mid-range circa 360 e sul tweeter 167. Anche in questo caso quanto detto sopra circa la somma delle potenze, che in questo caso è superiore a 1.000 W. Per far funzionare correttamente il nostro sistema dovremo quindi scegliere degli altoparlanti in grado di sopportare le potenze che abbiamo ricavato. Questa elaborazione delle percentuali di potenza offre delle importanti indicazioni anche nel caso di sistemi multiamplificati gestiti da crossower attivi. Una volta identificati gli altoparlanti idonei, per ottenere la stessa pressione acustica prodotta dal finale da 1.000 W, dovremo impiegare 3 amplificatori di potenza pari a quella ricavata dal calcolo.
SENSIBILITA' O PRESSIONE (SPL)
Nelle specifiche tecniche di un amplificatore generico potremmo leggere ad esempio: 500 W su 8 ohm; 1.000 W su 2 ohm.
Questo ci fa dedurre che un amplificatore non è un generatore di potenza costante, ma piuttosto di tensione costante, che in funzione di un carico variabile produce una potenza variabile (P = V^ 2/R): Questa considerazione sulla legge di ohm ci è particolarmente utile quando vogliamo conoscere il livello di pressione o SPL (sound pressure level) di un sistema a più diffusori. E' prassi comune ritenere che quando serve più pressione bisogna aumentare, oltre alla potenza, il numero dei diffusori. Ciò in parte è vero, ma l'aumento di pressione è condizionato dalla tipologia del collegamento tra i diffusori stessi (serie o parallelo). Proviamo a fare un esempio: supponiamo di avere un diffusore con impedenza 8 ohm il quale, alimentato con un segnale di tensione 2,83 V (2,83 V^2/8 = 1 W) produce, posizionando un microfono ad 1 metro di distanza, un livello di pressione di 100 dB. Se colleghiamo in serie al primo , un altro diffusore sempre da 8 ohm, otterremo una impedenza di 16 ohm. Applicando la legge di Ohm risulterà 2.83^ 2/16 =0,5 W, avremo quindi dimezzata la potenza, per cui, se teniamo conto del fatto che ad ogni raddoppio o dimezzamento della potenza la sensibilità aumenta o diminuisce di 3 dB, il nostro sistema in serie produrrà una pressione di 97 dB. A questa diminuzione va però sommata una altra importante grandezza, la superficie di emissione che, ad ogni suo raddoppio fa aumentare il livello SPL di 3 dB (a prescindere dal collegamento serie o parallelo). Concludendo, nel caso di due diffusori collegati in serie avremo -3 dB per il raddoppio della impedenza, + 3 dB per il raddoppio della superficie di emissione , ovvero la sensibilità del gruppo serie resterà la stessa di un singolo diffusore. Proviamo ora a collegare i due diffusori di cui sopra in parallelo, l'impedenza diventerà 8 / 2 = 4 ohm e sempre per la legge di Ohm 2,83^ 2/4 = 2 W, abbiamo raddoppiato la potenza e per quanto detto sopra otteniamo + 3 dB . A questo sommiamo l'effetto del raddoppio della superficie di radiazione, altri + 3 dB ed arriviamo a + 6 dB. Il gruppo parallelo produrrà quindi un livello SPL d 106 dB, cioè + 6 dB rispetto al singolo diffusore. Nel caso di un collegamento serie/parallelo ad esempio di 4 diffusori, si applica quanto detto prima per le due tipologie, cioè il livello resta lo stesso di un solo diffusore per i due in serie e aumenta di 6 dB per i due rami in parallelo. Da un gruppo serie/parallelo formato da 4 diffusori otterremo quindi 106 dB.
Distribuzione della potenza in un programma musicale standard IEC

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DI ALTOPARLANTI
Nei sistemi di diffusione professionali assume particolare importanza l'affidabilità degli altoparlanti, che dovrebbero resistere alle sollecitazioni dinamiche dei programmi musicali, a clipping prolungati dei finali, alla saturazione dei microfoni, agli effetti Larsen, al bump di innesco dei jack, a equalizzazioni esasperate, e così via,: Il più efficace accorgimento per garantire lunga vita agli altoparlanti è di evitare, o comunque minimizzare i problemi di cui sopra. L'altoparlante è in grado di sopportare picchi di potenza anche 10 volte superiori alla potenza nominale, purchè questi siano costituiti da impulsi di breve durata (pochi millesecondi) e l'amplificatore sia in grado di erogare quella potenza di picco. Se però regoliamo la sensibilità (volume) dell'amplificatore al massimo, il gain del mixer al massimo, e magari con l'equalizzatore esaltiamo la gamma di frequenze di competenza del nostro altoparlante, bè in queste condizioni su di esse arriverà un segnale completamente squadrato, assimilabile cioè ad una onda quadra, che per definizione è un segnale formato da infinite componenti sinusoidali di ampiezza (tensione) uguale alla tensione di alimentazione dello stadio finale dell'amplificatore. In breve questo significa che sui driver o sui tweeter, ma anche sui mid range arriverà un segnale alla massima potenza erogabile dal finale non in modo impulsivo ma prolungato nel tempo che provocherà la bruciatura della bobina mobile con conseguente decesso dell'altoparlante.
L'effetto Larsen, che è quel fastidioso fischio prodotto dai diffusori quando ci si passa vicino con un microfono,produce anch'esso una squadratura del finale che ci riporta a quanto detto sopra. Per evitare o ridurre questo problema è necessario curare in modo particolare la posizione dei diffusori rispetto alla zona dove saranno presenti dei microfoni. Sono disponibili anche dei particolari filtri elettronici anti Larsen.Una nota particolare merita l'equalizzazione: Come è noto l'equalizzazione è un dispositivo che, grazie ad una serie di filtri, consente di esaltare o attenuare una gamma di frequenze più o meno ampia per correggere eventuali problemi di assorbimento o riflessione dell'ambiente. I livelli di equalizzazione sono molto ampi (mediamente + o - 10 dB). E' molto importante riflettere sul fatto che ad ogni 3 dB di intervento in esaltazione, viene raddoppiata la potenza (se i 3 dB sono in attenuazione la potenza viene dimezzata), il che significa che se l'amplificatore sta funzionando al massimo, non potrà erogare il doppio della potenza, per cui in quella zona di frequenze si produrrà una violenta squadratura con le conseguenze viste sopra. Tuttavia quando, pur tenendo conto di quanto detto sopra, gli altoparlanti vengono utilizzati al limite delle loro caratteristiche, è opportuno inserire dei dispositivi che limitino la corrente massima che può circolare nelle bobine. Questi dispositivi possono essere "attivi" , cioè dei circuiti alimentati e inseriti a monte degli amplificatori che operano sul segnale preamplificato, attenuandolo gradualmente quando questo tende ai valori limite, sono chiamati "limiter" e generalmente vengono integrati nei crossower elettronici, o direttamente negli amplificatori. Altri sistemi di protezione sono quelli passivi, dispositivi posti in serie agli altoparlanti che operano direttamente sul segnale di potenza. Alcuni esempi di protezione passiva sono: il fusibile, costituito da un filamento calibrato per sopportare una determinata corrente, superata la quale si brucia interrompendo il segnale che arriva all'altoparlante. Naturalmente per ripristinare il collegamento è necessario sostituire il fusibile. IL PTC (Positiv Temperatur Coefficent), formato dalla giunzione di due materiali che attraversati da una corrente si riscaldano in modo diverso. Quando il salto termico, e quindi la corrente supera un certo livello, la resistenza della giunzione aumenta notevolmente attenuando il segnale anche di alcune decine di dB . Il vantaggio di questo dispositivo rispetto al fusibile è che questo sistema si ripristina automaticamente quando la giunzione si raffredda. La lampadina a filamento, inserita sempre in serie all'altoparlante da proteggere. Per questo impiego la lampadina non viene usata come tale, ma come resistenza variabile. A freddo infatti, la resistenza del filamento è di pochi milliohm (praticamente un corto circuito), ma quando viene attraversato da una corrente la sua temperatura aumenta notevolmente (fino all'incandescenza tipica delle lampadine). Siccome con la temperatura aumenta anche la resistenza otterremo contemporaneamente una riduzione del segnale inviato all'altoparlante. Inoltre considerando che il filamento si trova in un bulbo sotto vuoto avremo anche una buona velocità di risposta. Generalmente gli altoparlanti più sensibili alle sovracorrenti sono i tweeter o i driver a compressione, ed è su questi che si dimensionano questi tipi di protezione. Il dimensionamento generico delle protezioni può partire dalla precedente tabella sulla distribuzione della potenza. Si dovrà infatti tener conto di quanta potenza potenza giungerà all'altoparlante dopo il filtro. Facendo riferimento allo stesso esempio, vediamo che sul tweeter vengono erogati 167 W, supponendo che il tweeter ha un impedenza nominale di 8 ohm, esso verrà attraversato da una corrente di circa 4,56 A (I = sqr(W/R)). In teoria quindi dovremo inserire un fusibile o un PTC con questa corrente di intervento, tuttavia è consigliabile tarare il sistema usando inizialmente un valore inferiore (4 A) e poi su tutta la catena (mixer, ampli, crossover) è a posto, si può diminuire la protezione inserendo un valore più alto (5 A).
DIRETTIVITA' E POSIZIONAMENTO DEI DIFFUSORI
Uno dei maggiori obiettivi nell'istallazione di un sistema professionale consiste nella distribuzione omogenea del suono su tutta l'area destinata all'ascolto, che si tratti di una discoteca, di uno stadio, di un Pub o di un palazzo dello sport. Nella zona di ascolto si deve ottenere: uniformità di pressione acustica, linearità della risposta in frequenza , intelleggibilità delle voci. Per ottenere questi risultati occorre analizzare accuratamente sia la conformazione dell'ambiente che la disposizione dell'area di ascolto per definire quali diffusori usare, dove posizionarli e come alimentarli. Oggi sono disponibili diversi strumenti che aiutano a svolgere queste analisi: analizzatori di spettro, equalizzatori parametrici, time delay e software specializzati per l'acustica ambientale. Tuttavia possiamo fare delle considerazioni generali che con l'aiuto di un buon "orecchio" ci consentiranno di accelerare i tempi di ottimizzazione.
- Direttività.
La direttività di un altoparlante è determinata, oltre che dalle caratteristiche costruttive (es.le trombe), anche dal rapporto tra le sue dimensioni fisiche e la lunghezza d'onda della frequenza riprodotta, infatti quando la lunghezza d'onda è più grande delle dimensioni del diffusore (basse frequenze), l'emissione si dice omnidirezionale (che emette cioè a 360° in tutte le direzioni), viceversa quando la lunghezza d'onda è più piccola dell'altoparlante (media e alta frequenza), il diffusore diventa direttivo (emette su un angolo definito). Osservando la relazione tra frequenza , lunghezza d'onda e velocità del suono:
L= c/f
L = lunghezza d'onda in metri
c = velocità del suono = 345 m/s
f = Frequenza in Hz
risulta che più alta è la frequenza più è piccola la lunghezza d'onda, per esempio alla frequenza di 100 Hz la lunghezza d'onda è di 3,45 metri, mentre a10.000 Hz è di 34,5 mm. Da queste considerazioni possiamo dedurre che la direttività di un altoparlante aumenta all'aumentare della frequenza emessa.
- Posizionamento
Nell'allestimento di un sistema a moduli separati per basse, medie, e alte frequenze si deve tener conto delle caratteristiche di direttività di ogni modulo. Il posizionamento dei diffusori per bassa frequenza , che coprendo un range di frequenze fino a 150/200Hz possono essere considerati omnidirezionali, non è particolarmente critico, potrebbero essere poggiati a terra o sopra il palco. Nel caso di unità di basse frequenze multiple è consigliabile che siano adiacenti tra loro, per evitare sfasamenti e interferenze. Molta attenzione và posta nel posizionamento delle unità per le frequenze medie e alte. Ovviamente per unità singole il problema dell'orientamento non sussiste, per unità multiple invece occorre valutare con attenzione l'angolo di inclinazione (sia orizzontale che verticale) e la distanza tra le varie unità, ciò per evitare interferenze distruttive.
Generalmente i cavi si possono dividere in due grandi categorie: cavi di segnale e cavi di potenza. Cavi di segnale, cosi' detti perchè trasferiscono segnali a basso livello come quelli prodotti dai microfoni o dai mixer. Proprio perchè trattano segnali di basso livello sono molto sensibili ai disturbi esterni (radiofrequenze, ronzii di rete etc.). Per ridurre la sensibilità ai disturbi vengono spesso usate linee bilanciate, realizzate con cavi nei quali il polo caldo (+) e il polo freddo (-) del segnale scorrono in due conduttori separati ed entrambi sono schermati da una calza esterna collegata a massa. Naturalmente per poter effettuare questo tipo di collegamento le apparecchiature devono essere predisposte sia per inviare che per ricevere segnali bilanciati. Generalmente sulle elettroniche di pregio sono presenti sia prese bilanciate che sbilanciate. L'altra categoria è quella dei cavi di potenza, che trasferiscono il segnale ad alto livello dagli amplificatori ai diffusori. Questi cavi sono percorsi da correnti molto elevate che possono surriscaldare i conduttori fino a far aumentare la loro resistenza anche di diversi ohm. Ovviamente a questo aumento di resistenza corrisponderà una diminuzione della potenza che giunge ai diffusori con conseguente diminuzione della pressione acustica prodotta. Deve esser quindi valutata attentamente la sezione dei cavi in funzione della loro lunghezza e delle potenze disponibili. Una raccomandazione di carattere generale è di fare in modo che gli amplificatori si trovino più vicino possibili ai diffusori, in modo che le linee di potenza non siano eccessivamente lunghe, anche perche' nel calcolo delle perdite di potenza lungo la linea occorre considerare una lunghezza del cavo doppia della distanza tra amplificatori e diffusori, perchè la perdita la avremo sia sul polo positivo sia su quello negativo. Per lo stesso motivo, cioè la perdita di potenza dovuta al surriscaldamento dei cavi, va posta particolare cura anche ai cavi di alimentazione dei finali, che se sottodimensionati possono ridurre sensibilmente la tensione di alimentazione degli stadi finali e con essa la potenza erogata.
Calcolo in Decibel delle perdite di linea
PERDITA IN dB = 10 X Log[R diffusore/(R cavo + R diffusore)]
Questo potrebbe essere un compromesso accettabile, ma teniamo presente che se la perdita arriva a -3 dB vuol dire che metà della potenza erogata dal finale viene dissipata lungo la linea.
MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DEI CABINET
Per la realizzazione dei box possono essere usati i materiali più disparati, dal marmo al calcestruzzo fino al plexiglas ed al cristallo, con risultati in certi casi discutibili. Tuttavia il materiale più diffuso in assoluto è il legno che può avere diverse origini e conformazioni:
MDF o "medium density fiberboard" o ancora "medite": è composta da segatura fine mescolata con adesivi e pressata ad alta pressione, di facile lavorazione, buona tenuta all'incollaggio , buona reperibilità e costo contenuto: E' il materiale più utilizzato in assoluto.
TRUCIOLARE: è sempre un composto di segatura, ma a grana grossa e la pressione di formazione è più bassa del MDF, per la sua costituzione la lavorazione può risultare approssimativa, ha buona tenuta laterale ma scarsa di testa, di facile reperibilità e costo contenuto.
MULTISTRATO MARINO: è costituito da strati alternati di legno pieno e composito incollati e pressati, è molto rigido e pesante, consente una buona lavorazione, buona tenuta all'incollaggio, di difficile reperibilità, costo elevato.
MULTISTRATO DI BETULLA: è composto a strati alternati di legno di betulla e compositi incollati e pressati, è molto rigido ma anche relativamente leggero, la lavorazione è abbastanza difficoltosa, ottima tenuta sia all'incollaggio sia alle viti, di difficile reperibilità, costo elevato.
LEGNO MASSELLO: legni utilizzabili e discretamente reperibili sono il rovere, il faggio, l'ulivo, il noce. Gli spessori devono essere consistenti (dai 20 mm in su). E' consigliabile dividere la superficie in 2 o più pannelli affiancati e con le nervature alternate in modo da ridurre le risonanze proprie.
TAGLIO, FORATURA E
ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI.
Prima di procedere al taglio dei pannelli si raccomanda di controllare la
corrispondenza delle misure, tenendo presente che nei progetti le quote
potrebbero riferirsi alle dimensioni interne che il box finito dovrà avere, e che
dovranno essere rispettate a prescindere dallo spessore del legno scelto. Nei
progetti dove sono previste delle fresature per il montaggio degli altoparlanti
a filo del pannello frontale, e non si dispone dell'attrezzatura necessaria, si
suggerisce di utilizzare un ulteriore pannello di spessore pari a quello del
cestello o della flangia dell'altoparlante e dopo aver praticato un foro di
diametro pari al diametro esterno dell'altoparlante da alloggiare, incollarlo al
pannello frontale. Nella fase di taglio e foratura sono anche da considerare i
morsetti esterni, quelli cioè, ai quali si collegherà l'uscita
dell'amplificatore. Se si prevedono morsetti già assemblati in una vaschetta di
plastica occorrerà praticare il foro per l'alloggiamento della stessa,
solitamente sul pannello posteriore, se invece si useranno morsetti singoli
sarà sufficiente praticare i due fori per far passare la vite. Un altro piccolo
accorgimento è di praticare dei piccoli fori (di diametro circa metà di
quello delle viti che si useranno) sulle sedi degli altoparlanti, in
corrispondenza dei fori di fissaggio dei cestelli o delle flange, questo per
evitare sfaldamento del legno e la non tenuta delle viti. L'operazione di
incollaggio dei pannelli è molto delicata e va effettuata con cura e precisione
magari aiutandosi con dei morsetti di legno per tenere in posizione i vari
pannelli, è infatti di fondamentale importanza evitare qualunque possibilità
di passaggio d'aria attraverso le giunzioni, a tale scopo si consiglia,una volta
incollati tutti i pannelli, di ripassare un rigo di colla su tutte le giunzioni
nella parte interna dei box. Nel caso di diffusori in bass-reflex si consiglia
di montare il tubo di accordo prima di incollare i pannelli, in questo modo si
ha la possibilità di sigillare perfettamente il tubo al pannello ed
eventualmente anche di trattare l'esterno del tubo con antirombo per evitare
eventuali risonanze.
MONTAGGIO DEGLI ALTOPARLANTI.
Dopo aver controllato tutto il necessario: il filtro, i cavi, le viti, le guarnizioni adesive, i morsetti esterni, il fonoassorbente, giravite, saldatore (con stagno),e gli altoparlanti, si può iniziare il montaggio. Per facilitare la saldatura e il fissaggio, dei componenti, si consiglia seguente successione operativa:
1) saldatura sul filtro dei cavetti per gli altoparlanti e per i terminali esterni (attenzione alle fasi).
2) fissaggio del filtro all'interno del box, è consigliabile posizionarlo sulla parete posteriore subito sopra ai terminali in modo da renderlo accessibile dal foro del woofer. assicurarsi che il fissaggio sia stabile ed esente da vibrazioni.
3) saldatura dei cavetti ai terminali esterni e fissaggio dei medesimi. Per evitare che ci sia passaggio d'aria, interporre, nel caso di terminali a vaschetta, una guarnizione di tenuta (può andar bene quella autoadesiva da 2-3 mm che si usa per gli infissi), nel caso invece di terminali singoli è sufficiente far colare della colla sui dadi di fissaggio interni.
4) Posizionamento del fonoassorbente sui pannelli interni in modo da coprire il filtro, i terminali e i cavetti per gli altoparlanti, ci si può aiutare con alcuni punti di colla. Il fonoassorbente può essere costituito da diversi materiali, dalla lana di roccia al poliuretano espanso a cunei, alla ovatti acrilica, è comunque sconsigliabile, almeno nei sistemi reflex, l'impiego di lana di vetro, perchè nel tempo tende a sfaldarsi e le fibre proiettate all'esterno attraverso i condotti, possono essere dannose alla salute. per quanto riguarda le quantità di fonoassorbente fare riferimento alle indicazioni riportate sui progetti, in generale è bene tenere presente che nei sistemi reflex il fonoassorbente deve rappresentare una leggera coibentazione, è quindi sufficiente uno spessore di 2 cm disposto su tutte le pareti. Nel caso di sistemi in sospensione pneumatica il fonoassorbente ha la funzione di aumentare lo smorzamento del sistema quindi al quantità sarà maggiore, tipicamente spessori di 5 cm su tutte le pareti sono accettabili.
5) Posizionamento delle guarnizioni di tenuta per gli altoparlanti: Possono sempre usati i nastri autoadesivi per infissi da 2-3 mm di spessore, disposti sulle sedi degli altoparlanti, prestando attenzione che la guarnizione agisca sull'intera circonferenza d'appoggio garantendo la tenuta al passaggio d'aria .
6) Saldatura dei cavetti ai terminali degli altoparlanti. E' un'operazione molto delicata che va effettuata con precisione e velocità, perchè insistendo troppo con il saldatore sui terminali si corre il rischio di pregiudicare i collegamenti interni degli altoparlanti. Anche in questo caso prestare attenzione alle polarità.
7) Fissaggio degli altoparlanti. Posizionare l'altoparlante verificando che aderisca bene alla guarnizione di tenuta, quindi serrare le viti gradualmente e in modo incrociato(1-3; 2-4).
INDICAZIONI SULL'AUTOCOSTRUZIONE DEI FILTRI
Alcuni progetti prevedono dei crossower specifici che è necessario costruire seguendo degli schemi. Una volta reperiti tutti i componenti, si procederà al loro posizionamento su di un supporto, che può essere costituito da un pannello di legno (magari impiegando quello di risulta dalla lavorazione del cabinet), da una basetta millefori oppure per i più attrezzati da un circuito stampato appositamente realizzato. I componenti dovranno essere fissati al supporto in maniera stabile , si consiglia di usare colla a caldo o fascette serrate al supporto stesso. Le saldature dovranno essere fatte con la massima attenzione, è frequente in fatti, che un circuito funzioni male o non funzioni per nulla solo perchè c'è una saldatura " fredda". Terminato il collegamento di tutti i componenti si consiglia di controllare più di una volta che il circuito corrisponda allo schema.
DIMENSIONI DEI CONDOTTI DI ACCORDO
Non è raro che nella ricerca dei componenti per la realizzazione del progetto, non si riesca a trovare il tubo di accordo del diametro giusto, oppure che si desideri realizzare il diametro diverso. Per determinare le equivalenze è sufficiente seguire il grafico seguente. La procedura è molto semplice:
- determinare il coefficiente C prendendo i dati di VB e FB dal progetto;
- Seguire la curva relativa al coefficiente fino ad incrociare la verticale corrispondente al diametro interno del tubo desiderato.
- Tracciare l'orizzontale dal punto d'incrocio all'asse verticale e ricavare la lunghezza del tubo.
Relazione tra diametro e lunghezza del tubo di accordo con Vb e Fb costanti
C = ( Vb x Fb2 ) / 1000
IMPIEGO DI CONDOTTI MULTIPLI A PARITA' DI Fb
Nel caso si voglia scomporre un tubo in diversi condotti più piccoli, ricordare che la somma delle superfici dei vari condotti dovrà essere uguale alla superficie del tubo di origine, così pure la lunghezza di ogni condotto dovrà essere la stessa del tubo di origine. Nel caso invece si voglia aumentare la superficie del tubo di origine (magari per diminuire il fastidioso "soffio"), occorre trovare la superficie complessiva dei vari condotti o del singolo condotto più grande e ricavare il diametro equivalente:
D = 2 x sqr(S)/(3.14)
S: somma delle superfici o superficie del condotto più grande
E' sufficiente poi eseguire il grafico come descritto sopra per ricavare la nuova lunghezza dei condotti.
Tratto dal catalogo "CIARE: MY guide per l'autocostruzione"
![]()