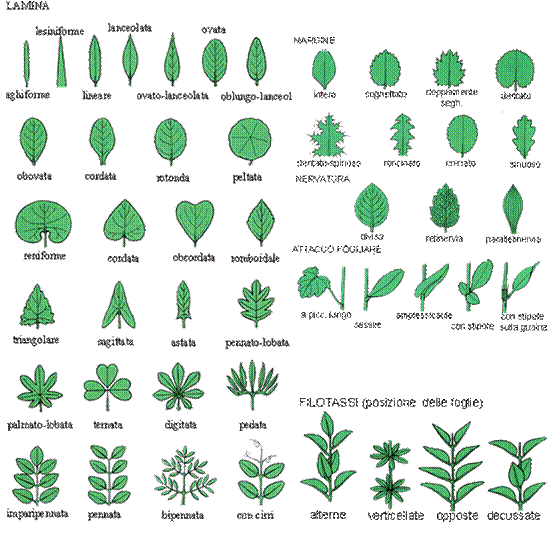|
|
ALBERI
Con il termine Albero si intende una pianta perenne il cui fusto
principale, legnoso, si sviluppa esternamente al terreno in senso
verticale.
Le specie arboree, che a maturazione sono in genere le più alte fra
le specie vegetali, si differenziano dalle piante a portamento
arbustivo, per avere spesso un unico fusto principale, e da quelle a
portamento erbaceo, per il fusto composto quasi interamente da
tessuto legnoso.
Sebbene gli alberi più piccoli si sviluppino a volte con più fusti,
similmente a quanto accade negli arbusti, la quasi totalità delle
specie di dimensioni maggiori cresce solo in forma arborea.
Le specie arboree sono comunemente suddivise in due gruppi: gli
alberi a foglie persistenti, o sempreverdi, e gli alberi a foglie
decidue, o caducifogli.
Le specie sempreverdi mantengono le foglie in tutte le stagioni
dell'anno, in quanto il ricambio tra le foglie vecchie e quelle
nuove avviene progressivamente e per piccole quantità. Inoltre, a
seconda della forma della foglia si distinguono le aghifoglie, come
le conifere, e le latifoglie, come il leccio e la sughera.
Le specie caducifoglie (ad esempio, il platano, il pioppo, il salice
e l'acero) sono tutte latifoglie e ogni anno perdono il fogliame
nella medesima stagione, in genere all'approssimarsi del periodo
freddo o di quello meno luminoso. Tutte le specie arboree sono
spermatofite (dotate di semi) e sono suddivise in :
- gimnosperme (piante a seme nudo)
- angiosperme (con semi racchiusi nell'ovario).
A loro volta, le angiosperme vengono classificate come
monocotiledoni o dicotiledoni, in base a differenze nella struttura
del seme.
ARBUSTI
Con il termine Arbusto si intende una pianta caratterizzata da un
lato dalla presenza di un fusto legnoso, che la differenzia dalle
piante erbacee, e dall'altro dalle dimensioni ridotte e dal
portamento caratteristico che la rende immediatamente riconoscibile
rispetto alle specie arboree. La definizione, tuttavia, non
corrisponde pienamente alla grande varietà di forme e strutture
presenti nel mondo vegetale: una stessa specie, infatti, può portare
contemporaneamente un carattere tipico di una pianta erbacea e un
altro riconducibile, invece, a un arbusto o a un albero; di
conseguenza, una classificazione troppo schematica può in certi casi
risultare artificiosa.
RADICE
La Radice
è l' organo delle piante superiori, solitamente sotterraneo o
ipogeo, con funzioni di assorbimento, trasporto e conservazione
dell'acqua e dei sali minerali, oltre che di ancoraggio della pianta
al suolo.
Le radici si distinguono dai fusti per la loro particolare
struttura, per il tipo di sviluppo e per l'assenza di appendici
quali gemme e foglie. La prima radice della pianta è detta
radichetta e si sviluppa durante la germinazione del seme,
allungandosi progressivamente fino a formare la cosiddetta radice
primaria, dalla quale, in un secondo tempo, si dipartono svariate
radici secondarie. In alcune piante le radici primarie vengono dette
"a fittone" perché crescono più delle radici secondarie, sia in
termini di dimensioni che di profondità all'interno del suolo. Il
trapianto di piante dotate di radici a fittone risulta spesso
problematico, in quanto questi organi sono molto fragili e dunque
possono rompersi facilmente, causando così la perdita di gran parte
dell'apparato radicale e la morte della pianta. Le radici avventizie
sono quelle che crescono alla base del fusto mentre le radici aeree
si sviluppano all'apice del fusto e hanno anche una funzione di
sostegno. In alcune piante, quando i nodi del fusto vengono a
contatto con il terreno possono sviluppare radici avventizie che
penetrano all'interno del suolo.
Le radici sono composte da tre tipi di tessuto:
- l'epidermide, che è lo strato più esterno,
- la corteccia, che si trova al di sotto dell'epidermide,
- il cilindro vascolare, che costituisce il cuore della radice.
Alcune cellule dell'epidermide presentano speciali propaggini,
chiamate peli radicali, specializzate nella funzione di
assorbimento, oltre che nell'ancoraggio della pianta al suolo;
l'acqua assorbita dai peli radicali viene trasportata, attraverso la
corteccia, all'interno del cilindro vascolare, dal quale viene
inviata agli altri tessuti della pianta.
Mentre all'interno del fusto i fasci vascolari, chiamati xilema e
floema, hanno una disposizione periferica, nella radice essi sono
raccolti al centro.
Nelle radici ipogee il nucleo centrale xilematico è solitamente
pieno e solido, mentre in quelle aeree si trova spesso una tenera
zona centrale, detta midollo.
Le radici tendono in genere a crescere in profondità nel terreno, in
senso verticale, a meno che la concentrazione dell'acqua nel suolo
non sia superiore in superficie. Nell'apparato radicale la crescita
avviene secondo due diverse modalità: lo sviluppo primario determina
il prolungamento e la ramificazione della radice a partire
dall'apice vegetativo, mentre dallo sviluppo secondario si origina
una corteccia dura e resistente, simile in tutto e per tutto a
quella del fusto, dovuta alla crescita dello xilema verso l'interno
della radice e del floema in direzione opposta.
Alcune specie sono in grado di sviluppare nuove radici dalle
estremità recise dei rami, dando così vita a nuove piante: questo
sistema di propagazione delle piante, detto a talea, è ampiamente
utilizzato in floricoltura. Alcune piante, come il salice, producono
radici con facilità, mentre le conifere emettono radici solo dopo
essere state sottoposte a speciali trattamenti, come l'applicazione
di speciali ormoni radicali, naturalmente presenti nelle piante al
momento della formazione di nuove radici.
In alcune specie arboree, dalle radici si sviluppano polloni che
talvolta danno origine a nuove piante, come si può osservare nel
pioppo e nell' ailanto che sono spesso circondati da giovani
pianticine, poste anche a una certa distanza dal fusto.
FUSTO
E' l' organo
fondamentale delle piante vascolari e generalmente porta foglie e
gemme e ha forma allungata, eretta o aerea; su questo modello
esistono, tuttavia, numerose variazioni.
Le foglie e le gemme sono inserite su punti specifici del fusto,
detti nodi, separati da spazi chiamati internodi.
I canali conduttori del fusto sono disposti verticalmente, nei
cosiddetti fasci vascolari composti dai tessuti dello xilema e del
floema.
Dal fusto i fasci vascolari si estendono nella struttura fogliare,
all'interno della quale prendono il nome di nervature.
Man mano che il fusto si allunga anche la rete dei fasci si espande,
in modo tale che tutte le foglie e i rami di nuova produzione siano
anch'essi dotati di tessuti conduttori.
La diversa disposizione dei tessuti vascolari caratterizza i due più
importanti gruppi di angiosperme: nelle monocotiledoni i fasci
vascolari sono collocati in ordine sparso per tutta la sezione del
fusto; nelle dicotiledoni, invece, essi sono disposti ordinatamente
in un anello periferico, posto internamente alla corteccia ed
esternamente al cilindro centrale.
Le funzioni del fusto sono essenzialmente di sostegno per le foglie
e tutte le altre strutture della pianta, e di conduzione dell'acqua
e delle sostanze nutritive, attraverso i vasi del tessuto vascolare.
I fusti di tipo legnoso sono caratterizzati dalla presenza di un
sottile strato di cellule, detto cambio, posto tra lo xilema e il
floema; essi sono diffusi in tutte le gimnosperme, tra le quali sono
comprese le conifere, mentre tra le angiosperme si trovano solamente
nelle dicotiledoni.
Al principio di ciascuna stagione di crescita le cellule del cambio
iniziano a dividersi, dando luogo alla formazione di nuove cellule
che si differenziano progressivamente, verso l'interno, nello xilema
secondario e, verso l'esterno, nel floema secondario. Via via che il
cambio cresce, il diametro del fusto aumenta di dimensioni e il
floema di nuova formazione preme verso l'esterno, sui tessuti più
teneri della corteccia, che si lacerano e lentamente muoiono.
Tuttavia, un secondo strato di cellule in grado di dividersi,
chiamato fellogeno, si forma all'interno della corteccia o, nel caso
di fusti non più giovani, all'interno del floema stesso. Il
fellogeno produce sughero, che va a sostituirsi alle cellule morte
dell'epidermide, proteggendo così le parti più tenere e scoperte del
fusto. La corteccia dei tronchi d'albero è, dunque, costituita da un
insieme di tessuti che comprende il floema e lo strato di sughero.
LA FOGLIA

E'
costituito dall'insieme delle foglie che formano la parte verde
della chioma e inoltre da quelle foglie "accessorie" che
eventualmente compaiono sul tronco, su rami isolati o sui cosiddetti
polloni radicali, assi sottili e diritti emessi dalle radici e che
di solito portano foglie più grandi di quelle della chioma.
Questo apparato provvede all'assimilazione delle sostanze nutrienti
attraverso il processo di fotosintesi.
E' oltremodo difficile stimare quante foglie ci siano su un albero
adulto sia perché sono troppe sia perché il quantitativo dipende
dallo sviluppo e dalle dimensioni della pianta; in ogni caso si può
trattare di decine di migliaia. Se però l'albero è una palma da
dattero, il numero complessivo non supera le 150, spesso addirittura
25. Se ne deduce che esiste una relazione inversa tra dimensioni e
numero delle foglie, fatto intuibile perché è evidente che per la
pianta la superficie fogliare totale non può essere inferiore a un
certo limite e quindi, mentre di foglie grandi ne bastano poche, di
piccole ce ne vogliono molte o moltissime.
LA FOGLIA:
ASPETTO E VARIABILITA
La foglia
appare uno degli organi più mutevoli e fantasiosi che madre natura
abbia mai inventato. La forma "canonica" è quella di una lamina
piatta dal contorno ora largo ora stretto, collegata per
un'estremità al ramo in quel punto che viene detto nodo. Di norma il
collegamento è mediato dal picciolo, sorta di rametto più o meno
breve, a volte brevissimo o assente, che in sezione appare
generalmente semicilindrico, con la faccia superiore piana o
addirittura concava e quella inferiore convessa. In certi casi
esiste una guaina, cioè un spansione membranosa del picciolo o della
base della lamina (quando il picciolo manca) che tende ad
abbracciare il ramo verso il nodo. Inutile dire che la lamina
fogliare può presentarsi intera e con il margine perfettamente
liscio, come ad es. nella Magnolia grandiflora; può avere margine
dentato o seghettato come nel castagno e nel ciliegio, può infine
presentare tutti i gradi di incisione fino alla divisione completa
in foglioline secondarie ciascuno dei quali imita una foglia intera
dotata o meno di un proprio picciolo; questo caso, comunissimo ad
esempio nelle Leguminose, è quello delle foglie composte. Molto
vario è anche l'aspetto delle nervature: nelle foglie pennate si
distingue un nervo centrale più grosso al quale confluiscono nervi
laterali più sottili, a loro volta variamente ramificati in
nervature di ordine crescente, via via più fini e terminanti in un
sistema reticolare formato di minute maglie poligonali che
circondano isolotti di tessuto verde. Le foglie palmate dell' acero
palmato e quelle orbicolari dell'albero di Giuda hanno diverse
nervature principali disposte a ventaglio come se la foglia
derivasse dalla fusione a cerchio di più foglie. Questa osservazione
trova conferma in alberi come l'ippocastano. Le loro foglie sono
composte, formate da segmenti indipendenti disposti a raggiera su un
picciolo comune, ciascuno con una nervatura centrale.
Nelle foglie delle Monocotiledoni non c'è una nervatura principale,
ma numerosissimi nervi paralleli che percorrono tutta la foglia per
il lungo confluendo nell'apice; questi possono a volte essere
collegati trasversalmente da nervature molto più sottili,
impercettibili a occhio nudo, che si dipartono ad angolo retto. Un
ricco vocabolario di combinazioni terminologiche è correntemente in
uso per classificare la morfologia dei diversi tipi fogliari, esso
tiene conto dei seguenti elementi: forma dei perimetro e grado di
divisione della lamina, apice, base, margine, nervature, picciolo.
Inoltre le foglie possono essere anche distinte in base alla
presenza, alla quantità, alla distribuzione e al tipo di peli (tricomi),
alla presenza di tricomi ghiandolari, tasche lisigene, cioè gruppi
di cellule trasformati in cavità piene di secreto, setole, mucroni,
spine, cere ecc.Anche l'ordine con cui le foglie si inseriscono sui
rami (fillotassi) è un elemento di un certo interesse, in parte
utilizzabile come carattere utile a riconoscere certe specie o certi
generi. Il problema della fillotassi nelle sue linee generali si
risolve in due casi principali: a ogni nodo si attacca una sola
foglia; a ogni nodo si attacca più di una foglia. Nel primo caso si
parla di foglie alterne, nel secondo di foglie opposte (due per
nodo) e di foglie verticillate (più di due per nodo). Le prime
possono essere, a loro volta: distiche, quando ogni coppia è
orientata esattamente come quelle adiacenti e tutte insieme
giacciono, quindi, sullo stesso piano, in due file ordinate;
decussate, quando una coppia è ruotata di 90° rispetto alla
successiva. Le foglie distiche si trovano solo su rami a portamento
orizzontale (abete bianco, tasso, Ligustrum sinense, ecc.) perché
altrimenti ogni coppia farebbe ombra a quella sottostante, mentre
tipiche dei rami a portamento verticale, sono le foglie decussate
(frassino, sambuco, giovani getti di Eucalyptus ecc.), messe in modo
da poter ricevere equamente la luce. Le foglie verticillate,
piuttosto rare nelle piante legnose (oleandro, alcune mirtacee),
sono orientate in modo che in un verticillo ognuna di esse si
disponga lungo la bisettrice dell'angolo formato da due foglie del
verticillo soprastante o sottostante. Mentre un tempo nelle
differenti fillotassi c'era chi ravvisava momenti diversi
dell'evoluzione delle Angiosperme oggi si sa che questo, come ogni
altro carattere, a priori non presenta aspetti più primitivi o più
evoluti. Quindi non si può dire, ad esempio, che le foglie alterne
caratterizzino le piante più primitive oppure che quelle più evolute
abbiano foglie opposte, perché l'evoluzione ha favorito ugualmente
ora l'una ora l'altra fillotassi un po' in tutti i gruppi di alberi.
Anche se non di regola, la foglia è accompagnata da una coppia di
foglioline accessorie molto ridotte, inserite sui due lati alla base
dei picciolo; si tratta delle stipole, organi la cui funzione non è
molto chiara, a meno che risulti evidente da precisi indizi. In
certe acacie tropicali le stipole sono legnose, rigonfie e al loro
interno delimitano una cavità abitata da formiche che difendono la
pianta dagli attacchi dei fitofagi. Nella robinia (Robinia
pseudoacacia) le,stipole si presentano sotto forma di un paio di
robuste spine la cui funzione non può essere che quella di
scoraggiare l'assalto di qualche specifico predatore legato,
verosimilmente, all'habitat della specie nella sua area d'origine
(Stati Uniti nordorientali), Infine ricordiamo nuovamente il caso di
diverse acacie, le cui stipole sostituiscono integralmente le foglie
assumendone aspetto e funzione. Ma a parte questi casi di evidente
significato adattativo, nella maggior parte degli alberi che le
possiedono le stipole sembrano apparentemente prive di funzione,
trascurando il contributo che esse possono dare con la fotosintesi
quando sono verdi. Verdi e persistenti infatti appaiono nei platani,
ma i faggi e le querce hanno stipole lineari, brunastre e
precocemente caduche; infine molti alberi, forse la maggior parte,
sono privi di stipole o presentano stipole ridottissime, fugaci e
difficilmente osservabili.
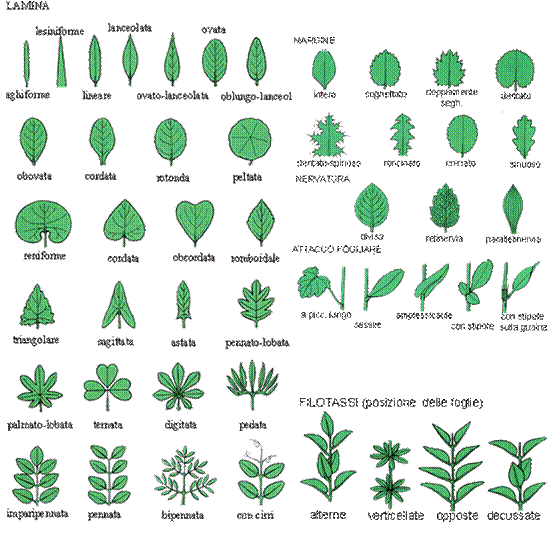
ILFIORE
 
Il fiore è l'
organo riproduttivo esclusivo delle cosiddette piante con fiori o
angiosperme.
Il fiore può essere considerato come un germoglio apicale, sorretto
e composto da un fusto modificato .
Su di esso sono inserite numerose appendici specializzate, formate
da foglie modificate, che nei fiori più evoluti sono disposte in
anelli concentrici (verticilli), mentre in quelli più primitivi
hanno una conformazione a spirale.
Il verticillo più esterno è detto calice e in genere è formato da
una serie di sepali verdi che proteggono la gemma fiorale prima che
il fiore sbocci.
All'interno del calice è inserita la corolla, formata da una serie
di petali che hanno la funzione di attirare gli insetti
impollinatori; per questo motivo hanno spesso colori sgargianti e
sono dotati di ghiandole che secernono nettare e altre sostanze
zuccherine .
Procedendo verso l'interno del fiore si incontra l'androceo, formato
dagli stami: essi sono costituiti da lunghi filamenti sormontati da
antere piene di granuli pollinici, che al loro interno conservano i
gameti maschili. Il verticillo centrale è detto gineceo ed è
costituito dai carpelli, spesso fusi assieme. Ogni carpello contiene
un ovario che porta i gameti femminili, detti ovuli.
Una volta avvenuta la fecondazione l'ovulo si trasforma in seme. Il
calice e la corolla formano insieme il perianzio.
Le angiosperme si dividono in due grandi classi, quella delle
dicotiledoni e quella delle monocotiledoni, che presentano notevoli
differenze anche a livello dei loro organi fiorali; le
monocotiledoni, ad esempio, presentano sepali colorati e spesso
indistinguibili dai petali, mentre le dicotiledoni portano spesso
molti stami e carpelli separati.
I fiori
di molte angiosperme si discostano dal modello descritto.
Esistono, ad esempio, fiori sprovvisti di alcune parti fiorali che
pertanto vengono detti incompleti. Se a mancare è una delle due
parti sessuate (gli stami o i pistilli), il fiore è detto
imperfetto. In questo caso, se il fiore è provvisto solo di pistilli
è detto pistillifero, mentre se è provvisto solo di stami è detto
staminifero. Solitamente i fiori sono ermafroditi, ovvero presentano
i caratteri di entrambi i sessi. Quando, invece, i fiori sono
unisessuati, le piante sono dette monoiche o dioiche a seconda che,
rispettivamente, portino i fiori di entrambi i sessi o di uno solo
dei due su ciascun individuo. Un altro carattere distintivo dei
fiori è la disposizione delle parti fiorali, che può essere di tipo
radiale o bilaterale.
I fiori possono essere classificati anche in base alla posizione
delle varie parti che li compongono. Nei cosiddetti fiori ipogini il
calice è posto inferiormente a tutti gli altri verticilli. Nei fiori
perigini, invece, il gineceo è circondato da una sorta di coppa, sul
cui margine superiore sono inserite le altre parti fiorali.
Nei fiori epigini, ad esempio quelli del melo, la coppa fiorale è
fusa al gineceo, mentre le altre parti fiorali sono inserite in cima
all'ovario.
Il
colore dei fiori è dovuto a due tipi di pigmenti: quelli
liposolubili (solubili nei grassi) e quelli idrosolubili (solubili
in acqua), che si trovano in due diversi tipi di organelli presenti
all'interno delle cellule epidermiche della pianta.
I fiori bianchi non devono la propria colorazione a particolari
pigmenti, ma alla presenza di numerose sacche d'aria microscopiche,
poste fra le cellule dei petali.
Il
profumo dei fiori è dovuto alla presenza nei petali dei cosiddetti
oli essenziali.
Dai fiori di alcune piante si ricavano essenze usate come profumi.
FORMULA FIORALE
Si utilizza la F.F. per abbreviare la descrizione delle
caratteristiche del fiore.
Le lettere utilizzate sono :
K (calice) a cui segue il numero dei sepali che lo compongono
C (corolla) a cui segue il numero dei petali
A (androceo) a cui segue il numero degli stami
G (gineceo) a cui segue il numero dei carpelli
Come esempio si riporta la F.F. del fiore delle Pittosporaceae che
possiedono cinque sepali, cinque petali, cinque stami e un ovario a
due carpelli, per cui avremo: K5 C5 A5 G2
IL
FRUTTO

Il
frutto è l' organo vegetale in cui si trovano racchiusi i semi,
presente nelle spermatofite, ossia nelle piante produttrici di semi
(gimnosperme e angiosperme). In tal senso, si possono considerare
frutti anche le pigne delle conifere.
Da un punto di vista strettamente botanico, si definisce frutto la
struttura che deriva dall'accrescimento e dalla trasformazione
dell'ovario (nel caso dei cosiddetti frutti veri) ed eventualmente
di altre parti del fiore, come il ricettacolo (nei frutti falsi): in
tal senso, il frutto è tipico delle sole angiosperme, cioè delle
piante con fiori.
Il frutto viene normalmente prodotto solo dopo la fecondazione
dell'ovulo. In entrambi i casi, la maturazione dell'ovario provoca
l'avvizzimento degli stimmi e delle antere e l'accrescimento
dell'ovario. Avvenuta la fecondazione, gli ovuli contenuti
all'interno dell'ovario fecondato si sviluppano in semi; nelle
varietà non fecondate, invece, gli ovuli non si sviluppano e
l'ovario conserva le dimensioni originarie. La funzione principale
del frutto è quella di proteggere lo sviluppo dei semi e di
contribuire alla loro dispersione.
Dopo la fecondazione, i carpelli dell'ovario, suddivisi in tre
strati, si sviluppano nell' epicarpo, esterno e formato da un
singolo strato di epidermide; nel mesocarpo, centrale; e
nell'endocarpo, interno e di spessore variabile a seconda della
specie. Nei frutti carnosi come le pesche e l'uva la polpa del
frutto è in genere costituita dal mesocarpo.
|
|