|
1.Come si studiano
i media
Per avere una conferma
dell'importanza assunta dai mezzi di comunicazione nella cultura contemporanea,
è sufficiente osservare la crescente attenzione destinata ad
essi da tutte le scienze umane. Rispetto a tutte le discipline e le
scuole di pensiero che si occupano di comunicazione, le aree individuate
costituiscono, naturalmente, una semplificazione. Tuttavia lo scopo
di un'opera introduttiva, come questa, non è di esaurire gli
argomenti di cui si occupa ma di ridurne la complessità, e di
fornire una visione di insieme effettivamente rappresentativa dell'universo
tematico a cui si riferisce. Se si considera che le discipline che possono
interessarci non sono tutte quelle che si sono occupate di comunicazione
sociale, ma soltanto quelle disposte ad eleggere la comunicazione
a principale oggetto di studio, la rassegna proposta, per quanto
forzatamente schematica, costituirà tanto più una buona
approssimazione, un valido strumento per costruire la propria attrezzatura
concettuale.
1.1 La ricerca
empirica
Prima fase:
gli effetti Con il novecento i media di massa raggiungono la loro
massima diffusione, e con essi nasce una nuova sensibilità nei
confronti della comunicazione sociale. Questa attenzione ha ottenuto
la sua prima razionalizzazione in una disciplina che è stata
definita genericamente communication research, cioè, appunto,
ricerca sul ruolo e sugli effetti della comunicazione.
Avendo conosciuto
prima di altri paesi la diffusione dei media di massa, a partire dalla
radio, gli Stati Uniti hanno costituito anche il primo laboratorio della
ricerca. In realtà, la prima idea diffusa sui media - tra gli
anni venti e i trenta - è un'idea del tutto rudimentale e perfino
antiscientifica. Passata alla storia con il nome di "teoria ipodermica"
o "teoria del proiettile", quest'idea supponeva una diretta
correlazione tra il messaggio veicolato dai media e i comportamenti
passivamente adottati dal pubblico (colpito appunto da un proiettile
o da un ago ipodermico). Non si trattava, in realtà, di un'autentica
teoria (tanto che non ne esiste un autore), ma piuttosto di una sensazione
di disagio nei confronti di un mezzo, come la radio, che aveva improvvisamente
invaso gli spazi della vita privata. Il successo dello scherzo radiofonico
di Orson Welles, che nel 1938 aveva gettato nel panico l'America recitando
brani da La guerra dei mondi di Herbert George Wells, è
la migliore dimostrazione di questo disagio. Questo rudimentale modello
Stimolo-->Risposta era quindi legato ad una concezione eccessivamente
negativa dei media di massa, ma in qualche modo era anche commisurato
all'inesperienza e all'immaturità del pubblico, che nei decenni
successivi avrebbe invece acquistato una maggiore consapevolezza di
sé.
Con il superamento
di quest'idea si apre il periodo più ricco della ricerca empirica
tradizionale, tra gli anni trenta e gli anni cinquanta. Pur avendo abbandonato
il modello ipodermico, peraltro, i primi analisti della comunicazione
avevano ancora lo scopo di misurare gli effetti dei media sulla
società. La principale urgenza conoscitiva, infatti, nasceva
ancora nello sconcerto seguito alla penetrazione sociale della radio
e all'utilizzo che di questo mezzo avevano fatto gli apparati propagandistici
dei regimi totalitari (soprattutto Goebbels in Germania).
Nell'esperienza
della communication research nordamericana è divenuto
però sempre più evidente che nel rapporto tra emittente
e ricevente intervengono diversi fattori di mediazione, e che quindi
gli effetti dei media sono di natura "indiretta" o, per l'appunto,
"mediata". Se prima si riteneva che la radio fosse capace
di indurre nei suoi ascoltatori specifici comportamenti - acquistare
un prodotto, votare un candidato - si inizia ora a sostenere che i media
agiscono sugli atteggiamenti del proprio pubblico e non sul suo comportamento
finale, che dipende invece da molte variabili. Da un modello tradizionale
Stimolo-->Risposta si passa ad un modello Stimolo-->Interpretazione-->Risposta,
che evidenzia come non tutti gli individui reagiscano allo stesso modo
ad uno stesso messaggio. Gli effetti dei media dipendono infatti da
diversi fattori, relativi sia alle caratteristiche del messaggio inviato
che a quelle del pubblico. Diventa così una variabile decisiva
la disponibilità dello spettatore: con i concetti di esposizione,
percezione e memorizzazione selettiva si vuole
appunto mostrare la discrezionalità del pubblico nell'esporsi
ai messaggi che possono influenzarlo. I principali protagonisti di questo
rinnovamento sono due ricercatori americani, Harold Lasswell e soprattutto
Paul Lazarsfeld.
La ricerca più
importante di questo periodo è stata svolta nel 1940 negli Stati
Uniti, e precisamente nella comunità di Erie County, nell'Ohio.
I risultati di questa ricerca, pubblicati nel 1944 con il titolo The
People's Choice dagli studiosi Lazarsfeld, Berelson e Gaudet, hanno
portato alla luce l'esistenza dei "leader d'opinione" e del
cosiddetto "flusso a due fasi" (two-step flow) della
comunicazione. La ricerca voleva analizzare gli effetti della propaganda
elettorale in una precisa comunità, ed aveva portato a concludere
che gli effetti di "attivazione" di un sentimento latente
o di "rafforzamento" delle idee preesistenti sono molto più
frequenti dei casi di autentica "conversione". Tuttavia, Lazarsfeld
e i suoi collaboratori avevano scoperto qualcosa in più. Cioè
che non esiste sempre un rapporto diretto tra emittente e ricevente,
ma che questo rapporto è mediato da particolari figure, appunto
i leader d'opinione, considerati competenti in alcune specifiche materie
e chiamati quindi a interpretare e diffondere il messaggio proveniente
dai media (flusso a due fasi). Ad ogni argomento presente nell'agenda
dei media corrisponde, tendenzialmente, un diverso opinion-leader: in
una comunità ci si rivolge ad esempio ad una casalinga per sapere
se il detersivo pubblicizzato è davvero efficace, ad un uomo
se si parla di un'automobile, e così via. Il rapporto tra emittente
e ricevente è mediato da alcuni individui, e quindi gli effetti
dei media dipendono dalle relazioni sociali che si stabiliscono intorno
alla ricezione dei messaggi.
E' necessario precisare
che le ricerche tradizionali sugli effetti dei media seguivano un metodo
quantitativo, e che uno degli strumenti principali era costituito
dall'analisi del contenuto. Calcolando la ricorrenza dei termini significativi
(simboli-chiave) nei messaggi dei media, si cercava di astrarre una
conclusione metodologicamente rigorosa sull'andamento globale della
comunicazione e della cultura. Una tendenza, questa, che in tempi più
recenti ha portato ad un'opposizione radicale - spesso, in verità,
accentuata oltre misura dagli studiosi coinvolti - tra metodi quantitativi
e qualitativi. Tra quanti sostengono la necessità di scomporre
la realtà in singoli frammenti - in questo caso, in singole situazioni
comunicative - empiricamente verificabili, per poi giungere a risultati
statisticamente significativi, e quanti rivendicano invece l'urgenza
di un sapere teorico di più ampio respiro, in grado di cogliere
i processi culturali non riducibili a misure quantitative. In questo
senso, dobbiamo ora rivolgerci ad una precisa area di ricerca, di tipo
qualitativo, e ad un preciso periodo, gli anni '70, in cui non ci si
è più interrogati sugli effetti dei media ma sul loro
valore culturale. In cui, come si usa dire, non ci si più è
chiesti "cosa fanno i media alle persone", ma invece "cosa
fanno le persone con i media".
Seconda fase:
il consumo
Se gli Stati Uniti
avevano battezzato la ricerca sui media, questa seconda fase ha invece
il suo epicentro a Birmingham, presso il Centre for Contemporary Cultural
Studies. Qui un nuovo movimento di studi, noto appunto come Scuola di
Birmingham, si pone l'obiettivo di studiare la cultura contemporanea
nel suo senso "antropologico", intesa cioè come modo
di essere degli individui e delle collettività. I cultural
studies, come si definiscono, riguardano l'insieme di "pratiche
e testi che costruiscono significati", cioè tutte le pratiche
culturali che coinvolgono l'individuo medio, compresi quindi i generi
"bassi" (fumetto, soap-opera, fotoromanzo, e così via).
Cercando di analizzare la cultura di massa dal punto di vista dei suoi
membri, gli studiosi di Birmingham si interrogano anche sulle relazioni
sociali sviluppate intorno ai media.
La ricerca tradizionale,
soprattutto attraverso l'analisi del contenuto, aveva considerato il
testo come l'elemento più significativo dei processi di
comunicazione. Il contributo fondamentale della Scuola di Birmingham
consiste invece nell'avere evidenziato la natura polisemica del
testo, mostrando come un prodotto mediale (un film, un articolo di giornale,
e così via) sia oggetto di interpretazioni molto diverse con
il variare delle condizioni socioculturali degli spettatori. Ad n
spettatori, quindi, corrispondono n diverse strategie di lettura
di uno stesso testo. Il ruolo dei media, quindi, si può valutare
soltanto a partire dalle condizioni del pubblico a cui essi sono destinati.
La communication
research, come visto, aveva fatto proprio lo schema Emittente-->Ricevente
e, pur arricchendolo di nuove variabili - i leader d'opinione, il contesto
di ricezione, l'esposizione selettiva, e così via - ne aveva
preservato la struttura profonda, continuando a considerare il processo
comunicativo come una congiungente tra l'emissore e il pubblico. Con
i cultural studies britannici, invece, viene accettata la centralità
del pubblico come agente positivo nella costruzione sociale della realtà.
Uno dei massimi studiosi di questo periodo, David Morley, ha mostrato
che il rapporto tra emittente e ricevente può perfino ribaltarsi,
in quanto la trasmissione di un messaggio mediale deve essere valutata
in base alla sua pertinenza rispetto alle condizioni culturali
del pubblico. Questo sistema di pertinenze precede il momento
dell'emissione: ad esempio, una famiglia operaia ha un suo quadro di
pertinenze (che i media contribuiscono a definire, ma non esauriscono)
costituito dagli argomenti verso i quali i suoi componenti hanno maggiore
sensibilità. La comunicazione televisiva, quindi, è efficace
soltanto quando i suoi contenuti sono conciliabili con il profilo culturale
del pubblico (o meglio: dei pubblici).
I cultural studies,
naturalmente, hanno bisogno di un metodo in grado di tradurre efficacemente
queste convinzioni a livello operativo. E il metodo operativo più
adatto a questo scopo è la ricerca etnografica, che possiamo
considerare genericamente come lo studio di una cultura attraverso il
contatto con le persone che la vivono. E infatti, tra gli anni settanta
e gli anni ottanta, la cosiddetta "svolta etnografica" ha
condizionato pesantemente i destini della ricerca sui media.
L'etnografia, secondo
la definizione di Shaun Moores, vuole scoprire "il senso che i
consumatori attribuiscono ai testi e alle tecnologie dei media nella
loro vita quotidiana". Il ribaltamento rispetto alla ricerca empirica
tradizionale non potrebbe essere più evidente: non si tratta
più di scoprire in che modo, e attraverso quali mediazioni, il
messaggio arriva al ricevente, ma invece di come i contenuti e le tecnologie
dei media sono utilizzati dai consumatori. Si passa, in altri termini,
dalla centralità del testo (il contenuto dei messaggi
veicolati dai media) alla centralità del contesto sociale
e culturale in cui i media si inseriscono.
Questo proponimento
ideale - osservare una cultura nel suo farsi - comporta però,
sul piano pratico, numerosi problemi di metodo. Infatti la ricerca empirica
tradizionale aveva il vantaggio di fondarsi su una solida strumentazione
di concetti e di procedimenti, e sulla garanzia della significatività
statistica dei suoi risultati. La ricerca etnografica è invece
di più difficile codificazione. Il suo obiettivo è quello
di raccontare storie di vita, in cui si esprima il rapporto quotidiano
tra gli individui e i mezzi di comunicazione di massa.
Due dei migliori
interpreti di questo orientamento, Morley e Silverstone, hanno così
sintetizzato le caratteristiche dell'etnografia: una particolare attenzione
al contesto (come detto); l'uso di strumenti qualitativi; la triangolazione
delle fonti (cioè il confronto tra i risultati di diverse rilevazioni,
che ne verifica l'attendibilità). La ricerca etnografica usa,
appunto, strumenti qualitativi, perché vuole misurare
atteggiamenti non traducibili in statistiche e in dati quantitativi.
Il suo metodo privilegiato è l'osservazione partecipante,
cioè l'intervento diretto del ricercatore nel luogo in cui si
svolge il consumo culturale (cioè, sostanzialmente, la famiglia).
Si tratta in molti casi - l'osservazione partecipante, la storia di
vita, l'intervista non strutturata - di strumenti di difficile utilizzo
perché non rigidamente codificabili. La ricerca etnografica,
rispetto a quella tradizionale, presenta infatti alcune difficoltà:
l'esiguità del campione sottoposto ad indagine, la difficile
traducibilità statistica dei risultati, la discrezionalità
di alcune tecniche di rilevazione, la forte distorsione operata dai
ricercatori sulle famiglie coinvolte nell'ossevazione partecipante.
Tuttavia queste
difficoltà sono compensate dall'innovatività di una pratica
di ricerca in grado di cogliere le dimensioni qualitative del consumo
mediale, non riducibili a risultanze statistiche. Se, ad esempio, si
vuole conoscere la diffusione di un medium o la popolarità di
un genere televisivo, la ricerca quantitativa (con strumenti di solito
standardizzati o facilmente standardizzabili) è certamente insostituibile.
Ma se si vuole indagare sul rapporto di una particolare generazione
con il mezzo televisivo - cioè su un tema che non è scomponibile
in una batteria di domande definite, se non a prezzo di una forte perdita
di informazione - il migliore strumento è costituito dai metodi
qualitativi della storia di vita e dell'intervista in profondità
(non strutturata). Nella ricerca sul campo, c'è una differenza
sostanziale tra quello che si può chiedere e quantificare
(ad esempio: quante ore al giorno guardi la televisione?), e quello
che bisogna scoprire con un'orchestrazione di metodi qualitativi,
perché non si può chiedere direttamente all'intervistato
(ad esempio, come si comporta la famiglia intorno al televisore).
Un'opposizione
tra metodi qualitativi e metodi quantitativi indubbiamente esiste: ma
non è una ragione valida per esasperare le differenze tra i due
approcci, come spesso viene fatto, piuttosto che cercare una possibile
integrazione dei loro strumenti e dei loro vantaggi. A molti anni di
distanza dai primi lavori della Scuola di Birmingham, e a molti decenni
dall'inizio della communication research, questa sembra l'unica
conclusione possibile.
1.2 La semiotica
Definizioni
e svolte semiotiche
Iniziamo con una
definizione. La semiotica non è soltanto lo "studio dei
segni", ma, più precisamente, lo studio dei codici,
cioè delle regole di correlazione che permettono di associare
un significato ad un significante. Queste regole sono molto varie perché,
ad esempio, le correlazioni tra il colore rosso del semaforo e l'obbligo
di arresto, tra il fumo e il fuoco di cui è indice o tra la parola
"cane" e l'idea a cui essa si riferisce, sono per l'appunto
tre tipi di correlazione diversi. In ogni caso, appaiono evidenti le
ragioni per cui la semiotica è stata considerata da subito una
delle discipline più adatte all'analisi dei processi comunicativi.
Tutto inizia con
il linguista Ferdinand de Saussure (1857-1913), che ha proposto per
primo un concetto di segno come "associazione di un significante
a un significato" (ovvero di "immagine acustica" e "pensiero").
Il segno, in Saussure, è sempre arbitrario, perché non
c'è nessuna relazione necessaria tra il significante "cane"
e il significato a cui esso rimanda (mammifero a quattro zampe eccetera).
A questa concezione, l'americano Charles Sanders Peirce (1839-1914)
ha aggiunto una terza variabile, sostenendo che oltre ad un significato
e ad un significante che lo rappresenta sostituendolo (come una
fotografia sostituisce una persona), esiste un destinatario del processo
comunicativo. Questo destinatario decodifica il processo comunicativo
attraverso un'immagine mentale di cui dispone, detta interpretante,
che è a sua volta un segno, utilizzato come astrazione neccessaria
a mettere in correlazione significati e significanti. Infatti non possiamo
intendere la relazione tra la parola "cane" letta in un libro
e il significato che essa vuole trasmettere se non avendo già
un'idea di cosa significhi "cane": ma quest'idea dipende ancora
da un'associazione di natura segnica, e così via, tendenzialmente
all'infinito. Tanto è vero che si parla, in questo caso, di "semiosi
illimitata".
Anche se più
marcata nel pensiero pragmatista di Peirce, l'adattabilità della
semiotica allo studio della comunicazione sociale dovrebbe apparire
evidente. E infatti sono ricchissimi i contributi della semiotica alla
ricerca sulla comunicazione e sulla cultura di massa, al punto che approcci
di tipo semiologico sono stati produttivamente applicati non solo alla
teoria della comunicazione, ma anche all'analisi dei diversi media e
generi contemporanei: la televisione, il cinema, la narrativa, la pubblicità,
il fumetto e perfino le ricette culinarie.
Qui non si vuole,
naturalmente, rendere conto dei diversi approcci e delle diverse correnti
della semiotica, ma semplicemente prendere atto della centralità
che questa disciplina ha guadagnato (al di là delle oscillazioni
della moda) negli studi sociali. Ora, esistono, schematicamente, due
tipi di semiotica: o meglio, esiste una semiotica in quanto studio
dei segni, ed una semiologia, come studio dei segni destinato
essenzialmente ai segni del linguaggio verbale (due filoni che risalgono
ai fondatori della disciplina, cioè rispettivamente a Peirce
e a Saussure). Entrambe queste tradizioni disciplinari sono state applicate,
con profitto, allo studio delle comunicazioni di massa: anche se entrambe
presentano, com'è inevitabile, alcuni rischi.
La semiologia,
come detto, è uno studio dei segni appiattito sui segni linguistici.
L'idea, cioè, non è che il linguaggio alfabetico sia una
variante della comunicazione, ma che al contrario sia il linguaggio
verbale a contenere in sé tutte le possibili forme di comunicazione
(anche perché il linguaggio alfabetico verifica quella condizione
tipica dei processi comunicativi, che è la disgiunzione
tra espressione e contenuto). La "superiorità" del
linguaggio verbale consiste nella sua maggiore duttilità: mentre
altri sistemi di segni possono soltanto esprimere dei contenuti, il
linguaggio verbale può anche parlare di se stesso.
Tutti i codici hanno una loro precisa espressività (la musica,
i gesti, la pittura, e così via), ma c'è soltanto un linguaggio
nel quale tutti gli altri linguaggi sono traducibili, ed è quello
verbale. Tuttavia questo tipo di approccio, molto marcato anche in un
semiologo geniale come Roland Barthes (1915-1980), insiste forse troppo
sulla traducibilità alfabetica degli altri linguaggi per sposarsi
perfettamente con le ambizioni della ricerca sulle comunicazioni di
massa, che deve necessariamente ricercare le qualità specifiche
ed irriducibili di diversi formati espressivi (quello orale, quello
scritto, quello visivo, e così via).
La semiotica, a
differenza della semiologia, ha invece l'obiettivo di costruire una
tipologia dei segni che prescinda dalla loro natura (segni linguistici
e non linguistici). Il problema è che l'apertura a qualsiasi
genere di segno crea, come visto in precedenza, un meccanismo di "semiosi
illimitata", cioè una deriva in una catena interminabile
di significazione (se qualsiasi pratica sociale è portatrice
di significato, come è possibile ordinare e comprendere l'insieme
di queste pratiche?). Per evitare questo rischio, la semiotica ha provveduto
a porre una cornice rigida ai processi di significazione: e questa cornice
è quella del testo. Per quanto cioè idealmente
disposta ad analizzare tutti i segni, la semiotica si è di fatto
concentrata soltanto su quelli contenuti nella categoria di testo (e
quindi, di nuovo, su segni di natura alfabetica). E', questo, il caso
di Umberto Eco, secondo il quale un testo non ha un significato univocamente
definito, ma può essere interpretato dal lettore. Tuttavia questa
interpretazione è (semiologicamente) legittima, cioè non
dà luogo ad una "sovrainterpretazione", soltanto se
è interna alla gamma delle possibili interpretazioni contenute
dal testo. Quindi, in poche parole, esiste sempre una demarcazione tra
ciò che è corretto in quanto interno ad un meccanismo
di natura testuale, e ciò che è scorretto in quanto esterno
a questa cornice, aberrante.
Sulla necessità
di una svolta, in questo senso, si è pronunciato il semiologo
italiano Paolo Fabbri (che ha intitolato un suo libro proprio La
svolta semiotica). Fabbri sembra ribaltare il procedimento classico
della semiotica: non scompone il linguaggio nelle sue unità minime
(appunto i segni), ma vuole invece costruire "universi di senso"
più ampi. E quindi studiare non più il segno - che esiste
solo come convenzione scientifica - ma la significazione, cioè
qualsiasi processo in cui esistono un significante ed un significato
diversi tra di loro (perché se un albero rappresenta un albero,
cioè se stesso, non c'è significazione vera e propria).
Questi processi non sono soltanto di natura verbale, ma rimandano a
qualsiasi pratica che può essere portatrice di significato.
Questo passaggio
rischia di riprodurre quella stessa deriva verso la "semiosi illimitata"
che abbiamo incontrato in precedenza: rischia anzi di accentuarla, perché
Fabbri sostiene che non c'è differenza tra le parole e le cose
(ad esempio la prigione è il significante di un significato,
quello di delinquenza, perché per capire lo stato della delinquenza
non bisogna pensare all'idea di prigione, ma al modo in cui le prigioni
sono realmente costruite). Torna così a porsi il dilemma tradizionale:
porre dei limiti concettuali ai processi di significazione, e quindi
escluderne alcuni, oppure rispettare la varietà di questi processi
e quindi rendere impossibile una loro codificazione. Perché se
tutto è portatore di significato, detto in termini più
rudimentali, non esiste una vera semiotica (che si fonda su una delimitazione
del campo, cioè sulla differenza tra ciò che è
significazione e ciò che non lo è); ma se invece sono
considerati portatori di significato solo alcuni processi (quelli testuali
o alfabetici, di solito), si perde l'obiettivo di analizzare il rapporto
generico tra significati e significanti.
Tuttavia il compito
della semiotica - quella successiva alla svolta - non è
di ridurre queste forme di significazione ad un unico linguaggio (verbale),
né di incastrarle in un sistema definito (il testo). Anzi, è
impossibile compiere queste operazioni perché non può
esistere una tipologia precostituita dei segni: se non, appunto, a prezzo
di una loro riduzione ad una categoria particolare. Ad ogni processo
comunicativo corrisponde un codice diverso: il compito della semiotica,
secondo Fabbri, è quello di stabilire categorie di significato
(o "quadri di pertinenza") variabili per i diversi modi comunicativi.
In questo caso, quindi, non c'è una riduzione di tutti i linguaggi
ad un'unità ultima di testo: al contrario, è il concetto
di testo ad essere moltplicato, perché a diverse pratiche comunicative
corrispondono criteri di testualità qualitativamente diversi.
Se si è insistito molto sul contributo di Fabbri, rispetto ad
altri, è proprio perché questa "svolta" - come
apparirà evidente - apre nuove possibilità di utilizzo
della semiotica nello studio delle comunicazioni di massa.
Modelli comunicativi
Questa strumentazione
- i concetti di significato e significante, di codifica e decodifica
- è stata utilizzata per costruire diversi modelli comunicativi,
adattabili anche al caso delle comunicazioni di massa.
In realtà
il primo di questi modelli comunicativi - che ha ispirato in modi diversi
tutti gli altri - è stato messo a punto tra il 1948 e il 1949
da due ingegneri, Claude Shannon e Warren Weaver, per cercare di ridurre
le perdite informative nel trasferimento di informazione tra una macchina
e l'altra (anche se il modello è stato considerato valido anche
per la comunicazione interpersonale). La loro teoria, nota come "teoria
matematica dell'informazione" segue questo schema:

Questo modello
riguarda quindi soltanto l'efficienza di un processo comunicativo (che
si raggiunge con la riduzione del rumore e della perdita informativa).
La semiotica ha cercato invece di spiegare il funzionamento effettivo
di questo processo, aggiungendo il concetto di codice (e quindi
i momenti della codifica e decodifica). Ne deriva questo
modello, elaborato nel 1965, tra gli altri, da Umberto Eco e Paolo Fabbri:
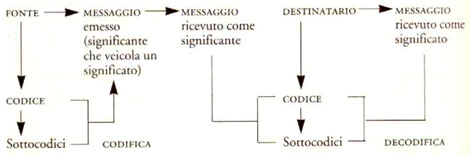
Il funzionamento
di un processo di comunicazione dipende quindi dai processi di codifica
e decodifica. Dopo la codifica, che avviene alla fonte, il messaggio
viene trasmesso (come significante che rimanda ad un significato, quindi
appunto sulla base di un codice), e quindi decodificato dall'emittente.
Perché ci sia un corretto scambio comunicativo, quindi, è
necessario che emittente e ricevente condividano lo stesso codice. Se,
ad esempio, uso l'aggettivo "intelligente" in senso ironico
(per sostenere che una persona è stupida) e il mio interlocutore
lo intende in senso letterale, il trasferimento informativo risulta
compromesso, proprio perché non c'è stata intesa sul codice
utilizzato.
Questo modello
semiologico di base, detto anche modello "semiotico-informazionale",
può essere ulteriormente complicato. E' quanto accade con il
cosiddetto modello "semiotico-testuale", elaborato da Eco
e Fabbri nel 1978. L'idea, in questo caso, è che un destinatario
non riceva mai un singolo messaggio (come in una condizione teorica
ideale) ma sempre un insieme di messaggi, detto "insieme testuale".
Questo modello è stato pensato specificamente per le comunicazioni
di massa (e non per le comunicazioni in generale), perché un
individuo riceve dai media una quantità enorme di messaggi: il
suo rapporto con l'emittente non è paritario, come quando si
scambiano singole informazioni, ma subalterno. I media veicolano quindi
un insieme di testi, che l'individuo decodifica soprattutto in base
all'insieme di pratiche testuali che già possiede grazie alla
sua esperienza.
Guardando un film
in televisione, ad esempio, noi non riceviamo un semplice messaggio,
ma una quantità di sollecitazioni e di informazioni. Un film
non ci racconta soltanto una storia, ma ci comunica per prima cosa la
sua natura testuale di film, che possiamo decodificare solo perché
possediamo alcune "pratiche testuali depositate", cioè
perché sappiamo già cos'è un film, avendone visti
molti altri in precedenza. Se la comunicazione è, in generale,
una trasmissione di informazioni, la comunicazione di massa è
trasmissione di testi che comprendono in sé anche una definizione
della propria natura e una definizione della natura del pubblico.
Il corretto funzionamento
della comunicazione è legato, come detto, alla coerenza tra codifica
e decodifica: se il ricevente utilizza lo stesso codice usato dall'emittente,
si dà una corretta trasmissione, altrimenti si parla di "decodifica
aberrante", cioè di un'errata interpretazione del codice
che vanifica la trasmissione. Tuttavia, nel caso delle comunicazioni
di massa, è piuttosto raro che l'emittente e il ricevente utilizzino
lo stesso codice (basta pensare gli schermi che si usano verso i messaggi
televisivi: l'ironia, la contestazione ideologica, il disinteresse,
la sopravvalutazione degli argomenti considerati interessanti, e via
dicendo). E' quanto ha rilevato nel 1980 uno studioso inglese (nell'area
dei cultural studies), Stuart Hall, con il suo modello "encoding/decoding"
(cioè, appunto, "codifica e decodifica"). Secondo Hall,
il ricevente non deve necessariamente rispettare la codifica avvenuta
alla fonte, ma può invece utilizzare tre strategie diverse, definite
lettura preferita, negoziata e di opposizione:
può cioè, rispettivamente, condividere peinamente il codice
dell'emittente, condividerlo solo parzialmente o contestarlo del tutto.
Ma la cosa importante è che la lettura preferita non è,
come nei modelli semiologici "puri", il caso dominante: è
anzi quello più raro, perché il ricevente modifica sempre
in qualche modo il codice usato dall'emittente. La "decodifica
aberrante" è quindi, nel caso delle comunicazioni di massa,
il caso più frequente.
1.3 La sociologia
dell'interazione
Interazioni
di sistema...
Il primo contatto
tra il pensiero sociologico e la questione dei media avviene al livello
che si definisce "macrosociologico", cioè a livello
di analisi delle grandi strutture che costituiscono la società.
L'orientamento di pensiero che ha cercato di spiegare più sistematicamente
l'andamento della società è quello della sociologia funzionalista
(che deriva, appunto, dalla riflessione struttural-funzionalista generale).
Quello che il funzionalismo propone è una visione d'insieme della
società, che in quanto tale prescinde, per molti versi, dai suoi
singoli componenti (si parla, in questo senso, di posizione "olistica").
In questa prospettiva, infatti, la società è considerata
come un insieme, come un sistema globale e integrato che mira
al proprio mantenimento.
E per mantenersi,
un insieme sociale (nell'ottica funzionalista) deve risolvere alcuni
problemi fondamentali (detti "imperativi funzionali"), che
sono tradizionalmente considerati: la conservazione del sistema (attraverso
la socializzazione degli individui, che vengono così educati
ad interiorizzare le norme di comportamento, piuttosto che a
subirle); l'adattamento all'ambiente (per cui un sistema sociale deve
adeguarsi alle varie condizioni geografiche, sociali ed economiche in
cui si inserisce); la definizione degli scopi (ad esempio: la scolarizzazione,
la piena occupazione, eccetera); l'integrazione tra le parti (che è
condizione fondamentale dell'esistenza di un sistema). In qualche modo,
il funzionalismo ricalca quindi quell'analogia tra struttura sociale
e organismo animale (in quanto entrambi insiemi che dipendono dall'armonia
delle parti) che aveva caratterizzato il primo periodo della sociologia,
alla fine del diciannovesimo secolo.
In sociologia,
il funzionalismo ha vissuto una stagione molto fortunata, ma è
stato poi soggetto a molte critiche. In particolare, è stata
fortemente contestata la sistematizzazione fornita dal sociologo americano
Talcott Parsons (1902-1979), l'interprete più riconosciuto di
questa scuola di pensiero. Non è qui possibile dare conto dei
meriti e delle imperfezioni del modello teorico, tanto più che
le critiche rivolte ad esso rimangono a tutt'oggi quelle più
tradizionali: secondo le quali il funzionalismo fornisce una visione
statica dei processi sociali e, soprattutto - esaltando i fattori
di integrazione - non dà conto dei conflitti che si consumano
nella società (tanto che il funzionalismo è spesso opposto,
per l'appunto, alle "teorie del conflitto", quali la sociologia
marxiana).
In realtà,
nelle sue versioni più evolute, la teoria funzionalista ha rinunciato
alla staticità di questa visione originaria, accettando la distinzione,
ad esempio, tra funzioni "manifeste" e funzioni "latenti".
Sempre all'interno della riflessione funzionalista, soprattutto, è
stata messa in evidenza una serie di disfunzioni (ovvero di funzioni
negative) che rendono più verosimile (in quanto meno armonico)
il quadro teorico complessivo. Tuttavia, malgrado l'apporto di queste
sostanziali innovazioni, l'obiettivo del funzionalismo rimane quello
di spiegare la società come struttura globale che dipende dall'integrazione
e dal funzionamento "corretto" delle sue parti.
In questa visione
d'insieme, naturalmente, è stato preso in considerazione anche
il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa. Esistono infatti diverse
teorie comunicative costruite sull'impianto generale della sociologia
funzionalista, destinate a studiare - per l'appunto - le funzioni
dei media rispetto alla società. L'obiettivo è quindi
analizzare l'importanza strategica dei media rispetto alla società
nel suo insieme, ma anche rispetto alle sue componenti (gruppi e individui).
Naturalmente, le funzioni dei media possono essere di vario genere:
ma quelle solitamente considerate sono le funzioni di socializzazione
(per chi consuma i media), di attribuzione di status (per chi è
protagonista nei media) e, più in generale, di diffusione dell'informazione.
Alla riflessione
funzionalista ha partecipato, soprattutto negli Stati Uniti, una parte
significativa dell'intelligenza sociologica (Lazarsfeld, Blumer, Katz,
Wright, McQuail, Gurevitch, Rosengren, Merton). Il prodotto più
tipico della scuola funzionalista, nel campo della comunicazione di
massa, è sicuramente la teoria degli "usi e gratificazioni"
("uses and gratifications"), elaborata, nelle sue versioni
mature, negli anni settanta. L'idea è che il sistema dei media,
in quanto componente dell'insieme sociale, sia dotato di una serie di
funzioni fondamentali che ne favoriscono l'uso da parte degli
individui, in vista (appunto) di particolari gratificazioni.
Secondo la versione più accettata di questa teoria, gli individui
utilizzano i media per alcuni bisogni fondamentali: bisogni cognitivi
(ricerca di informazioni e di sapere), bisogni affettivi (ricerca di
emozioni), bisogni di integrazione individuale (status personale) e
sociale (rafforzamento dei rapporti sociali), bisogni di evasione (come
superamento della tensione).
L'approccio funzionalista
alle comunicazioni di massa ha quindi dei vantaggi oggettivi rispetto
ai metodi tradizionali di studio, come la ricerca sugli effetti dei
media. Rispetto a questi studi, infatti, la teoria degli "usi e
gratificazioni" considera lo spettatore come un soggetto attivo,
che compie delle scelte in vista di un obiettivo da raggiungere. Questo
modello sminuisce quindi il potere dei media, perché li considera
come agenzie in concorrenza con altre agenzie per la soddisfazione
di alcuni bisogni essenziali, e rivaluta invece il ruolo del pubblico.
Il problema, tuttavia, è che questa teoria mantiene la caratteristica
del pensiero funzionalista: costruisce cioè un sistema chiuso
in cui tutte le possibili combinazioni di fattori sociali e culturali
tendono ad integrarsi in un ciclo sostanzialmente armonico di bisogni
e di funzioni.
A questa caratteristica
non sfugge nemmeno la cosiddetta "teoria della dipendenza",
messa a punto tra gli anni settanta e gli anni ottanta dai ricercatori
americani Melvin De Fleur e Sandra Ball-Rokeach. Anche se frutto di
una lunga lavorazione, la "teoria della dipendenza dal sistema
dei media" è appunto, in realtà, l'ultimo tentativo
di applicare il modello funzionalista allo studio delle comunicazioni
di massa. L'idea è che la società abbia una relazione
di dipendenza nei confronti dei media (sia nei confronti del sistema
mediatico, che nei confronti di un singolo medium o di un singolo genere,
come il telegiornale), e che questa dipendenza venga attivata
quando uno spettatore seleziona un programma da vedere (o un testo da
leggere, un programma radiofonico da ascoltare, e così via).
Lo spettatore si pone così in una situazione di coinvolgimento
non solo cognitivo, ma anche affettivo e comportamentale, perché
dipende dai media per obiettivi di natura diversa (di "comprensione,
orientamento e svago"), che hanno a che fare con tutta la sua esperienza
sociale.
...e interazioni
quotidiane
Ad un livello "microsociologico",
cioè di interazioni quotidiane, il discorso cambia. Naturalmente
questo piano di analisi (in qualche modo condiviso da sociologia e psicologia
sociale), che riguarda le relazioni interpersonali, non si presta a
grandi riflessioni sul ruolo dei media nella società. Si presta
piuttosto alla ricerca sul modo in cui i media si inseriscono nel vissuto
sociale (etnografia dei consumi) o lo modificano (ricerca sugli effetti),
come già visto in precedenza. Tuttavia non solo a livello empirico
(come nei casi appena citati), ma anche a livello teorico, la prospettiva
microsociologica ha offerto spunti interessanti allo studio della comunicazione.
In quest'area di studi, come detto, non è possibile mettere in
campo una riflessione sistematica sui media, come nel caso della macrosociologia.
Ma è invece possibile, come vedremo, sviluppare un'indagine che
tenga conto della comunicazione come variabile decisiva nei comportamenti
sociali. E, come vedremo, queste indagini, pur non riguardando direttamente
i media, offrono alla ricerca mediologica elementi perfino più
significativi, in molti casi, di quelli offerti dalla riflessione di
area macrosociologica sul ruolo dei mezzi di comunicazione.
E' il caso di Erving
Goffman (1922-1982), sociologo tra i più raffinati nella cultura
contemporanea, e del suo studio sulla "vita quotidiana come rappresentazione"
(1959). L'idea di Goffman (frutto sia di una ricerca empirica che di
una speculazione teorica) è che i gruppi sociali si dividano
in due categorie: i gruppi di "performance" e i gruppi di
"audience". La vita sociale è, appunto, una rappresentazione
(si parla infatti di "metafora drammaturgica"), che i gruppi
sociali mettono in scena di fronte ad altri gruppi. Goffman cita l'esempio
dei camerieri in un hotel delle isole Shetland (dove aveva svolto la
sua ricerca). Verificando che il gruppo di performance dei camerieri,
di fronte al proprio pubblico (ovvero i clienti del ristorante), inscena
una rappresentazione, mostrandosi deferente, rispettoso, discreto, e
così via. Questo accade in uno spazio di "palcoscenico"
(cioè dove il pubblico è presente): mentre nello spazio
di "retroscena", nascosto al pubblico, i camerieri hanno un
comportamento del tutto diverso, molto più informale e irrispettoso.
E' quanto accadeva nella cucina dello Shetland hotel.
La vita sociale,
quindi, si divide in spazi di palcoscenico e di retroscena, cioè
in spazi privati, in cui gli individui non "recitano", e spazi
pubblici in cui inscenano invece una precisa rappresentazione. Naturalmente,
il comportamento nel retroscena contraddice il comportamento pubblico:
una persona insicura, ad esempio, può assumere in pubblico un
atteggiamento spavaldo, e mostrarsi invece vulnerabile soltanto nel
suo retroscena (ad esempio in famiglia). Secondo Goffman, quindi, la
vita sociale si fonda sulla demarcazione dei confini tra palcoscenico
e retroscena: infatti il gruppo di audience non deve accedere alle situazioni
di retroscena che contraddicono il comportamento pubblico.
Vediamo perché
questo modello è importante per lo studio della comunicazione.
La società, sostiene Goffman, si divide in gruppi di audience
e di performance (dove ogni individuo, a seconda delle situazioni, appartiene
sia a gruppi di audience che a gruppi di performance). Per appartenere
ad un gruppo, quindi, bisogna condividere il suo retroscena, che è
lo spazio in cui si prepara la rappresentazione pubblica. Condividere
il retroscena, però, significa soprattutto conoscere i "segreti
distruttivi" del gruppo (cioè quei segreti che, portati
all'esterno, renderebbero poco credibile la rappresentazione): appartiene
al gruppo dei camerieri chi sa quello che i camerieri fanno nel retroscena
della cucina. Infatti se un cameriere raccontasse al pubblico dei clienti
i segreti del gruppo - il modo in cui i camerieri preparano le portate,
il modo in cui mangiano o in cui deridono i clienti - il gruppo stesso
verrebbe distrutto, perché la sua rappresentazione apparirebbe
falsa e non credibile. I segreti devono quindi rimanere all'interno
del gruppo: e per questo motivo, il gruppo stesso deve comprendere,
per definizione, tutte le persone che sono a conoscenza di questi segreti.
Quindi, appartenere ad un gruppo sociale - un gruppo di amici, una categoria
professionale, un'associazione, un circolo informale - significa soprattutto
condividere i suoi segreti, cioè il suo patrimonio di conoscenze.
Pertanto Goffman (non a caso un autore fortemente "durkheimiano",
e quindi interessato alla costruzione dell'ordine tramite il vissuto
culturale) finisce per fondare la sua sociologia sull'informazione
come risorsa strategica e come criterio di differenziazione. Solo il
controllo dell'informazione distingue un gruppo sociale da un altro:
è sufficiente trasportare questa considerazione sul piano macrosologico,
per verificare quanto sia rilevante nello studio delle comunicazioni
di massa.
Non è un
caso che Joshua Meyrowitz, uno studioso americano autore forse dell'ultima
grande teoria mediologica sulla televisione, abbia utilizzato proprio
il pensiero di Goffman per costruire il suo modello di analisi del rapporto
tra tv e società. In realtà, Meyrowitz parte dal superamento
della sociologia goffmaniana, sostendendo che la televisione ha eliminato
i confini tra palcoscenico e retroscena, rendendo visibili tutti gli
angoli della società. Infatti oggi, attraverso la tv, è
possibile conoscere il retroscena dei gruppi a cui non si appartiene:
non è più necessario essere un medico per conoscere i
segreti distruttivi della categoria dei medici (ad esempio), perché
questi sono mostrati a tutti dalla televisione. Meyrowitz ha ragione
nel sostenere che, rispetto al pensiero di Goffman, non esiste più
identità tra luogo e informazione (come quando
le notizie di retroscena circolavano, appunto, solo nel retroscena),
perché la televisione ha illuminato (ed eliminato) tutti i retroscena.
Tuttavia lo studio di Meyrowitz, pur superando i contenuti della sociologia
di Goffman, ne ricalca in realtà il metodo, mostrando come la
dinamica sociale dipenda sempre più dal modo in cui vengono distribuite
le risorse strategiche dell'informazione.
1.4 La "mediologia"
La mediologia
come studio dei mezzi
Tutti gli approcci
che stiamo prendendo in considerazione studiano la comunicazione a partire
da un preciso punto di vista: dal punto di vista della società
(la sociologia), dal punto di vista dei codici utilizzati (la semiotica),
dal punto di vista degli effetti che essa provoca sugli individui (la
ricerca empirica) o del modo in cui si inserisce in un contesto sociale
(l'etnografia). Vediamo ora cosa succede nel momento in cui si decide
di studiare la comunicazione da un punto di vista interno ad essa,
e cioè a partire dai mezzi attraverso i quali la comunicazione
avviene.
L'epicentro di
questa fase di studi è Toronto, dove, a partire dagli anni cinquanta
e a diverse ondate, un gruppo di ricercatori (Innis, McLuhan, Havelock,
de Kerckhove, più altri meno conosciuti in Europa) ha iniziato
a studiare il rapporto tra la cultura occidentale e i supporti fisici
della comunicazione (cioè i mezzi attraverso i quali la cultura
si diffonde e si mantiene). I protagonisti principali di questo rinnovamento
sono due studiosi piuttosto particolari, Harold Adams Innis (1894-1952)
e Marshall McLuhan (1911-1980).
Innis è
il vero fondatore della Scuola di Toronto, perché (dopo essersi
occupato di economia e di politica industriale) ha indagato per primo
in modo sistematico la relazione tra civiltà e mezzi
di comunicazione. La sua idea è che una civiltà
sia definita, principalmente, dai suoi equilibri spaziotemporali e dalle
sue convenzioni culturali: nel momento in cui questi equilibri e queste
convenzioni entrano in crisi, la civiltà si dissolve e viene
rimpiazzata da una nuova forma sociale e istituzionale. I mezzi di comunicazione,
secondo Innis, sono esattamente gli agenti di questa possibile rottura
storica, perché la loro natura tecnologica implica un particolare
modo di impiego e genera una precisa forma istituzionale. L'argilla
non è soltanto un mezzo di comunicazione, ma uno strumento di
diffusione del sapere: essendo difficilmente trasportabile, dà
luogo ad una forma istituzionale - quella delle civiltà mesopotamiche
- in cui il sapere, e quindi il potere, è fortemente
concentrato. Essendo più facilmente trasportabile, invece, il
papiro ha permesso un'organizzazione politica più complessa,
come quella della civiltà egizia. La semplificazione delle tecniche
di scrittura con l'invenzione dell'alfabeto ha permesso un ulteriore
allargamento della vita civile, e quindi la nascita della democrazia
(anche se esclusiva) in Grecia.
McLuhan, vivace
studioso di letteratura e di teatro convertito alla ricerca sui media,
utilizza questa concezione, arricchendola di una straordinaria capacità
di intuito e di esposizione, e sintetizzandola nei suoi celebri slogan.
Il più noto di questi slogan è, senza dubbio, "il
mezzo è il messaggio". E cioè: un mezzo di comunicazione
esiste in quanto tale, e la sua natura sarà sempre più
importante dei suoi contenuti. Quindi, ad esempio, quale che sia il
suo messaggio esplicito, la televisione è significativa in
quanto televisione. Questa era anche la tesi avanzata da Innis,
secondo il quale i diversi media (argilla, papiro, eccetera) definiscono
un sistema di realtà semplicemente per la loro natura - malleabilità,
duttilità, e così via - e non per l'utilizzo che di essi
viene fatto. Anzi: l'utilizzo di un medium è sempre vincolato
alla sua natura, previsto dalla sua qualità tecnica.
McLuhan applica
questo discorso anche ai media contemporanei, costruendo una tipologia,
divenuta classica, che prevede tre fasi storiche. In principio era l'oralità,
cioè l'epoca in cui l'uomo comunicava solo verbalmente o attraverso
i gesti. L'invenzione dell'alfabeto fonetico ha invece creato
una disgiunzione tra il linguaggio e la realtà (perché
mentre il pittogramma di un albero somiglia ad un albero, la parola
"albero" non ha niente a che vedere con il suo referente fisico,
ma dipende da una convenzione culturale e da un particolare utilizzo
dell'apparato di fonazione). Con questa disgiunzione, estremizzata dalla
stampa (McLuhan parla infatti di "galassia Gutenberg"), il
modo di pensare dell'uomo si sgancia dalla sua esperienza fisica, e
fa quindi nascere l'astrazione intellettuale e gli ordinamenti sociali
che ne derivano (la società in senso lato). Questo perché
la comunicazione orale sollecita l'udito, mentre la scrittura
porta ad una visualizzazione del sapere (infatti nell'epoca della stampa
nasce anche la prospettiva) e stimola quindi la vista. Con i
media elettronici - radio e televisione - la comunicazione orale guadagna
invece una nuova posizione di egemonia (la cosiddetta "oralità
secondaria" o "di ritorno"), e quindi, secondo McLuhan,
sollecita di nuovo l'udito, favorendo il recupero di forme di associazione
non più societarie ma tribali, come era nell'epoca dell'oralità
primaria (anche se questa aggregazione, favorita dai media elettronici,
può avvenire a livello planetario, tanto che McLuhan parla di
"villaggio globale").
McLuhan (che era
un autore talmente enfatico da divenire spesso antiscientifico) ha commesso
alcuni errori sostanziali. Infatti le diverse fasi oralità-scrittura-oralità
secondaria non si pongono in una relazione di reale discontinuità
(o meglio: sono discontinue sul piano fenomenologico, ma continue sul
piano storico). A differenza di quanto sostenuto da McLuhan, in realtà,
ogni fase rinforza quella precedente: non è un caso che nell'epoca
della televisione la lettura (a dispetto di quello che si sostiene)
sia molto più diffusa che in precedenza. In questo campo, sono
certamente più profonde le riflessioni di Eric Havelock, storico
della lingua greca molto attento al passaggio dalla cultura orale all'alfabeto
fonetico, e del padre gesuita Walter Jackson Ong (peraltro esterno alla
Scuola di Toronto), studioso di retorica e di lettere antiche, autore
della migliore monografia sul rapporto tra oralità e scrittura.
Ma l'utilità di McLuhan - la sua carica antiaccademica, la sua
fortissima capacità innovativa - non è in discussione:
la mediologia non può anzi prescindere dal suo contributo.
Tre sono, in sintesi,
i meriti fondamentali della Scuola di Toronto: aver portato la comunicazione
al centro del dibattito scientifico, fino a sviluppare un modo di studiare
la storia in funzione della comunicazione stessa; avere svelato
il condizionamento che i media operano in quanto tecnologia, indipendentemente
dall'utilizzo che se ne fa; e, infine, aver mostrato come tutti i sistemi
culturali e comunicativi dell'uomo, a partire all'invenzione dell'alfabeto,
siano di natura tecnologica e artificiale (una considerazione che invalida
quindi le tante discussioni sulla presunta superiorità della
scrittura sull'immagine, del libro sulla televisione, e così
via). Ma questo orientamento di studi comporta anche un rischio. Quello
di cadere nel cosiddetto "determinismo tecnologico", cioè
di spiegare tutti gli eventi storici e sociali soltanto come conseguenze
della tecnologia, e non, più realisticamente, come negoziazione
tra tecnologia e società. E' probabilmente per questo che un'area
sempre maggiore della mediologia (intesa come studio qualitativo dei
media) si è concentrata sull'archeologia dei mezzi di
comunicazione, cercando di scoprire le ragioni sociali che precedono
l'ideazione tecnologica dei media.
La mediologia
come ricerca archeologica
La mediologia,
come detto, non può rinunciare al contributo della Scuola di
Toronto. Tuttavia il suo scopo è quello di dare conto della relazione
dialettica che si stabilisce tra tecnologia e società,
mentre quella di McLuhan, come visto, è una posizione "determinista",
che spiega cioè la società come espressione della tecnologia
(scrittura, comunicazione elettronica, e così via). Ma questo
tipo di mediologia rischia di risultare - pur in tutta la sua produttività
- piuttosto arida. E qui nasce una seconda fase della mediologia, quella
"archeologica".
I media hanno ovviamente
una storia: ma hanno anche una protostoria. Infatti la nascita
dei media dipende dalla ricerca tecnologica (e quindi dalla produzione
industriale), ma il loro successo è commisurato alla necessità
sociale a cui questi media riescono a rispondere. Quindi è vero
che i media condizionano la società, ma è anche vero che
- nel lungo periodo - la società condiziona i media, nel senso
che le dinamiche socioculturali creano una condizione adatta all'affermazione
di una tecnologia piuttosto che di un'altra. Per capire la cultura televisiva
attuale, quindi, non basta più studiare la tecnologia audiovisiva:
bisogna anche studiare la storia delle civiltà che hanno conosciuto
la televisione, a partire dalla rivoluzione industriale e quindi dalla
modernità.
Uno dei fondatori
di questa area di ricerca è certamente il sociologo francese
Edgar Morin, ideatore di un approccio che si definisce "culturologico"
(in quanto analisi dei processi culturali generali in cui si inseriscono
i media, le tecnologie, i conflitti e così via). Morin parla
di "spirito del tempo" per spiegare una nuova condizione culturale,
quella della società di massa, che ha preparato l'avvento e la
diffusione della televisione. Secondo Morin, infatti, la società
industriale avanzata genera una cultura di massa, resa necessaria dall'allargamento
dei diritti (politici e, appunto, culturali). Questa cultura, per essere
adeguata ad un pubblico di massa, non può che fondarsi su stereotipi:
e appunto di stereotipi si costituisce la comunicazione audiovisiva.
Quindi: in una società esiste un immaginario collettivo
(un insieme di credenze, di simboli e di conoscenze), rappresentato
da alcuni archetipi (simboli o valori ideali), che la cultura
televisiva trasforma in stereotipi, mettendoli in circolo in
un circuito di consumo sociale. La televisione, pertanto, non nasce
solo come imposizione, ma anche come desiderio, nel senso che
riproduce alcuni valori socialmente diffusi.
Una simile prospettiva
"culturologica" è stata adottata, in Italia, da Abruzzese.
Portando avanti l'idea che la televisione non sia la causa dei
processi culturali della modernità (come spesso si sostiene),
ma invece la sua conseguenza. Abruzzese riprende infatti una
letteratura ricca ma poco organica (Simmel, Benjamin, Sennett, Kracauer)
facendo precipitare tutte le questioni culturali della modernità
occidentale nello spazio della metropoli. E' proprio nelle metropoli,
nei grandi conglomerati urbani sorti nel XIX secolo (e quindi assai
prima dell'invenzione della televisione) che si viene a creare quella
ridefinizione dei rapporti tra spazi interni (la casa) e spazi esterni
(la strada), che sarà messa in atto definitivamente dalla tv
(che per l'appunto apre una "finestra sul mondo" all'interno
dello spazio domestico). Soprattutto, nella metropoli viene esaltata
l'esperienza visiva attraverso una lunga serie di dipositivi:
l'illuminazione nelle strade, il valore estetico assunto dalle merci,
l'abbellimento delle vetrine, lo sfoggio spettacolare delle Esposizioni
universali. Situazioni e "cornici" che anticipano la televisione,
e che ne creano lo spazio culturale. Abruzzese parla in questo senso
di "dinamiche prototelevisive", cioè di eventi che
hanno abituato gli individui al confronto con una complessità
visiva e linguistica che la televisione ha poi riprodotto e amplificato.
La tv riesce quindi ad incarnare un desiderio sociale a lei preesistente:
e questa è la ragione del suo fascino, ma anche della sua fragilità
(nel senso che se la televisione è stata generata dalla storia
della modernità, il passaggio alla post-modernità,
creando nuove necessità sociali non più di aggregazione
ma di differenziazione individuale, rende inevitabile anche la rovina
della tv).
Questo approccio
archeologico è stato spesso contestato sul piano scientifico
(per via di una certa assenza di metodo), ma ha certamente il merito
di fornire una migliore visione d'insieme dei processi culturali in
cui i media di massa si sono trovati ad agire. E, in aggiunta, questo
metodo consente anche una valutazione serena e ideologicamente equilibrata
della cultura di massa, molto spesso fatta oggetto di critiche severe
e irriducibili da parte degli ambienti intellettuali.
Non è casuale,
infatti, che questo approccio trovi i suoi migliori precedenti teorici
nell'opera di alcuni autori poco apprezzati dall'accademia, ma capaci
più di altri di intendere la diversità culturale dell'epoca
moderna rispetto a quelle precedenti: capaci soprattutto di cogliere,
nelle pieghe di un processo quantitativo (la trasformazione della
società tradizionale in società di massa e l'incremento
delle folle urbane) un valore qualitativo, cioè l'affermazione
di una nuova cultura. E' il caso di pensatori difficilmente collocabili
come Walter Benjamin (1892-1940), Siegfried Kracauer (1889-1966) e perfino
Antonio Gramsci (1891-1937), protagonisti di una prima legittimazione
dei generi della cultura di massa (cinema, romanzo giallo, romanzo d'appendice,
musica operettistica, letteratura di consumo, e così via) nel
nome delle funzioni svolte da questi generi nella società industriale
avanzata.
1.5 Media e
politica
Elezioni e tv
Uno dei problemi
più dibattuti negli ultimi anni è il rapporto tra politica
e televisione. Questo problema ha molte dimensioni: il limite da porre
alla presenza dei personaggi politici in tv, la regolamentazione della
propaganda elettorale e la propaganda "occulta", il controllo
politico (parlamentare) sull'emittenza, il conflitto di interessi e
la normativa antitrust, e così via. Tuttavia, in termini mediologici,
la questione fondamentale riguarda proprio il rapporto (in generale)
tra la politica e i media. E cioé: dal momento che la vita politica
è sempre più "mediatizzata", in che modo cambiano
le sue regole?
A questa domanda,
tuttavia, bisogna arrivare in modo graduale. Infatti la prima questione
da risolvere riguardava, inevitabilmente, gli effetti della televisione,
e cioè il potenziale distruttivo della propaganda televisiva
rispetto agli ordinamenti democratici. In questo come in altri casi,
peraltro, si è passati progressivamente da una concezione "forte"
degli effetti dei media ad una valutazione più equilibrata dei
poteri della televisione. Un ideale spartiacque tra queste due concezioni
può essere individuato nella ricerca condotta dagli studiosi
Jay Blumler e Denis McQuail sulle elezioni inglesi del 1964. Focalizzata
su due collegi elettorali, questa ricerca ha messo in luce un legame
reale tra le preferenze espresse dagli elettori e la loro esposizione
alla propaganda elettorale: in particolare, (anche) alla televisione
poteva essere imputato il successo sorprendente del "terzo partito"
(il partito liberale). Tuttavia, se è vero che la popolarità
del partito liberale era cresciuta nel corso della campagna elettorale,
è anche vero che aveva contagiato soprattutto i soggetti che
affermavano di rivolgersi alla televisione per chiarire la propria posizione
politica, e quindi soggetti non dotati in partenza di un'idea "forte",
e anzi particolarmente (e consapevolmente) malleabili anche perché
poco interessati alla politica, al di là dell'appuntamento elettorale.
Quindi il potere della televisione, per molti versi, viene assai ridimensionato
dai risultati di questa ricerca.
Giungendo a conclusioni
equilibrate, e poggiando su una metodologia di ricerca inappuntabile,
lo studio di Blumler e McQuail ha costituito a lungo il miglior esempio
di analisi degli effetti di una campagna elettorale. Tuttavia i tempi,
rispetto ad allora, sono cambiati. Con l'era della cosiddetta "videopolitica",
o della "politica spettacolo", il problema del rapporto tra
televisione e consenso elettorale si è posto in termini più
urgenti: le discussioni suscitate dalla vittoria di Berlusconi nelle
elezioni del 1994 e del 2001 ne costituiscono la migliore dimostrazione.
A partire dal 1994, infatti, in Italia si sono moltiplicate le iniziative
di studio destinate ad analizzare il rapporto tra elezioni e propaganda
televisiva. E' naturalmente difficile dare conto della varietà
di questi studi, ma se ne può fornire una minima visione d'insieme.
Infatti per questi scopi, oltre agli studi di Paolo Mancini, è
sufficiente ricordare la ricerca di Luca Ricolfi sulla campagna elettorale
del 1994 (la più scrupolosa sugli effetti della televisione)
e, sempre a partire da questa scadenza, l'attività dei gruppi
di ricerca e di monitoraggio sulle apparizioni dei leader in televisione,
coordinate da Franco Rositi all'Università di Pavia (il celebre
"osservatorio di Pavia") e da Mario Morcellini all'Università
di Roma. Anche di queste attività, com'è ovvio, non si
può fornire un resoconto significativo. Bisogna però rilevare,
più in generale, la frattura che si è creata tra le forti
convinzioni sugli effetti della televisione maturate dall'opinione pubblica
e dalla pubblicistica (soprattutto di sinistra), e i risultati della
ricerca mediologica di vario genere, che ha portato a conclusioni varie,
ma comunque meno allarmanti rispetto a questo clima di opinione.
Sarebbe però
superficiale far coincidere l'avvento della "politica spettacolo"
con il successo di Berlusconi, per quanto quest'ultimo ne abbia certamente
costituito la manifestazione più clamorosa e più appariscente.
In realtà questa trasformazione era già in atto nei decenni
precedenti all'avventura di Forza Italia. E' anticipita, negli Stati
Uniti, dalla presidenza di John Kennedy (1960-1963), diviene visibile
con i mandati di Nixon (1968-1973) e Carter (1976-1980), ed è
già definitivamente compiuta nel periodo della presidenza Reagan
(1980-1988). Con i suoi celebri interventi televisivi noti come "discorsi
al caminetto", ad esempio, Carter aveva inaugurato una nuova stagione
comunicativa, votata ad un tono protettivo e confidenziale (molto significativo
era l'utilizzo del maglione al posto dell'abbigliamento "ufficiale").
E negli anni ottanta, come accennato, Ronald Reagan ha portato a compimento
questo processo, servendosene come strumento essenziale alla definizione
della propria leadership (non dissimile, in Italia, è stata negli
stessi anni la strategia di Craxi).
Su questa "mediatizzazione"
della politica bisogna però riflettere. Infatti, anche se la
posta in gioco è la stessa, e cioè la conquista del consenso,
c'è una differenza sostanziale nel modo in cui i leader contemporanei
gestiscono la comunicazione, rispetto a come la gestivano i leader politici
tradizionali. Infatti, laddove questi ultimi erano (si sforzavano di
essere) autoritari, i leader di oggi si mostrano sempre più
seduttivi e confidenziali: non devono imporsi, ma devono piacere.
Di fronte ad una telecamera, si direbbe, più che ad esercitare
un potere sono chiamati a difendere la propria immagine.
Infatti la "televisizzazione"
della politica non ha aumentato il potere dei leader - come spesso si
sostiene - ma lo ha invece indebolito. Lo ha spiegato uno studioso come
Meyrowitz, mettendo in luce come la televisione tenda a ridurre lo scarto
tra governati e governanti. Con la tv, infatti, i governanti divengono
per la prima volta nella storia visibili: al punto che diviene
visibile, come dimostra il caso di Clinton, anche la loro vita privata.
Questo processo, naturalmente, indebolisce la figura del leader perché
la umanizza e ne scopre gli aspetti di maggiore vulnerabilità.
E scoprendo questi aspetti, inevitabilmente, i media espongono i leader
politici al rischio di essere screditati e messi in difficoltà
(come nel caso appunto di Clinton, processato in mondovisione), o addirittura
delegittimati (come nel caso dello scandalo "Watergate", alimentato
dal "Washington Post" fino alle dimissioni di Nixon). Queste
trasformazioni radicali ci riportano all'interrogativo di partenza,
e cioè al ruolo della politica nella società mediale.
Perché la democrazia televisiva, a ben vedere, non è semplicemente
una democrazia giocata su un terreno diverso (quello mediatico), ma
è invece un tipo diverso di democrazia.
E' possibile
una mediologia dello Stato?
Con la diffusione
della televisione, si è detto, nasce una democrazia diversa da
quelle precedenti. Se non altro perché, attraverso la televisione,
l'elettore può essere direttamente e continuamente aggiornato
sulle questioni politiche, svincolandosi quindi dalla sua dipendenza
informativa verso un istituto di mediazione come il partito (e questa
è una spiegazione della crisi dei partiti politici). Per molte
ragioni, siamo quindi nel pieno di una democrazia di tipo "televisivo".
Ma ogni mezzo di comunicazione dominante (nel periodo in cui
è cioè il più importante mezzo di comunicazione)
ha il potere di definire una particolare forma dell'azione politica.
Lo aveva intuito,
già negli anni '20, lo studioso americano Walter Lippmann, notando
come la formazione di un'opinione pubblica dipenda dalla creazione di
ambienti informativi, cioè di rappresentazioni della realtà.
Essendo impossibile, nelle società complesse, un contatto diretto
tra l'individuo e l'evento (se non in casi particolari e comunque minoritari),
la creazione di questo ambiente informativo dipende sostanzialmente
dall'azione dei media: Lippmann cita infatti l'esempio degli abitanti
inglesi e tedeschi di un'isola sperduta che, non essendo stati informati
dello stato di guerra tra Inghilterra e Germania, si comportavano come
se la guerra non esitesse. E quindi - questo è il punto - la
guerra non esisteva: perché sono i media a definire le condizioni
e le possibilità del confronto (o dello scontro) politico.
Se i media definiscono
la porzione di realtà di cui si interessa la politica e i modi
in cui se ne interessa (si pensi ai tempi dei dibattiti, sempre più
contratti per esigenze televisive), l'intreccio comunicazione-politica
investe questioni anche più rilevanti degli effetti (presunti
o reali) della propaganda televisiva. Come è possibile spiegare
questo intreccio? O meglio: è possibile un'analisi comunicativa
della politica, una mediologia della forma-Stato?
Ne é convinto,
senza riserve, Régis Debray, singolare studioso francese (ex
guerrigliero guevarista ed ex consigliere di Mitterrand), recentemente
convertitosi alla ricerca sui media. Secondo Debray, lo Stato si è
sempre mantenuto attraverso il controllo dei mezzi di costruzione della
propria immagine: i diversi ordinamenti istituzionali della storia moderna
(monarchia assoluta, monarchia feudale, repubblica) dipendono soprattutto
una strategia di costruzione dell'immagine. L'araldica e l'iconografia
(cioè l'insieme dei ritratti e degli stemmi di una casa regnante)
sono esempi di strategie di legittimazione del potere messe in atto
appunto attraverso le immagini. Esiste quindi uno "Stato scritto",
uno "Stato scuola" e uno "Stato schermo", nel senso
che le trasformazioni nella sfera dei media determinano una trasformazione
delle possibilità dello Stato di accedere ai mezzi per costruire
la propria immagine. Non si può comunque negare che l'idea di
Debray - malgrado i suoi innegabili aspetti di interesse - è
frutto di una colossale costruzione intellettuale non sempre rapportabile
alla realtà delle cose.
Passiamo ad un
piano più concreto, e più attuale. Se esiste una democrazia
televisiva (con caratteristiche riconoscibili: massima partecipazione
al voto, spettacolarizzazione della politica, esaurimento progressivo
del ruolo dei partiti), quale democrazia corrisponderà all'epoca
della Rete telematica (Internet)? Il problema, sostanzialmente, è
questo: se la rete Internet, essendo interattiva, permettesse a tutti
i cittadini di avere un contatto diretto con le istituzioni e con le
amministrazioni, quale sarebbe il ruolo della politica? Serviranno ancora
le istituzioni rappresentative (i partiti, il parlamento, i comitati,
e via dicendo) se ogni cittadino potrà esprimere direttamente
la propria opinione, sul nuovo territorio telematico?
Su questo tema,
la posizione più radicale è certamente quella del giovane
filosofo francese Pierre Lévy, per qualche anno lo studioso europeo
più quotato nel campo delle comunicazioni di massa. L'idea di
Lévy è che la Rete renderà inutili, secondo il
meccanismo di cui si è detto sopra, le istituzioni politiche
attuali. Questa idea ruota intorno alla distinzione tra democrazia "diretta"
e democrazia "rappresentativa". La democrazia diretta è
la condizione ideale dell'esistenza umana, cioè la democrazia
vera e propria, in quanto governo di tutto il popolo: per questioni
pratiche, tuttavia, questo ideale non è mai stato realizzato
se non, molto parzialmente, nelle polis classiche (molto parzialmente
perché la democrazia ateniese non era "inclusiva" ma
"esclusiva", cioè limitata ai cittadini e preclusa
agli schiavi). Nelle società complesse è ovviamente impossibile
la democrazia diretta (nella misura in cui è impossibile pensare
ad un parlamento che raccolga decine di milioni di persone), ed è
stata quindi adottata la formula rappresentativa in cui i cittadini
delegano la propria autorità attraverso le elezioni. Ma la democrazia
rappresentativa, ricorda Lévy, non è un ideale ma un'approssimazione,
o meglio uno strumento e non un fine, reso indispensabile dall'estensione
delle società (una democrazia diretta è possibile, per
forza di cose, solo in una piccola comunità).
Ma cosa succede
nel momento in cui - attraverso la tecnologia - è possibile immaginare
un parlamento con decine di milioni di persone? Succede, prosegue Lévy,
che la democrazia rappresentativa viene superata e si instaura una democrazia
diretta, in cui tutti i cittadini intervengono alla discussione e alla
deliberazione attraverso la Rete. La risposta di Lévy, in verità,
non è troppo convincente, e ancor meno convincente è l'estusiasmo
con cui il filosofo francese immagina la nascita di questo "parlamento
virtuale". Esistono infatti (almeno) due obiezioni rispetto a questo
modello. In primo luogo, è da considerare la possibilità
che l'accesso alla rete non sia realmente a beneficio di tutti, se non
altro per questioni economiche (e questo potrebbe creare una discriminazione
fondata sulla ricchezza). In secondo luogo, è indimostrabile
(e poco probabile) che gli utenti della Rete siano, per questa stessa
ragione, membri di una "comunità intelligente", cioè
persone in grado di interrogarsi sulle questioni politiche più
delicate, come imporrebbe l'appartenenza al parlamento telematico o
"agorà virtuale".
1.6 Apocalittici
e integrati
Chi sono
Esistono, secondo
un approccio ormai tradizionale, due modi di affrontare i media: uno
"apocalittico" e uno "integrato". Questa distinzione,
proposta da Umberto Eco nel 1964, ha avuto un successo straordinario,
fino a condizionare fortemente il rapporto della cultura italiana con
la tecnologia. Sono "apocalittici" i pensatori che sostengono
un'idea negativa della cultura di massa e "integrati", viceversa,
quelli che seguono un approccio più ottimistico, senza pregiudizi
ideologici verso il "midcult" e il consumo di massa. E' appena
il caso di sottolineare che il primo orientamento, quello degli apocalittici,
è molto più diffuso del secondo: basta pensare al clima
di opinione fortemente avverso alla televisione, sostenuto ancora oggi
da molti intellettuali.
Naturalmente,
neanche gli apocalittici sono realmente estranei a quella realtà
che dicono di disprezzare. Anzi, il loro lavoro critico è sempre
più interno ad un meccanismo di produzione (industriale)
e di consumo (di massa), che rende piuttosto paradossali certe esternazioni
(così come è paradossale sostenere, senz'altra specificazione,
che la televisione "rincretinisce" il pubblico, perché
chi lo sostiene è necessariamente un telespettatore, e quindi
una vittima eventuale). Rispetto all'idea di Eco, vanno però
aggiunte anche alcune considerazioni più precise. Infatti non
sembra che gli apocalittici abbiano realmente come aspetto distintivo
un giudizio negativo sui mezzi di comunicazione: al punto che gli intellettuali
(e gli apocalittici sono sempre intellettuali, o pretendono di
esserlo) fanno un uso sempre più consapevole delle tecnologie
(appaiono in tv, utilizzano Internet e la posta elettronica, e così
via). In realtà, gli apocalittici non hanno (necessariamente)
un'idea negativa dei media, ma hanno sempre un'idea negativa del
pubblico di massa.
Quando si parla
di apocalittici, è impossibile non pensare alla Scuola di Francoforte.
Con questo termine ci si riferisce ad un gruppo di filosofi e di studiosi,
raccolti negli anni Trenta intorno all'Istituto per gli Studi Sociali
di Francoforte, e poi emigrati negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo.
I pensatori più noti di questa scuola sono Herbert Marcuse (1898-1979)
e Theodor Adorno (1903-1969), filosofo e sociologo il primo, filosofo
e musicologo il secondo. Secondo Adorno, la società contemporanea
ha progressivamente eliminato e razionalizzato "il mito",
cioè l'insieme dei valori culturali in cui si riconoscevano le
civiltà tradizionali. La vita è quindi ridotta alla semplice
applicazione dei comandi imposti dalle "macchine", cioè
dalla tecnologia avanzata, e il progresso non fa che esasperare questa
tendenza. Allo stesso modo, Marcuse ritiene che la società industriale
avanzata, per ottimizzare il proprio rendimento, abbia gradualmente
imposto il silenzio a tutte le "voci antitetiche", cioè
a tutte le discipline portatrici di opinioni contrarie all'ideologia
del progresso (l'arte, il libero pensiero, la letteratura). In entrambi
i casi, i mezzi di comunicazione hanno un ruolo decisivo nell'alimentare
questa ideologia del progresso, fino a creare, come sostiene Marcuse,
una società "ad una dimensione".
La riflessione
dei francofortesi nasce da un tentativo di reinterpretare il pensiero
marxiano. Questi autori si sono infatti interrogati sul fallimento della
prospettiva rivoluzionaria (e quindi dell'idea di Marx), individuandone
la ragione nella capacità della "sovrastruttura" (i
media, la cultura, la stampa) di agire sulla "struttura" (l'ordinamento
del capitalismo) legittimandola e preservandone l'integrità.
Di qui, naturalmente, una forte critica nei confronti dei media, che,
tuttavia, è spesso scaduta in un semplice esercizio di critica
verso la modernità, e verso la superficialità della cultura
di massa. Ragione per cui la riflessione della Scuola di Francoforte
sull'industria culturale non può che provocare effetti schizofrenici:
del tutto efficace nello svelare i meccanismi di cui si costituisce
l'apparato della produzione culturale (la razionalizzazione, la "chiusura
dell'universo di discorso", la collusione dei poteri), risulta
invece assai approssimativa nel prendere in esame il rapporto tra i
media ed il loro pubblico. Rimarrà, questo, il grande nodo irrisolto
del pensiero critico: voler dedurre dalla macchina della produzione,
e dall'iniquità del suo funzionamento, uno stato di passività
del consumatore che costituisce, invece, un problema di ordine diverso.
Il pensiero
negativo che serve
L'opposizione tra
apocalittici e integrati, tuttavia, non spiega tutto. Infatti anche
un approccio integrato non può non tenere conto dei poteri e
dei valori negativi di cui i mezzi di comunicazione di massa sono portatori.
Essere "integrati", quindi, non significa sostenere un'idea
indiscriminatamente positiva dei media, ma mantenere un approccio di
studio equilibrato. Se le convinzioni "apocalittiche" più
estreme, come accennato, sono del tutto improduttive, ci sono infatti
alcune teorie (ormai classiche) sugli effetti negativi dei media, che
vanno invece tenute in considerazione.
La letteratura
scientifica conviene sul fatto che la ricerca (soprattutto nordamericana)
sugli effetti dei media è distinta in due fasi. Il primo periodo
è occupato dagli studi sugli effetti "immediati" dei
mezzi di comunicazione (cioè sull'assunzione di comportamenti
immediatamente riconducibili all'esposizione mediale, come assistere
ad una campagna elettorale e poi votare per il candidato più
pubblicizzato), ed ha avuto esiti complessivamente negativi, nel senso
che questi effetti "immediati" non sono realmente riscontrabili.
La seconda fase, al cui sviluppo hanno concorso studiosi europei e nordamericani,
riguarda invece gli effetti di "lungo periodo" dei media:
si ritiene cioè che la televisione (per fare l'esempio classico)
non influenzi direttamente il comportamento del pubblico, ma che,
nel lungo periodo, l'esposizione prolungata alla tv alteri l'atteggiamento
dell'individuo e la sua percezione della realtà (si parla infatti
non più di effetti "comportamentali" ma di effetti
"cognitivi"). Questa seconda fase, che giunge a piena maturità
negli anni '70, ha fornito alcuni modelli di studio degli effetti dei
media, che neanche un approccio "integrato" può trascurare.
Il più noto
tra questi modelli è quello conosciuto come "agenda-setting".
Messo a punto principalmente da due studiosi americani, McCombs e Shaw,
nel corso degli anni settanta, questo modello costituisce una delle
ipotesi più accreditate nella ricerca sugli effetti. L'idea è
che i media definiscano, per l'appunto, un'agenda: cioè
che non riescano ad imporre che cosa pensare, ma che siano in
grado di definire gli argomenti sui quali riflettere. Quindi,
per fare un esempio banale, non è detto che lo spettatore abituale
delle reti Mediaset abbia un'opinione positiva di Berlusconi: ma è
inevitabile che la figura di Berlusconi sia presente nella sua "agenda".
Secondo questa
ipotesi, il pubblico è portato a dare importanza agli argomenti
ai quali i media danno importanza (se non altro perché i media
sono l'unica fonte di informazione), al punto che esiste una corrispondenza
significativa tra l'importanza attribuita dai mezzi di comunicazione
a diversi eventi o problemi e l'importanza ad essi attribuita dagli
spettatori (o ascoltatori, o lettori). Il pubblico, pertanto, costruisce
la propria "agenda" di conoscenze inserendo in essa ciò
che è presente nei media ed escludendo ciò che nei media
non è presente (quindi l'agenda del pubblico riproduce sostanzialmente
l'agenda dei media).
Originariamente,
questa teoria è stata elaborata con riferimento al "potere
di agenda" della stampa: anche se risulta certamente applicabile
agli altri media (radio e televisione), va detto che ad ogni medium
corrisponde un potere di agenda diverso (che le ricerche, sorprendentemente,
hanno scoperto più marcato nella stampa che nella tv), e che
è quindi difficile riunire tutti i mezzi di comunicazione di
massa in un'unica visione di insieme. Qualche problema si pone anche
nel momento in cui bisogna misurare l'effetto di agenda con una
ricerca sul campo. In primo luogo, è difficile calcolare l'intervallo
di tempo ("time-lag") in cui questo effetto si verifica (quanto
tempo serve perché l'agenda del pubblico si modelli su quella
dei media?). In secondo luogo, se è abbastanza semplice valutare
l'agenda dei media (anche attraverso l'analisi del contenuto), è
invece più complicato ricostruire l'agenda di uno spettatore,
nel senso che non sempre la presenza di un argomento è indice
della sua rilevanza (se nel periodo considerato, ad esempio, la tv ha
insistito molto sul tema dell'adozione, e lo spettatore intervistato
cita la questione delle adozioni, rimane difficile da valutare l'intensità
del suo interesse); anche perché non sempre la frequenza di una
parola in una conversazione (in questo caso, la parola "adozione"
o simili) è una misura significativa della sua importanza.
Una teoria più
radicale, ma che ha comunque orientato il dibattito scientifico, è
quella della cosiddetta "spirale del silenzio". Elaborata
tra gli anni settanta e i primi anni ottanta dalla studiosa tedesca
Elisabeth Noelle Neumann, questa teoria chiama in causa l'influenza
dei media nell'orientare la discussione pubblica. Secondo la Noelle
Neumann, infatti, il sistema dei media è portatore di un messaggio
culturalmente omogeneo, al di là delle differenze di superficie
tra diversi generi o tra emittenti diverse, e diffonde continuamente
questo messaggio nella società. Per queste due caratteristiche,
che la Noelle Nuemann definisce di "consonanza" e di "cumulatività",
i media creano un'opinione maggioritaria, nel senso che l'opinione pubblica
tenderà a sposare la visione della realtà propagandata
dai mezzi di comunicazione.
Nel momento in
cui l'opinione pubblica si conforma al messaggio veicolato dai media,
per i soggetti sociali che sostengono idee diverse, tendenzialmente,
non rimane che il silenzio. Infatti sostenere un'idea non propagandata
dai media è difficile, per diversi motivi: in primo luogo, naturalmente,
perché è difficile perfino conoscerne l'esistenza, visto
che i media sono la fonte (quasi) esclusiva di informazione; in secondo
luogo, però, anche perché la visibilità mediatica
di un'opinione (per esempio l'apparizione in tv di persone che la sostengono)
è un incentivo per quanti la condividono, e fornisce anche le
argomentazioni necessarie a difenderla. Se, ad esempio, un telespettatore
italiano condivide le ragioni di Ocalan (il leader curdo espulso dall'Italia
e attualmente nelle carceri turche), avrà grosse difficoltà
ad esprimere un'idea che è, per l'appunto, minoritaria
rispetto a quella maggioritaria veicolata dai media: gli mancano, infatti,
sia il sostegno emotivo di una buona copertura televisiva della sua
opinione, sia il possesso delle notizie e delle argomentazioni che soltanto
questa copertura potrebbe garantire (si tratta, appunto, di una spirale).
In entrambi i casi
(agenda-setting e spirale del silenzio) abbiamo naturalmente semplificato.
Tuttavia le idee essenziali che informano queste teorie rimangono particolarmente
utili - qualunque sia l'approccio di studio - per la ricerca sulle comunicazioni
di massa.
La guerra santa
dei neo-apocalittici
Negli ultimi anni,
il dibattito (e, in particolare, il dibattito italiano) sui media è
stato scosso dagli interventi di diversi intellettuali "apocalittici".
Il caso più clamoroso è quello di Karl Popper (1902-1994),
epistemologo e filosofo della scienza tra i maggiori del novecento,
che a pochi mesi dalla morte ha dato alle stampe un pamphlet
significativamente intitolato "una patente per fare tv". La
sua idea (peraltro indimostrabile) è che la televisione educhi
i suoi spettatori, soprattutto i bambini, alla violenza, desensibilizzandoli
attraverso l'esposizione continua di comportamenti devianti e aggressivi.
Essendo un mezzo pericoloso, la tv va quindi controllata, e la concessione
delle licenze di trasmissione deve essere vincolata ad una sorta di
prova di moralità. Secondo Popper, la soluzione ideale sarebbe
l'istituzione di una commissione in grado di concedere e revocare la
"patente", cioè l'autorizzazione a trasmettere. Un'idea
che, come ognuno potrà giudicare, somiglia sinistramente ad una
proposta di censura.
Un altro contributo
molto critico verso la televisione è dovuto al politologo italiano
Giovanni Sartori, docente alla Columbia University, che ha invece denunciato
l'aspetto "antropologico" delle mutazioni indotte dalla tv.
Secondo Sartori, infatti, la televisione trasforma l'uomo da essere
razionale (homo sapiens) a essere superficiale e istintivo (homo
videns), perché, a differenza della scrittura, non stimola
ma anzi atrofizza le facoltà mentali e intellettuali degli individui.
In realtà, naturalmente, non c'è una ragione reale per
cui un'educazione fondata sulla scrittura debba essere superiore ad
un'educazione fondata sull'immagine: senza contare che, soprattutto,
la scrittura non rappresenta quella condizione ideale e necessaria a
cui Sartori la fa coincidere, ma è a sua volta una tecnologia,
con i vantaggi ed i limiti di ogni altra tecnologia (e che la scrittura
non sia necessaria è dimostrato dal fatto che, se l'homo
sapiens esiste da circa 40.000 anni, la "scrittura" propriamente
detta è stata inventata solo intorno al 3500 avanti Cristo nelle
regioni mesopotamiche).
Popper e Sartori
costituiscono due esempi significativi dell'atteggiamento delle classi
intellettuali (con poche eccezioni) nei confronti della televisione
(lo stesso discorso riguarda ad esempio Pierre Bourdieu, uno dei maggiori
sociologi europei, ed il circolo di intellettuali progressisti riuniti
in Italia intorno alla rivista "Reset"). In realtà
le critiche avanzate da questi intellettuali - come dimostrano gli esempi
presi in esame - sono scientificamente molto immature, e spesso perfino
risibili: tuttavia il loro impatto sull'opinione pubblica è
talmente rilevante, da non poter essere passato sotto silenzio (anche
perché, e questo è l'aspetto più singolare della
vicenda, questi autori sono studiosi di grande spessore, che hanno raggiunto
risultati molto rilevanti nelle loro discipline).
La distinzione
tra "apocalittici" e "integrati", quindi, assume
oggi un nuovo valore: non oppone più gli "ottimisti"
ai "pessimisti" ma, prima ancora, contrappone gli specialisti
dei media a quanti invece studiano i media dall'esterno. Non
è un caso, infatti, che i grandi apocalittici siano intellettuali
di vario genere (filosofi, scrittori, linguisti, scienziati della politica,
e così via) ma che non siano mai realmente dei sociologi della
comunicazione. Se si studiano i media dal loro interno, infatti,
se ne avrà una visione più complessa di quella proposta
dai pensatori critici: che porti ad un'idea ottimistica, equilibrata
o anche più critica e "conflittuale" dei mezzi di comunicazione,
infatti, questa scelta di campo esclude per sua natura un'opzione ideologicamente
caratterizzata come quella degli apocalittici.
Gli autori
Roland Barthes
Roland Barthes
(1915-1980), semiologo tra i più brillanti della cultura contemporanea,
ha insegnato al Collège de France e all'École Pratiques
des Hautes Études di Parigi. Tutta la sua esperienza di studio
è stata dedicata alla scoperta dei processi di significazione
nascosti nei fenomeni artistici (scrittura, fotografia, pittura) ma
anche nelle pratiche sociali quotidiane (design, pubblicità,
e così via). Barthes ha infatti esteso i concetti della
semiotica per analizzare tutti i linguaggi della società contemporanea:
esemplare, in questo senso, è la rassegna di Mythologies
(tradotto in Italia con il titolo di Miti d'oggi), in
cui Barthes ha preso in esame i più svariati fenomeni della cultura
di massa (il catch, le vacanze, i detersivi, i giocattoli, le
patate fritte, il Tour de France, e così via). Va anche aggiunto
che, molto spesso, Barthes ha applicato a questi linguaggi i concetti
della cultura alfabetica, sacrificandone quindi alcune particolarità.
Tuttavia la sua ricerca è importante proprio perché ha
portato ad una legittimazione dei diversi generi e linguaggi
della cultura di massa.
Riflettendo sulla
propria opera, Barthes aveva individuato tre fasi essenziali della sua
riflessione: la fase della semiologia come critica ideologica (negli
anni cinquanta), quella della semiologia "pura" (gli anni
sessanta), e infine la fase della semiologia come analisi del testo
(gli anni settanta). Al di là di queste diverse ispirazioni,
in ogni caso, nella ricerca di Barthes esiste una sostanziale linea
di continuità, segnata dalla progressiva esplorazione dei modi
in cui la società contemporanea ha espresso ed esprime la propria
cultura.
Tra le sue numerose
opere, possiamo ricordare: Miti d'oggi (1957), Il sistema
della moda (1967), S/Z (1970), Il piacere del testo
(1973), Frammenti di un discorso amoroso (1977), La camera
chiara (1978), La grana della voce (pubblicato nel 1981).
Per saperne di
più: U. Eco, La maestria di Barthes, prefazione a R. Barthes,
Miti d'oggi, Einaudi, 1994; P. Fabbri, La svolta semiotica,
Laterza, 1998; P. Malcolm, W. Thody, Introducing Barthes, Totem
Books, 1997; R. Rylance, Roland Barthes, Harvester, 1994;
U. Volli, Il libro della comunicazione, Il Saggiatore,
1994.
Jean Baudrillard
Jean Baudrillard
(1929) è uno degli autori più sofisticati e più
discussi della filosofia sociale contemporanea, ormai tradizionalmente
impegnato nella ricerca sulle comunicazioni di massa. In particolare,
l'interesse del filosofo francese per i consumi di massa (materiali
e culturali) nasce da un tentativo di applicare alle società
industriali avanzate le riflessioni marxiane sul "feticismo"
della merce. Secondo Marx, infatti, la merce avrebbe progressivamente
perso il suo "valore d'uso" per acquisire un valore estetico,
legato più alla sua "spettralità" che all'immediata
riconoscibilità delle sue funzioni. Se, ad esempio, l'oggetto
"piatto" è sempre stato usato dall'uomo per la sua
utilità concreta (cioè per contenere del cibo), nell'epoca
del capitalismo diviene invece una tentazione estetica (per fermarsi
allo stesso esempio, si può acquistare un servizio da tavola,
pur non avendone un immediato bisogno, semplicemente perché lo
si trova bello e decorativo).
Baudrillard - che
è un autore apocalittico - radicalizza questo discorso. Se ogni
oggetto ha un'aura estetica che trascende la sua funzionalità,
infatti, significa che la società dei consumi è una colossale
macchina di straniamento che nasconde progressivamente la realtà
dietro una rappresentazione artificiale, imponendo all'individuo
dei falsi bisogni. Il ruolo dei media, in questo sistema, è proprio
quello di costruire una forma di realtà alternativa che nasconde
il reale svolgimento delle cose (per cui esiste un "eccesso di
realtà", determinato dalla pervasività della televisione,
e insieme una sparizione della realtà concreta).
Le sue opere più
conosciute sono: Il sistema degli oggetti (1968), La società
dei consumi (1974), Per una critica dell'economia politica del
segno (1976), Della seduzione (1979), Il delitto
perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? (1995).
Per saperne di
più: D. Harvey, La crisi della modernità (1990),
Il Saggiatore, 1993; D. Kellner, Baudrillard: A Critical Reader,
Blackwell, 1994; A. Sokal, J. Briomont, Imposture intellettuali,
Garzanti, 1999; U. Volli, Fascino. Feticismi e altre idolatrie,
Feltrinelli, 1997.
Règis
Debray
Régis Debray
(1941), affermato teorico della "mediologie", è uno
dei più singolari studiosi di comunicazione. E' possibile che
al fortuna attuale di Debray - prima guerrigliero guevarista in Bolivia,
poi membro del Consiglio di Presidenza di François Mitterrand
ed infine, appunto, teorico della mediologia - sia legata proprio alla
sua esperienza di vita, che ha attraversato le diverse fasi della politica
contemporanea: quella militare, quella diplomatica e quella "mediatica",
che vede oggi in primo piano appunto il ruolo dei media (come dimostra,
in Italia, il caso di Berlusconi). Ma procediamo con ordine.
Debray propone
un metodo "mediologico": ritiene cioè che per studiare
la comunicazione si debba analizzare la struttura fisica dei
supporti che rendono possibile la trasmissione del sapere (la carta,
il telegrafo, e così via). E' quello che Debray chiama "materismo"
(cioè, appunto, studio della dimensione "materiale",
concreta, dei media). Anche se intrigante, in realtà, la proposta
di Debray non è troppo innovativa (anche se può sembrare
tale per la cultura europea, meno abituata di quella americana a procedere
in termini "mediologici"), e anzi si riallaccia sostanzialmente
alle idee della Scuola di Toronto di Innis e McLuhan (che avevano appunto
sottolineato l'importanza dei mezzi e dei supporti fisici della comunicazione
nel creare gli equilibri sociali e istituzionali). Ma il merito di Debray
(che ha applicato questo metodo soprattutto all'analisi della forma-Stato)
è probabilmente quello di (cercare di) sistematizzare questa
convinzione in una visione di insieme per molti versi lacunosa, ma inevitabilmente
seducente (e necessaria) per la cultura europea.
I suoi scritti
più importanti (in ambito mediologico) sono: Cours de médiologie
générale (1991), Vie et mort
de l'image (1992), Lo stato seduttore (1993), Transmettre
(1997).
Per saperne di
più: A.A.V.V., Pourquoi des médiologues?, "Cahiers
de médiologie", 6, 1998; K. Reader, Régis Debray:
A Critical Introduction, The Free Press, 1995.
Umberto Eco
Umberto Eco (1932),
professore di semiotica all'Università di Bologna, è il
semiologo attualmente più conosciuto e uno degli studiosi più
apprezzati in senso assoluto. Eco ha infatti costruito la più
ricca strumentazione teorica per gli studi semiologici, dedicandosi
anche ad un (appezzabile) tentativo di trasformare la sua attività
di ricerca in un'opera di più ampia divulgazione (soprattutto
con il Diario minimo del 1963 e il Secondo diario minimo,
del 1992).
Nella ricerca di
Eco convivono anime diverse. La prima è quella più strettamente
semiologica: a Eco è infatti dovuta la più imponente
sistematizzazione degli studi semiotici e dei concetti fondamentali
della disciplina (soprattutto con il Trattato di semiotica generale
e con Semiotica e filosofia del linguaggio). La seconda
"anima" è quella di Eco narratologo, e riguarda
gli studi compiuti dall'autore intorno al concetto di "opera aperta",
che hanno rivalutato il ruolo del lettore nella costruzione e nel consumo
del testo letterario. La terza dimensione significativa negli studi
di Eco è quella sociologica, che ha a che fare soprattutto
con l'approccio positivo e "integrato" proposto dall'autore
verso i prodotti della cultura di massa. C'è poi, infine, l'Eco
narratore: è infatti inevitabile considerare le sue opere narrative
come una sorta di prolungamento (non sempre coerente) delle sue riflessioni
narratologiche. Confrontarsi alla ricerca di Eco è quindi un'operazione
piuttosto complessa, che richiede, come spesso accade alle forme di
pensiero così enciclopediche, un atteggiamento critico:
ma è ancora, per lo studio della comunicazione, un'operazione
necessaria.
Nella produzione
sterminata di Eco, sono di particolare importanza (nelle diverse aree):
Opera aperta (1963), Apocalittici e integrati (1964),
Trattato di semiotica generale (1975), Lector in
fabula (1979), Semiotica e filosofia del linguaggio (1984),
I limiti dell'interpretazione (1990), Sei passeggiate nei
boschi narrativi (1994).
Per saperne di
più: P. Fabbri, La svolta semiotica, Laterza, 1998; R.
Grandi, I mass media tra testo e contesto, Lupetti & Co.,
1994; P. Magli, G. Manetti, P. Violi, Semiotica: storia, teoria,
interpretazione. Intorno a Umberto Eco, Bompiani, 1992.
Paolo Fabbri
Paolo Fabbri (1939),
professore di Semiotica dell'arte all'Università di Bologna,
è oggi uno degli interpreti più innovativi della disciplina.
Dopo avere insegnato in diverse Università in Nord America e
in Europa e aver lavorato a Parigi con A. J. Greimas, Fabbri ha costruito
un modello semiotico in qualche modo alternativo a quello (più
conosciuto) di Umberto Eco. Il tentativo di Fabbri è infatti
quello di sottrarre la semiotica all'area delle scienze umanistiche,
per confrontarla invece ai processi più concreti della comunicazione
sociale.
Se in una prima
fase aveva analizzato la comunicazione lavorando all'applicazione dei
concetti classici della semiotica, negli anni più recenti Fabbri
si discosta invece dagli aprocci tradizionali, proponendo infine una
vera e propria "svolta semiotica". A questa svolta dovrebbe
corrispondere una rifondazione che permetta alla disciplina di occuparsi
non solo di "segni" ma di "significazioni", cioè
di tutti i processi che hanno a che fare con la produzione e con la
diffusione sociale dell'informazione. E' ipotizzabile quindi non solo
una semiotica delle passioni (che già appartiene al patrimonio
classico della disciplina) ma anche, ad esempio, una semiotica degli
oggetti, nella misura in cui proprio gli oggetti sono costruzioni
sociali portatrici di significato. Non è forse casuale che a
questo rinnovamento disciplinare si accompagni un forte rinnovamento
di stile e di metodo, che Fabbri ha condotto rinunciando (almeno
in parte) al prestigio accademico della scrittura (e del libro), in
favore di una più intensa attività di divulgazione orale
(convegni, seminari, interviste, e così via).
Tra le sue opere,
vanno segnalate: Prima proposta per un modello di ricerca interdisciplinare
sul rapporto televisione-pubblico (1968, con U. Eco e altri), Progetto
di ricerca sull'utilizzazione dell'informazione ambientale (1978,
con U. Eco), Tacticas de los signos (1996), La svolta semiotica
(1998).
Per saperne di
più: per informazioni di vario genere e per una bibliografia
completa, consultare il sito Internet di Paolo Fabbri, all'indirizzo
<http://www.guaraldi.it/fabbri/default.htm>
Harold Innis
Harold Adams Innis
(1894-1952) è uno degli autori più importanti nella storia
della ricerca sulla comunicazione. Studioso di politiche economiche
e industriali, Innis si è dedicato poi alla sociologia partecipando
alle ricerche della cosiddetta Scuola di Chicago, e solo nei suoi ultimi
anni ha affrontato il problema della comunicazione, fondando la Scuola
di Toronto (resa poi celebre da Marshall McLuhan).
Il contributo di
Innis allo studio della comunicazione è stato fondamentale. Infatti,
mentre i sociologi della comunicazione usavano lo strumento privilegiato
dell'analisi del contenuto, Innis sostiene che la parte più significativa
dei processi comunicativi non è legata ai contenuti trasmessi,
ma invece al mezzo tecnico che ne costituisce il supporto. Per questa
ragione, Innis elabora un metodo di studio della storia, in cui
proprio i mezzi di comunicazione sono considerati un fattore decisivo:
le diverse fasi della civilizzazione dipenderebbero quindi dai media
attraverso i quali viene conservato e trasmesso il sapere (argilla,
papiro, carta, comunicazione via etere, e così via). Da variabile
dipendente, i media divengono così la variabile indipendente:
è - per usare un'espressione abusata - un'autentica rivoluzione
copernicana.
Malgrado la sua
innovatività, Innis è un autore poco considerato nella
ricerca sui media, e ancora poco conosciuto in Europa. Conferma di questo,
è il fatto che siano state tradotte in italiano soltanto due
sue opere: Le tendenze della comunicazione (1951) e Impero
e Comunicazioni (1950).
Per saperne di
più: J.W. Carey, Harold Adams Innis and Marshall McLuhan,
"The Antioch Rewiew", 1, 1967; T.W. Cooper, McLuhan and
Innis: The Canadian Theme of Boundless Exploration, "Journal
of Communication", 3, 1981; F. Ferrarotti, La storia e il quotidiano,
Laterza, 1986, M. Sanfilippo, V. Matera, Da Omero ai cyberpunk. Archeologia
del villaggio globale, Castelvecchi, 1995.
Harold Lasswell
Harold D. Lasswell
(1902-1978), politologo americano, è stato uno dei primi studiosi
di questioni istituzionali e politiche ad interrogarsi in modo sistematico
sul ruolo dei mezzi di comunicazione di massa. In particolare, Lasswell
ha analizzato le strategie di propaganda, ritenendo che il linguaggio
della politica fosse un indice diretto delle dinamiche di potere. La
sua ricerca appartiene quindi ad un'epoca di studi sui media molto condizionata
(a partire dagli anni trenta) dall'utilizzo che dei media (e soprattutto
della radio) veniva fatto da parte degli apparati politici e militari.
Il metodo utilizzato
da Lasswell è di ordine strettamente quantitativo, e il suo strumento
decisivo è l'analisi del contenuto. Misurando la ricorrenza
dei termini più significativi (o "simboli-chiave")
nel discorso politico, Lasswell vuole infatti comprendere quello che
definisce il "mito politico", cioè il particolare universo
di valori al quale una strategia di propaganda fa riferimento. Anche
se evidentemente condizionato, in origine, dalle urgenze della guerra
e della mobilitazione ideologica, il modello lasswelliano è stato
in seguito adattato all'area più generale della comunicazione
sociale.
Il metodo di Lasswell
è, in realtà, piuttosto datato. Dopo gli studi di Innis
e di McLuhan, infatti, l'analisi del contenuto ha perso la posizione
di egemonia che deteneva nella ricerca sulla comunicazione. E datata,
di fatto, è anche la tipologia costruita da Lasswell, secondo
la quale, per comprendere la comunicazione di massa, bisogna chiedersi
"chi dice cosa attraverso quale canale
a chi con quale effetto" (il cosiddetto modello
delle cinque w, con cui iniziano in inglese questi cinque termini
chiave). A tutt'oggi, a Lasswell va comunque riconosciuto un merito:
quello di avere mostrato la complessità dei processi comunicativi,
sottraendoli alle interpretazioni schematiche di cui erano inizialmente
fatti oggetto.
Le sue opere più
importanti sono: Propaganda Techniques in the World War (1927),
Politics: Who Gets What, When, How (1936), World Revoluntionary
Propaganda (1939), Il linguaggio della politica (1949, con
N. Leites).
Per saperne di
più: G. Losito, L'analisi del contenuto nella ricerca sociale,
Franco Angeli, 1993; A. Mattelart, La comunicazione mondo (1991),
Il Saggiatore, 1994; A. Rogon (a cura di), Politics, Personality
and Social Science in the Thentieth Century: Essays in Honor of Haold
D. Lasswell, University of Chicago Press, 1969; M. Wolf, Teorie
delle comunicazioni di massa, Bompiani,
1985.
Paul Lazarsfeld
Paul Felix Lazarsfeld
(1901-1976) è stato uno dei fondatori della sociologia della
comunicazione nordamericana. Statunitense di origine austriaca, dopo
avere frequentato gli ambienti intellettuali (e socialisti) di Vienna,
si "converte" allo studio dei media negli anni trenta (pur
essendo, di formazione, un matematico), analizzando con particolare
cura gli effetti della comunicazione radiofonica sul pubblico.
La più conosciuta
ricerca di Lazarsfeld è stata condotta nel 1940 nella comunità
di Erie County, nell'Ohio, durante la campagna per le elezioni presidenziali
degli Stati Uniti. Con questa ricerca, Lazarsfeld e i suoi collaboratori
(Berelson e Gaudet) hanno scoperto l'esistenza dei "leader d'opinione",
cioè di soggetti particolarmente esposti ai media ed in grado
quindi di diffondere l'informazione ricevuta agli altri membri della
comunità (si parla, appunto, di "flusso a due fasi"
della comunicazione). Con questa ricerca si è aperta una nuova
fase nella ricerca sui media, in quanto è stata definitivamente
superata l'idea che gli effetti dei mezzi di comunicazione fossero forti
proprio perché diretti (mentre sono, per l'appunto, "mediati").
Il nome di Lazarsfeld,
in realtà, è legato anche alla cosiddetta macchina "Lazarsfeld-Stanton"
(elaborata insieme al funzionario della CBS Frank Stanton), usata per
misurare la reazione degli ascoltatori alla comunicazione radiofonica
(nel senso che l'ascoltatore sottoposto alla prova poteva esprimere
giudizi di soddisfazione o di fastidio premendo tasti diversi). La necessità
di misurazione degli effetti introdotta da Lazarsfeld, bisogna
aggiungere, è alla base di una vocazione empirica (che lo stesso
Lazarsefd definiva "ricerca amministrativa") che ha tradizionalmente
differenziato la sociologia della comunicazione nordamericana dalla
sociologia europea.
Le sue opere più
significative sono: Radio and the Printed Page (1940), Radio
Research (1943, con F. Stanton), The People's Choice (1944,
con B. Berelson e H. Gaudet).
Per saperne di
più: E. Cheli, La realtà mediata. L'influenza dei mass-media
tra persuasione e costruzione sociale della realtà, Franco
Angeli, 1992; G. Losito, Il potere dei media, La Nuova Italia
Scientifica, 1994; R. K. Merton (a cura di), Qualitative and Quantitative
Social Research: Papers in Honor of Paul F. Lazarsfeld, Free Press,
1980; M. Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani,
1985.
Pierre Lévy
Pierre Lévy
(1956), professore prima nel dipartimento Hypermédia dell'Università
di Parigi VIII e poi nel dipartimento di Comunicazione dell'Università
del Quebec, filosofo, allievo di alcuni importanti intellettuali della
cultura francese (Serres e Castoriadis), nella seonda metà degli
anni novanta è stato considerato - ormai lo si può dire:
frettolosamente - come il più quotato studioso europeo nel campo
delle comunicazioni di massa e, in particolare, della cultura informatica.
Infatti gli studi di Lévy sono dedicati al rapporto tra le culture
tradizionali ed i prodotti dell'innovazione tecnologica, come il computer
e la Rete telematica.
Lo scopo di Lévy
è mostrare come le tecnologie dei nuovi media siano perfettamente
conciliabili alle funzioni fondamentali della vita umana (Le
tecnologie dell'intelligenza), e come possano anzi costituire
un compimento ed una realizzazione di queste funzioni. In questo senso,
naturalmente, non si possono considerare le nuove tecnologie come artefatti
esterni alla vita dell'uomo. Infatti l'idea di Lévy è
che la tecnologia sia del tutto complementare alla società,
in quanto entrambe costruzioni "artificiali" (o meglio: virtuali)
che l'uomo utilizza per definire il proprio ambiente di vita che è
quindi, per l'appunto, un ambiente virtuale (Il virtuale).
Le possibilità
offerte dalle nuove tecnologie interattive (che consentono, tramite
Internet, un accesso diretto e non controllato all'informazione) sono
tali da aprire, secondo Lévy, una nuova fase "antropologica",
in cui l'uomo può realizzare tutte le proprie esigenze di autorealizzazione
(fino ad ora frustrate) proprio grazie ad un nuovo e più diretto
rapporto con la tecnologia (L'intelligenza collettiva).
Anche se molto intrigante (e bene argomentata) l'idea di Lévy
sembra - comunque la si guardi - fin troppo ottimistica, e poco sensibile
ai rischi di esclusione generati dalle nuove tecnologie dell'informazione.
Le sue opere più
riuscite sono: Le tecnologie dell'intelligenza (1990), L'intelligenza
collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio (1994), Il virtuale
(1996), Cyberculture (1997).
Per saperne di
più: F. Berardi, Introduzione a P. Lévy, Le
tecnologie dell'intelligenza (1990), Synergon, 1992; P. Lévy,
M. Autier, Les arbres de connaissances, La Découverte,
1992.
Marshall McLuhan
Herbert Marshall
McLuhan (1911-1980) è stato l'interprete più noto e più
rivoluzionario dell'epoca delle comunicazioni di massa. Canadese, studioso
di letteratura e critico teatrale di formazione (si era occupato soprattutto
di Shakespeare), McLuhan ha applicato alla ricerca sui media un metodo
del tutto particolare e difficilmente ripetibile. Animatore principale
della Scuola di Toronto, lo studioso canadese ha sovvertito in modo
radicale gli orientamenti principali della sociologia della comunicazione,
trasformando la ricerca sui contenuti della comunicazione nella ricerca
sulla qualità dei media.
Secondo McLuhan,
"il mezzo è il messaggio", nel senso che un mezzo di
comunicazione determina una precisa visione della realtà (partecipativa
nel caso dell'oralità, distaccata e scientifica con la scrittura,
di nuovo tattile con l'oralità dei media elettronici)
e deforma irrimediabilmente i propri contenuti. A ben vedere, McLuhan
non è realmente (come spesso si sostiene) un autore entusiasta,
ma è invece consapevole della complessità delle relazioni
tra l'uomo e le proprie "estensioni tecnologiche". Infatti
la sua idea è che i media siano, appunto, estensioni di un senso
- la vista per la scrittura, l'udito per la radio, il tatto per la tv,
e così via - e che quindi costringano l'uomo ad un determinato
rapporto con la realtà sociale.
Una caratteristica
essenziale di McLuhan è la sua quasi totale assenza di metodo
e di rigorosità scientifica. Questo è, naturalmente, il
suo difetto principale: ma è anche, paradossalmente, il suo merito
e la ragione della sua popolarità. Perché soltanto una
propaganda intensa e anti-istituzionale come quella di McLuhan poteva
ribaltare i termini del dibattito scientifico, facendo dei mezzi di
comunicazione non più un valore di sfondo ma l'oggetto principale
della ricerca sociale. A diversi decenni dalla sua predicazione,
infatti, fare a meno di McLuhan non è ancora possibile.
Le sue opere fondamentali
sono: La sposa meccanica (1951), La galassia Gutenberg. Nascita
dell'uomo tipografico (1962), Gli strumenti del comunicare
(1964), Dall'occhio all'orecchio (1982).
Per saperne di
più: AA.VV., I conti con McLuhan trent'anni dopo, "Problemi
dell'informazione", 3, 1997; G. Bechelloni, L'immaginario quotidiano.
Televisione e cultura di massa in Italia, Eri, 1984; G.Gamaleri,
La galassia McLuhan. Il mondo plasmato dai media, Armando, 1995;
M. McLuhan, E. McLuhan, La legge dei media (1988), Edizioni Lavoro,
1994.
Edgar Morin
Edgar Morin (1921)
è uno dei maggiori sociologi viventi ed uno dei massimi studiosi
della cultura di massa. Insignito della laurea honoris causa
dalle università di diversi paesi europei, già coordinatore
di alcune riviste ("Arguments", "Communications"),
ha diretto a lungo il Centro di Studi Interdisciplinari all'École
des Hautes Études di Parigi, ed è oggi considerato, in
assoluto, uno degli studiosi più prestigiosi nell'area delle
scienze umane.
La ricerca di Morin
è molto complessa, e si articola in diverse fasi: l'analisi delle
culture contemporanee e delle dinamiche della società di massa
(L'industria culturale; Le star), lo studio
dell'immaginario (Il cinema o l'uomo immaginario) e del rapporto
tra essere sociale ed essere biologico (L'uomo e la morte), ma
anche dei problemi metodologici della sociologia (Il metodo,
1991-1997). Al termine di questa riflessione, com'era forse inevitabile,
Morin ha proposto, tra anni ottanta e anni novanta, una vera e propria
rifondazione del pensiero, necessaria per comprendere i problemi più
urgenti della fine del XX secolo (Penser l'Europe, 1987).
Rispetto alla ricerca
sulle comunicazioni di massa, il contributo più interessante
di Morin risale agli anni sessanta, quando il sociologo francese ha
fornito un'importante legittimazione dell'industria culturale di massa,
mostrando come essa non sia imposta ai consumatori (come sostenuto
da quasi tutti gli intellettuali), ma sia invece il frutto di una continua
negoziazione tra le esigenze della produzione industriale e quelle del
pubblico di massa: una negoziazione che produce, come risultato, esattamente
gli stereotipi di cui si costituisce la cultura audiovisiva di
massa.
Tra le opere di
Morin, le più importanti sono: L'uomo e la morte
(1951), Le star (1955), L'industria culturale (1962),
Il paradigma perduto (1972), Il cinema o l'uomo
immaginario (1978), Sociologia (1994).
Per saperne di
più: A. Abruzzese, A. Miconi, Zapping. Sociologia dell'esperienza
televisiva, Liguori, 1999; F. Casetti, Teorie del cinema 1945-1990,
Bompiani, 1993; M. Kofman, Edgar Morin, Pluto, 1996; G. Lipovetsky,
L'impero dell'effimero. La moda nelle società moderne
(1987), Garzanti, 1989.
David Morley
Il ricercatore
inglese David Morley è stato probabilmente l'interprete più
efficace della "svolta etnografica" seguita dalla ricerca
empirica sui media, a seguito della forte opera di mobilitazione dei
cultural studies britannici (nati nel secondo dopoguerra
intorno alla Scuola di Birmingham). Nel corso degli anni ottanta, Morley
ha infatti messo a punto alcuni modelli di ricerca molto fortunati,
che rappresentano al meglio le ragioni e le ambizioni di questa "svolta"
metodologica.
La prima ricerca
è stata condotta da Morley sul pubblico del programma di attualità
"Nationwide" (1980), per mostrare - come puntualmente si è
verificato - che i diversi segmenti del pubblico interpretano in modo
diverso uno stesso messaggio. In realtà, questa ricerca è
stata molto contestata, e a ragione, sul piano metodologico: in ogni
caso, l'obiettivo di mostrare la "polisemia" del testo audiovisivo
era certamente raggiunto.
Più riuscita
è stata invece la ricerca di Morley su "Family Television"
(1986), condotta attraverso una serie di interviste non strutturate,
sul tema della tv, in diciotto nuclei familiari paragonabili per condizioni
etniche e socio-culturali. Questa ricerca ha mostrato l'esistenza delle
cosiddette "pertinenze", cioè di un sistema di aspettative
che appartiene al pubblico e che precede l'emissione delle informazioni:
l'analisi del contesto di fruizione, che può rivelare queste
pertinenze, diviene così necessaria per comprendere il ruolo
dei media (non più riconducibile soltanto ai poteri della produzione
editoriale o industriale). La "svolta etnografica" è
giunta al suo compimento ideale.
Le opere più
importanti di Morley sono: The "Nationwide" Audience
(1980), Family Television (1986), Communication and Contexct
(1991, con R. Silverstone), Television, Audience and Cultural Studies
(1992).
Per saperne di
più: R. Grandi, I mass media tra testo e contesto, Lupetti
& Co., 1994; M. Jancovich, David Morley, The Nationwide Studies,
in M. Barker, A. Breezer (a cura di), Reading into Cultural Studies,
Routledge, 1992; S. Moores, Il consumo dei media. Un approccio etnografico,
il Mulino, 1998.
Paul Watzlawick
Paul Watzlawick
(1921), tra i tanti studiosi che si sono occupati di comunicazione,
è certamente uno dei più atipici. Austriaco di nascita,
ha studiato tra l'Italia e la Svizzera, ha insegnato psicoterapia a
Filadelfia e a El Salvador, ed è attualmente professore di psichiatria
alla Stanford University e all'Istituto di Ricerca Mentale di Palo Alto
(ed è, appunto, il massimo rappresentante della cosiddetta "Scuola
di Palo Alto").
Watzlawick giunge
allo studio della comunicazione passando appunto per la psichiatria.
La sua idea, infatti, è che le malattie mentali non nascano nell'individuo,
ma dipendano invece dal suo rapporto con l'ambiente sociale. Questo
rapporto è legato però ad un processo comunicativo: infatti
tutta la realtà sociale è fatta di comunicazione, perché
ogni comportamento comunica qualcosa, compreso il silenzio (di qui la
fortunata conclusione sul fatto che è "impossibile non comunicare").
Comprendere la comunicazione, quindi, significa comprendere e risolvere
le patologie di cui soffrono gli individui (Pragmatica della comunicazione
umana).
Watzlawick, com'è
ovvio, non si occupa di comunicazioni di massa. Tuttavia il suo metodo
è significativo, anche perché mostra la crescente attenzione
che tutte le discipline delle scienze umane hanno dovuto rivolgere alla
comunicazione. La conclusione dello psichiatra austriaco, in questo
senso, è di fondamentale importanza: Watzlawick afferma infatti
che è proprio la comunicazione a costruire la realtà
(La realtà della realtà),
come dimostrano alcuni esempi più o meno verosimili (Watzlawick
usa anche dei casi-limite, parlando della comunicazione tra uomini e
orsi e tra uomini ed extraterrestri) in cui un piccolo difetto comunicativo
costruisce un sistema di realtà completamente diverso dal previsto.
Tra le sue opere,
vanno ricordate: Pragmatica della comunicazione umana (1967,
con H. Beavin e D. Jackson), Change (1974, con J. H. Weakland
e R. Fisch), La realtà della realtà (1975), Il
linguaggio del cambiamento (1977), La realtà
inventata (1988).
Per saperne di
più: J. Fredenborg, Paul Watzlawick: A Bibliography (disponibile
in Internet al sito www.amazon.com); P. Watzlawick, G. Nardone, L'arte
del cambiamento, Ponte alle Grazie, 1990.
Raymond Williams
Raymond Williams
(1921-1988), storico della cultura, critico letterario e sociologo inglese
di area marxista, è stato tra i fondatori e tra gli esponenti
più significativi dei cultural studies, nati nel secondo
dopoguerra intorno all'Università di Birmingham, con lo scopo
di analizzare la cultura delle società complesse. Se l'obiettivo
di questa scuola era di conciliare (finalmente) il sapere sui
media alla pratica dei media (facendo nascere quindi il sapere
da un'analisi accurata dei processi sociali e non da costruzioni teoriche
astratte), Williams ne è stato un interprete ideale: al punto
che le sue teorie sulla televisione nascono nella sua esperienza di
critico televisivo per alcuni quotidiani britannici.
L'idea di Williams
è che la rivoluzione industriale abbia creato una frattura decisiva
nella storia della civiltà occidentale, portando ad una valorizzazione
del nucleo domestico privato e insieme ad una maggiore mobilità
(fisica e sociale) degli individui (Williams parla infatti di "privatizzazione
mobile"). Se si considera l'origine della modernità, è
allora errato interrogarsi sul rapporto di causalità tra tecnologia
e società: nel senso che esse sono due parti complementari di
uno stesso processo di evoluzione (la tv, come recita il sottotitolo
di un suo libro, è appunto "tecnologia" ma anche "forma
culturale"). L'unico metodo per comprendere la cultura di massa,
allora, è la "storia sociale" delle tecnologie, cioè
una riflessione che tenga conto dei diversi fattori chiamati in causa
nell'evoluzione quotidiana della società industriale avanzata.
Metodo messo in atto puntualmente da Williams, con una delle più
convincenti intepretazioni storico-sociologiche della televisione.
Le sue opere fondamentali
sono: La lunga rivoluzione (1961), Televisione. Tecnologia
e forma culturale (1974), Keywords (1976), Marxismo
e letteratura (1977), Sociologia della cultura
(1981).
Per saperne di
più: R. Grandi, I mass media tra testo e contesto, Lupetti
& Co., 1994; S. Laing, Raymond Williams and the Cultural Analysis
of Television, "Media Culture & Society", 13, 1991;
C. Spada, Introduzione a R. Williams, Televisione. Tecnologia
e forma culturale (1974), De Donato, 1981.
|
