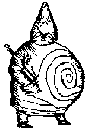
Da www.artribune.com, 3 agosto 2021
Marcello Faletra
Adotta un artista. Il pamphlet di Pablo Echaurren
Pablo Echaurren
– Adotta un artista e convincilo a smettere per il suo bene. Kellermann Editore, 2021
Adotta un artista è il titolo provocatorio
del pamphlet di Pablo Echaurren, pubblicato dalla casa editrice Kellermann. Il libello di ottanta pagine si chiude con una
pungente postfazione di Gianfranco
Sanguinetti, ultimo situazionista e sodale
di Guy Debord. La
tesi sostenuta nel libro è tanto radicale quanto semplice: l’arte che
ufficialmente circola come “arte contemporanea” è una truffa. Il sottotitolo,
poi, non trattiene l’ironia che pervade il saggio: “… e convincilo a
smettere per il suo bene”. L’artista, dunque, è il principale soggetto in
causa, che lungo le pagine di Echaurren, è trattato
alla stregua di un servizievole funzionario arruolato nelle fila del sistema
dell’arte, il quale è il vero motore di un nuovo “colonialismo culturale”,
nuova forma di ideologia estetica, che richiama lo zdanovismo d’altri tempi.
A questo punto il lettore si trova davanti a una scelta: o chiude il libro
davanti a una presa di posizione che appare nichilista, oppure si mette a
curiosare tra le pagine dove incontra espressioni come “il popolo dell’arte…
è un popolo ubbidiente”, oppure: “L’arte non è più il prodotto
dell’artista bensì è l’artista a essere prodotto del sistema dell’arte”.
Naturalmente a tutte queste espressioni seguono argomenti che a volte
rilanciano posizioni dadaiste e ciniche. Ecco, Echaurren,
trattando dell’artista e dell’arte definita “contemporanea”, tratta di fatto
dell’ideologia che pervade il capitalismo estetico d’oggi, dove gli artisti –
con i loro personali capricci o la moda degli estremismi ‒ svolgono la
funzione di attrattori strani (star system),
mentre le mostre, denunciate nel pamphlet come vere epidemie, ratificano l’arte
come spettacolo di massa; infine, il
sistema dell’arte, la cui funzione è di produrre consumatori di cultura.
In altre parole, Adotta un artista rilancia la convinzione di
Duchamp secondo la quale i musei sono pieni di mediocrità e stupidaggini.
ARTE, SCIOCCHEZZE E STRONZATE
Per certi aspetti
l’invettiva di Echaurren ricorda il pamphlet del
filosofo Harry G. Frankfurt,
il quale, in un suo ironico saggio dal titolo eloquente – Stronzate –,
argomentava l’imbecillità che circola in ambito teorico-filosofico.
Abbiamo molte teorie e contro-teorie dell’arte, della società, della storia,
della religione, della politica, dell’economia, di qualsiasi altra cosa, ma non
abbiamo, ribadiva Frankfurt, una teoria, anche minima, delle stronzate che ci circondano.
Le stronzate, osservava Frankfurt, non differiscono dalle sciocchezze. L’uso di
una parola al posto dell’altra è solo questione di “educazione”: “è più
educato, e meno forte, esclamare “sciocchezze!” che non “stronzate!”. Per il
resto hanno lo stesso ruolo nell’economia del linguaggio.
Detto più semplicemente: chi dice stronzate “non rifiuta l’autorità della
verità” e quindi a suo modo alimenta ciò che passa per verità convenzionale.
Fare stronzate significa liberarsi dalla responsabilità etica di saper fare o
dire qualcosa. Scorrendo le pagine del libro di Echaurren,
troviamo sorprendenti analogie col ragionamento di Frankfurt. Se sostituiamo la
parola “verità” con “sistema dell’arte”, abbiamo la stessa condizione:
l’artista non nega l’autorità di un sistema che passa per l’immagine dell’arte
– un’arte, beninteso, convenzionale.
E nel consumatore di cultura – altro bersaglio di Echaurren,
prodotto della democratizzazione dell’arte – potremmo vedere l’ultimo uomo
dello Zarathustra di Nietzsche, ovvero ciò che di più spregevole vi è al mondo:
l’uomo asservito, avvilito che è “l’incarnazione dell’espropriazione in
atto, della piramide della disuguaglianza, della subalternità economica e
psicologica”. L’ultimo uomo, per Nietzsche, è colui che ha eliminato dalla
realtà ogni fonte dei conflitti, e che vede il mondo appianato, senza più alcun
destino che non sia quello della propria mediocrità. Non è difficile
riconoscere in quest’uomo l’eroe della società dei consumi, versione
contemporanea del nichilismo passivo, l’eroe-consumatore che si muove dopo la
liberazione (o liberalizzazione) di ogni sfera dell’arte.
Ma qual è l’immagine
dell’artista che ci è stata tramandata per secoli? Le leggende degli
artisti sono ben note. All’alba della modernità, in pieno impeto romantico,
l’immagine dell’artista circolava nei panni dell’eroe-buffone, del saltimbanco
o del clown.
La più grande lirica della modernità, quella di Baudelaire, è piena di presenze
a un tempo clownesche e tragiche, dove la bellezza coesiste con il proprio
contrario, cioè con il repellente, il brutto, l’effimero. Un modo parodistico
di porre il problema dell’artista che troverà in Ubu
Re di Jarry la più decisa manifestazione,
fino al punto che prima di morire Jarry non si
riconoscerà più come uomo, ma come Ubu, la sua
stravagante e iperbolica creatura. Mentre Joyce dichiarava: “Io sono
soltanto un clown irlandese”. “Guardatemi bene!” ‒ affermava Tristan Tzara in uno dei
manifesti dadaisti ‒ “Sono un idiota, sono un buffone, sono un
mistificatore! (…) Sono brutto, ho un viso inespressivo, sono piccolo. Sono
come tutti voi!”. In tutti questi esempi ci troviamo di fronte a
volontarie deformazioni che l’artista amava dare di sé.
Il carattere distruttivo che ha segnato l’arte moderna per certi aspetti si è
fatto carico di questi problemi. Il non-senso, la ricerca di un vuoto di
significato erano una forma di rigenerazione del senso stesso, una sua
possibile rinascita a partire dalla messa in dubbio delle certezze che sorreggevano le idee sull’arte.
I valori dell’onorabilità borghese erano dissacrati nel gioco deformante del
clown, del buffone, del folle. In tale critica dobbiamo riconoscere uno dei
tratti specifici della modernità, una specie di autocritica per mano degli
artisti.
Ma è di fronte all’artista-narciso – frutto del capitalismo estetico ‒
che il pamphlet di Echaurren si scaglia senza alcun
riserbo. Questo artista che esce dalle pagine del libro riassume culturalmente
il potenziale delle forze reazionarie del presente, le quali sono in grado di
assorbire, a volte in anticipo, qualsiasi elemento sovversivo che minerebbe la
sua egemonia, a costo di farsi esso stesso promotore della trasgressione,
neutralizzandola in fenomeno estetico.
E l’immagine prevalente dell’artista contemporaneo è ben diversa dai loro
colleghi del passato, come ci informa Echaurren.
Infatti, in tutt’altra direzione, Adotta un artista suggerisce
che la contemporaneità ha prodotto un nuovo tipo d’artista, la cui immagine può
essere riassunta nello yuppie-mercenario,
caratterizzato dalla debolezza per il banale, dall’irresistibile attrazione per
il successo, dal cinismo e dall’opportunismo nelle relazioni. Nei modi spesso
somigliano a dei manager, e passano gran parte del tempo a consolidare le
pubbliche relazioni. Sull’articolazione arte/comunicazione, poi, molto in voga
da tempo, la posizione di Echaurren è molto chiara,
ed è prossima a quella di Gilles Deleuze, quando
afferma che l’atto di creazione è un atto di resistenza. L’orinatoio di
Duchamp, autore a cui spesso Echaurren ha fatto
riferimento in altre pubblicazioni, non comunica nulla se non l’atto stesso di
resistere alla sacralizzazione dell’opera.
In fondo Adotta un artista, sotto le parole, suggerisce che il
sistema dell’arte non ha fatto altro che sostituirsi alla dottrina del giudizio
(vecchia metafisica teologica sopravvissuta al razionalismo): “Il popolo
dell’arte… è un popolo ubbidiente”, afferma Echaurren.
A cosa ubbidisce? Alle logiche del sistema dell’arte, con “la retorica del
suo schematismo del giudizio”. E l’atto di resistenza è sempre un atto che
si oppone al giudizio, qualunque esso sia. Con le parole lapidarie di Sanguinetti nella sua postfazione, questa contrapposizione
registra un fatto importante dello stato dell’arte oggi: e cioè che “il
monoteismo del mercato ha soppresso il politeismo dell’immaginazione”.
LA MORTE E LA FINE DELL’ARTE
Ora, leggendo il libro
si potrebbe pensare che per Echaurren l’arte sia
morta. Niente affatto. L’autore non cade nella trappola dei gadget mortuari, per
lui l’arte non muore, continua a
esistere fuori dalle cornici istituzionali e dalle grandi kermesse culturali.
A questo punto s’impone una riflessione sulla morte dell’arte, perché dalle
pagine del pamphlet emerge uno scenario che prefigura questo argomento. Sanguinetti nella sua postfazione osserva: “Ciò che si
può rimproverare all’arte contemporanea non è di esser morta in quanto arte, ma
è di non aver saputo fare della propria morte qualcosa di più alto… L’arte non
ha dunque saputo fare della propria morte una tragedia vitale e creativa”,
un pensiero forte che coniuga arte e vita in un divenire che non esclude la
morte. Per Sanguinetti c’è qualcosa di più urgente
dell’arte: saper morire all’altezza di un gesto stoico e dionisiaco allo stesso
tempo.
Ora, la tesi sulla “fine dell’arte”, dopo il verdetto di Hegel,
è stata una costante delle teorie sull’arte moderna. Hegel
osservò che l’arte classica portava con sé il germe della propria dissoluzione;
la spregiudicata ironia di Socrate, il riso sferzante del comico e del satiro
erano la forma attraverso cui la cultura greca veniva desacralizzata. Tuttavia,
nonostante il suo idealismo, Hegel anticipava alcune
questioni che sono anche del nostro tempo. La “fine dell’arte”, corollario
della “fine della Storia”, coincide nella prospettiva di Hegel
con l’avvento del sapere assoluto: l’erosione della distanza fra soggetto e
oggetto, il vuoto che garantiva la presa a distanza della rappresentazione del
mondo, viene a cadere in una fatale coincidenza.
Il sapere assoluto è l’identità pura, senza più l’altro. In un certo senso
tutto il pensiero di Hegel è una riflessione
sull’esaurimento, sulla finitudine di tutte le cose. La lotta contro la morte,
l’azione storica, l’impulso creatore, sono tutte condizioni destinate a esaurirsi.
Lo stesso Napoleone – incarnazione dello Stato assoluto per Hegel
– non sfugge a questo destino: il suo esilio è l’esilio della storia da questo
mondo.
Potremmo vedere in tale pensiero un’anticipazione dell’arte concettuale, la
coincidenza fra concetto e opera nella stessa persona, l’arte come fare dove
si riflette la coscienza estetica è per Hegel una
cosa del passato, ed essa sopravvive solo grazie alle idee, e ciascuno ha le
proprie idee. Estremizzando questo concetto Arthur C. Danto
osserva: “Si può essere astrattisti al mattino, iperrealisti al pomeriggio,
minimalisti alla sera. Oppure ritagliare bambole di carta o fare quel che
caspita si vuole. L’epoca del pluralismo è imperante; quello che uno fa non ha
più importanza, questo è appunto il significato di pluralismo”.
IL SISTEMA DELL’ARTE È UNA TRUFFA
Da questa aleatorietà,
da questo stato di incertezza divenuto effetto speciale dell’arte
contemporanea, deriva l’esigenza di un sistema dell’arte che ne giustifichi la
produzione di valore estetico. È in questa “traduzione” di un’immagine o di un
oggetto qualsiasi strappati dal loro contesto e inseriti in una logica estetica
che si ha creazione di valore. Perché, come oggetto, l’opera, come ricorda Echaurren, è significata e comunicata, diviene cioè fatto culturale,
e sottostà alle regole della circolazione del mercato.
Questa operazione di “traduzione” di un oggetto o immagine, da cosa qualsiasi
in fenomeno culturale e commercio estetico ‒ feticcio ‒ non manca
d’unità, né di organizzazione. Ciò che è comunemente definito “sistema
dell’arte” è il motore di tale strutturazione generalizzata dei significati, è
il mondo degli elementi scambiabili, delle equivalenze generalizzate.
Dopo che l’orinatoio di Duchamp è entrato a pieno titolo nel sistema
del valore, cioè è stato sacralizzato, feticizzato – pur nascendo come gesto
dissacratorio –, perde la forza distruttiva della dissacrazione per partecipare
come elemento codificato nel sistema del valore estetico.
La fine dell’arte in
tale prospettiva è strettamente connessa al problema del valore. Essa
affiora là dove si verifica un’inflazione del valore estetico. Si fa strada un
paradosso: la fine dell’arte non finisce, ma ricomincia sempre, e di
conseguenza, come osserva Didi-Huberman sulla scia di
Goethe: “Il discorso storico non ‘nasce’ mai, ricomincia sempre”.
L’opera d’arte assoluta, come auspica Sanguinetti, ha
mancato di mettere in scena la fine dell’arte. Ma, forse, la banalità di gran
parte dell’arte d’oggi ci dissuade dal pensare una simile eventualità. Contro
questa condizione si può ipotizzare che la fine dell’arte consiste proprio in
questo: che questa morte non ci sarà mai, condizione che condanna l’arte a
sopravvivere alla propria fine, in ogni modo, anche col banale.
www.artribune.com, 3 agosto 2021