Quella
che fu detta, in un momento di esposizione mediatica,
“Nuova Destra”, non ha più modo di insistere troppo sull’aggettivo, ché cosa
ormai di lustri - e non son pochi. Quanto al sostantivo sembra essere meno
inderogabile d’una volta. Colpisce tuttavia la mole, peraltro mai invadente,
del lavoro al quale si è sottoposta, principalmente nei nomi di spicco, a
cominciare dal de Benoist
che ne è stato - e, crediamo si possa
dire, ne è - il mallevadore. E proprio in de Benoist, ma non solo in lui, si ritrovano tali e tanto ben
espresse capacità che anche di fronte a motivi e spunti di discordia non si
può, onestamente, che restare ammirati. Rilevando dalle pagine di “Diorama” -
la più vecchia testata italiana ascrivibile alla corrente - questa
recensione (del suo direttore) al recente libro di Germinario su de Benoist,
s’è voluto dunque far prevalere l’intenzione chiarificatrice che la anima su tutto il resto – per giunta
tutt’altro che ordinario.
Marco
Tarchi
il de Benoist di Germinario
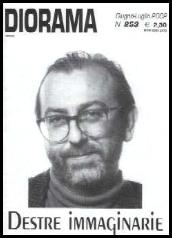
Francesco Germinario, La destra
degli dei. Alain de Benoist
e la cultura politica della Nouvelle droite, Bollati
Boringhieri, Torino 2002
Chiunque
abbia familiarità con le idee di Alain de Benoist, sa che racchiuderle in un’analisi unitaria è
impresa ardua. Sono occorse quasi quattrocentocinquanta pagine, per provare a
farlo, a Pierre-André Taguieff,
in quel La Nouvelle droite. Jalons d’une analyse critique (Descartes & Co) che resta di
gran lunga il miglior libro in argomento; eppure anche quel risultato non può
dirsi esaustivo. Sarebbe stato difficile far meglio riempiendone poco più di un
terzo, e non è dunque l’incompletezza il difetto che si può rimproverare a
Francesco Germinario; né gli si può far troppo carico
di una lettura qua e là marcatamente antagonistica della materia nella quale si
è addentrato, perché le sue non celate passioni di militante di una sinistra
poco propensa ad aprirsi alle altrui ragioni – testimoniate dalla
collaborazione al quotidiano di Rifondazione comunista, "Liberazione"
– avrebbero autorizzato ad aspettarsi ben di peggio. Al contrario, i toni
riflessivi e pacati con cui l’argomento è affrontato rappresentano il pregio
maggiore del libro. La cui vera pecca è di presentarsi come un’opera a tesi,
schiva di sfumature, condotta con l’intento non di interloquire criticamente
con la filosofia politica del pensatore normanno, ma di inquadrarla in un
progetto strategico le cui coordinate sono date per scontate, facendone
combaciare a forza i refrattari tasselli.
Questo è
infatti il palese proposito con cui è stato scritto La destra degli dei: ridurre il complesso itinerario delle
meditazioni dell’autore studiato, che si sono estese lungo sette lustri e hanno
conosciuto ripensamenti, contraddizioni e revisioni di rotta, a un ininterrotto
e lineare filo rosso, mosso dalla preoccupazione quasi ossessiva di rifondare
una "vera destra", rinnovata nelle forme espressive e in taluni
contenuti ma rigidamente fedele allo spirito della droite
éternelle. Un’intenzione che non può che condurre
fuori strada il lettore neofita, invitato a percorrere scorciatoie senza via
d’uscita nel tentativo di catturare l’essenza di idee che sono invece, per
volontà di chi le ha esposte, aperte all’evoluzione e al dubbio.
Beninteso:
che fra gli obiettivi di Alain de Benoist,
uscito deluso da un giovanile attivismo nelle file della destra radicale
francese, vi sia stato in origine la modernizzazione dell’ambiente dal quale
proveniva, non può essere messo in dubbio. Ma, come Taguieff
ha documentato e una bibliografia personale ormai di proporzioni straripanti
dimostra, proprio gli scarsi esiti dei tentativi da lui effettuati in tal senso
sino al 1967 – l’epoca di riviste come "Europe-Action"
e i "Cahiers Universitaires"
e dell’effimero Rassemblement Européen
des Libertés condotto da Dominique Venner –, uniti alla
curiosità intellettuale che da sempre caratterizza de Benoist,
hanno poi ampliato e ridisegnato quell’orizzonte. Già
nella seconda metà degli anni Settanta, quando la sua antologia Vu de droite
vinse il premio di saggistica dell’Académie Française, il fondatore di "Nouvelle École"
si rese conto di non potersi più dire "di destra", stanti le forti
differenze tra le sue convinzioni e le opinioni diffuse negli ambienti a cui quell’etichetta si applicava, e puntò su una formula un po’
equilibristica, affermando che le sue idee si
trovavano in quel momento "a destra" per effetto del convergere di
una serie di elementi di circostanza, ma avrebbero potuto benissimo collocarsi
altrove, cioè anche a sinistra, se quello scenario politico-culturale si fosse
modificato.
I suoi
atti, da allora in poi, hanno confermato la vocazione di de Benoist
a coltivare un pensiero sincretico e trasversale. Non
solo, infatti, egli non si è lasciato coinvolgere nelle campagne politiche
delle varie destre, ma molte delle scelte compiute lo hanno nettamente separato
dagli ambienti nazionalisti, tradizionalisti, conservatori o xenofobi. Le sue
pubbliche prese di posizione contro Le Pen e il Front
national, accusati di accollare agli immigrati la
responsabilità di una serie di squilibri e tensioni che affondano le radici nel
cuore delle odierne società industrializzate di massa, ma anche contro i
liberali giscardiani succubi della tirannia degli
interessi economici o i neogiacobini centralisti
annidati nelle file del gollismo, non si contano. Anche se ne La destra degli dei non se ne trova, non casualmente,
neppure una flebile eco. Non a caso: perché darne conto avrebbe significato
indebolire, agli occhi del lettore, l’ipotesi monolitica del de Benoist votato a "stare a destra", anzi,
destinato ad essere "l’ultimo intellettuale che la destra francese del
Novecento abbia prodotto", attorno a cui l’intero studio è costruito.
Va
riconosciuto che Germinario sostiene la sua tesi,
parziale e riduttiva, con accortezza e garbo (quello che da anni si guarda bene
dal riservare a uomini e idee dell’ex Nuova Destra italiana, con i quali ha
ingaggiato un’unilaterale singolar tenzone che non
gli fa onore), evitando di inciampare nei "giudizi orecchiati e
semplicistici" di "storici peraltro documentati" (il riferimento
diretto è a Eatwell, ma chi si è più spinto avanti su
questo versante è Griffin) che hanno presentato Alain de Benoist "come uno
tra i "pensatori fascisti più seri del dopoguerra"". Il
ricercatore di Molfetta ammette anzi che
"ricondurre il pensiero politico di de Benoist
al fascismo tout court è operazione quantomeno semplicistica, certamente
utile per delegittimarlo, ma sterile sul piano conoscitivo, se non del tutto
disonesta sul piano intellettuale" ed esprime disaccordo verso quei
critici prevenuti che fanno passare il teorico della Nouvelle droite per "una versione aggiornata e mascherata –
e dunque, proprio per questo, più pericolosa – di Alfred
Rosenberg e Heinrich Himmler". Ma poi scivola negli stessi errori che
addebita agli altri.
La
convinzione che "il revisionismo [si noti la scelta del termine, di per sé
carico di forti ambiguità, ndr] di de Benoist è riuscito in un certo senso a mantenersi fedele
alla precedente cultura di destra" lo spinge infatti a scrivere che costui
"ha comunque cercato di rendere presentabile quella cultura di destra che
aveva pur sempre assunto a punto di riferimento i regimi e le culture politiche
fasciste" e "si presenta come l’ultimo esponente d[el] filone [di destra della cultura francese degli anni venti-trenta], accentuando il terzaforzismo
ereditato dalla cultura politica del collaborazionismo (Drieu
La Rochelle ecc.), che riteneva il nazismo un
tentativo di salvaguardare la civiltà europea dall’espansionismo sovietico e
dal mercantilismo delle talassocrazie anglosassoni di schmittiana
memoria". E non basta, perché a de Benoist
premerebbe soprattutto "ricostruire speditamente i fondamenti della
cultura di destra, sottraendola ai sensi di colpa provocati dalla sconfitta del
1945 e addebitando invece alla sinistra le storture di una modernità
abbrutente". Da qui a farne quel tessitore di sulfuree trame culturali
revansciste caro a certa pubblicistica sbrigativa presente sia al di qua che al
di là delle Alpi, il passo è breve, a prescindere dalle buone intenzioni
dichiarate in avvio di libro, e Germinario lo compie
immediatamente quando scrive, a prezzo di un’evidente contorsione logica, che
"de Benoist sembra non avere quasi mai influito
sulle scelte politiche dei movimenti di destra europei, almeno nel senso che
nessuno dei movimenti di destra politicamente più significativi di fine-inizio secolo si è mai richiamato esplicitamente alle
sue posizioni. Eppure non v’è dubbio che proprio lui abbia messo in
circolazione alcune tematiche – prima fra tutte, il differenzialismo
– che sono entrate nel patrimonio genetico dei movimenti xenofobi, tanto da
poter rivendicare una qualche paternità di pensiero rispetto al variegato
panorama storico-politico della destra europea di
questi ultimi decenni".
Questa
paternità, tuttavia, Alain de Benoist
non solo non l’ha mai rivendicata, ma si è impegnato in ogni modo per
respingerla, ovviamente inascoltato da chi, a sinistra ma anche a destra (basta
pensare agli attacchi furibondi degli ambienti più estremisti del cattolicesimo
tradizionalista italiano impegnato a destra: per prima Alleanza Cattolica),
vuole utilizzare il suo nome nella costruzione di un tipo ideale di Nemico per
darsi nuove ragioni di impegno militante che riescano a sostituire quelle ormai
al tramonto. Favorevole ad un assennato multiculturalismo
e assertore del diritto dei popoli e delle culture ad affermare le proprie
specificità – e per questo motivo in aspra polemica con i sostenitori
dell’occidentalizzazione del mondo e dell’assimilazione, da lui giudicata
spersonalizzante, degli immigrati nelle società multietniche
dei paesi di accoglienza –, de Benoist non si è
limitato a respingere la gerarchizzazione delle
razze, ma ha deplorato le forme di apartheid che i movimenti xenofobi
più o meno apertamente sostengono. E non si può certo dire che questo sia
l’unico fondamento del contenzioso che lo divide dall’universo politico
populista incarnato dai Le Pen, dagli Haider, dai Bossi e dai tanti loro odierni emuli. Altri
motivi di conflitto sono infatti le sue critiche del liberismo, del moralismo familista, del produttivismo,
dell’individualismo, della tattica del capro espiatorio applicata agli
immigrati: altrettanti punti fermi della visione del mondo populista. Mentre le
sue convinzioni federaliste e avverse al culto dello stato lo contrappongono
alle destre di ascendenza nazionalista e neofascista, inclusa quell’Alleanza nazionale che pure si sforza per includerlo
nel suo smilzo pantheon di pensatori di riferimento, a mero titolo strumentale
(Fini è arrivato al punto di citare al recente congresso nazionale di An una sua frase decontestualizzata,
spingendo il "Corriere della sera" a titolare in sede di commento:
"La nuova destra? È quella di de Benoist"),
e fa leva sull’isolamento di cui soffre in patria per farne la vedette
di convegni e tavole rotonde, indifferente ai contenuti dei suoi interventi ma
attenta a trarne il massimo vantaggio d’immagine.
Per
enfatizzare i motivi di continuità fra i vari filoni del pensiero di destra del
XX secolo e le idee dell’autore studiato e sottacerne gli elementi di rottura e
di evoluzione, Germinario effettua una rigorosa
delimitazione dell’opera da analizzare, espungendone quasi tutto ciò che de Benoist ha scritto su temi economici, giuridici,
sociologici e politici in senso stretto. Cioè quei materiali da cui il suo
progressivo distacco dalla cultura e dalla mentalità delle varie destra appare
più evidente. Abbondano viceversa i riferimenti agli articoli e ai libri di
impianto filosofico, che meglio si prestano a giustificare l’immagine di un
pensatore metafisicamente ancorato a destra, che della sinistra avrebbe fatto
il proprio idolo polemico, trascinandola "sul banco degli imputati,
chiamata a render conto di tutti gli orrori storici, a cominciare dai
totalitarismi (tutti i totalitarismi)" e nel cui bagaglio culturale
avrebbe ancora un peso cruciale l’insegnamento evoliano.
A contribuire a questa scelta è verosimilmente anche l’infondata convinzione
che la metapolitica debenoistiana
– che Germinario considera, sottoscrivendo un
discutibile giudizio di Bobbio, "strategia
evanescente e di corto respiro" – esprima una "rinuncia alla politica
in nome dell’autoeducazione individuale",
prossima all’evoliana apolitìa,
mentre è ad un superamento della dimensione meramente istituzionale e
quotidiana della politica, proiettato verso un intervento sulle mentalità
collettive, che essa è sempre stata orientata.
In
questa strategia discorsiva, indirizzata verso quello che potremmo definire un
"incatenamento a destra" di de Benoist,
l’ambizione di dimostrare l’esaurimento delle capacità descrittive e prescrittive dei concetti di destra e di sinistra è
trasfigurata in un banale uso di categorie culturali "appartenenti"
alla sinistra, in rilettura da destra di quanto è stato elaborato dalla
sinistra, insomma in "parassitismo ideologico". E il passaggio dall’acerbo
"né destra né sinistra" degli scritti dei primi anni Ottanta ad una
più matura posizione di "e destra e sinistra", in realtà mutuata
dalle teorizzazioni della Nuova Destra italiana, è
giudicato poco originale e poco trasgressivo, sempre per non sottrarre
all’impostazione pregiudiziale del lavoro nemmeno uno dei presupposti che la
sostanziano.
Un ruolo
cruciale, nell’equazione Nouvelle droite = destra
vera, rinnovata ma eterna, lo assume il richiamo alla polemica anticristiana di
de Benoist. Di uno dei motivi di fondo della
riflessione dell’autore di Come si può
essere pagani?, il libro, come il titolo lascia del resto intendere, fa
una presenza onnipervadente, chiamata, con non poche
forzature, a giustificarne ogni presa di posizione.
L’opposizione
tra paganesimo politeista e monoteismo giudaico-cristiano
è trasformata arbitrariamente in fondamento storico e metastorico
della distinzione assiale destra/sinistra, e la critica che de Benoist fa del cristianesimo è ricondotta all’influenza di Nietzsche "attraverso la mediazione del rigoroso
paganesimo di Evola". Facendo leva su alcune
delle affermazioni più radicali del filosofo francese, il ricorso al paradosso
è sistematicamente invocato a sostegno di questo assunto: nell’interpretazione
semplificata del pensiero debenoistiano proposta da Germinario, "san Paolo, espandendo in Occidente il
monoteismo di Abramo, ha creato Lenin e il rock’n’roll, Voltaire e Hitler,
Robespierre e Mussolini", e il Dio del Sinai
"è un Dio di sinistra". E poiché la sinistra oppone e divide, mentre
la sua avversaria unifica e accomuna, "la destra non ha bisogno di Dio per
governare il mondo" (anche se poi apprendiamo, a pagina 74, che
"nell’epoca del dispiegamento della massima potenza del mondialismo, lo scontro non si dà fra destra e sinistra […]
ma fra paganesimo e monoteismo": eppure avevamo letto che la seconda di
queste opposizioni è il fondamento della prima…).
Il
registro della sovrapposizione forzosa tra de Benoist
e l’idealtipo della destra è, nel libro, talmente
ossessivo da togliere vigore persino ad alcuni interessanti spunti critici che Germinario avanza su particolari aspetti del pensiero
dell’autore studiato. Non possiamo comunque non concordare su almeno due delle
sue osservazioni. In primo luogo, là dove mette in rilievo il meccanicismo
della trasposizione di una concezione spiritualistica e trascendente del
divino, quale è quella cristiana, in "quell’utilitarismo
che, sia nella versione liberale sia nella versione totalitaria, finisce per
emarginare Dio stesso dal mondo", sebbene de Benoist
ne faccia una semplice derivazione secolarizzata dell’insegnamento biblico ed
evangelico, e di conseguenza invita il teorico della Nouvelle Droite a rendersi conto che l’individualismo cristiano è
differente, per sostanza, dall’individualismo invocato dal liberalismo. In
secondo luogo, quando imputa all’autore di Comunismo e nazismo di fornire, tramite l’accusa al monoteismo
di essere alle radici della mentalità totalitaria, una lettura destoricizzata e depoliticizzata dei fenomeni reali
ascrivibili alla categoria del totalitarismo, talché per lui "diviene
totalitaria qualsiasi cultura che non si ispiri al paganesimo".
Malgrado
queste promettenti incursioni nelle aporie di un pensiero che, come abbiamo
notato all’inizio, è necessariamente segnato anche dalle contraddizioni, per la
lunga serie di innesti e revisioni che l’autore vi ha operato fra gli anni
Sessanta ed oggi, l’analisi complessiva del discorso debenoistiano
sulla politica operata da Germinario resta poco
convincente. Dopo averne identificati alcuni tratti basilari, come la
descrizione del liberalismo come un totalitarismo dal volto umano o il
superamento/assorbimento dell’anticomunismo nell’antiamericanismo, egli ne
liquida infatti in poche righe i caratteri di novità – il trasversalismo
e la "azzardata" scissione fra Europa e Occidente – e si ingegna in
una macchinosa indagine che ne sveli invece le stigmate di continuità con la
destra. Finisce così o per falsificare dati di fatto – come quando scrive che
"per gli intellettuali fascisti degli anni trenta il comunismo sovietico
era una particolare forma storica del liberalismo", convinzione che era
viceversa propria solo di una ristretta minoranza di essi, perlopiù in odore di
fronda – o per attribuire a de Benoist idee (antidemocratiche)
che sono ricavate dalle interpretazioni di suoi critici – come l’inscindibilità
del binomio "demos e oro",
teorizzata da Michela Nacci in merito alla cultura
antiamericana dell’Europa fra le due guerre mondiali. E non può non sollevare
quantomeno una perplessità il funambolico tentativo di sostenere da un lato che
la concezione del divenire di de Benoist resta legata
alla cultura della destra tradizionalista, giacché che per lui il futuro si
identificherebbe con la custodia del passato (strana lettura della concezione
sferica del tempo che l’autore de Le idee a posto ha raccolto – questa
sì! – da Nietzsche) e dall’altro che la sua critica
del tradizionalismo, anche e specialmente evoliano, è
mossa dall’accusa che egli gli farebbe di essere… in realtà di sinistra, perché
ancora "tributari[o] della filosofia della storia tipica delle grandi
narrazioni ideologiche egualitarie".
È
comunque il capitolo conclusivo, Approdi
del differenzialismo, a racchiudere i
maggiori difetti dell’opera. Usando come argomento di autorità le note (e
infondate) insinuazioni di Pierre-André Taguieff sul "razzismo clandestino" che si
celerebbe nelle pieghe del discorso della Nouvelle Droite,
il libro rilegge la dottrina debenoistiana sul
diritto alla differenza, Leitmotiv dei suoi interventi sulle questioni
etniche, in modo parziale e polemico. Non volendo aggredirne frontalmente i
contenuti, perché essi riecheggiano in larga parte tesi care alla sinistra
radicale, Germinario la colloca, senza fornire prove,
in una strategia mirante a "rivoltare contro la sinistra i suoi stessi
argomenti o di appropriarsi da destra delle culture di sinistra"
(approcci, a noi pare, in contraddizione) e la sottopone all’accusa di strumentalismo. Strumentale è, a suo avviso, il confronto
con l’altro, che de Benoist predica in opposizione
alle chiusure xenofobe, perché "finalizzato a sottolineare la propria
specificità", in quanto "l’io vede nell’altro da sé il mezzo per
preservare la propria differenza"; e addirittura sostiene che questa
attitudine lo apparenterebbe (di nuovo!) ad Evola,
più precisamente all’Evola impegnato nella campagna
razziale del regime fascista, che celebrava l’"affermazione della qualità
e della differenza di fronte al mito livellatore dell’umanitarismo demomassonico e enciclopedico". E strumentale viene
addirittura giudicata la dura critica di de Benoist
al biologismo razzista, perché, citando Taguieff, in queste forzature davvero cattivo maestro,
l’attacco alle assolutizzazioni del dato razziale
fondato sul sangue e su presunte leggi di natura viene interpretato come un
trasferimento della logica razzista sui "termini nobili della postmodernità: etnia, cultura, patrimonio (culturale e
genetico), ereditarietà, memoria, storia, tradizione, mentalità, differenza e
identità".
In
questo uso fuorviante delle limpide affermazioni debenoistiane
in materia di razzismo, Germinario arriva buon
ultimo. La schiera dei discepoli maldestri di Taguieff
è ormai ampia, e l’infondatezza delle loro accuse, mosse da preoccupazioni
esclusivamente ideologico-politiche, merita una
trattazione a parte, che abbiamo già iniziato e presto proseguiremo. Ma è
grave, e spiacevole, che in un testo che si vorrebbe riassuntivo – oltre che
critico – delle opinioni dell’autore studiato, delle repliche che de Benoist ha in più sedi fornito alle insinuazioni dei suoi
detrattori non si tenga alcun conto. Se lo si fosse fatto, ci si sarebbe resi
conto di come, dietro alla denuncia del presunto "razzismo differenzialista", si celi spesso la volontà di
criminalizzare per fini politici proprio alcune delle nozioni che Taguieff cita: identità, differenza, tradizione, etnia,
patrimonio culturale, imponendo il diktat del "politicamente
corretto" tipico di ogni forma di pensiero intollerante e smaniosa di
egemonia.
Se si
indulge al gioco delle analogie decontestualizzate ci
si può consentire ogni tipo di affermazione, ed è ovvio che, così come
scrivendo di critiche al cristianesimo si sono malignamente evocati i nomi
sulfurei di Rosenberg e Vacher
de Lapouge, possano essere messi nello stesso sacco,
in nome della comune diffidenza per l’universalismo, teorici e correnti di
pensiero fra i più svariati: di destra, da Joseph de Maistre in poi, come fa Germinario,
ma anche di sinistra. Un’analisi equilibrata dei caratteri innovativi del
pensiero di Alain de Benoist
non si limiterebbe tuttavia ad ammettere che "con il differenzialismo
il corpo smette di essere il significante dell’anima e dello spirito, come
invece voleva il pensiero razzista classico", insinuando che dietro questo
punto di vista si celi un razzismo rinnovato, il cui culto di una differenza
promossa ad assoluto farebbe da battistrada a prassi discriminanti verso le
minoranze etniche ("una rinnovata ma non per questo meno rigida ghettizzazione".
In de Benoist, la differenza non è mai elevata ad
assoluto, né il particolare è privilegiato rispetto al generale (posizione che
sarebbe in contrasto con il dichiarato olismo
dell’autore, per cui il tutto è sempre maggiore della somma delle parti che lo compongono).
L’avversione all’egualitarismo si accompagna dichiaratamente, in lui,
all’accettazione del dialogo interculturale, e vederlo come l’estensore di
"una Dichiarazione dei diritti della natura" contrapposti ai diritti
dell’Uomo, all’interno di una visione del mondo nella quale "natura e
storia sono dimensione opposte, ed è la prima a dare scacco alla seconda"
significa operare una forzatura.
Anche da
questo punto di vista, inserire a forza Alain de Benoist nella tradizione culturale della destra significa
misconoscerne l’originalità. Che questo sia l’obiettivo di fondo del libro di Germinario appare, finalmente, evidente quando egli scrive
che "il differenzialismo debenoistiano
non è solo significativo perché ha aggiornato lo statuto teorico di un razzismo
screditato e indifendibile, dopo il 1945, davanti alla memoria collettiva"
(come si vede, l’accusa di criptonazismo congedata
dalla porta viene fatta rientrare, con tutti gli onori, dalla finestra), ma
anche perché "dalla contrapposizione fra monoteismo giudaico-cristiano,
universalismo, totalitarismo, sinistra da un lato, e politeismo, differenzialismo, destra dall’altro, de Benoist
conclude a un giudizio di perversa innaturalità
dell’universalismo e quindi della sinistra". Questo giudizio sull’innaturalità della sinistra non risulta, a nostra
conoscenza, da alcuna delle molte migliaia di pagine vergate dal teorico della
Nouvelle droite. Germinario
però lo legge in filigrana, lo decodifica, lo profetizza ricomponendo,
nella sua mente di militante della Giusta Causa, tasselli sparsi e non
collimanti. Sarebbe interessante sapere se lo fa senza rendersi conto di
regalare così un’icona, un autore di culto, un’immaginetta
beatificante alle destre reali, e soprattutto agli ambienti giovanili
neofascisti alla disperata ricerca di una cultura già pronta in scatola di
montaggio che li assolva dai sospetti di impresentabili nostalgie senza farli
passare per la fatica dell’autocritica, o se lo fa invece proprio perché vuole
ottenere questo risultato, dando in pasto le idee della Nuova Destra all’ultima
progenie di una destra stravecchia pur di non rischiare di lasciarle entrare in
sinergia con i ben più promettenti e vivaci ambienti di una sinistra non
liberale, preda di una sempre più lacerante crisi di identità e strategie.
Lasciando
planare senza faziosità il dubbio su questa intenzione, non possiamo esimerci
dal constatare come Germinario sbagli quando legge
nel differenzialismo un desiderio di emanciparsi
dalla politica o di metterla fuori gioco, ripetendo l’errore commesso nel
ridurre l’intuizione contenuta nel cosiddetto "gramscismo
di destra" ad una riedizione dell’apolitìa
evoliana. Tutte le riflessioni recenti di de Benoist testimoniano, all’opposto, la volontà di rimettere
la politica al centro della vita collettiva, in un’epoca in cui essa ne è stata
evacuata dal predominio combinato dell’economia e dell’etica (ma sarebbe meglio
dire del moralismo). E anche se nella rivendicazione del realismo e della
concretezza la sua visione della politica si apparenta a quella di altre
destre, addebitargli la convinzione che "natura e storia sono dimensioni
opposte, ed è la prima a dare scacco alla seconda" – accostandolo, per
l’ennesima volta, al nazionalsocialismo – vuol dire travisarne l’opera. È
esagerato dire che il suo pensiero assume il rousseauismo
come idolo polemico; se così fosse, perché mai un filosofo impegnato a
prendersela con "l’ombra malefica di Rousseau,
ritenuto il padre di tutte le rivoluzioni e sovversioni moderne" avrebbe
scritto, e per giunta in "Études et Recherches", la
rivista di formazione interna del Grece, officina
culturale della Nouvelle Droite, un articolo
intitolato Relire Rousseau,
in cui si mette in guardia dalle interpretazioni deformanti che gli esegeti di
destra hanno fornito del pensatore ginevrino e si
invita a riconsiderarne l’opera senza prevenzioni?
La cosa
è strana, si converrà. Peccato che nel libro di Germinario
di questo saggio, come di molti altri testi debenoistiani
"eretici" o collidenti rispetto al pensiero di destra, non si trovi
neppure l’ombra di una traccia o di un riferimento. Prenderli in
considerazione, analizzarli e discuterne gli elementi di originalità avrebbe
messo a dura prova l’impalcatura granitica e squadrata attorno a cui è stato
costruito La destra degli dei.
La cui lettura si risolve così, malgrado gli innegabili sforzi di erudizione
dell’autore, in un esercizio scarsamente utile alla conoscenza di un pensiero
critico e anticonformista che oggi, piaccia o non piaccia ai manichei, ha molto
più da dire alla sinistra postmarxista tuttora in
crisi che alle destre gonfie di fragili e molto soggettive certezze.
“Diorama letterario”, giugno-luglio 2002