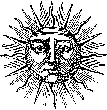
Eric
Stark
Wat
vuota il sacco
Alexander Wat IL MIO
SECOLO. Sellerio, 2013
“Io sostengo sempre in modo assoluto
che l'unica perfetta e pura realizzazione del marxismo e del comunismo sia
stato lo stalinismo, e in particolare lo stalinismo degli anni dal 1937 al 1941
col suo magnifico terrore”; ed ancora: ”Non in Russia, ma nella Polonia
Popolare e in paesi come la Francia e l'Italia, c'è una sorta di corrente di
dandismo -direi quasi baudelairiano- congiunto con un portamento ascetico e con
la provocazione come scelta: io scelgo Satana, perché è bello e provoca e
irrita i filistei; è inflessibile, crudele e fa paura ai profani”. Le due
citazioni, distillate dall'esperienza dolorosa dello scrittore polacco Wat
(1900-1967) estratte e messe in forma dalla sbobinatura delle lunghe
conversazioni con l'amico C. Milosz (prima in California e poi a Parigi) nel
momento in cui appaiono volte in italiano hanno perso parecchio in qualità
rivelativa o urticante. L'ovvio confronto con il capolavoro del connazionale Herling, senza
dover tirare in ballo le relazioni dal gulag russo-sovietiche, è per molti
aspetti improponibile e d'altra parte Wat non conobbe, tecnicamente, i campi di
Stalin, ma ne percorse per così dire le stazioni periferiche in quanto mai
giudicato e formalmente condannato. Il suo mondo a parte, sfocato ed intuito, se perde in
geometrico rigore guadagna, per la viva e digressiva voce di Wat, in pullulare
di umanità sbandata, raffigurando, lontano da un centro organizzatore,
province formicolanti di fantasmi anche
quando questi si chiamino Šklovskij o Zoščenko, opprimenti e soffocanti
anche nei mesi sottratti al contrappunto burocratico delle celle staliniste
(Leopoli, Kiev o Mosca ed infine Alma Ata).
Al tempo di questa rievocazione, gli
anni sessanta della sofferta maturità, l'incomprensione con il sistema
letterario polacco dei giovani critici marxisti e l'esilio di Wat erano
conclamati ed alle sue spalle stava pure il soggiorno a Genova Nervi, quando
aveva collaborato con l'editore genovese Silva,
occupandosi particolarmente della collana di slavistica. (Nel libro c'è
una foto del notevole terzetto Wat, Milosz e Herling in Riviera).
Personalmente abbiamo apprezzato, si
sarà intuito, il ricordo degli anni polacchi più che la rievocazione
dell'esperienza carceraria (dal 1939) culminata nelle deportazioni e nel
genocidio di intere popolazioni, sotto la pressione dell'avanzata nazista e
della geopolitica staliniana. Il tomo è
massiccio nonostante, per anticipata morte dell'autore, si soffermi soprattutto
sullo sgradevole soggiorno in terra di soviet e pur dopo l'editing dello stesso
Milosz e i tagli aggiuntivi del
traduttore: molte le ripetizioni nell'andirivieni dell'affabulazione, ma valga
come giustificazione che occasione scatenante fu non solo l'intento di fornire un
meditato punto prospettico sui destini polacchi nel novecento. Origine
conclamata furono il trauma di un espatriato e il tentativo quasi impossibile
di alleviare il senso di spaesamento e distacco di Wat all'epoca di un
soggiorno americano che avrebbe dovuto sancirne la fedeltà ai valori
occidentali. Queste memorie, più che rapporto dall'interno del comunismo
polacco, importano i due dialoganti come terapia, votata ahimé allo smacco, e
dunque il lettore comune rischia di perdersi, se non di annoiarsi, tra le
minuzie ripetitive delle spesso strazianti disavventure dell'autore di Lucifero
disoccupato.
Simile a tanti, Wat, ebreo per nulla
osservante, si lasciò abbracciare, dopo i giovanili esordi di un velleitario
marinettismo (durante i quali attrasse l'attenzione del Majakovskj in
tournée) e l'influenza del geniale Witkiewicz, imitato ed
ineguagliato compagno di bevute, da un comunismo poi abbandonato come si lascia
indietro un punto alto generoso e disinteressato. Solo dopo l'incarcerazione
(in quanto polacco e tiepido comunista) e gli anni di sfollato esilio, di volta
in volta alleato o traditore secondo la paranoia staliniana, gli venne chiaro
come a spingerlo verso il comunismo fosse stata
non tanto l'adesione ad una fede, quanto l'impossibilità di vivere fino
alle estreme conseguenze uno scetticismo assoluto. Per il Wat sessantenne in
dialogo con Milosz, a fronte di un
ideale comunista creatore di una setta di fratellanza, di una “delinquenza
settaria”, stava un semplice incontrovertibile fatto: del primo gruppo
letterario di otto persone di cui fece parte, formatosi sul finire degli anni
venti intorno al Mensile letterario, cinque morirono in Russia; al
momento di questi ricordi, lui, unico sopravvissuto, bollato come rinnegato dai
compatrioti più o meno sovietizzati; non solo, convertito segretamente ad un
cristianesimo dubbioso che comunque lo tenne lontano dalle espressioni della
fede popolare, nella ritrovata patria
prima, in Italia poi, dove ebbe un traumatico e deludente incontro con l'iroso
Padre Pio.
Traendo le somme da quelle esperienze,
la sua giovanile adesione ad un generico
comunismo viene ripensata, in queste pagine, a partire da un socialismo
persistente e diffuso anche in ambiente ebraico, mentre il progetto comunista risulta equivocato,
dagli intellettuali del suo tempo, come sbocco salutare e salvifico di un
iniziale nichilismo e teppismo intellettuale che tutto metteva in discussione.
In tal senso l'umanista Wat assimila nel ricordo la sua fascinazione per il
comunismo alle traiettorie tipiche di un Brecht o Aragon, ma con
l'imprigionamento in più a segnarne il risveglio, il limite della caduta,
toccato il quale, l'uomo può rialzarsi sulle proprie gambe, uscendo
dall'equivoco. “Fogli di Via”, marzo-luglio 2014