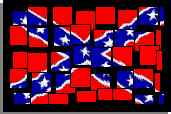le voci che corrono
spade e magnolie
> Raimondo Luraghi, “La spada e le magnolie. Il Sud nella storia degli Stati Uniti”,
Donzelli 2007
Luigi Licchelli
La terza american way
Stato della Pennsylvania, Guerra civile, culmine dell’avanzata delle truppe sudiste
del generale Lee in territorio nemico poco prima dell’epico scontro di
Gettysburg: “Si narra dunque che presso un bivacco due soldati confederati
stavano chiacchierando: ‘Che cosa pensi che faremo della città di Washington
quando l’avremo presa?’chiedeva l’uno. Risposta: ‘Questa tua domanda mi ricorda
il caso di un mio amico nero il quale possedeva un cane che aveva la brutta
abitudine di correre dietro ai treni. Io gli chiesi se non avesse paura una
volta o l’altra, di perdere il cane. Lui mi rispose che il vero problema che lo
preoccupava era che cosa avrebbe fatto il cane del treno una volta che fosse
riuscito a prenderlo’”. Ecco condensato in questa battuta il “dry humor”, il
crudo e realistico senso dell’umorismo proprio della gente del sud degli Stati
Uniti che in qualche modo racchiude l’essenza di quella terra e della sua
filosofia di vita. Filosofia che ha aiutato le sue popolazioni ad affrontare le
numerose catastrofi che hanno costellato (e costellano) la sua a volte tragica,
ma sempre vitale, storia: dalla sconfitta nella Guerra civile – passando per la
grande musica, dal jazz al blues, e la sua formidabile letteratura, da Twain a
Faulkner alla O’ Connor – fino all’uragano Katrina che ha devastato New Orleans
due anni fa. La storia di queste terre del sud, di quest’altra America un po’
scugnizza, una sorta di Terza America così diversa dalle più vicine al nostro
immaginario – quella delle grandi metropoli come New York e Los Angeles come
quella del vecchio West, rappresentate da una vasta cinematografia – con le sue
particolarità, tradizioni e contraddizioni adesso è tutta nel bel libro di
Raimondo Luraghi “La spada e le magnolie. Il sud nella storia degli Stati
Uniti” edito da Donzelli (pp 232, euro 29).
Parte da lontano l’epopea di questi luoghi almeno da quando lo spagnolo Lucas Vasquez de Ayllon nel luglio del 1526 partì dall’Europa con sei navi al seguito e fondò la prima colonia in quella che sarà la Carolina meridionale, portando con sé alcuni schiavi africani. Così giunsero, in catene, i primi uomini neri: il principio della “peculiare istituzione”, la schiavitù. Da qui l’avvio di quella mescolanza di razze che avrebbe così tanto cambiato i destini e la cultura dei suoi abitanti, bianchi e neri. Spiegò, con un filo d’ironia, Marshall Frady, un giornalista molto attivo al tempo della lotta per i diritti civili: “E’ stato il nero che, in verità, ha fatto il bianco del sud così diverso dai bianchi del resto del paese. Noi siamo molto più vicini a loro (i neri), dannazione, di quanto non lo siamo della gente bianca di lassù, di New York o Minneapolis. Noi abbiamo lo stesso modo di vivere in scioltezza, lo stesso tipo di umorismo, lo stesso godimento nel cibo… All’inferno abbiamo anche preso da loro la parlata. Siamo solo un po’ più pallidi in tutte queste cose”.
D’altra parte la dura vita nelle piantagioni non consentiva certo i lussi della privacy e la promiscuità – nel lavoro, nel mangiare e nel riposo – era spesso la regola. E proprio tale promiscuità rendeva impossibile la segregazione, mentre i proprietari accanto alla pretesa di cieca obbedienza avvertivano spesso – al contrario di quanto comunemente si pensi – il dovere di protezione e assistenza verso i propri schiavi. Curioso l’episodio raccontato da Luraghi – autore di una famosa “Storia della Guerra civile americana” – della lettera inviata a suo tempo a un giornale da un grande piantatore: l’uomo manifestava la sua grande indignazione emersa quando, durante un viaggio attraverso il nord a bordo di un treno con tutta la sua “famiglia”, camerieri e nutrici (ovviamente schiavi neri) compresi, gli fu intimato da parte del controllore di far viaggiare i “negri” nel carro bestiame invece che nella carrozza da lui prenotata. La maggior parte dei proprietari, spiega Luraghi, erano infatti paradossalmente “buoni” con i loro schiavi – cioè “buoni” con i propri interessi – ma proprio con questa interessata “bontà” cingevano più strette le catene, attenuando la voglia di ribellione dei neri. Piuttosto fu al nord che nacque la prima vera forma di segregazione de facto (e in taluni casi anche de iure).
Il ghetto nacque al nord: al sud bianchi e neri abitavano sempre, e per lo più abitano tuttora, gli stessi quartieri condividendo tutto, a volte anche la miseria. Il fatto era che la schiavitù, scrive Luraghi, “era così intrinseca alla vita stessa del sud che pur costituendo la base su cui tale società, la sua cultura, la sua civiltà stessa poterono sorgere, ne costituì anche la ‘pietra da mulino’ che l’avrebbe trascinata a fondo”. E lo scontro della Guerra civile drammaticamente lo testimonierà, anche se la “peculiare istituzione” ne rappresenterà soltanto l’inevitabile matrice ideologica. Eppure il sud all’inizio della storia americana fu al vertice delle istituzioni politiche e militari esprimendone le classi dirigenti e guidando le colonie all’indipendenza. Dei primi cinque presidenti statunitensi quattro furono sudisti, e tra questi il padre della patria George Washington, a sua volta grande proprietario di schiavi. Del valore dei sudisti in battaglia furono testimoni molti degli stessi ufficiali nordisti, tra cui il generale William T. Sherman: “La guerra è il loro ambiente… Essi sono splendidi cavalieri, tiratori di prim’ordine e del tutto sprezzanti del pericolo”. Ma questo era anche il riflesso di una società incline alla violenza con l’utilizzo di antiche usanze cavalleresche come il duello per ristabilire l’onore offeso. D’altra parte cominciò ad emergere quel contrasto che si rivelerà poi insanabile con la borghesia industriale del nord: tra l’etica cattolica e quella protestante, tra due sistemi produttivi radicalmente diversi, tra la ricerca del piacere e del lusso e quello che appariva il gretto e avaro mondo del capitalismo. Contrasto che si notava anche nella diversa conformazione delle città: “Nel sud il centro della produzione rimanevano le campagne. Le città erano unicamente il luogo ove si spendeva il reddito agrario (…). Così esse nell’intero Mezzogiorno, a differenza delle grandi, formidabili, fumose città industriali, rimanevano di modeste dimensioni; ma dato il loro carattere e le loro funzioni spirava da esse tutta la grazia, l’eleganza, l’atmosfera rilassata e anche gaudente del sud”. Per dire: lo straniero cui capitava di viaggiare per il nord poteva essere apostrofato: “Perdoni signore che cosa viene a fare qui?”, mentre se era in viaggio verso il sud veniva sovente invitato: “Si segga forestiero, che cosa posso offrirle?”.
Sono terre di profonde contraddizioni quelle della Terza America, abitate da “un popolo mitico, creato per metà dal sogno e per metà dalla calunnia, che vive in una terra ancora da leggenda”, raccontava lo scrittore Jonathan Daniels. Terre romantiche e crudeli, quindi, dove convivevano eruditi gentiluomini come il filologo Basil Lanneau Gildersleeve e feroci pirati come Jean Laffitte, contrabbandiere di merci e di uomini, che nella New Orleans dei primi dell’Ottocento, nascosto tra i bayou, i corsi d’acqua semistagnanti disseminati attorno alla città, assaltava navi nemiche durante il conflitto del 1812 con l’Inghilterra, non disdegnando però di attaccare anche quelle americane. L’attrito latente tra i due mondi andò avanti e si trasferì sul piano dei destini dei nuovi stati dell’ovest le cui terre i “freesoiler” volevano riservate soltanto ai “bianchi liberi”, escludendo la schiavitù. Fu così che in seguito alla dichiarazione di secessione della Carolina meridionale gli eventi precipitarono e fu la guerra. Prevalsero in quel momento, secondo Luraghi, i sentimenti più irrazionali, la volontà di riscattare il proprio onore combattendo. Emerse insomma la tradizione cavalleresca dei meridionali che consideravano il nord “una nazione di bottegai incapaci di battersi”. Mai valutazione fu tanto sciagurata. Al motto di “Free soil, free labor, free man” i nordisti si compattarono e al di sotto della Mason e Dixon – la linea tracciata a fine Settecento, che per convenzione separava il nord dal sud – scese la notte. Il “rebel yell”, fiero grido di battaglia dei sudisti, non basterà sui campi di battaglia di Gettysburg contro la potenza della guerra industriale. E così i “Lee’s miserables”, come autoironicamente si definiranno alcuni soldati confederati parafrasando Victor Hugo, capitoleranno.
La memoria storica delle ferite della sconfitta coverà a lungo negli animi della gente del sud. Di qui il risentimento e l’insofferenza verso quel nord che voleva imporre non solo il suo mercato ma anche la sua morale. E le radici di un malessere che si esprimeva a volte nelle forme più terribili – come con il Ku Klux Klan, sorto nel Tennessee – e che tuttora spesso si manifesta nella diffidenza e nella sfiducia verso il potere centrale federale. Terra nobile e orgogliosa, ma anche povera. E da questa povertà la “Terza America” ha tratto anche una sua singolare ricchezza e diversità, dalla concezione dei rapporti sociali fino alla vita quotidiana. Per esempio, con la sua curiosa cucina, che ha subìto contaminazioni di ogni tipo: africane, indiane, francesi, spagnole, britanniche e irlandesi. Come per il gumbo, dalla lingua bantu “ngombo”, piatto principale della Louisiana, composto da un misto di pesce e carne accompagnato da riso e salsa di verdure quali okra, peperoni e pomodori. Tipico piatto del profondo sud è poi anche la redeye gravy, una salsa scura dal forte sapore che si ottiene versando del caffè nel grasso che resta in fondo alla pentola dopo la cottura del maiale, con l’aggiunta a volte anche di latte caldo – difficile immaginare che possa suscitare entusiasmo altrove. Per non parlare di un classico come la barbecue, carne spezzettata cotta a fuoco lento nella omonima salsa. Mentre la bevanda nazionale del Mezzogiorno americano è il mint julep che secondo alcune cronache dell’Ottocento sembra avere origine in Virginia: in realtà è molto simile al mojito, però rigorosamente a base di bourbon, il whisky del sud.
Ma la “Terza America” è terra anche di grande letteratura. Se nell’Ottocento ha avvertito per lo più l’influsso del “romantico” Edgar Allan Poe – di origini bostoniane ma direttore del Southern Literary Messenger, la più importante rivista letteraria del sud – e di Mark Twain, nel corso del Novecento ha invece dato vita a un genere letterario del tutto particolare. Questioni di luce, magari, di storia, forse anche di quello strano caldo umido tipico di quelle zone. Così i personaggi che popolano i romanzi e i racconti di Flannery O’Connor come quelli di William Faulkner e di Carson McCullers, sono sempre al limite tra il surreale e la crudeltà, tra il genio e la follia. Luoghi da cui gli autori non si staccano quasi mai, luoghi dove sempre ritornano. Senza rimpiangere apparentemente nulla e nessuno. Niente nostalgia, come nel caso della O’Connor con le sue storie, “i suoi profeti vagabondi, i negri, gli alberi, la campagna, il Peccato, la Grazia, la Redenzione” (Piero Citati), un miracolo di quotidiana insopportabilità. O’Connor è forse la scrittrice più efficace di questo strano sud degli Stati Uniti, occhio vigile nella grande casa in Georgia con le osservazioni di ore e ore, interi giorni, di tutta una vita, dei pavoni che vivevano lì intorno, e l’attesa di una morte che sapeva inevitabile. Luogo metaforico della solitudine, il sud. Come lo fu anche per Faulkner, come lo fu per McCullers, che di quei luoghi racconta con precisione linguaggi e tic e sempre quel vagare letterario sulla linea tra la mediocrità e una sorta di illuminazione. E solo in quel sud, in quei luoghi, tutto – dalle cose più facili alle scelte più estreme – può ruotare intorno a un mite orologiaio sordomuto come John Singer, appunto il protagonista di “Il cuore è un cacciatore solitario” della McCullers.
La Terza America ha prodotto la letteratura forse meno convenzionale dell’intero continente, passata pure per un cult come “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee, dove l’avvocato Atticus Finch cerca inutilmente di difendere un nero ingiustamente accusato di violenza carnale, o per un altro “classico” come “Il colore viola”, con il lungo dolore delle due sorelle Celie e Nettie, separate e violentate e offese, “e poi, a pensarci bene, il mio Dio non mi sembra un granché. Ma è tutto quello che ho”, che forse classico lo è diventato grazie al film di Spielberg. E ancora questo Mezzogiorno a stelle e strisce come terra di musica e di grandi musicisti, soprattutto del blues e del jazz di cui il sud è stato notoriamente la culla: Luis Armstrong nacque a New Orleans mentre “Duke” Ellington nacque sì a Washington, ma da genitori originari della Carolina del nord. Musiche e canzoni che spesso riflettevano tragedie. Come nella struggente “Strange Fruit” di Billie Holiday, che nell’America a cavallo degli anni Trenta e Quaranta fece scalpore per la chiara denuncia sociale dei linciaggi razziali, e che commuoveva la sua interprete al punto da farla piangere dopo ogni esibizione: “Gli alberi del sud producono uno strano frutto/ Sangue sulle foglie/ Sangue sulle radici/ Corpi neri ondeggiano nella brezza del sud/ Uno strano frutto che pende dai pioppi/ Scena pastorale del nobile sud/ Gli occhi sbarrati e la bocca contorta/ Dolce e fresco profumo di magnolia (…)”. Il Novecento vedrà a lungo la sopravvivenza della segregazione, ma anche il ritorno con Wilson di un presidente del sud alla Casa Bianca dopo mezzo secolo, e gli anni Sessanta con le speranze di convivenza e integrazione nate grazie a Martin Luther King e per alcuni aspetti morte con lui. Fino ad oggi, fino alla furia dell’uragano Katrina. “Ma se il sud (…)” – spiega Luraghi –, pressato dalla formidabile forza economica e sociale del nord, “ha appreso una grande lezione dalla sua tragica storia è quella di sapersi adattare rimanendo sempre se stesso”. Così la Terza America nobile e povera, orgogliosa e combattiva, tra le sue contraddizioni continua testarda a correre dietro ai veloci e possenti treni del nord, come il cane di quel tale nero. E chissà che un giorno non li prenda davvero.
“il foglio”, 12 gennaio 2008
§
Da “La settimana in libri”, a cura di
Angelo Costa
“Torinese d’elezione” (i suoi genitori si erano trasferiti nel capoluogo piemontese quando era ragazzo), come si legge in un sito che parla di lui, Raimondo Luraghi, giornalista, professore universitario, storico, Medaglia d’argento al valor militare, fu da giovanissimo, redattore dell’edizione piemontese dell’Unità, poi ordinario di storia americana all’Università di Genova, ove è attualmente professore emerito. Luraghi si dedicò alla storia dell’America e, in particolare, a quella del conflitto armato tra Nord e Sud. Questo lo portò a numerosi viaggi di ricerca in archivi americani e ad insegnare come “Visiting Professor” in diverse Università degli Stati Uniti e del Canada, da Harvard alla University of Richmond (Virginia), a Notre Dame (Indiana), alla New York University, alla University of Georgia, a quella canadese di Toronto. La sua opera più nota è Storia della Guerra civile americana,1861-1865, quindi Cinque Lezioni sulla guerra civile americana. Nel 1999 fu insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d’oro per benemerenze della cultura e della scienza. In questo libro Luraghi esamina il ruolo degli stati del Sud e dell’identità sudista nella storia degli Stati Uniti d’America.
Concordo con Gorlier, che ha recentemente recensito questo libro, che il filo rosso del libro è costituito dal destino perdente degli stati del Sud. Luraghi, infatti, sottolinea la sconfitta dell’economia agraria basata sull’uso degli schiavi, contrapposta a quella finanziaria e industriale del Nord. Neppure il cosiddetto «Rinascimento del Sud», nella prima metà del XX secolo, impedì un’altra sconfitta della mentalità sudista: la fine della segregazione razziale in America durante gli anni cinquanta e sessanta. In questa opera, che è il coronamento di oltre quarant’anni di studi, uno dei nostri massimi americanisti, autore della fondamentale Storia della Guerra civile americana, ricostruisce in maniera esemplare le peculiarità che hanno fatto del Sud una «nazione nella nazione»: dai primi insediamenti dei coloni alle missioni cattoliche, dallo schiavismo al separatismo, alla effimera stagione della «nazione sudista», e via via lungo il difficile cammino della «ricostruzione». «Il lungo viaggio attraverso la notte», come Luraghi intitola il suo sesto capitolo, fu durissimo nei decenni della cosiddetta Ricostruzione. Ma con l’inizio del ‘900 e la presidenza di Theodore Roosevelt, si realizzò il «ritorno», tanto che il suo avvento nel 1913 fu un vero trionfo, nel senso che elettorato e politici meridionali avevano sostenuto una parte decisiva.
La catastrofe che nel 2005 ha travolto New Orleans, come si legge nella presentazione dell’editore, ha avuto l’effetto di porre drammaticamente all’attenzione un problema che si riteneva risolto: quello del Sud degli Stati Uniti. È emerso che il Sud ha ancora ampie sacche di povertà, sia tra i neri sia tra i bianchi; che in esso predomina tuttora un senso di rassegnazione del tutto estraneo allo spirito di iniziativa che caratterizza il resto del paese; che nel Sud vige ancora una profonda diffidenza nei confronti del governo dell’Unione, spesso con esiti di localismo esasperato; che, insomma, il Sud è e rimane per molti versi una specie di corpo estraneo a tutto ciò che fuori dall’America comunemente si considera americano. “Da tempo – scrive l’autore - serpeggiava fra gli elementi più miserabili del Sud un razzismo più o meno latente. E un fatto apparentemente paradossale della storia sudista che le aspirazioni popolari e democratiche tra i bianchi di più bassa estrazione andassero di pari passo con la tendenza a rivendicare una maggiore discriminazione razziale; dopo l’emancipazione degli schiavi, sempre più i bianchi poveri si erano trovati a competere con i neri per i posti di lavoro ricompensati con bassi salari (e di ciò la propaganda razzista gettava, falsamente, la responsabilità sulle spalle dei neri la cui concorrenza avrebbe consentito di ridurre le mercedi). La massa dei bianchi poveri (e dopo la guerra civile erano la stragrande maggioranza della popolazione ditale etnia) viveva nel terrore di essere spinta all’ultimo gradino della scala sociale e quindi aspirava a cacciare i neri ancora più in basso e a rivendicare privilegi democratici per sé, negandoli a questi ultimi”. (p. 125) Luraghi giustamente nota che gli africano-americani stavano peggio nei ghetti del Nord e dell’Ovest che nello stesso mezzogiorno. Fu il presidente Eisenhower, repubblicano, a decretare la fine della segregazione, ma decisivi risultarono i democratici del Sud nell’elezione di John Fitzgerald Kennedy, e sudista era Martin Luther King, che si vantava di avere il tipico accento meridionale, il «Southern Drawl». Lauraghi in queste pagine risponde ad alcune domande fondamentali: che cosa è stato ed è il Sud nella storia degli Stati Uniti? Quale ne è stata la caratteristica dominante? La presenza della schiavitù? La predominanza dell’economia agraria e l’ostilità verso l’industrialismo? L’atmosfera culturale romantica, in contrasto con il pragmatismo dominante nel resto del paese? La naturale ospitalità della sua gente? O tutto questo insieme? “Perché – scrive Lauraghi - nel Sud degli Stati Uniti le insurrezioni di schiavi rimasero un fenomeno del tutto sporadico e marginale? Secondo i maggiori studiosi del problema ciò avvenne per la capacità della classe dirigente sudista di esercitare quella che Antonio Gramsci chiamò la sua egemonia, vale a dire l’arte di governare conquistandosi fino a un certo punto il consenso delle classi soggette; e ciò fu realizzato mediante il paternalismo esercitato su larga scala e non senza generosità, mescolato con una «giusta misura» di repressione. Ciò non significa che non vi fossero nella massa degli schiavi fenomeni diffusi di resistenza all’oppressione; la prima e principale era quella che i bianchi chiamavano furto; ma che per gli schiavi era appropriazione pura e semplice di beni che, facendo parte della piantagione, erano a disposizione dell’intera comunità; era cioè proprio quella ideologia della «grande famiglia», della «vita comune» su cui molto si basava l’egemonia stessa dei proprietari, la qua le aveva fin troppo penetrato la mentalità dello schiavo il quale ne aveva dedotto una sua peculiare nozione di moralità. Una grande proprietaria di piantagione paragonò (giustificandole) tali appropriazioni a quelle degli israeliti a danno dei padroni egizi”. (p. 38) Ed ancora: “La schiavitù dette al Sud uno specifico modo di vita perché formò la base di un ordine sociale in cui il lavoro schiavistico ne dominò - e praticamente escluse - ogni altro tipo. Su tale base si fondò l’autorità di una potente e notevole classe sociale, la quale, pur costituendo soltanto una minima parte della popolazione bianca, riuscì con rimarchevole successo a edificare un tipo particolare di civiltà che, fino ad un certo punto, fu la ripresa di una sostanzialmente arcaica. E’ fuori discussione che il carattere agrario della civiltà sudista influì enormemente sulla sua cultura, i suoi valori sociali, l’intera vita della sua comunità: ma quello che sembra per lo più difficile da intendere - ma che bisogna intendere, se si vuoi capire la realtà intrinseca del Sud - è che esso fu vincolato al suo carattere agrario (arretrato) praticamente senza possibilità di progresso o di trasformazione proprio dai sorgere e dallo svilupparsi della schiavitù”. (p. 41) La vera storia, per molti aspetti mai raccontata, del Sud degli Stati Uniti: un libro che sarà un classico.
http://www.tocqueville-acton.org/ , 6 gennaio 2008
§
Seba Pezzani
Da Lincoln a Faulkner, il
Sud che ha fatto storia
Di libri sulla storia americana e, in particolare, sulle travagliate vicende
del Sud ne sono stati scritti parecchi. Non capita, però, tutti i giorni
d’imbattersi in un saggio sul ruolo esercitato dal Sud nella storia
statunitense che sia al tempo stesso serio e adatto a un pubblico non
accademico. Se poi il saggio in questione è stato scritto da un italiano e, per
giunta, da un comandante partigiano, i motivi di interesse crescono.
Raimondo Luraghi dopo la guerra, si dedicò anima e corpo allo studio della
storia degli Stati Uniti, di cui divenne ordinario. La Spada e le Magnolie - Il
Sud nella storia degli Stati Uniti (Donzelli Editore, pagg. 227, euro 29) è
scritto con la passione di un ragazzino e la profonda conoscenza di chi in
America ci è stato molte volte, finendo per ricevere prestigiosi riconoscimenti
e convocazioni da atenei illustri. Alla base di questo saggio c’è un grande
amore per il Sud, troppo spesso bistrattato dalla storia dei vincitori. Senza
negare l’infamia dello schiavismo e della segregazione e senza sminuire il peso
di una certa ingenuità storica del Sud, Luraghi ricostruisce, grazie a ipotesi
talvolta coraggiose, quelle che sono le radici di certi tratti ancor oggi
visibili del vivere sudista. Per un ex-partigiano, ex-redattore dell’edizione
piemontese de L’Unità, dunque uomo di sinistra, non deve essere stato
semplicissimo convivere con certe scelte statunitensi e con un certo
antiamericanismo. «Penso che la guerra in Irak sia stata un grosso errore», ci
dice. «La lotta contro il terrorismo si conduce in altro modo (con il
controterrorismo). Fare una guerra è come sparare un cannone per ammazzare una
mosca. Ciò detto, durante la guerra partigiana abbiamo sempre ammirato
l’America, sia per il suo antifascismo sia per la sua vita democratica. Un vero
antifascista non poteva che essere - e non può che essere - filoamericano». Ha
le idee chiare, Luraghi. Lo si capisce da come analizza le contraddizioni che
da sempre fanno del Sud un mondo a sé, rappresentandone una fastidiosa zavorra
storica ma anche un patrimonio culturale da preservare. C’è tanta storia e
tanto folklore in questo libro. Ci sono il carisma militare del Generale Lee e
la lungimiranza politica del Presidente Lincoln, la grande cultura del Sud, con
personaggi del calibro di Tennessee Williams e William Faulkner, il
paternalismo dei ricchi bianchi del Sud, l’amore per la classicità, la forza
dei sentimenti, una certa ipocrisia del Nord nei confronti della questione
razziale che, tutto sommato, sembrerebbe oggi abbia fatto più passi avanti al
Sud che al Nord. C’è molto di più. Soprattutto, c’è un grande amore per un
grande Paese. «Sono un po’ un homme d’autrefois», dice ancora Luraghi. «Negli
Usa sono stato accolto con grande cordialità: nelle Università americane conta
il livello scientifico, non le n. 91 del 2008-04-16raccomandazioni. Del resto
io ho un figlio che è professore ordinario di materie classiche a Harvard e che
ci si trova benissimo».
“Il giornale”, 16 aprile 2008