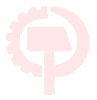
Genesio Tubino
Gramsci jazz
Roberto
Franchini Gramsci e il jazz
(Bibliotheka 2024)
Brividi epilettici scuotevano il corpo elettrico, ma non era
precisamente l’avverarsi di una profezia futurista. Secondo Arnaldo Fraccaroli
il garbo e la discrezione dei latini doveva ridurre alla ragionevolezza le
furie e mattane del jazz afroamericano: “il jazz è un problema sociale… si è
impadronito del mondo” (Il Corriere della Sera, dicembre 1928). Per niente
accomodanti e bellicosamente ostili a mediazioni, le camicie nere torinesi
preferivano manganellare chi, come il torinese Renato Germonio, era sorpreso a
suonare anche solo The Sheik of Araby al Valentino. Mentre la
musica che tanto piaceva ai grassi predatori bianchi (M. Gor’kij) non era
immune da sospetti nell’Unione Sovietica, Gramsci affidava le personali
riflessioni sulla questione a pochi accenni (se ne occuparono già Luigi Spina e
Franco Bergoglio) contenuti in lettere ben posteriori alle cronache sulle
pagine dell’Avanti dove il tema era per forza di cose assente, se si
tiene per buono il 1917 come prima data d’incisione di un disco jazz. Il
praghese Franz Werfel stigmatizzava la voglia di godere di masse
arraffa-piaceri appena sfuggite alla strage del primo conflitto mondiale, “una
gioventù degenerata accompagna con il deretano un ritmo di sassofono. Dieci
milioni di morti! Una generazione che si avvia a passo di shimmy verso nuove
catastrofi...” Parlare di jazz equivaleva a parlare di ballo e solo intorno al
1920 Torino conosce lo shimmy (in attesa del 1935 quando vi suonò Armstrong).
Da rari spunti epistolari, del 1927 e ‘28, Franchini parte per valutarne il
peso e il ruolo, intuibile per lampeggiamenti e cenni sfuggenti, all’interno
della più generale teoria gramsciana sulla cultura popolare. L’inciso in cui
Gramsci confida che, nella detenzione, non si fa sfuggire nemmeno i libri di
bassa qualità, va interpretato nel contesto del suo generale interesse per la
cultura popolare ed il consumo di massa. E per quanto mediato da letture, non
dalla vituperata radio e tantomeno dai dischi, il rapido confronto col jazz
(non c’è all’orizzonte nessuna possibilità di leggere in chiave nazionale
popolare il jazz come corrispettivo “negro-americano” del nostro melodramma) si
rivelò cruciale per ridefinire il posto della modernità, cioè
dell’americanismo, nel primo dopoguerra europeo. La questione jazz risaltava
sullo sfondo di un dibattito, cui non sono aliene sfumature scherzose, sul
carattere identitario dell’Europa bianca e cristiana, già lavorata ai fianchi
da una penetrazione d’ideologia asiatica (Tagore e Gandhi, mediato da Tolstoj,
in primis). Gramsci sospettava a ragione che il maggior candidato all’egemonia
in Francia (al tempo punta avanzata della penetrazione americana) e i più
pericolosi antagonisti della residua cultura di destra, monarchica e cattolica
sarebbero stati il modello statunitense,
la massificazione, la semplificazione. Di più: con la sua primitiva
elementarietà, facilmente assimilabile e, grazie al ballo, allargabile per
automatismo a tutto il mondo psichico, il jazz era “una molecola di una civiltà
eurafricana” (lettera a G. Berti). Altro che surrealismo, Parigi era “una mezza
colonia dell’intellettualismo senegalese”, quel jazz un pericoloso attacco
all’omogeneità della civiltà occidentale, più letale dell’innesto di uno
spiritualismo asiatico sul ceppo della razionalità cristiana. Il fordismo
musicale portato dalle band afroamericane dettava il nuovo corso dell’ascolto
distratto, forte del calo d’attenzione richiesto dalla civiltà meccanica a
stelle e strisce, evasiva o irrazionale. Questa l’America cui guardava pure
Pavese, pensosa e barbarica, felice e rissosa: disarmante nella sua
insolenza, la chiassosa tattica del jazz si manifestava vincente. Anche Anton
Giulio Bragaglia scriveva di un “incubo negro che ci assilla, più del pericolo
giallo ormai…” (Jazz band) annuncio di future cupe tragedie per
questioni di colore. La nuova sensibilità musicale si modellava al ritmo
brutale e lascivo di una forza barbarica tale, scrisse Alfredo Casella, da
smuovere un cadavere: quello di una senile morente Europa, appunto.