Giuseppe Zuccarino
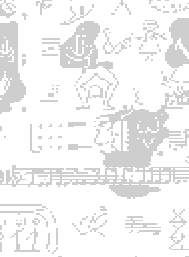 sulle
tracce di Sarastro
sulle
tracce di Sarastro
Partendo dall’idea di
proporre una documentazione relativa al proprio lavoro artistico,
Chi sia press’a poco
coetaneo di Galletta soggiacerà senz’altro alla tentazione di vedere in queste
pagine un ricco e fedele campionario di segni – iconici e verbali – da assumere
nella prospettiva del «come eravamo». E in effetti non c’è dettaglio delle
fotografie presenti nell’Almanacco,
specie di quelle più lontane nel tempo, che non si presti ad essere chiosato in
riferimento ai modi di pensare, di leggere, di vestirsi, di atteggiarsi o di
sognare che, pur con varianti individuali, sono stati propri di un’intera
categoria di giovani, in un momento e in luogo determinati. Tuttavia questo côté quasi sociologico costituisce solo
uno dei motivi di interesse dell’album. È in causa innanzitutto il lavoro di un
artista, sviluppatosi secondo una traiettoria piuttosto particolare. Com’è
stato notato da uno dei critici che l’hanno seguita con attenzione,
Nelle opere, performance o installazioni documentate visivamente nell’album, esistono delle tematiche o dei procedimenti di cui è agevole rilevare la costanza. Consideriamo ad esempio la frequente presenza dell’immagine dell’autore, che non va certo intesa come un’esibizione di tipo narcisistico: da un lato, infatti, essa consente di costruire un personaggio immaginario (che solo casualmente ha i tratti di un individuo reale) e dall’altro di esercitare su questo stesso personaggio, specie in quanto rivesta il ruolo di artista, una sistematica negazione ironica. Se, già per il fatto di essere fotografata, la persona tende a trasformarsi in spettro (lo ricorda Roland Barthes in un passo trascritto da Galletta), nell’Almanacco tale operazione derealizzante ha il suo culmine nell’immagine di copertina, costituita dal ritaglio di una lastra radiografica: ritratto dell’artista come scheletro, dunque.
Poiché si è parlato di
ironia, sarà bene precisare che quella praticata nelle opere gallettiane non si
limita mai a ribaltare o a cambiare di segno ciò che a prima vista viene
sostenuto: l’affermazione (esplicita o implicita) permane, pur essendo
idealmente messa fra virgolette. Ciò vale per i segnali di carattere politico,
frequenti soprattutto nelle opere più antiche: elementi chiaramente connotati,
che vanno dall’impiego di drappi rossi ai richiami ad autori, eventi o
personaggi legati alla tradizione rivoluzionaria, non vengono ingenuamente
fatti propri da Galletta, ma solo «citati», con un’affettuosa evocazione a
distanza. E qualcosa di simile si può dire per un altro tema ricorrente di
questi lavori, ossia la centralità assegnata agli oggetti di uso comune,
assunti sia quali anonimi emblemi della merce sia per le valenze private o
inconsce di cui potrebbero eventualmente essere dotati. Così la vernice
colorata che spesso li riveste svolge la funzione di isolarli dal contesto
originario, e magari di drammatizzarli, smaterializzarli o sacralizzarli:
avremo allora, ad esempio, un tavolo e un coltello tinti di rosso, una
pistola-giocattolo ricoperta d’azzurro o degli occhiali interamente dorati.
Tutto ciò dà luogo a un teatrino allusivo, composto di elementi per la cui
decifrazione non è obbligatorio far ricorso ad esegesi colte: anzi, la
coscienza della dimensione ironica del discorso («un’ironia tendente al
macabro», precisa Sarastro) resta la chiave di lettura più semplice, e nel
contempo meno ingannevole, per comprendere il senso dell’intera operazione.
A chi gli chiedesse che cosa
ha voluto comunicarci ricostruendo davanti a noi un percorso artistico in
apparenza interrotto (l’ultima installazione fotografata risale al 1993),
Galletta potrebbe rispondere alla maniera di Gadda, che in un testo intitolato Come lavoro esordiva dicendo: «Come non
lavoro. Che dà egual frutto, a momenti, nella vicenda oscillante d’uno spirito
fugitivo e aleatorio, chiamato dall’improbabile altrettanto e forse più che dal
probabile». Volendo, di tutto ciò che l’album non esibisce sarà sempre
possibile cercare degli indizi altrove, se è vero che «anche le cose non fatte
lasciano tracce». A Sarastro, cui si deve questo apoftegma, e che ci ha fatto
da guida nella lettura dell’Almanacco
(cosa che gli si addice, visto che il suo nome è quello di un esperto di
iniziazioni, il sacerdote isiaco che compare nel libretto del Flauto magico di Schikaneder e Mozart),
converrà lasciare l’ultima parola. Spetta a lui, infatti, il merito di aver
chiarito perfettamente quale sia la situazione in cui l’artista genovese si
trova adesso, anzi da sempre: «Egli cammina su un filo sospeso e da qualsiasi
parte cada il suo destino è segnato. Di raggiungere un’altra sponda non se ne
parla nemmeno. Troppo lontana. Da questo punto di vista il tempo svolge un
ruolo importante. Ma Galletta non sembra preoccuparsene. Attende il passo falso
con l’agitata tranquillità del pendolare. Osserva i volti dei suoi compagni di
viaggio [i nostri volti, dunque] e si commuove dal divertimento».