Riceviamo da Luigi Corvaglia – autore, fra l’altro, di La sovranità dell’individuo – perché l’America non è anarchica?, Don Juan 2001 – l’ampio
saggio che segue. In qualche modo esso si va ad aggiungere al botta e risposta
fra i nostri Wolf Bruno e C.L. Lagomarsino
pubblicato su queste pagine tempo addietro (vedi il sommario del 2002: Di
un articolo sugli anarco-capitalisti e Risposta a Wolf).
Luigi Corvaglia
ripensare l’anarchia
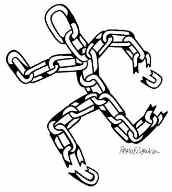
Al buio
tutte le vacche sono nere. In termini di ethos e di pulsione tutti gli
anarchici sono uguali. Negli aspetti meno culturalizzati
– quando cioè l’ethos non è ancora episteme – la
intolleranza per ogni costrizione è il comune denominatore naturale di chi si
definisce libertario. Con ciò intendo quella stessa insofferenza alla
costrizione che già si manifesta nel neonato che si divincola da chi vorrebbe
trattenerne le braccia o le gambe. Una pulsione naturale che la cultura
generalmente mortifica e sottomette. Eppure anche l’adulto che abbia serbato un posto per questo conato
di libertà tanto da farne l’insopprimibile tendenza che guida la sua vita –
quella, insomma, che gli fa dire “sono anarchico!” – questa tendenza l’ha culturalizzata, filtrata, appesantita, sclerotizzata,
in altri termini disinnescata ed inquinata da sovrastrutture di vario tipo.
Ognuno declina una propria versione “educata” di quell’impulso,
educata dalla propria idea (o, peggio, dal proprio autore) di riferimento.
Alla luce
del giorno, insomma, le vacche
presentano un vasto campo di variazioni cromatiche. Un autore marxista, ironizzando e
parafrasando Stirner, disse che gli anarchici sono
talmente “unici” che non se ne trovano due che vanno d’accordo. Emblematico a
tal proposito è il principale dei “colli di bottiglia” in cui ci si imbatte
nelle discussioni fra questa minoritaria sottospecie di adulti che si
supporrebbe relativista e
tollerante. Ogni volta ci si impantana
sullo stesso punto: proprietà si, proprietà no.
Ora, una
contrapposizione ideologica fra posizioni chiare e nette è naturale quando a confrontarsi sono
due “verità”, due “ideologie”, cioè due concezioni infalsificabili,
in pratica due fondamentalismi e non è quello che ci aspetteremmo in un
dibattito “libertario”. Per chiarire questo concetto sento di dovervi
appesantire le borsette scrotali con una (prima)
breve digressione di carattere epistemologico. Karl Popper ha chiarito una volta per tutte
che la conoscenza scientifica non è oggettiva, né sicura né tantomeno
completa. La nostra attuale visione del mondo non è necessariamente “vera”, ma
sicuramente verosimile, la migliore lettura attualmente disponibile. Un tempo
era “vero” che la terra fosse al centro dell’universo, poi non è più stato
vero. Nel passaggio da Tolomeo e Copernico ci siamo
però persi Galileo. L’assolutismo della
fede (e questo vale tanto per quella religiosa, quanto per quella politica o
calcistica) comporta l’infalsificabilità, ovvero la
svalutazione delle evidenze contrarie ai propri dettami di fede. Popper ci ha spiegato che perché una teoria possa essere di
una qualche utilità deve essere fornita di “falsificatori potenziali”, degli
elementi cioè che, una volta smentiti, facciano crollare l’intera costruzione teorica che verrà sostituita da
nuova, “più vera” e sempre falsificabile lettura. Ad esempio, dato il costrutto
“la terra è piatta” la circumnavigazione del globo diviene atto in grado di
invalidare tale costrutto che è pertanto “falsificato”. Non c’è indagine, non
c’è conoscenza, non c’è dibattito se non ci sono, paradossalmente, possibilità
di falsificazione. In tal caso parliamo di fedi. Il costrutto “dio è buono” non
è falsificabile dai disastri naturali (scappatoia: inconoscibilità del piano
divino), il costrutto “ogni bimbo vuole scoparsi la mamma” non è invalidato dal
fatto che nessuno ricordi nulla di simile nella propria infanzia (scappatoia:
rimozione delle pulsioni da parte dell’Io sotto la spinta del Super-Io). Il marxismo, per esempio, è completamente
privo di falsificatori. Lo stato “marxista” non si è estinto (scappatoia:
creazione di un bastione di resistenza contro l’ ”imperialismo fase senile del
capitalismo”. Che furbastro quel Lenin!). E’ autoreferenziale
e risponde solo a se stesso. E’ una fede. Discutere con un religioso è
fruttuoso come piantare zucchine nel deserto del Gobi
perché lui ha ragione e tu sei nel torto. Il libertarismo
dovrebbe allora essere esattamemente il contrario. Se
così fosse come si spiegano certe incomunicabilità con relativo scambio di
ingiurie a difesa del nucleo unico e puro del proprio concetto – unico vero - di libertà? La verità è che anche
le differenti “teorizzazioni anarchiche” corrono il
rischio di strutturarsi in modo da divenire infalsificabili. Ed eccoci nel pieno
della religione libertaria (il “dottrinarismo” di cui
parlava Berneri) che, come tutti i fondamentalismi che si rispettino, si basa su certi dogmi e
certissimi sacramenti. Esaminando quelli che fondano
le diverse sette libertarie, due hanno una funzione importante ai fini di
questo discorso: 1: la proprietà è un
furto (è il fondamento di certi
anarchismi socialisteggianti fra Kropotkin
e Malatesta)
, 2. La proprietà è il fondamento della
libertà ( quasi esclusivo del libertarianism di Rothbard e Friedman). A rafforzare questa dicotomia è la immarcescibile
tendenza a leggere le idee mediante l’utilizzo di concetti manichei quali
“destra” e “sinistra” che è come valutare il
peso di un oggetto con il metro
da sarta perché si tratta di termini spaziali
quando si dovrebbe invece riflettere esclusivamente sulle potenzialità concrete
di incremento della libertà portate dall’una o dall’altra concezione. Tertium non datur? Fu Paolo
(Ranieri) una volta a suggerirmi che quando sembra che non ci siano terze
soluzioni è perché non si è guardato bene. Su questo torneremo. Ora si
esaminino le consequenzialità logiche (nonché le conseguenze pratiche) di
questi opposti teoremi. Per far questo è utile valutarne i corollari:
1. Burattino senza fili
Il socialismo sarà volontario o non sarà affatto.
M. Bakunin
Teorema I: La
proprietà è un furto (premessa principale).
Corollario
I: La
proprietà è un crimine (premessa secondaria).
Se fosse un
sillogismo aristotelico, dalle due preposizioni deriverebbe la conclusione che
la proprietà va “repressa”, come tutti i crimini. Ma qui si parla in termini
libertari, la parola repressione in tale
ambito stona e il sillogismo non regge
per il semplice fatto che è il concetto stesso di crimine ad essere equivoco
nell’ottica anarchica. Io credo che il discorso sulla proprietà vada di pari
passo con quello sulla devianza in generale. E’ deviante qualunque
comportamento così definito dalla cultura dominante di una società in un dato
momento storico e, per godere di tale etichetta, questo comportamento deve
minare i “valori” su cui tale società si fonda. In una società fondata su
valori comunitari ecco quindi il proprietario e lo scambista (nel senso – non
mi si fraintenda - di colui che scambia,
vende, baratta qualcosa con qualcuno) come devianti! La proprietà come atto
anti-sociale, stante una società collettivizzata. L’esperienza storica
ci insegna che la messa al bando della devianza è inutile ed improduttiva
(prostituzione, droga, omicidio, ecc.). Se ne conclude che anche nell’isola non
trovata di tanti sognatori socialisti qualcuno si approprierà di qualcosa e
questi, in combutta con altri, scambierà beni “come se “ fossero suoi. Che
quadro si configura a questo punto? Un paradosso. La cospirazione dello scambio
contro il volere comune! A me il volere comune
fa sempre una certa impressione mentre i cospiratori godono in
genere della mia simpatia. Ma in questo caso? Ecco l’impasse!
Urge a questo punto – almeno a me urge – un’ulteriore incursione nell’ambito
della filosofia della conoscenza. Questo per chiarire come accada che si
strutturino teorie infalsificabili e non ci si avveda
di simili incoerenze ed impasse. Qui mi scappa Lakatos, filosofo della scienza,
il quale, rigettando un’interpretazione dialettica dell’evoluzione e della
storia – quella cioè di Kuhn – modellata sul
materialismo dialettico marxiano (quello di tesi, antitesi e sintesi),
evidenzia come il sapere, la conoscenza non aumenti e non si affini in modo
fluido ma per rotture epistemologiche. Una teoria ci serve a capire ed
interpretare il mondo. Ognuno ha una
teoria del mondo e di sé. Lakatos definisce “nucleo
metafisico” quella parte della teoria
che si deve considerare non confutabile, cioè gli assiomi di base (ad esempio,
“la proprietà è un furto”). A difesa dell’assioma centrale si ergono le ipotesi
ausiliarie che costituiscono la “cintura protettiva”. Queste hanno la funzione
di impedire la falsificazione del nucleo e mantenere un senso di coerenza
interna. Si definisce “euristica positiva” il processo di arricchimento di
ipotesi e letture ausiliarie a rafforzamento del nucleo centrale. Ogni evidenza contraria si scontra con la
cintura protettiva. Vediamo quindi quali
possono essere i nuclei metafisici dell’anarchismo (non più, quindi, ethos, bensì episteme). Innanzitutto, direi
che assioma basilare sia il concetto di potere e di autorità. Esso viene visto
- permettetemi il rimando alla favola prepotentemente tornato di moda oggidì
- come una sorta di mangiafuoco che
dirige gli umani come burattini tirandone i fili. Altro assioma è che i
burattini non avrebbero bisogno di fili. L’anarchico come pinocchio. Il potere
non è quindi giustificabile. Intorno a questa base comune si strutturano delle
cinture protettive, delle euristiche positive che pongono le basi per nuovi
assiomi, nuovi nuclei metafisici. Per alcuni, ad esempio, la proprietà è il
principale ed il più terribile dei fili che imbrigliano il nostro burattino,
per altri è il paio di forbici che lo libererà.
Accettata una delle due opzioni, anche intorno a queste si struttura una
cintura protettiva che tenderà a svalutare le evidenze contrarie. Ne conseguono
il fondamentalismo (anarco?)socialista
ed il fondamentalismo (anarco?)capitalista.
Ma torniamo al nostro discorso sulla devianza. Se sia accetta l’opzione
socialista della proprietà come crimine e quindi come devianza, si pone, come
già detto, il problema della sua
gestione. Varie opzioni sono state storicamente valutate dagli anarchici per
il fronteggiamento
della devianza. Ognuna di queste è il derivato di uno specifico costrutto
sotto-nucleare. Vediamole:
1. In una
versione “romantica” dell’anarchismo – quella rigettata da Berneri – il crimine non esiste
(nucleo metafisico) in quanto sarebbe la società autoritaria a definire le
forme di devianza. Il divieto di proprietà starebbe quindi a testimoniare
l’esistenza di un paradosso (come il mitologico “catoblepa”) quale
l’ ossimoro linguistico e logico rappresentato dall’ “autoritarismo libertario”, quello cioè che
può definire crimine la proprietà (in quanto, appunto, atto anti-sociale
proprio perché anti-socialistico). Manca in questa visione quella che, in
termini epistemologici, si chiama “coerenza interna”. Né mi sembra utile la
differenziazione proudhoniana fra proprietà e
possesso perché non è concepibile ammettere il possesso dei beni e considerare
deviante l’utilizzo di quei beni per produrre reddito (almeno a questo punto
del discorso). Pertanto d’ora in poi definirò proprietà tanto la proprietà
quanto il possesso. Il concetto poi di “furto” è ancora tutto dentro la logica
del possesso: non si ruba se non quello che qualcun altro possiede. Si suppone
quindi che i possessori di tutto siano tutti.
Concetto validissimo se lo limitiamo alla “original
position” di Rawls ma che suppone un essenzialismo buonista alla Rousseau per poter
pretendere di perpetuarsi, cioè l’idea che esista una essenza umana data
dell’uomo e che questa sia buona prima di venire inquinata dalla società e
dalla cultura. Ciò ci porta dalle parti
dei russi Kropotkin e, soprattutto, Tolstoj (cosa che non mi entusiasma). Sia chiaro che
concetti come “mutuo appoggio”, comunitarismo ed altri hippiesmi
sono una gran cosa ma se per caso quel mollaccione di
Rousseau col suo mito del buon selvaggio (così caro a
tanta parte dell’anarchismo storico) si sbagliava sapete che succederebbe? Che
di devianti non disposti a mettere in comune e ad “appoggiarsi mutualmente” ce ne sarebbero un fottio e diverrebbero un
problema che può essere risolto solo mediante soluzioni autoritarie:
collettivizzazione forzosa e / o messa al bando del deviante. Il paradiso
diventa l'inferno. Il Kibbutz israeliano è una buona approssimazione di società
volontaria basata sul socialismo ed il mutuo appoggio ma è scelto da una infima
percentuale di persone. Credo che bisogna tenere in considerazione questo dato.
2. Gustav Landauer non si discosta granché dal campo con il suo
anarchismo tutto persuasione e pedagogia. In quest’ottica
il
crimine esiste ma è espressione di una società distorta (nucleo metafisico). Comportandoci in modo
diverso, dice Landauer, si creerà una nuova modalità
di relazione e di società. Pertanto la proprietà scomparirà (come doveva
sparire lo stato marxista). Al di là dell’ingenuità della cosa, trovo la
pedagogia uno strumento di estrema pericolosità perché schiava di un approccio sapientista per cui io che so insegno a te che sei
nell’errore ciò che è giusto. Ancora una volta la premessa libertaria cozza con
le conclusioni e si realizza una scarsa coerenza interna. Ma anche ammettendo
questo concetto si avrebbe quale risultato ideale una società in cui tutti,
finalmente edotti e convinti, sarebbero concordi tanto sui fini quanto sui
mezzi della cultura libertaria trasmessa. Magari tutti schiferebbero la
proprietà e il mercato. In tal caso l’anarchico si concretizza come un pedante grillo parlante e il liberato in
un pinocchio che può affermare “com’ero buffo quand’ero burattino!”. Questo è
certamente funzionale ma mi fa paura come il 1984 di Orwell. Una società in cui la
condivisione è totale è stata delineata della scuola sociologica nota come “struttural-funzionalismo” (Talcott Parsons), conformistica oltre modo e
priva di conflitti. Peccato che sia il conflitto il motore della storia.
Tornando all’epistemologia, non si avrebbe passaggio a nuovo paradigma senza
falsificatori potenziali invalidati. Nella società del consenso libertario di Landauer, essendo tutti d’accordo, quando anche ci fossero
dei falsificatori, questi non verrebbero neppure solleticati. Meglio una
società composita e stridente, che dia diritto di cittadinanza a tutte le
devianze. In tal caso dovrebbe godere di questo diritto anche il
proprietario.
3. accettando
invece un essenzialismo di segno contrapposto a quello buonista
, l’egoistico individuo stirneriano ci viene a ricordare che “la proprietà non è un
furto”: La proprietà è un dono. Se altri hanno proprietà è perché noi
gliela lasciamo, è grazie al nostro sacrificio. Se altri hanno – dice il
vecchio Max – è colpa nostra perché non li derubiamo. “La terra non è di chi la
coltiva, è di chi se la sa prendere”. Quindi siamo ancora dalle parti della
proprietà (e, in tutta onestà, non troppo lontani dal liberismo!). Se ci
pensiamo bene, colui che è il deviante nell’anarchismo buonista
è esattamente l’uomo stirneriano che, in un regime comunitaristico,
rivendica la torta tutta per se (o, meglio, tanta torta quanto riesce a
papparsi); nella versione stirneriana, il deviante non esiste perché il
crimine – svuotato di ogni significato
morale o utilitaristico, quindi non-crimine
- è il mezzo di affermazione della libertà
personale. La proprietà vi è
quindi contemplata quale segno della propria affermazione, anzi rivendicata. La
banda Bonnot
ha rappresentato un buon esempio concretizzato di questa visione “illegalista”.
Ma è nella
concezione radicale di Paolo Ranieri
che la proprietà di tutti finisce con
l’essere quella di nessuno , cioè una serie di “condotte concludenti”, cioè di
appropriazioni che durano il tempo della consumazione dell’atto (“l’atto che dà
vita alla norma, e in quell’atto la norma si
esaurisce”). La mela che mangio, prima che la cogliessi era di tutti, ma
diviene mia nell’atto di ingoiarla, digerirla e defecarla (immagino che le feci
tornino poi ad essere patrimonio collettivo). In tal caso l’anarchico si configura
come Lucignolo nel Paese dei Balocchi. Qui non esiste una “pars costruens”, un mondo nuovo da edificare con tanto di “homo novus”, e questo aspetto rende la cosa più razionale e meno
utopica del mutualismo kropotkniano alla “volemose bbene”. Domina anzi la
pars destruens. Qui non c’è “collettivizzazione”
a-posteriori, in quanto si agisce in un mondo naturalmente ed originalmente
collettivo – c’è in pratica un riconoscimento di un diritto, quello di tutti
all’usufrutto – da riconquistare ma è proprio questo comunismo “nature”
coniugato al diritto del singolo (diritto espresso nell’atto) alla spoliazione
a risultare incongruente. Comunque questo processo di spoliazione, che in breve
porterebbe ad un deserto non più spoliabile, non è molto congruente neppure con il supposto “buon senso” che – ed
è questo il tallone d’Achille anarchico – tanto gli stinchi di santo come Tolstoj, quanto i cattivoni come Stirner ritengono risolverebbe ogni questione. Quando
ognuno si rendesse conto di essere proprietario di un mondo indiviso – cosa,
ripeto che è assolutamente vera in senso originario – la teoria del buon senso
di Paolo cadrebbe miseramente. Il “buon senso” funziona solo in condizioni di abbondanza. E’ vero che
ogni mattina tutti noi prendiamo il nostro ombrello dal portaombrelli e non
assaliamo gli altri per disombrellarli ma ciò avviene
perché tutti possiamo accedere ad ombrelli a basso costo grazie alla produzione
di massa, cosa che non sarebbe possibile nello stato di natura ranierano dove l’eventuale ombrellaio i suoi se li terrebbe
per sé oppure li cederebbe dietro compenso, scambio, baratto, cioè creando un
mercato, e comunque ad un costo elevato a causa della bassa produzione rispetto
alla domanda ed alla artigianalità dei manufatti. Per
finire, incongruente è l’essenzialismo umano implicito in tale visione, cioè la
commistione di egoismo (soddisfare le proprie esigenze immediate in barba agli
altri) e virtù (buon senso e condivisione), la stessa di chi, liberista, ha
teorizzato delle “virtù dell’egoismo”.
Né secondaria mi sembra la considerazione che in questa comunità di cacciatori-raccoglitori (perché
l’agricoltura, quello scemotto di Zerzan ce lo “insegna”, è mamma
dell’oppressione) l’economia sarebbe, nel migliore e più improbabile dei
casi, di sussistenza e quindi compatibile al massimo con una libertà
“negativa”. Isahia Berlin ha
chiaramente distinto l’idea di libertà come privazione, mancanza di
costrizione, libertà appunto “negativa” (quella possibile nell’arcadia dei
raccoglitori), che è una libertà da un
potere (nella fattispecie, dalla
proprietà), rispetto ad una libertà “positiva” o libertà di, che nel mondo pre-agricolo
può declinarsi in ben pochi casi. Quando
Murray Bookchin esalta
le società organiche primitive (le stesse che piacciono a Zerzan
e ad altri primitivisti luddisti
ipertecnologici) lo fa utilizzando lo strumentario
psicoanalitico; parla infatti di un “principio di piacere” che, nella società attuale, è soffocato dal
“principio di realtà” produttivistico mentre, sue parole, “ nelle società
organiche il principio di realtà nasceva dai limiti fisici naturali”, in altre parole, non era
necessario che qualcuno imponesse autoritariamente un limite in quanto la
natura lo imponeva naturalmente. Laddove è la natura stessa a fissare i limiti
della realtà con cui si confronta il principio di piacere, la realtà (mi si
passi il gioco di parole) è che c’è ben poco da trarne piacere. A questo punto l’uomo atavico in un mondo
atavico è libero nella stessa misura in cui un disoccupato è libero dal
fisco. Però è tanto romantico.
Insomma, sia furto, sia dono, sia di
tutti o di pochi, sia dei “buoni” o dei “cattivi”, che sia bene, che sia male
la volontà di impossessarsi ed utilizzare senza limiti le risorse è
onnipresente e, probabilmente, costitutivo dell’essere umano, non meno del
desiderio di libertà. Del resto mio figlio di tre anni reclama il mondo per sé
ed è molto stirneriano. Pertanto se il proprietario è deviante
rappresenta una forma di devianza esistente sotto ogni cielo. Questo ci porta
ad un altro approccio:
4. il crimine
esiste ma è ineliminabile. La proprietà è quindi si un
crimine ma dobbiamo rassegnarci alla sua esistenza come ci rassegniamo alla
violenza, alla truffa, ecc. . In tal caso la società libera vede quale sua
sfida prioritaria proprio il disinnesco delle cariche più pericolose per le
libertà dei singoli. In questo caso, tendenza ad appropriarsi di beni fisici e
tendenza all’aggressione convivono fisiologicamente e vanno “tollerate”. Meglio
sopportare che reprimere perché reprimere sarebbe peggio. L’anarchico è qui una
comprensiva ma esigente fata turchina. La proprietà come male, si, ma male
necessario, come un tempo la chiesa diceva delle prostitute. Ma questo tipo di tolleranza sa di
sopportazione e la sopportazione è una conoscente ma non un’ amica della
libertà. E poi se la prostituzione esiste e persiste anche in regime
proibizionista è perché soddisfa una richiesta ed un bisogno che non sparisce
né per decreto né per decisione consiliare.
Stesso ragionamento si può fare a proposito del mercato che, anche in
regimi proibizionistici come quelli del “socialismo reale”, sopravviveva
clandestinamente. Se qualcosa preme per la sua soddisfazione io ritengo sia
buona norma sbrigliarla. Gilles Deleuze diceva che l’uomo è “una macchina desiderante
in rotta con ogni principio di realtà”. Accontentarla è d’uopo. Non
“tollerarla”. Lasciamo libero sfogo agli impulsi sessuali come a quelli
proprietari. Ma qui torniamo a Stirner e Berlusconi. In altri termini, anche qui il problema è di
coerenza interna. Rieccoci in una impasse.
In
conclusione, dato l’assioma centrale della proprietà quale atto
ingiustificabile e violento di appropriazione a danno degli esclusi e la
conseguente necessità di rimediare a ciò, l’anarco-socialismo
si è consolidato tramite un’euristica positiva tale da impedire di cogliere il
paradosso costituito dallo schizoide atteggiamento di chi preveda un diverso
approccio per struttura e sovrastruttura (parlando in termini marxiani e
marxisti), cioè totale libertà in termini “politici”, morali e quant’altro,
giustificata da svariate considerazioni “etiche”, e limitazione della
sfera economica, grazie a giustificazioni etiche con non quagliano granché con
le prime. Insomma i “falsificatori” di
cui parla Popper non vengono attivati. E’ proprio
quello che fa il talebano. Jean Piaget ci ha chiarito il processo
tramite il quale avviene l’esclusione della falsificazione, ovvero tramite i
meccanismi di “assimilazione” ed “accomodamento”. L’assimilazione è l’inserimento di nuovi dati
nelle strutture cognitive preesistenti mentre l’accomodamento è la modifica
delle strutture per poter accogliere nuove configurazioni di stimoli incompatibili con la passata struttura del sistema;
Immaginiamo una libreria a caselle che si stata costruita in modo tale che vi
entrino solo dei libri di una certa dimensione e con certe caratteristiche , ad
esempio quelli con su scritto “l’acqua bolle a 100 gradi” o “la proprietà è un
furto”. Se ci si trova davanti ad imput differenti,
come lo scoprire che in alta montagna l’acqua bolle ad una differente
temperatura, la situazione è come quella di un libro di dimensioni non consone
a entrare in quella libreria. Ci sono due sole possibilità: o “accomodare la
struttura”, allargare le caselle in modo da includere il nuovo imput incongruente che viene quindi “assimilato”, oppure
negarvi l’ingresso impedendo tanto l’assimilazione quanto l’accomodamento. Sono
i paraocchi psichici. Un confronto
fruttuoso e dinamico con il mondo può avvenire solo solo
tramite un equilibrato rapporto fra assimilazione ed accomodamento che porti
all’aumento della complessità e flessibilità della lettura, dell’impalcatura
dei costrutti. Un eccesso di accomodamento comporta che ogni nuovo imput stravolga la struttura e questo rende la nostra
identità vaga, imprecisa, cangiante, come nella schizofrenia. Uno squilibrio,
invece, in termini iper-assimilativi senza
accomodamento è quello del paranoico che non modifica mai la sua teoria, anzi
utilizza i nuovi imput per confermarla (dogmatismo).
Il marxista legge in ogni evento una conferma alla teoria del trevigiano (come si chiamano gli abitanti di Treviri?), lo psicoanalista legge in ogni sintomo la
conferma della teoria del viennese, il paranoico legge in ogni traccia la
conferma della sua teoria della infedeltà della coniuge. Una strategia
“intermedia” generalmente utilizzata è quella di cedere su un costrutto meno
focale (estinzione dello stato, universalità della pulsione di morte, necessità
per l’anarchismo di essere antistatalista, ecc.) , meno nucleare, per
salvaguardare quello che si è dogmaticamente deciso essere immodificabile
(teoria del plus-valore, la repressione della sessualità quale origine della
nevrosi, la proprietà come furto). E’ quello che generalmente è stato fatto dai
socialisti anarchici “duri e puri” che poi si rivelano piuttosto spuri ed
impuri. Noam Chomsky ed Akim Bey, per esempio, hanno espresso idee
in cui è facile scorgere all’opera questo meccanismo, per cui lo stato,
cacciato dalla porta rientra dalla finestra come regolatore dell’economia. Ciò
evidenzia come nella loro struttura mentale l’antistatalismo sia
gerarchicamente subordinato all’antiproprietarismo,
ma a questo punto un socialismo autoritario risulterebbe molto più coerente e
consequenziale. Non si capisce perché
chi ritiene inammisibile la proprietà ed ammissibile
polizia, esercito, tribunali, ecc. meriti di definirsi anarchico più di chi
ritiene possibile la proprietà e inconcepibile tutto il resto. E’ il caso di
dire “mistero della fede”!
Insomma,
Le teorie politiche assomigliano molto al delirio paranoide, il quale è delirio fintanto che rimane
individuale ma diviene fede quando è condiviso da altri (una fede è un delirio
condiviso). Anche l’anarchismo ha i suoi credi, i suoi martiri, i suoi profeti,
le sue icone, i suoi ordini religiosi e i suoi sacramenti. Si propone qui una
cura a base di massicce dosi di iconoclastia.
2. Il migliore dei teatrini possibili?
La
libertà senza il socialismo porta al privilegio, all’ingiustizia;
e il socialismo
senza libertà porta alla schiavitù e alla brutalità.
M. Bakunin
Si
consideri ora l’altro nucleo metafisico:
Teorema II:
La
proprietà è il fondamento della libertà
Corollario:
il
mercato è il luogo della libertà.
Se la proprietà per gli anarco-socialisti è sempre e comunque illegittima e
criminale, per gli anarco-capitalisti è sempre e
comunque una mano santa. Senza proprietà non esiste libertà. In quest’ottica il mercato significa sovranità degli individui
in quanto consumatori. I miei acquisti sono voti e questo è il miglior mezzo di
controllo sociale dei mezzi di produzione. Nel mercato, dicono i libertarians,
nessuno mi impone qualcosa in nessun ambito (morale, etico, di consumo, ecc.)
ed io sono realmente libero di fare qualunque cosa. I servizi di cui intendo
usufruire (educazione, sanità, trasporti, infrastrutture, agenzie di
protezione, tribunali, ecc.) non mi sono imposti dallo stato ma li acquisto
liberamente nella misura che voglio e per il tempo che voglio. In tal caso
l’eventuale individuo che non volesse essere proprietario né compromettersi con
un sistema basato sulla proprietà ed il commercio lo potrebbe tranquillamente
fare, da solo o in gruppo, potrebbe
perfino creare una comunità comunista senza che ciò venisse a
configurare crimine alcuno perché non sarebbe deviante nel senso in cui lo è il
proprietario nei confronti del socialismo, non inficierebbe
cioè il sistema. In altri termini, la soluzione anarco-capitalista
è sotto certi aspetti più valida dal lato della coerenza interna. Qui la
cintura difensiva è però rinvenibile altrove e in punto ben più profondo,
laddove si ragiona sul concetto di sfruttamento. “Lo sfruttamento non esiste”,
recita il mantra anarco-capitalista.
Robert Nozick, pur non
essendo tecnicamente un anarco-capitalista di provata
fede ma solo un loro compagno di merende, ha liquidato ogni “assurda” pretesa
di considerare sfruttamento l’ approfittarsi della altrui condizione di
svantaggio con la formuletta che vede le transazioni
economiche come “rapporti economici fra adulti consenzienti” intercorsi cioè
fra soggetti “volontari”. Il salariato non è sfruttato dall’imprenditore che si
compra i suoi sforzi e il suo tempo per arricchirlo. Per difendere il nucleo
metafisico dell’individualità autonoma
fondata nella proprietà e quindi del mercato quale fonte di libertà, non
è possibile “assimilare” nella costruzione ideologica il concetto di
sfruttamento, pena il crollo dell’intera impalcatura. La difesa è quindi
strenua, anche davanti all’evidenza dell’utilizzo del differente potere
contrattuale, non solo per poter utilizzare il lavoratore, ma per far si che
tale disequilibrio si perpetui, perpetuando insieme la possibilità di
continuare ad usufruire di tale maggior potere, cosa che delinea un disegno anti-libertario. Asserire che un
lavoratore “sceglie” liberamente in quanto “imprenditore di sé stesso”, di
accettare le condizioni propostegli è una mistificazione perché dei due attori
coinvolti, imprenditore e lavoratore, il secondo ha già un padrone e si chiama
bisogno. Qust’ultimo lo affitta al primo. Sono quindi
due padroni alleati, pertanto il primo (imprenditore) farà di tutto per
mantenere in vita il secondo (il bisogno) in quanto gli è funzionale e
simpatico. Vivono in simbiosi. Pertanto la transazione, “il rapporto economico
fra adulti consenzienti” non è realmente a due, ma a tre. Questo inquina
notevolmente il clima perché oltre ai due “adulti ” c’è n’è un terzo che ad uno
dei due punta un’arma, quella della necessità. Questa situazione è consensuale
come l’accettazione della “protezione”
delle attività commerciali proposta dalla mafia ai negozianti (o dallo
stato ai cittadini, che poi è la stessa cosa). A tal proposito, di uno dei loro
autori preferiti, Lysander Spooner,
esponente dell’anarchismo individualista americano del XIX secolo, i libertarians
amano citare un brano famoso, quello in cui si paragona lo stato ad un
rapinatore: lo stato, come un bandito di
strada, intima alle persone “o la borsa o la vita”. E molte, se non tutte le
tasse sono pagate sotto il peso di questa minaccia. Lo Stato, in effetti, non
tende un agguato a un uomo in un luogo solitario, balzando dal ciglio della
strada, per puntargli la pistola alla tempia e svuotargli le tasche. Ma non per
questo la rapina cessa di essere una rapina a tutti gli effetti. Giustissimo,
sottoscrivo. Ciò che è strano è che non tutti si accorgono che questo stesso
discorso si applica anche al datore di lavoro. Non ti rapina con la mascherina
al volto ma ti sottrae la vita. La possibilità di trasposizione del discorso spooneriano continua quando egli, proseguendo, dice che la
rapina dello stato “è più codarda e
vergognosa . Il bandito di strada assume su di sé la responsabilità, il
pericolo e la criminalità del suo atto. Egli non pretende di avere un giusto
titolo al vostro denaro, né di volerlo usare a vostro beneficio”. Il bandito almeno non pretende che voi
dobbiate ringraziarlo perché vi deruba, non pretende, come l’imprenditore, di meritare gratitudine per il fatto di avervi
acquistato a suo beneficio, il rapinatore ammette di avere agito per il suo
unico bene e a vostro danno. Stato e padrone no. Mi
si obietterà che accettando ( volontariamente, of course ) le condizioni propostegli il
salariato si garantisce comunque un lavoro; perché, pagando le tasse il
cittadino non accede forse ai servigi dello stato? I trenta denari che otteniamo per il
tradimento di noi stessi non possono accecarci a tal punto da non vedere al di
là dei nostri momentanei meschini guadagni
l’importanza di ciò che perdiamo.
E’ curioso constatare
come davanti a situazioni così lampanti ed allo spettro della “invalidazione”
del costrutto, le giustificazioni anarco-capitaliste
diventino vaghe e tautologiche. Piombini,
ad esempio, una volta ha risposte alle
mie obiezioni dicendo che “in uno
scambio le parti non hanno mai identico potere contrattuale altrimenti non
avrebbero bisogno di fare alcuno scambio”. Sarà, ma se lo scambio riguarda dei
beni voluttuari, tipo se io ho una mela e tu una pera e facciamo cambio, o
anche se io voglio due mele per una pera, non è facile stabilire la graduatoria
di potere contrattuale fra me e te, le cose bene o male si equivalgono e io e
te siamo realmente liberi di scambiare ciò che abbiamo oppure di mangiarcelo,
ma se io voglio acquistare parte della tua vita per permetterti di restare in
vita anche per il tempo che non lavori , cioè se io considero te stesso come un bene di consumo
perfettamente intercambiabile con chiunque altro e tu vedi quello che io “ti
offro” (per farmi del bene) come una
possibilità di portare a casa la pagnotta la questione cambia e il discorso di
Piombini sta solo a indicare che considera questa condizione, che io chiamo
sfruttamento, inevitabile, pertanto ne conferma la validità e ne ammette la
sussistenza anche in regime anarco-capitalistico.
Infatti, sempre Piombini mi dice “i libertari non hanno nulla in contrario alle
gerarchie e alle organizzazioni private, per il semplice motivo che, a
differenza di quelle statali, sono volontarie"” e rieccoci
punto e daccapo, abbiamo fatto un giro di valzer per trovarci al punto di
prima. Francamente non so che tipo di
potenzialità libertarie siano insite in una società che veda la servitù, per
quanto volontaria, quale base di effettualizzazione,
anzi lo so perché non devo fare molti
sforzi di immaginazione. Del resto la
società propostaci da questa scuola di pensiero prevede che, liberamente scelti
dai consumatori e in regime di concorrenza fra loro, sussistano scuole,
esercito, polizia, magistrati, carceri, ecc.
Ora, senza scendere troppo in questioni circa la legittimità di questa o
di quella istituzione in situazione “anarchica”, cosa che ci porterebbe
lontano, è da notare che se l’anarco-socialismo perde
le sue qualità libertarie nella scelta di favorire le istituzioni sociali
sovra-personali (silentemente accolte) ma rifiutando
la proprietà, l’anarco-capitalismo
perde queste velleità accogliendo tanto la proprietà quanto le istituzioni
autoritarie, purché private. A questo
punto la libertà rischia di diventare uno specchietto per le allodole. Perché considerare autoritaria la situazione
statale e libertaria quella in cui le istituzioni statali sono private? In
realtà, ancora una volta, c’è un’unica
risposta che i seguaci di Rorhbard forniscono: perché
nel secondo caso è possibile la scelta, e Liberty
is choice. “Ogni gruppo
umano – dice sempre Piombini – è libero di organizzarsi volontariamente come
desidera, anche in maniera gerarchica e autoritaria, se ciò favorisce il
perseguimento dei fini che si prefigge entrando in quell’organizzazione”,
ad esempio il fine di sopravvivere.
Siamo sempre intorno allo stesso nucleo, alla libertà di scelta di cui
abbiamo già evidenziato la fallacia nel caso dei rapporti
imprenditore-salariato. La cosa non muta di molto se parliamo di altri tipi di
associazioni e affiliazioni né se si considera la semplice scelta dei
consumatori in un mercato che determina i bisogni, le mode e la sorte dei vari
beni. La situazione che si configura è simile a quella del ridicolo ed
umiliante rito del voto quando siamo liberi di scegliere uno sconosciuto da una
lista pre-compilata da altri sconosciuti per
“rappresentarci” e fargli fare ciò che decide lui o il di lui duce. Ma se nel
mercato dei beni materiali di consumo la cosa può ancora essere tollerabile,
non potendo nessuno ardire di distinguere fra “veri” e “falsi” bisogni (che è posizione religiosa,
autoritaria e moralista), e perché
chiunque può sempre scegliere di non acquistare alcunché, perfino di boicottare
specifici beni (arma di controllo dei mezzi di produzione effettivamente non
presente in assenza di mercato), quando i beni cominciano a chiamarsi
“giustizia”, “salute”, “istruzione”, “sicurezza”, ecc. , il discorso cambia un
bel po’. Mettiamo che io fossi il proprietario di una forza di polizia tutta
mia o di un esercito di guerrieri di
ventura, bè avrei tutto l’interesse a creare le
condizioni di insicurezza sociale che sarebbero favorevoli alla mia attività.
Del resto il mercato opera spesso
creando prima la domanda e poi l’offerta. A questo punto l’acquirente
non è più così “libero” di scegliere se difendersi o meno, è costretto ad
acquistare il servizio; non gli conviene né rimanerne sguarnito né boicottarlo.
E’ una strana libertà. Certo, può sempre scegliere fra me e un altro fornitore
di servizi di sicurezza o di bounty killers e alla fine decidere per quello che lo “serve
meglio”, ad esempio l’esercito che per lo stesso prezzo gli porta gli scalpi
dei nemici o i loro attributi per farne nacchere, ma questo non mi fa apparire
la condizione più desiderabile, anzi. Né
mi appare come una grande conquista di libertà quella di pagare dei continui
pedaggi stradali anche per andare a far la spesa all’alimentari del mio paese,
cioè la metastasi della cellula proprietaristica in
ogni ambito della vita, incluso quelle attualmente ancora relativamente non
intaccate. Insomma, quello che mi sembra stonato in tutto ciò è che in una
simile concezione uno ha tanta libertà quanto riesce a comprarsene. Ma questa
non è altro che la estremizzazione del mondo che già abbiamo. Previti, per esempio, può già comprarsi la giustizia.
Questo costituisce un atto di ostilità nei confronti del consorzio sociale, non
astratta entità, ma unione dei singoli, tutti individualmente aggrediti. Insomma credo che non potrà smentirsi che,
devianza o non devianza, utile o inutile, la proprietà si configuri come uno
strumento violento e sia violenza essa stessa in quanto atto espropriativo, privativo nei confronti di chi non può
accedere ai beni. Dico ciò, ora, in termini a-valutativi, solo descrittivi, sia
chiaro; ad ogni modo ritengo che la proprietà sia una forma di violenza più
raffinata dell’aggressività fisica ma ben più pregna di possibilità offensive
(e difensive). La proprietà è la
violenza che continua con altri mezzi. Ciò balza nella sua immediatezza se
trasponiamo alla posizione originale il seguente esempio: sono invitato ad una
festicciola fra amici e, stanco, decido di occupare una delle sedie in
dotazione della casa ospitante. Nessuno avrà nulla da ridire, neppure un altro
mio amico che fosse ugualmente stanco ma avesse trovato la sedia occupata da
me. Io e lui siamo ugualmente liberi di utilizzare i beni a disposizione. Se
però io mi alzo e pretendo che la sedia che avevo occupato rimanga libera anche
se non la utilizzo, sto considerandola come mia indipendentemente dalla
necessità strumentale che la aveva temporaneamente resa da me legittimamente
utilizzabile e, facendo ciò, sto manifestando una aggressione nei confronti del
mio amico paragonabilmente stanco in
quanto lo privo della possibilità di usufruire del diritto comune all’usufrutto
del quale io stesso mi ero avvalso. Violenza privativa.
C’è un’unica ragione per cui si può
sottovalutare l’aspetto aggressivo della proprietà, quella di attribuire agli
aggrediti, ossia agli esclusi dal banchetto, quelli cioè a cui si toglie ciò
che sarebbe naturalmente loro per poi rivenderglielo (ad esempio, il tempo), il
motivo della loro esclusione, per scelta o per incapacità. Sorvoliamo sulla
prima ipotesi, improbabile, fallace e comunque residuale. La seconda è una
attribuzione di colpa (come dire “cornuti e mazziati”)
per il proprio stato di esclusione che è un diffuso ed arcaico pregiudizio
liberista noto come “spencerismo” o “darwinismo sociale”
e sa molto di malthusianesimo. In altri termini, il mercato “genera eminenze” (parole di Giovanni Sartori).
L’idea, ricapitolando, è questa:
se tutti abbiamo le stesse possibilità e A realizza maggiori traguardi di B, A
se l’è meritato (ha guadagnato
l’”eminenza”), mentre B merita il suo permanere in una condizione di
inferiorità a causa della sua imperizia, pigrizia o stupidità. Si può giungere
a queste conclusioni perché sia ad A che a B sono state concesse le stesse chances,
partivano cioè nella stessa situazione di “libertà”. Quando anche una simile
situazione possa essere stata vicina
alla realtà in una condizione affatto particolare come la land of
opportunites che
poteva essere il continente vergine degli Stati Uniti
appena indipendenti - che furono il vero primo laboratorio del liberalismo
pratico - tale situazione cambiò radicalmente con il sorgere delle prime
“eminenze”. Estremamente efficace a tal
proposito mi sembra l’esempio che Erich Fromm
propone per sciogliere il nodo sulla natura dell’uomo, cioè sulla questione se
egli sia libero o determinato. L’esempio
è quello del gioco degli scacchi. Egli
scrive:
Supponiamo che due giocatori egualmente bravi iniziano
una partita, ambedue hanno la stessa chance di vincere .... In altre parole,
ognuno ha la stessa libertà di vincere. Dopo, diciamo, cinque mosse, il quadro
è già diverso. Ambedue possono ancora vincere, ma A, che ha fatto una mossa
migliore, ha già una chance migliore di vincere. Egli ha, per così dire, più
libertà di vincere del suo avversario B. Eppure B è ancora libero di vincere.
Dopo qualche altra mossa, A, avendo continuato a fare mosse corrette che non
venivano efficacemente controbattute da B, è quasi sicuro di vincere, ma
soltanto quasi. B può ancora vincere. Dopo qualche altra mossa il gioco è
deciso. B, sebbene sia un bravo giocatore, riconosce di non avere più libertà
di vincere.
E’ chiaro come, in questo esempio,
bastino poche “mosse” per cambiare la situazione di partenza e restringere
i gradi di libertà di uno dei
contendenti, nonostante essi partissero in condizioni di parità di opportunità
e fossero entrambi meritevoli. Se abbandoniamo il terreno degli scacchi e ricontestualizziamo l’esempio nell’arena economica, ché a
questo si riduce l’interesse neo-liberale, vediamo che quando anche ci fosse (e
non c’è) una terra delle pari opportunità, poche mosse economiche verrebbero a
minare profondamente le possibilità di eguale riuscita di un avversario di
paragonabili capacità, con buona pace
della “creazione delle eminenze”. Un irriducibile liberista potrà obiettare che
A merita comunque di “vincere” in quanto ha avuto la bravura di fare la prima
mossa giusta. Se questo argomento può
anche essere vero a livello puramente concettuale in una situazione ideale di livellamento
economico e in una società in cui la qualità coincida con la velocità, comunque
non si tiene conto che 1) la possibilità della prima mossa dipende molto spesso
dalla fortuna e non dalla scelta, 2) che poteri forti creatisi grazie a “mosse
giuste” e/o fortuna ostacoleranno perfino la possibilità di “giocare” ad
eventuali attori sociali pervenuti sullo scacchiere economico in ritardo.
Interi strati della popolazione nascono a giochi già fatti, nascono cioè in
scacco matto, così come altri vedono la luce già vittoriosi a causa
dell’”eminenza” dei loro antenati. Questa è un’altra situazione di partenza che
non assomiglia affatto alla equality of opportunites con cui i “liberals”
anglosassoni si sciacquano di continuo la bocca. I due giocatori partono forse
nelle stesse condizioni? Hanno le stesse possibilità di vittoria? Hanno, in
altre parole, la stessa libertà di
vincere?
Fu comunque Nietzsche a scoprire la maggiore
incongruenza del darwinismo sociale: questo sostiene che chi vince è il
migliore, ma ciò non è vero – fa notare il tedesco - perché la vittoria non va
affatto al “più idoneo” per una legge di natura, bensì a colui che dimostra la
maggiore “volontà di potenza”. Da qui la
necessità, secondo Nietzsche, di esortare
i “migliori” a dimostrare volontà perché i “peggiori”, se motivati ed
organizzati, possono vincere. A questo punto la “differenziazione che genera
eminenza” produrrebbe una selezione non
in base a virtù intellettuali o d’altro tipo, bensì solo in base alla nietzschiana
“volontà di potenza”. Il premio va al più vorace (e rapace)! Questo
sembra essere il valore principe della
società di mercato capitalistica! Ecco il vero
problema.
Verrò forse accusato di comunismo se
ritengo che una società in cui tutti gli esclusi dal banchetto non potranno
acquistare alcuna libertà e premeranno
ai bastioni delle enclaves fortificate dei “liberi”
(cioè gli “eminenti”) che vi saranno rinchiusi (!) protetti dai loro eserciti
privati non rappresenti poi una gran conquista?
Si badi che non ragiono per esagerazioni ed iperboli se libertari come
il fiammingo Boudewijn Bouckaert o
l’americano Evan
MacKenzie, tessono le lodi delle “privatopie”, le città private in cui la upper-class
americana tende sempre più a rifugiarsi, chiusa in cittadelle medioevali con
tanto di mura di cinta e di bravi salariati a difenderne gli ingressi.
Finalmente liberi! Gli altri, gli esclusi dai benefici effetti della società
capitalistica, sono rimasti “chiusi fuori”. Più che una utopia mi sembra una distopia simile al futuro presentatoci dalla letteratura cyberpunk alla Gibson o alla Sterling. Impressione che si rafforza nel constatare a che
paradossi apra la porta una visione che presevi sempre e comunque gli accumuli
di potere (cioè le concentrazioni di violenza) e il loro compattamento nelle
forme classiche di autorità, (ribadendo che l’autorità altro non è se non
monopolio della forza e come tale dovrebbe essere invisa a dei liberali sì
radicali), ad esempio leggendo due economisti ultra-liberisti e para-anarchici,
James Dale Davidson e William Rees_Mogg, i quali , per
risolvere alcune questioni relative alla
integrazione dei servizi e alla risposta a varie domande sociali generalmente
trascurate dagli ana-cap, propongono una soluzione
rivolgendosi al passato, ma non a quello glorioso della frontiera che tanta
parte ha nell’immaginario anarco-capitalista, bensì a
quello oscuro del medioevo: come un tempo gli ordini militari e religiosi
potevano gestire il potere politico ed economico senza che ciò significasse
anche la sovranità territoriale, così si possono ipotizzare delle nuove
corporazioni economiche capaci di gestire la cosa pubblica. Ma è “Blade Runner”! In realtà tutto
ciò è in linea con un discorso come quello di Albert Jay Nock, uno
dei precursori ai quali gli anarco-capitalisti sono
più affezionati, il quale ha chiarito che il vero fine di una società di
mercato è il passaggio “dagli stati ai governi” quando la coerenza
intellettuale di uno che si proclama anarchico dovrebbe quanto meno puntare al
passaggio dallo stato all’auto-organizzazione. Qualcuno, invero, arriva anche
alla dis-organizzazione, per quanto io ritenga che la logica sistemica
impedisca sempre uno stato di anarchia negativa per produrre stati stazionari
in equilibrio.
Ma,
tornando al discorso delle privatopie e dei governi
non statali, ciò che più mi colpisce,
al di là dell’incongruenza della cosa, è il continuo riferimento alle utilità
sociali di un siffatto sistema i cui riferimenti ideologici sono invece
fieramente individualistici e fortemente anti-utilitaristici, almeno nella
preponderante vulgata che si rifà a Rothbard. Eppure
è proprio lui che, in un’opera senile, ha completato l’opera di ulteriore
sabotaggio della macchina libertaria che aveva contribuito a creare con l’idea
incongruentemente sociale, strano inciucio di
sovranità dell’individuo e riconoscimento di comunità, di “nazione per consenso” che, se da una parte l’ha resa più
inservibile di quanto già non fosse, da un’altra ha avuto la terribile colpa di
aver dato patente di anarchici a soggetti fascistoidi,
xenofobi e particolaristi che non toccherei neppure
con una canna da pesca. Persino l’ultra liberale Bruno Leoni, al quale tutti, Rothbard
incluso, devono tanto, ricordava che il padrone più vicino non è meglio di
quello lontano. I nostri legaioli, con la scusa della
“decomposizione dello stato nazionale”, di cui si fa partigiano anche quel
bacia-pile di Herman-Hoppe, vogliono invece un mini-leviatano
basato sullo Jus-excludendi alios, con l’aggravante di essere fondato su base
etnica. La versione allargata delle “privatopie” di
cui sopra, solo molto peggiorata. Capisco il discorso della “secessione
individuale” – io infatti ho già secesso, seceduto… come cacchio si dice? – che è concetto simile a
quello goodmaniano di “tracciare il limite” oltre il
quale non si intende collaborare con lo stato e l’autorità, ma fra questo e la
nazione per consenso vedo una incommensurabile cesura.
Quanto
all’aspetto dell’utilità sociale, vi ravviso un’altra impasse. E’ presto
detta: la legittimazione della proprietà
e della concorrenza è basata su un giusnaturalismo,
una legge di natura che, per tutto quanto si è detto circa la violenza che
tutto ciò rappresenta e per altre considerazioni circa lo stato di natura, non
credo sia accoglibile. Unica legittimazione resterebbe quella
dell’utilità che da tale atto violento si ricava quale effetto collaterale (e David Friedman
se non sbaglio la pensa così). Ma qui Rothbard si
ritrova coerentemente individualista e
ci ricorda che l’idea di un bene comune presuppone una uniformità di vedute che
non esiste, pertanto non esiste una “utilità collettiva”. Inoltre, dice il
vecchio Murray, l’utilitarismo, usando strumenti di
valutazione di tali supposte utilità collettive quali strumenti oggettivi è
altamente “immorale” perché comporta una coercizione nei confronti di chi a quell’utile (ad esempio, l’aumento del PIL) preferisce
altro (ad esempio, un’aria più pulita che sarebbe minacciata dalle pratiche
necessarie all’aumento del PIL). L’utilitarismo come atto aggressivo da parte
dell’assolutismo del bene nei confronti del relativismo degli individui. E’
proprio un peccato che tutto questo si trovi in contraddizione profonda con la
filosofia oggettivistica di Ayn Rand che i più considerano la base epistemologica dell’anarco-capitalismo, quella che, per usare le parole
dell’attrice-filosofa, ha come metafisica la realtà, come epistemologia il
realismo e come estetica la bellezza oggettiva.
Insomma, si fa presto a dire “anarco-capitalismo”
quando in realtà si tratta di fronde spesso difficilmente integrabili.
Comunque, annullata la giustificazione giusnaturalista,
disinnescata quella utilitaristica, cosa rimane? Solo l’utilità del singolo, la
possibilità dell’individuo di agire la propria violenza a suo uso, per offesa o
per difesa.
Insomma, a voler proprio fare le pulci
alle varie teologie libertarie, tanto socialiste quanto capitaliste, è
possibile avvedersi di una serie di incrinature e incongruenze che da lontano,
protette dalla nebbia delle “euristiche positive”, non balzano agli occhi e gli
permettono di spacciarsi come le griglie
culturali attraverso cui leggere il mondo, millantando un credito di
onnicomprensività ed “onnintellettività” che non
hanno. Le visioni certe e incrollabili che costituiscono una fede hanno la
caratteristica di vedere chiaro, di semplificare la realtà (che, si è detto, è
sempre incompleta e non totalmente coglibile) e, con
altrettanta chiarezza e schematicità, di individuare “il male” e scrivere
facili ricette per eliminarlo. Lo psichiatra Paul Watzslavick ha definito “iper-soluzioni” le illusioni di poter incidere
definitivamente sulla realtà delle cose alterando una volta e per tutte una o
più variabili. Per esempio la “soluzione finale” hitleriana. Si muove cioè
dalla erronea convinzione che, individuato il male (chessò,
la proprietà o il socialismo) rivoltarlo nel suo contrario ci porterà al “bene”
, quando il contrario del male è quasi sempre il peggio.
Oltre le iper-soluzioni: La
terza via
Non sono cattiva; è che mi disegnano così.
Jessica Rabbit
L’anarchico
è un fallito. E’ un naufrago del tempo moderno che si muove con una mappa
ingiallita e vecchia di secoli; legge il mondo attuale con categorie ottocentesche.
Nella condizione esistente ai tempi dell’anarchismo classico, quello i cui
rappresentanti sono stati Bakunin, Kropotkin, Malatesta, ecc., i
“giganti” di cui parlava Berneri, alle cui pesanti statue molti sono ancora
abbracciati (non rendendosi conto che ciò li porterà sempre più in fondo al
mare), il movimento operaio vedeva giusto. Esisteva un potere ben chiaro e
definito ed era il capitale, esistevano due classi contrapposte, quelle dei
lavoratori e quella dei capitalisti sfruttatori, lo stato era il “comitato
d’affari della borghesia”, lo strumento più forte di perpetuazione dello
sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Le ideologie dominanti erano le ideologie
funzionali al capitale ed allo stato. L’abbattimento della condizione di
sfruttamento passava quindi necessariamente dall’abbattimento dello stato e del
capitale. Benché alcuni elementi di questa visione siano ancora validissimi,
forse ancora più validi ora (si pensi al concetto marxista dello stato quale
“comitato d’affari della borghesia” e si guardi il nostro attuale governo),
questa descrizione è stata sorpassata dall’incredibile aumento della
complessità connaturata alla crescita dei sistemi. Michel Foucault, già da tempo, ha messo in
evidenza come il potere si sia diluito e camuffato passando da una condizione
“macrofisica” , cioè quella di un potere centrale e visibile, ad una situazione
“microfisica”, interstiziale. Il potere è ovunque,
nei nostri rapporti quotidiani, nei mass media, nel nostro lavoro, è il
groviglio di fili che ci lega agli altri, ora in funzione di vittime, ora di
carnefici, tutti indistintamente, è nella parcellizzazione e gerarchizzazione, nella ossessivizzazione
della vita quotidiana. Questo disinnesca definitivamente l’idea di un assalto
al cielo, di una lotta diretta al potere macrofisico. Ognuno di noi non può più
definirsi unicamente come sfruttato o come sfruttatore. Saremo sfruttati
dall’imprenditore ma guardate che quello non è più il proprietario della
ferriera ma un tizio che è a sua volta sfruttato dallo stato, e noi, quando
acquistiamo i prodotti della Nike o della Nestlè siamo a nostra volta sfruttatori di bambini del
terzo mondo, quando subiamo il potere del capoufficio non siamo dei martiri
perché la gerarchizzazione e parcellizazione
delle attività della macchina è tale che quasi sicuramente noi svolgiamo la
stessa funzione con qualcun altro, ecc. Non c’è più Mangiafuoco che fa ballare
i burattini ma milioni di piccoli mangiafuoco interconnessi in un groviglio
inestricabile di relazioni autoritarie, è una macchina infernale di cui nessuno
ha le chiavi e che corre in discesa senza autista. Perfino lo stato è , come ogni individuo,
oppressore (dei cittadini) ed oppresso (dalle istituzioni sovra-statali, dalle
multinazionali, ecc.). La vecchia
strategia rivoluzionaria è romantica ma adatta per una canzonetta che emozioni
i vecchi bacucchi in camicia rossa. Contro chi ti rivolti?
C’è poi
l’aspetto dell’ essenzialismo umano. Questo è un altro punto fondamentale. L’anarcosocialismo archeologico parte dal presupposto
dell’uomo sociale e della natura benigna, l’anarcocapitalismo
dall’opposto concetto di homo aeconomicus. Entrambe
queste concezioni vengono supportate da esempi pertinenti. Ma un essenzialismo
umano non esiste! L’uomo è tutto questo e molto altro. Bisogna tornare al concetto di “sistema”.
Ragionare in termini di essenzialismo umano dopo la Teoria Generale dei Sistemi
di Von Bertanlaffy e la sua
applicazione psico-sociologica da parte di Gregory Bateson vuol
dire essere completamente fuori dal tempo. L’uomo è prodotto e produttore del
mondo, in interscambio continuativo. Prodotto biologico e storico insieme,
l’uomo è caratterizzato da qualcosa che, dal punto di vista psicologico, non è
soltanto suo, ma suo e di altri contemporaneamente. Asch, uno psicologo sociale, spiega questo concetto
paragonando un individuo ad un atomo e la cultura ad una sostanza formata
appunto da una combinazione di atomi in molecole disposte a loro volta in modo
specifico. Ogni singolo atomo ha la sua autonoma essenza di partenza ed essa,
aggiungo, non è né buona né cattiva, è neutra perché è la struttura che
determina le qualità morali delle cose e degli eventi. La struttura, poi, ha
delle qualità sue proprie, tipiche cioè della sostanza composta, non frutto
della semplice somma delle qualità degli atomi, ma del loro arrangiamento. La
proprietà è solo uno degli elementi di arrangiamento. L’aggiunta o la
sottrazione di un solo atomo ad una molecola trasforma il diamante in grafite e
viceversa.
La conclusione
è quindi questa: esistono le qualità innate e disposizionali
dell’uomo ma tali disposizioni si concretizzano nel rapporto con le cose e,
soprattutto, con gli altri. La nostra società, come gli aggregati molecolari, è
creata dagli individui costituenti come gli atomi ma, a sua volta, annulla
negli individui alcune delle loro caratteristiche essenziali. La nostra società capitalista, ad esempio,
non permette il concretizzarsi di determinate qualità e pulsioni o lo permette
in forma distorta. Permettere la riemergenza di alcuni di questi aspetti negati non
significa distruggere l’organizzazione e trasformarsi in atomi vaganti. Questa
si chiama anarchia negativa ed esiste
già nell’attuale strutturazione psicologica
del capitalismo monopolistico.
Esistono molteplici combinazioni molecolari e strutturali. Infinite sono le alternative;
infinite proprio a causa degli elementi
fissi e delle legature sistemiche, come espresso da Chomsky
in linguistica.
Cambiare l’uomo cambia la società e cambiare la
società cambia l’uomo. Fine di chi ama la libertà sarà quindi quello di
produrre una presa di coscienza degli uomini affinché la loro piena espressione
modifichi la struttura e contestualmente premere sulla struttura con la
certezza che essa modificherà gli uomini. Questa si chiama anarchia positiva. In tutto
ciò la rivoluzione c’entra come un cavolo a merenda.
In quest’ottica l’anarchico è un perturbatore di sistemi, da atomo legato si dimena ( con la propaganda, la promozione di pratiche alternative ed anti-autoritarie, il rifiuto e la non partecipazione, la lotta, la rivolta, se necessario), fino al punto di disequilibrio del sistema stesso, il quale dovrà riassestarsi ad un altro livello omeostatico che diverrà la base per nuove perturbazioni. E’ già successo. L’illuminismo, la Rivoluzione Francese, il libero mercato, ecc., sono stati scossoni che hanno perturbato irreparabilmente la struttura e modificato irrimediabilmente la psicologia degli individui, creando le condizioni per nuove perturbazioni. Cosa viene fuori da questo cambio di prospettiva? La coscienza fondamentale che se gli uomini si giudicano solo se inquadrati in specifici contesti strutturali, anche le loro azioni e i loro prodotti sono a-valutabili estrapolati dalle loro legature sistemiche. Ciò vale quindi anche per la violenza, quindi anche per la proprietà. Il “socialismo” e il “capitalismo” sono solo attributi sistemici che definiscono particolari arrangiamenti e portano specifiche culture sistemiche. Non sono i singoli costituenti a definire i sistemi, non è insomma “il proprietario” a definire il capitalismo e la mancanza di proprietari a definire il socialismo. Diverse configurazioni aventi quali “emergenze sistemiche” differenti culture potrebbero invertire il quadro. Sono le condizioni particolari a decidere. Ma proviamo a considerare le idee di violenza anche avulse dalla logica sistemica: dopo i fatti di Genova molti duri e puri della distruzione quale atto libertario si sono sorpresi della presa di distanza dagli atti di violenza di larga parte del movimento e hanno manifestato nei confronti di questa parte la sprezzante sufficienza di chi, superati moralismi e pietismi retaggio di una cultura autoritaria, ormai psichicamente liberato, opera sulla realtà come “l’unico” di Stirner o, se preferite, “la magnifica bionda bestia” del suo figlioccio Nietzsche. I “pacifisti” del movimento vengono ironicamente descritti come vergini violate pateticamente facili a scandalizzarsi. Non si avvedono di giocare lo stesso ruolo ( e di fare la stessa figura) dei pacifisti violati di fronte a Troia fumante quando si scandalizzano davanti ai possessi e al possibilismo proprietario (che configura una Babilonia di peccato). Puro spirito gesuitico. La proprietà, si è detto, è la violenza continuata con altri mezzi. Se si è quindi disposti a immaginare la violenza in modo a-valutativo ma giudicabile di volta in volta in base alle contingenze in modo strumentale, allora non si vede perché ciò non debba essere un trattamento da utilizzare per ogni tipo di attacco agli altri, sia quando questo si configura come atto di aggressione fisica, che quando si manifesta in un atto privativo (la proprietà, appunto). La violenza non è “cattiva” di per sé, è pura energia vitale direzionata, parte del nostro repertorio comportamentale ed ha una preziosa funzione adattativa; lo stato, però, è violenza monopolistica e concentrata e ciò è negativo. La proprietà non è “capitalistica” di per sé, ma il capitalismo è un regime di sfruttamento basato sulla proprietà concentrata e monopolistica dei mezzi di produzione. Mutare le condizioni organizzative vigenti dovrebbe portarci a vedere le cose nella giusta neutralità.
La proprietà è come un coltello, ci
puoi tagliare il pane, ti ci puoi
difendere dagli altri, li puoi aggredire, ti ci puoi suicidare. Quale società
vi sembra più desiderabile? Quella in cui nessuno possiede coltelli tranne
l’elite che è abilitata a utilizzarli tutti come vuole e contro chi vuole, anche contro di voi? E’ la condizione
del socialismo autoritario. Quella in cui i coltelli neppure si fabbricano
perché si suppone che siano inutili e pericolosi e si impone il divieto di
fabbricarli e utilizzarli anche a chi li userebbe per tagliarci il pane? E’ la
scelta del socialismo libertario. Quella
in cui è garantito solo a pochi di fabbricare ed accumulare coltelli nonché
utilizzarli per minacciare gli altri ed indurli a lavorare per loro alla
costruzione di altri coltelli che i costruttori non useranno è la situazione
del capitalismo industriale, tanto quello imperante nelle nostre “democrazie
liberali”, tanto nel vagheggiato eden anarcocapitalista,
con l’attenuante, per quest’ultimo, che questo
sfruttamento non si realizzerebbe con l’aiuto delle istituzioni statali. Quella
in cui tutti sono liberi di costruire, usare e scambiarsi coltelli. Quest’ultima è sicuramente la situazione più libera, ma
anche la più desiderabile.
In quest’ultimo caso non c’è un aprioristica condanna per
l’oggetto ma un giudizio sulla funzionalità strumentale date specifiche contingenze.
Accoltellare chi se ne sta per i fatti suoi, ad esempio, ha altro significato
dell’accoltellare chi ci assale a pistolettate. In altri termini, la
violenza stessa può svolgere una
funzione biofila piuttosto che necrofila. Una
rivoluzione è un atto di violenza eppure i rivoluzionari la considerano in
genere uno strumento per raggiungere una condizione gradita. Così, come nel difendersi da un aggressore può essere utile
utilizzare il coltello in modo violento, anche la proprietà (violenza espropriativa) può essere utilizzata per la difesa da
poteri ed autorità che pretendono di insinuarsi nella nostra personale sfera di autorità. A violenza con
la violenza. Perfino il pacifico Mahathma Gandhi affermava che la “non violenza” ha senso solo
quando è una alternativa, cioè quando la violenza è possibile ma noi scegliamo
di non rispondere per spiazzare l’aggressore e disarmarlo (passività attiva),
non quando è l’unica soluzione a causa della nostra incapacità o impossibilità
ad essere violenti, quando cioè siamo al muro (passività coatta). Nei confronti dell’aggressione del capitale
monopolistico essere disarmati comporta la condizione di essere al muro e
condannati alla passività coatta. Solo armati potremo decidere se essere
violenti o non violenti, per scelta. Ad esempio, se una grande industria decide
di inquinare il fiume che passa dal mio giardino o se una istituzione
sovra-personale come un comune o uno stato decide di impiantarci una discarica.
Tutto ciò non gli è permesso se il giardino è mio. Sorge un problema, la
disparità fra possessori e non possessori di giardini. Ma il problema della
proprietà è, si è detto, lo sfruttamento (che nel possedere un giardino non
esiste) e non la diseguaglianza nel cumulo di
possessi, per quanto all’aumentare delle diseguaglianze
aumenti la possibilità di utilizzarle quale strumento di ricatto e
sfruttamento. In altri termini, se la proprietà è uno strumento offensivo come
un coltello e tutti hanno lo stesso coltello, le possibilità di sfruttamento
saranno minime e connesse più alla forza e alla abilità degli attori,
esattamente come avverrebbe in condizioni di “disarmo”, se però le condizioni agevolano l’accumulo di
strumenti offensivi troveremo una situazione affatto diversa, quella di uno o
pochi individui che possiedono cannoni e contraeree mentre le moltitudini sono equipaggiate
all’arma bianca o completamente espropriate del loro coltellino. Nella prima
situazione, se io chiedo a qualcuno di innaffiarmi il giardino dietro compenso
pattuito o dietro scambio di un bene perché a me l’idea di innaffiare giardini
non mi sconfifera, è una relazione di mercato libera,
un “rapporto economico fra adulti consenzienti” come diceva Nozick
anche perché, probabilmente, a questo tizio, per qualche insondabile motivo o
perversione, innaffiare giardini piace una cifra al punto da farne la sua
occupazione. Nella seconda situazione, quella in cui i giardini sono tutti
miei, gli altri sono giardinieri forzati che, mossi dal bisogno, aspettano con
ansia di essere acquistati da me per non morire di fame. Condizione quindi necessaria per una società
libera è la diminuzione delle condizioni di alterato potere contrattuale,
ovvero l’impedimento degli accumuli illegittimi. Ma questa forma di “socialismo”
non prevede che io livelli lo stile di vita del consorzio umano togliendo a
tutti tanto la proprietà quanto l’usufrutto (la “filosofia della miseria” di Proudhon), quanto il permettere a tutti di possedere
qualcosa e ciò può avvenire solo in un regime di scambio realmente libero, non monopolistico,
non diretto, non trustizzato. E’ in tal senso, io
credo, che Proudhon, il quale non era un liberista
come invece piace presentarlo agli anarco-capitalisti,
pur partendo dal presupposto della proprietà quale furto e quale elemento di
contraddizioni profonde – come è ovvio per ogni atto di violenza – riteneva che
il mercato e la concorrenza, più che elementi di contrasto al socialismo, ne
fossero fattori, date certe condizioni, favorienti.
Ma quali condizioni? Evidentemente quelle di un mutamento sistemico che assegni
nuovi e diversi significati, differenti ruoli agli attori sociali e ai loro
prodotti culturali, come la proprietà.
E’ infatti vero che la situazione ideale è quella in cui le condizioni
fossero tali che la necessità di costruire, utilizzare e scambiarsi strumenti
di offesa - così come le proprietà che ne sono
la versione raffinata - venisse meno (lo splendido “socialismo
volontario” di Rudolf Rocker) ma in una società in cui sia garantito il
libero scambio e in cui ogni individuo e associazione fosse attento a mantenere
tale scambio appunto libero, un sistema societario stabilizzatosi in uno stato
culturale differente, l’aspetto capitalistico propriamente detto, quello
centrato sull’accumulazione del capitale, sulla rendita e sulla rincorsa al
successo economico quale primaria motivazione culturale verrebbe meno. Ciò
conferirebbe all’economico il posto che gli compete nella vita degli individui
e della società, vale a dire il suo ruolo marginale di sfera fra le sfere delle attività umane e, come tutte le altre,
talvolta portatrice di fatti positivi, talvolta negativi, ma mai centrale,
focale. Questo mentre l’anarco-capitalismo prevede il
disciogliersi del politico nell’economico. Mi piace pensare che è in tal senso
che Berneri
parlava di “possibilismo” degli anarchici in economia. Lui non poneva il
liberismo quale fondamento della libertà, diceva solo che gli interessava molto
di più la lotta all’autorità che è più centrale, l’economico è residuale,
pertanto nel suo ambito tutto è possibile, senza pregiudizi. Questo è il
ritorno della subordinazione dell’economico al politico al quale, al più, può
fornire le condizioni per il suo miglior svolgimento grazie alle possibilità
libertarie insite nello scambio, ma nulla di più. Cambiare la struttura cambia
l’uomo e questi modifica fluentemente la struttura. In tal modo la proprietà
continuerà ad avere la sua funzione ma l’economico sarà scivolato in una
posizione tale che gli elementi più passibili di deriva “capitalistica” vengono
tenuti sotto controllo. In altri termini, non illudiamoci di mutare le cose se
non si creano le condizioni per un riassestamento sistemico. Per esempio,
tornando all’esempio del giardino, il problema vero sorge nel momento in cui
decido di darlo in affitto o di lasciarlo
in eredità al mio stirneriano figliolo. Nella rendita
e nella trasmissione ereditaria stanno le vere fonti delle grandi diseguaglianze nell’accesso ai beni che permettono lo
sfruttamento. Impedire queste storture non è in contraddizione con le premesse
libertarie perché se la proprietà è illegittima dal punto di vista giusnaturalistico ma legittimabile da quello strumentale,
la rendita e la trasmissione ereditaria (ovvero
proprietà senza lavoro) sono condizioni non naturali ma costruzioni
socio-culturali, illegittime tanto dal punto di vista giusnaturalistico
quanto da quello utilitaristico,
stratificazioni eliminabili. Mi faceva giustamente notare Fabio (Nicosia), l’anarcocapitalista
più intelligente che conosco, come l’eliminazione dei brevetti e dei copyrights basti da sola ad abbattere il “capitalismo”
storico, il sistema come lo conosciamo. Di simili stratificazioni invischianti
ce n’è un groviglio, sono i filacci di quel potere microfisico di cui si diceva. Ma abbatterle è possibile
solo grazie ad una profonda modificazione culturale e psicologica che non può
essere frutto di una rivoluzione violenta, fisica, ma psicologica. Quindi come
realizzare questa “rivoluzione cognitiva”?
Con la perturbazione del sistema! E come si realizza? Con la propria
vita, con le proprie scelte, con la propria propensione a vivere quanto più
possibile nella società che abbiamo come se fosse quella che non abbiamo,
adagiandoci negli spazi di libertà che resistono, forzandone le pareti quando
ci sbattiamo, dilatandone i limiti, slabbrandone le maglie di volta in volta,
sperimentando alternative, qualcosa di molto simile al concetto goodmaniano di “tracciare il limite” e quello, condiviso
con Colin Ward, di “allargamento degli spazi di libertà”, a
quello di Berneri
dei “programmi minimi” a carattere opportunista, a quello di Akim Bey sulle “zone temporaneamente autonome” da
colonizzare e difendere. Di Paul Goodman mi scappa una citazione che mi pare
appropriata:
Nel periodo del mercantilismo e delle patenti regie, la libera impresa gestita da società per azioni era anarchica. Il Bill of Rights jeffersoniano e l’autonomia del potere giudiziario erano anarchici. Le Chiese congregazionaliste erano anarchiche. La pedagogia progressista era anarchica. I liberi Comuni e le norme delle corporazioni nel sistema feudale erano anarchiche. Ai giorni nostri, il movimento dei diritti civili negli Stati Uniti è stato decentralista e anarchico in senso quasi classico. E potremmo continuare fino a cose infime, come il libero accesso alle biblioteche pubbliche. Certo, agli storici successivi questi fenomeni non sembrano anarchici, ma nei tempi in cui si verificarono erano visti come tali e perfino chiamati così, e come al solito bollati con l’orrenda accusa di provocare il caos. Ma questa relatività del principio anarchico rispetto alla situazione esistente ne rappresenta una parte essenziale, non può esserci una storia dell’anarchismo che definisca “anarchico” uno stato di cose divenuto permanente. E’ un continuo misurarsi con una nuova situazione, una vigilanza continua per garantire che le libertà passate non vadano perdute, che non si trasformino nel loro opposto, proprio come la libera impresa si è tradotta nella schiavitù del salario e nel capitalismo monopolistico; l’autonomia del potere giudiziario nel monopolio dei tribunali, dei poliziotti e degli avvocati; e l’autonomia didattica negli apparati scolastici.
Aggiornando potremmo dire: internet è stata anarchica
in senso più che classico, configurando il sogno proudhoniano
di un mondo in cui “il centro è ovunque e la periferia in nessun posto”, finché
multinazionali, governi e copyright non ci hanno messo le mani nel tentativo di
“riterritorializzare” ciò che era “nomade” (uso il
vocabolario di Deleuze
e Guattari,
i migliori allievi di Foucault). Esistono però ancora
spazi (come il nostro) per discutere questioni importanti e vedute non
ortodosse, ambiti di nomadismo residuale, fiammelle di autogestione; che
facciamo, buttiamo tutto all’aria con la solita vecchia logica del “tanto peggio, tanto meglio” tipica del
“cretinismo anarchico” di berneriana memoria o
decidiamo di fare di questi luoghi delle “isole nella rete” temporaneamente
autonome secondo lo sputtanatissima ma valida
definizione di Bey? Espandere l’anarchia e l’autogestione che già esistono in nuce nella nostra società invece di adeguarsi a
fallimentari e patetici millenarismi in salsa apocalittica è via praticabile
per cominciare a vivere la libertà qui, ora e non rischiare di vederla mai e in nessun posto. Tutto ciò è quanto di più adatto ad un mondo
di potere impersonale ed interstiziale, microfisico
come quello descrittoci da Foucault, un mondo di
lotte parziali. Chiunque per motivi
religiosi storca il naso davanti a
questa prospettiva sta confondendo i mezzi con i fini, altro storico errore
anarchico. Quando la corrente anarcosindacalista
promuove l’autogestione delle aziende da parte dei lavoratori, pone questo
obiettivo come un fine, quello di una
società ed una economia autoregolata. Ma le
aziende, per quanto autogestite, permarrebbero in una
situazione di concorrenza, peraltro difesa anche da Proudhon,
e questo inevitabilmente porterebbe al successo di alcune ed al fallimento di
altre con la conseguenza del ricrearsi delle disuguaglianze. L’autoregolazione non
è “la fine della storia”, una condizione di omeostasi. Non esiste una “condizione anarchica” ma un
“agire anarchico”. Non c’è, girato l’angolo della rivoluzione, il bengodi di
cornucopie straripanti di libertà e canditi. L’essere “autocrati di se
stessi” non è pertanto il mezzo che
porterà alla società perfetta, alla “città del sole”, è invece il fine, la riconquista psicologica della individualità,
la riscoperta di quel gestire che produce l’Io, la riconquista del Soggetto.
Perché non è il gestire ad essere funzione dell’Io, ma il contrario. La
“società anarchica”, totalmente autoregolata, è una
finzione, come dire “la salute” o “la follia”, cioè l’estremo di una retta
infinita che serve a definire la nostra posizione relativamente a tali estremi,
un faro mentale, non un traguardo da raggiungere, quindi una condizione
statica, ma un processo di costruzione infinita e progressiva, non un fine
materiale. I fini devono essere psicologici (la ricostruzione della soggettività),
materiali sono solo i mezzi (lotte personali o collettive) o i fini parziali
(le ipo-soluzioni). La realtà è che la società anarchica non è il paradiso in
terra, non l’utopia della armonia totale, della anarchia (intesa come progetto
organizzativo) come fine. L’anarchia, come approccio mentale e modus operandi e vivendi, è insieme mezzo e
fine. Per dirla sempre con Berneri, la libertà è come l’orizzonte, si allontana man
mano che cerchiamo di raggiungerla. Una società libera non può essere staticità ma
movimento, progresso, prodotto e produttrice di uomini in liberi e
“processuali”, non sclerotizzati e monolitici (unidimensionali, diceva Marcuse) come quelli che sono il
prodotto tanto della società dei consumi quanto delle fedi ideologiche, quelle
anarchiche (socialiste e capitalistiche) incluse. Se la filosofia politica è
storicamente teoria della conquista (socialismo) o della gestione (democrazia
liberale) del potere, l’anarchismo è ipotesi di conquista di sé e autogestione,
pratica a-teorica del superamento del potere. Si tratta, per tornare per
l’ultima volta al campo epistemologico, di abbandonare l’idea galileiana ed induttiva di un metodo per la conoscenza e la
pratica (iper-soluzione) per abbracciare
definitivamente l’epistemologia dadaista di Paul Feyerabend, il divulgatore dell’
”anarchismo metodologico” , ovvero dell’idea che tutto procede né per disegno
né per evoluzione né per dialettica ma assolutamente per caso. Il suo motto era
“everything goes” , tutto
va bene; la buona maggioranza degli avanzamenti scientifici non è affatto
frutto di organizzate visioni e piani metodologici ma del caso, della “serendipità” e, spesso, della assoluta mancanza di rigore.
Concetti che riteneva estensibili alla società che teorizzava libera, laddove Popper si limitava a immaginarla “aperta”. Un life
style-anarchism, come lo definisce criticamente Bookchin che ha sicuramente più chances
di produrre mutazioni psicologiche e culturali di qualunque azione strategica
sua o di un Malatesta perché più in grado di
produrre perturbazioni del sistema cui seguano riassestamenti stabili e utili.
Perfino più “socialistiche”. Socialismo e capitalismo sono solo attributi
sistemici; come arrangiare i sistemi è
la occupazione del libertario, non perseguire, armati di libretto rosso e
versetti coranici, la distruzione del tempio o la
santificazione dei sacramenti. Serve una rivoluzione iconoclastica e
psicologica che inizia col buttare a mare gli idoli e l’abbattere le cortine
fumogene religiose nelle nostre menti (accomodare ed assimilare, secondo Piaget). Un’ opera di scarnificazione delle costruzioni
culturali, di abbattimento dell’ episteme per
recuperare quell’ ethos
da cui siamo partiti. Un’idea talmente non anarchica, nel suo senso
tradizionale, da risultare straordinariamente anarchica.