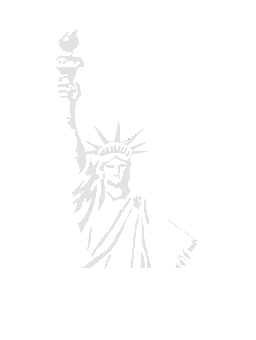 Apparso sul “Corriere
della Sera” del 22 maggio 1971, il
seguente articolo di Enzo Bettiza rimane ancora oggi
una bella introduzione alla figura di Andrea Caffi, che del giornale di Bettiza (rinunciando tuttavia presto all’incarico) fu
inviato all’epoca della guerra civile in Russia. Ci piace ricordare che a
Genova, a cura del circolo Gobetti, di questo amico di Chiaromonte,
Camus, Faravelli, McDonald,
Tasca, fu pubblicato, proposto da Salvatore Rotta e con la prefazione di Chiaromonte, un volumetto (I Socialisti, la guerra, la
pace, 1958) assai prima che Azione Comune, nel 1964, pubblicasse
l’antologia (riproposta nel 2011 dalle edizioni di Una Città) Socialismo
libertario curata da Gino Bianco –
ricercatore presso l’Università di Genova e corrispondente da Londra dell’
“Avanti” - e che da Bompiani uscisse,
nel 1966, Critica della Violenza.
Apparso sul “Corriere
della Sera” del 22 maggio 1971, il
seguente articolo di Enzo Bettiza rimane ancora oggi
una bella introduzione alla figura di Andrea Caffi, che del giornale di Bettiza (rinunciando tuttavia presto all’incarico) fu
inviato all’epoca della guerra civile in Russia. Ci piace ricordare che a
Genova, a cura del circolo Gobetti, di questo amico di Chiaromonte,
Camus, Faravelli, McDonald,
Tasca, fu pubblicato, proposto da Salvatore Rotta e con la prefazione di Chiaromonte, un volumetto (I Socialisti, la guerra, la
pace, 1958) assai prima che Azione Comune, nel 1964, pubblicasse
l’antologia (riproposta nel 2011 dalle edizioni di Una Città) Socialismo
libertario curata da Gino Bianco –
ricercatore presso l’Università di Genova e corrispondente da Londra dell’
“Avanti” - e che da Bompiani uscisse,
nel 1966, Critica della Violenza.
Enzo Bettiza
la parabola di un
socialista
Sembrano diverse le ragioni che
hanno tenuto finora lontana una parte del pubblico colto da Andrea Caffi. Una è
d'ordine pratico. La frammentarietà dei suoi scritti, sparsi per l'Europa, e
riordinati a poco a poco con affettuosa pazienza da amici ed estimatori quali
Nicola Chiaromonte, Aldo Garosci,
Lamberto Borghi, Gino Bianco, consente a chi non conobbe personalmente l'uomo
di poterne afferrare solo per gradi la complessità e l'originalità del
pensiero: un pensiero, del resto, che non essendo mai fuori ma sempre dentro la
vita e che avendo della vita anche una certa frammentaria enigmatica
indefinitezza, costituzionalmente si negava all'imbalsamazione accademica.
Ora, dopo i saggi storico-filosofici di Caffi, curati da Chiaromonte
su “Tempo Presente” e poi pubblicati
da Bompiani nel 1966 con il titolo Critica
della violenza, seguono presso i'editrice Nuova Italia, presentati da Gino
Bianco i preannunciati Scritti politici
che ne sono il completamento. Si definisce così meglio la fisionomia geniale di
un outsider dello spirito che, per chiarezza di stile, rettitudine morale, novità
d'analisi, velocità di riflessi culturali, lascia ad ogni pagina convinto e
insieme turbato il lettore. Leggere Caffi, oggi, è un'operazione profilattica
contro le epidemie pseudofilosofiche che inquinano l'aria che respiriamo più
della nafta e dei detriti industriali.
Per un quarto veneto, per un altro russo e per la restante metà cittadino del
mondo, Andrea Caffi presentava un modello biografico in perfetta sintonia con
la sua cultura: entrambi irrequieti, mobilissimi, plurinazionali, poliglotti aperti
al relativo e ai rischi di libertà che corrono i pensieri e le vite senza
dimora fissa in luogo anagrafico e ideologico. Prezzolini, che ebbe Caffi fra i
collaboratori alla “Voce”, lo
descriveva così venticinquenne: "Arrivava all'improvviso, non si sapeva da
che parte del mondo, con gli abiti sgualciti e l'aria di avere un grande
appetito. Scompariva allo stesso modo, senza che si sapesse perché né per dove.
Da per tutto portava la sua gentilezza, un'aria d'innocenza, un enorme fascio
di erudizione che slegava e da cui traeva regali a qualunque richiesta”.
Nato a Pietroburgo nel 1887, divenne, ancora adolescente, socialista e nella
clandestinità lavorò al fianco di Kalinin e di
Molotov. Diciottenne prese parte alla rivoluzione del 1905, conobbe le carceri
dello zar. Partecipò alla grande guerra sui fronti francese e italiano,
rimanendo ferito due volte. Tornato nella Russia dei Soviet, si mise in
contatto con la sinistra menscevica di Martov, fu
imprigionato alla Lubianka e all'ultimo momento
sottratto da Angelica Balabanoff ad un plotone
d'esecuzione bolscevico. Poi, di nuovo in Italia, collaborò nello stesso tempo
al “Quarto Stato” di Pietro Nenni e
di Carlo Rosselli e alle “Ricerche
religiose” di Ernesto Buonaiuti.
La sera andava alla russa al popolo, nei vecchi quartieri romani, parlando di storia greca e conquistando proseliti alla causa del socialismo. Nel 1926 si stabilì in Francia dove divenne membro simultaneo dell'emigrazione socialista russa e di quella italiana. A partire dal 1936 iniziava a frequentare Modigliani, Saragat, Tasca e Faravelli. La sua collaborazione con Angelo Tasca segnava anche un'adesione alle posizioni politiche che quel gruppo, il più lucido e spregiudicato dell'emigrazione antifascista, esprimeva: le riserve nei confronti dell'ambigua unità d'azione con i comunisti nei fronti popolari, il rifiuto dello stalinismo e delle alleanze di vertice con esso, la battaglia per l'autonomia del movimento socialista.
Sempre visse in condizioni di
povertà volontaria, in certi momenti di miseria, fino alla morte avvenuta il 22
luglio 1955 all'ospedale parigino della Salpetrière.
In Andrea Caffi, definito di volta in volta "spirito arcangelo”,
"strano tipo”, "povero e prodigo”, si combinavano sotto la superficie
cosmopolitica due grandi tradizioni di verità: quella del pensatore socratico,
che si donava parlando più che scrivendo, e quella del narodnik
russo del diciannovesimo secolo, animato da un'ansia pedagogica e di redenzione
sociale intollerante d'ogni barriera tra la privacy dell'uomo di pensiero e il
tumulto del mondo. L'idea di "società”, nel senso quasi più religioso che
laico che l'intelligencija populista dava al termine,
era preminente in lui. Il nucleo esistenziale della sua personalità fu quello
di un filosofo peripatetico che aveva dialogato con Herzen,
che aveva trasformato in Peritato la Russia e l’Europa intera e che era
disposto, fra la malafede intellettuale e la cicuta, a scegliere sempre
quest'ultima. Fu qui il vero significato etico della sua socievole solitudine e
della sua programmata e francescana nudità nella vita quotidiana.
Vorremmo soffermarci soprattutto sul saggio che apre gli Scritti politici, La
Rivoluzione russa e l'Europa, di cui Pero Gobetti disse che era il più
importante e serio scritto che fosse apparso in quegli anni sull'argomento.
"Quegli anni” erano il 1918: scritto datato, dunque, ma che colpisce
subito per la sua illuminante attualità. Mentre Gramsci e Bordiga
divulgavano una loro immagine di maniera del Bolscevismo, Caffi sezionandolo
dall'interno, anticipava già con una impressionante esattezza analitica tre
anni prima della deliberazione "antifrazionistica” imposta da Lenin al X
congresso del partito, certe conclusioni sul fenomeno russo alle quali la più
sofisticata sovietologia doveva arrivare molto più tardi.
Caffi non aveva nessuna simpatia per l'élite bolscevica impadronitasi del potere. Faceva anzi una distinzione sociologica e psicologica fra gli idealisti che avevano alimentato il movimento socialdemocratico russo e i personaggi avventurosi, pragmatici, spesso del tutto insensibili alle idee, assetati di comando, che erano stati affascinati dalle proposte rivoluzionarie aristocratiche e temerarie di Lenin. Egli, che aveva conosciuto bene i capi bolscevichi come militante socialista, non si faceva illusioni: fino dal 1905 aveva intuito la rottura che Lenin doveva, anzi voleva rappresentare, nella tradizione del socialismo non solo russo ma europeo.
Con Chiaromonte,
la cui forte e appartata opera di pensatore s'è nutrita ai dialoghi caffiani, potremmo dire che Caffi vide subito nel leninismo
trionfante l'evento che sconfigge l'idea. La sua critica non era però
partigiana, andava al fondo della questione e coinvolgeva, con il bolscevismo,
anche il mito burocratico e il marxismo-hegelismo statocratico
del capostipite dei "partiti moderni”, la socialdemocrazia tedesca: fra Ebert e Noske che aprono il fuoco
sugli operai di Berlino, e Lenin e Trotckij che
"tirano ai fagiani” di Kronstadt, egli scorgeva
la stessa parabola di una idea sconfitta dalla ragione di Stato. Ma, nel
medesimo tempo, scorgeva, con acutissima oggettività, le ragioni e
l'inevitabilità del successo bolscevico. Anche Caffi, come Vojtinskij
e come Ashub, usava quella serenità di giudizio del
menscevico perdente nei confronti del bolscevismo che i bolscevichi vincenti
non useranno mai, neppure mezzo secolo dopo la rivoluzione, nei confronti del
menscevismo. Già allora egli notava la straordinaria "capacità dimostrata
dai bolscevichi nel dare un centro intelligente alla sfrenatezza delle masse
russe”.
L'inerte vuoto di potere, apertosi fra il 5 e il 17 novembre 1917, mentre
l'iniziale trionfo dei socialrivoluzionari finiva nel
burlesco con Kerenskij in fuga travestito da donna,
poteva essere occupato in quel momento solo dalla specifica tradizione
culturale, politica e organizzativa del gruppo d'azione leninista. Soltanto chi
come Lenin in quel frangente seppe mettersi in sintonia con "la
sfrenatezza delle masse anarchiche e pacifiste, optando per una
"utilizzazione quasi cinica delle contingenze”, poté sostituire il proprio
gruppo organizzato e inesorabile al potere vacante. Lo spazio e il tempo
preconizzati dal gradualismo menscevico s'erano violentemente contratti. I
Girondini della rivoluzione russa apparivano sconfitti quasi prima d'averla incominciata.
Nel momento supremo dell'anarchia, dello sfacelo dei resti del Governo
Provvisorio, non erano né gli ideali socialisti né le analisi marxiste che
potevano servire a Lenin per dominare la situazione: gli servivano benissimo
invece la spietata demagogia giacobina, il
pragmatismo blanquista, sommandosi alle tradizioni
del libertarismo russo di Bakunin e di Lavrov.
Ma la verità viene tanto meglio fuori dal discorso di Caffi quanto esso è meno
ideologizzato. La grande forza culturale e anche filosofica dello scrittore è
di parlare dei fatti attraverso i fatti: essi, nella sua analisi, vivono
liberi, dilatati, enigmatici e tuttavia inevitabili come la vita stessa. E'
questa visione della storia, o meglio questa percezione immediata della storia
nell'ambiguità dell'evento, che conferisce ancora oggi una rara potenza
interpretativa ed evocativa al dramma russo colto da Caffi sul vivo, nel 1918.