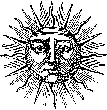 Jean
Montalbano
Jean
Montalbano
Bouvier sulla strada
Un
articolo sull' Illustrato Fiat del 1955 firmato Nicolas Bouvier
ed intitolato Viaggiare...lentamente rappresenta forse il primo testo
italiano dello scrittore ginevrino: corredata da foto scattate durante il
viaggio ma soprattutto da una posa immortalante uno sciccoso Bouvier appoggiato alla sua Topolino nel salone Fiat di
Bombay (gestito da un conte fiorentino) la pagina riporta per brevi cenni
l'impresa di Bouvier e Vernet
cominciata a Ginevra due anni prima con il necessario per dipingere, un
registratore Nagra, una fisarmonica, una chitarra,
una macchina da scrivere, oltre il solito bagaglio (ed un buon numero di
lettere di presentazioni tra cui quelle di Ella Maillart)
tutto stipato in una Fiat 500 A con alle spalle già due proprietari e più di
40.000 chilometri. Il duro viaggio attraverso Jugoslavia, Anatolia, Kurdistan,
Iran e Afghanistan dei due amici di una vita può dirsi concluso in vista del
subcontinente indiano perché il pittore Vernet volerà
a Colombo (Ceylon) dove l'aspetta per sposarlo la
fidanzata Floristella mentre lo scrittore e fotografo
Bouvier, malconcio per ricorrenti febbri, dopo Kabul
si sposterà a Delhi e Bombay per far revisionare (gratuitamente: altri tempi)
l'altrettanto disastrata Topolino e tirare su un po' di grano con articoli e
conferenze, prima di raggiungere i freschi sposi.
Le
soste nelle città per "riprendersi" occuparono gran parte del viaggio
assaporato con lentezza. Tappe ed oasi in cui ci si "riempiva" come
cammelli e si imbastivano piccoli lavoretti (articoli per la stampa locale,
esposizioni o addirittura esibizioni) resi possibili o facilitati anche dalla
nazionalità elvetica e dalla fitta rete di istituzioni culturali di lingua
francese. Frequentazioni (e fermate) non dettate da scelte populiste ma perlopiù
dalle necessità (ristrettezze) della borsa e geopolitica appresa sulla propria
pelle se, appena messo piede in India, Bouvier
avvertirà la fine dell'egemonia francese e dovrà arrendersi alla tecnica
dilatoria anglo-indiana.
Il
massiccio tomo (oltre 1500 pagine) di corrispondenza tra Bouvier
e Thierry Vernet, che le Éditions Zoé pubblicano, Correspondance des routes croisées, copre il
ventennio dal 1945 al 1964, dettagliando occupazioni creative o attività
alimentari, frequentazioni, preferenze e ripulse, dalle confidenze e dagli
ultimi fuochi adolescenziali fino alla data di pubblicazione in Francia del
libro che, dopo otto anni di elaborazioni e ripensamenti, tra le braci
controllate delle maturità, concluse, per così dire, la scoperta dell'oriente. Dal
1945, allorché il futuro contempla "altrettante possibilità quante sono le
strade su di una cartina Michelin" al 1964 che nel libro-ricordo prolunga
il gran viaggio e ne riattiva i benefici.
Stupisce
in soggetti così giovani la determinazione a farsi strada forti del consapevole
possesso di doti ed ingegno ma pure, riflettendovi, del contesto parentale, di
tradizioni rivendicate prima che ripudiate, di un "capitale sociale"
cui ricorrere quando qualche porta si ostinava a restare chiusa. Facile
richiamare l'educazione ginevrina ed accusare un vizio precoce di autoanalisi
quando si legge il giovane Bouvier scrivere
all'amico:"Dobbiamo batterci per non essere mediocri". Ma sarebbe
trascurare le segrete fedeltà che tengono lontato
l'orrore della maturità riuscita e finita, quelle tradite e rimpiante tra le
righe di un Bernanos subito sottolineato: "Ma il
più morto dei morti è il ragazzino che fui".
Prontamente
complici negli anni del collegio, i due sognarono viaggi e avventure senza
nessuna esibizione di marginalità o rottura urlata con l'ambiente d'origine e
comunque Bouvier prima dovrà addottorarsi in lettere
e diritto (per qualche tempo penserà pure di trasferirsi a Genova per studiarvi
diritto marittimo ospite di "casa Schiaffino") mai perdendo di vista
la stella che ne orienterà la vita:
partire
per sottrarsi alla pesantezza borghese e all'incasellamento professionale,
verificando i viaggi infantili compiuti su libri e atlanti (il padre di Bouvier, bibliotecario, non gli fece mancare i giusti
stimoli) mentre la scrittura opererà lo scioglimento e la risoluzione, ad un
superiore livello, dei motivi e spunti di partenza. Non tanto viaggi di
piacere, le puntate solitarie o in gruppo in Nordafrica
o Lapponia saranno solo un assaggio delle strade polverose del biennio '53-'55
cui tacitamente verranno commisurati i dubbi e le ambizioni successive. Bouvier, già di ritorno a Ginevra dalla Finlandia (1948) si
sente come l'Hurone di Voltaire, che con le sue
domande mette a disagio chiunque, arrivando a confidare: "è come se avessi
sulle spalle un sacco di cose incomprensibili da chiunque". E Vernet che ha già interrotto gli studi per saltuari lavori
artistici (incisione e disegno) da Parigi lo rincuora confidandogli:
"forse il mio solo titolo di gloria sarà di averti conosciuto" ma
pure lucidamente sottolineando: "il principale obbiettivo non è arriver, aver successo, ma mantenere le promesse
fatte a diciassette anni". Il reciproco sostenersi ed incoraggiarsi vale
come antidoto al comune timore che, con l'usura della vita ed un fatale
cedimento, ci si accontenti di "ciò che non si voleva essere" (parole
del conterraneo Ramuz). A contrappunto dei rari
momenti di "ottusa" salute, segnali di sventatezza ed inquietudine,
che li esiliano dal focolare protettivo e risanatore, punteggiano le lettere,
come quando la "perspicace morfina" (somministrata a Bouvier per l' intervento ad un ginocchio durante il
servizio militare nel "formidabile esercito svizzero") viene definita
"mirabile accessorio per la conoscenza".
Ma
lungo l'intero scambio di messaggi restiamo ammirati per la qualità delle
scelte e la sincerità dei proponimenti che i due amici si confidano. Se
ascoltano Bach, allora è quello diretto da Scherchen,
se leggono di cinema sono le recensioni di Truffaut
su Arts e se ci vanno, al cinema, sarà
per segnare il distacco dalla moda esistenzialista. Così dopo la visione di un
film tratto da Sartre: "l'unhappy end
sistematico dei Francesi comincia a rompermi. Lo scacco come tesi,
l'incomprensione come insegna..." fino a riconoscere che certo "gusto
del pavé" di solito abbonda tra chi "vive sulle moquettes".
Come si sarà intuito, circola, per tutte le pagine un'aria che interroga e
confonde la pigra spocchia di chi ancora si contenta del motto usurato di
Greene, messo in bocca a Welles, sugli svizzeri "solo" creatori di
cioccolato e cucù.
Per
Bouvier, il viaggio apporta la rivelazione e
certifica che i ponti ormai sono tagliati e la distanza tra la famiglia e il
lavoro scelto (la scrittura) si è fatta troppo grande. Così, senza recriminazioni
e senza addossare colpe, mentre ammette gli smacchi ed i colpi ricevuti
riconosce che quella "crudeltà" scoperta viaggiando c'è, esiste ma
che poi, al di là, c'è pure dell'altro ovvero "quella poesia mongola ed
invernale, dei riflessi azzurri inauditi sulle moschee, che salvavano ogni
cosa, per sempre". Oltre che trarre un senso ed una conoscenza di sé
attraverso lo scrivere, il difficile sarà proprio dire quest'altra cosa,
facendola intuire a chi è rimasto a casa; arduo sarà giusto distillare del
"lirismo produttivo" a partire dalla propria solitudine (scriveva da Ceylon).
L'Usage du monde (che in Italia fu reso
disponibile dall'editore Diabasis) venne subito
pensato come prolungamento stampato del comune tragitto, nascendo e
cristallizzandosi (testo, suoni e disegni) durante il percorso da Belgrado a
Kabul.
Il
Bouvier che tentava di piazzare articoli al ritorno
da ogni fuga sapeva, dapprima oscuramente, che il viaggio non si basta,
tendendo a concludersi sulla pagina scritta dopo una spesso faticosa e paziente
decantazione. Non dire parola, dopo essere andati, è voltare le spalle alla
stessa impresa, tradendo l'intenzione e le doti personali (scrivere, dipingere,
fotografare) che consentono di incorporare e comunicare l'evento.
L'incompletezza
del solo andare chiama alle fatiche della messa in forma esigendo per sovrappiù
la trama di un libro totale da cui niente sia escluso. Il viaggio rifatto in
pagina sarà informazione, presentazione e narrazione allo stesso tempo.
Superate
le molte perplessità ed i ricorrenti tentennamenti su quanto sia da
"bottegai" l'ostinarsi a trarre partito da ogni cosa e le tentazioni
di lasciar perdere tutto, il libro giustificherà fondatezza e decisione di
partire e varrà come ringraziamento e lode del mondo e delle sue bellezze.
L'occhio
è sempre occhio che scrive (François Laut) e
l'imperativo estetico prevale (anche nei successivi Pesce-Scorpione o
nella Cronaca giapponese) sulla fedeltà autobiografica. Il profitto
simbolico è parte del viaggio.
Dunque
non ci sono viaggi di piacere e viaggiare erode un poco, distrugge e dunque
allena alla sparizione (è accettazione della perdita e limatura di sé, giusta
la nota immagine della saponetta-osso di seppia levigata dall'uso); è il
viaggio stesso a vantare il diritto di distruggerci, consumando e disperdendo
le piume (vanità) del pavone dopo averci sradicato, col rischio pressoché
scontato di restare, terminato il viaggio, con " l'insufficienza centrale
dell'anima " che è forse il nostro motore più sicuro.
Questo
è forse l'aspetto più problematico delle riflessioni di Bouvier
e travalica l'argomento su cui si dilungano le pagine della corrispondenza:
nonostante qualche mente fuorviata tuttora si illuda di incontrare il divino
nei deserti algerini, quanto valgono ancora certi ripetuti appelli alla
passività, alla fragilità, al vuoto, alla cancellazione di sé oggi che la via
dell'autoflagellazione e dell'occultamento del punto di vista europeo si rivela
compiutamente impotente, dopo decenni di entusiastiche pratiche ascetico-buddistiche?
Ma
sarebbe caricare di troppe intenzioni la pagina asciutta e limata del Bouvier che sottolinea di cercare il mondo "nella
trasparenza e semplicità originali", lodando "la trasparente evidenza
del mondo... la quieta coappartenenza".
Lui
si limitava a raccontare la terra e ad amarla incitando a percorrerla in
profondità.