Da “Prometeo” nn. 1 e 2 del gennaio e febbraio 1924. Sono
i primi due numeri della rivista che Amadeo Bordiga, in via di esautoramento
nel suo stesso partito, fece uscire a Napoli nel gennaio del 1924. Ancora quell’anno
(Conferenza di Como) la maggioranza sarà favorevole alle sue tesi (“la
Sinistra”) ma già alla fine (Congresso di Napoli) la situazione volgerà a suo
sfavore. “Prometeo”fu presto
considerata, dalla nuova linea del partito, una rivista “frazionista”. La
testata fu ripresa all’estero da coloro che si ispiravano alla “Sinistra
comunista italiana” e poi ancora, alla fine della guerra, nel 1946, con un “Tracciato di impostazione” dello
stesso Bordiga, ma furono altre testate (“Programma Comunista”, per esempio) a
raccoglierne poi l’eredità. Inserito
di solito malamente fra i protagonisti del XX secolo, perlopiù episodicamente o
solo in relazione alla diffusione del mito rivoluzionario russo, Amadeo Bordiga
gode di scarsa reputazione sotto il profilo del contributo intelletuale,
relegato con sufficienza nel novero del settarismo determinista. Niente affatto
epigono del successo bolscevico, Bordiga, nella sua rottura col vecchio
socialismo, ne rappresentava in realtà l'estrema difesa di contro all'appiattimento
parlamentaristico e alle concezioni soreliane e volontaristiche - e in questo
senso, andrebbe aggiunto, anche contro il leninismo, per quanto si ostinasse a
difenderne una supposta antica purezza. Estraneo a ogni forzatura del conflitto
sociale e a soluzioni immaginose, nel perseguimento della chiarezza dottrinaria
- seppur fra ovvie rigidità ma anche senso dell'umorismo - Bordiga delineò di
fatto, se così si può dire, una "teoria critica" in lingua italiana.
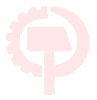
Amadeo
Bordiga
il
movimento dannunziano
I. La Dottrina
Pochi degli odierni movimenti politici italiani si preoccupano di fornire ad amici e nemici gli elementi atti a definirne con chiarezza le opinioni, i metodi e gli obiettivi. Un marxista può studiare i movimenti politici trovandone le spiegazioni indipendentemente dai loro testi e dichiarazioni ufficiali, come ad esempio si spiega marxisticamente la Rivoluzione francese facendo tabula rasa delle tesi storiche e sociali contenute nella Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e nelle ideologie politiche che quella rivoluzione rivendicano ed esaltano, ma certo un primo aspetto dello studio deve consistere nell’esaminare come ciascun partito ed aggruppamento ufficialmente annunzi il proprio pensiero e la propria politica.
Volendo prendere ad esaminare il movimento “dannunziano” (di cui consideriamo, per intanto pacifica questa ortografia), possiamo dire di disporre di qualche soddisfacente elemento autentico, per quel che riguarda la dottrina politica; di molto meno per ciò che si appartiene all’orientamento pratico e tattico attuale nel quadro della vita italiana. Cominciamo a considerare la prima questione, e ad avvalerci per questo del documento che i militanti del dannunzianesimo non cessano di rivendicare come il loro Evangelio politico: la Carta di Libertà del Carnaro, ossia lo Statuto dello Stato libero di Fiume, promulgato dal Comandante Gabriele D’Annunzio l’8 settembre 1920.
Non intendiamo trattare qui il “problema Fiumano” (su di esso chi scrive ebbe ad esporre qualche idea dopo una visita alla città avvenuta nel 1921, dunque dopo la partenza di D’Annunzio, in un articolo Fiume e il proletariato apparso nella Rassegna Comunista del 15 settembre 1921) né invocare contro il carattere asserito di filoperaismo della Costituzione suddetta i torti usati ai lavoratori dal regime della Reggenza. La Carta del Carnaro è considerata oggi dai dannunziani come un programma politico “per l’Italia”: ed anche in questo non saremo tanto poco imparziali, d’altronde, dal fondare obiezioni su disposizioni di dettaglio particolarmente adatte ad uno Stato così sui generis come era quello di Fiume. Noi domandiamo, e troviamo nella Carta, un testo riconosciuto da cui si possa desumere, per discuterla, una dichiarazione di principii politici, cominciando, per discuterla dal “classificarla”.
La Carta dichiara la sua tradizione storica con richiami alla Romanità imperiale, a generici concetti religiosi, al Risorgimento italiano, alla vittoria italiana nella guerra mondiale, e per qualche parte ai liberi comuni medievali. Troppi elementi storici, dunque; e per orizzontarci preferiremo l’esame oggettivo del suo contenuto politico e sociale. E non possiamo non preoccuparci di un’affermazione che ha molto... circolato: che lo Statuto Dannunziano abbia quasi dei caratteri soviettisti, che rappresenti una applicazione latina, in un certo senso, delle conquiste della rivoluzione russa, e di un’altra asserzione meno arrischiata, che rivesta certe linee di sindacalismo, come è stato sostenuto nel suo Comento da Alceste de Ambris, collaboratore di D’Annunzio, e capo di quel sindacalismo italiano secessionista che costituì nel 1915 la Unione Sindacale Italiana di tendenza interventista, ma anche prima della guerra aveva tenuto atteggiamenti assai poco classisti. Diciamo subito come, a nostro giudizio, va classificato il documento che consideriamo: si tratta di una costituzione chiaramente “democratica” nei suoi fondamenti, integrata da quelle misure di riformismo sociale che sono da decenni il bagaglio dell’estrema destra operaia e sedicente socialista. I principii della costituzione sono quelli della rivoluzione borghese, sottolineati nella luce ideale in cui sempre li hanno visti gli elementi di sinistra della democrazia.
Talune sue norme codificano le richieste di carattere sociale del proletariato, che non sono inconciliabili con un regime politico democratico, e, parallelamente, con un’economia capitalistica, se pure appaiono audaci. Gli elementi di originalità, se ve ne sono, non possono essere accettati come un avvicinamento alle concezioni rivoluzionarie, anche se si ammettesse il discutibile punto di vista che esista un quid medium tra una democrazia borghese avanzata e il regime della dittatura del proletariato di cui ora dovremo ricordare i caratteri distintivi e specifici.
I principii di democrazia “classica” si ritrovano, soprattutto, all’art. IV laddove è detto che la reggenza si fonda sulla “sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingue, di classe, di religione”. Più oltre terremo conto delle parole immediatamente successive sui “diritti dei produttori”. Quei principii sono ribaditi agli artt. V, VI, VII (libertà di pensiero, di stampa, di riunione, di associazione, di culto). Potrebbe sembrare una eccezione a queste norme quanto è sancito dagli artt. XXXXIII e seguenti sulla possibilità della elezione di un dittatore (detto il Comandante), ma non saremo certo noi a stupire che ogni democrazia, anziché nella vera realizzazione terrena delle divine figure che si denominano Libertà, Eguaglianza, Fraternità, vada a sboccare nei proconsolati. Può essere un atto di sincerità il dichiararlo nella carta costitutiva.
Le rivendicazione della democrazia di sinistra sono tutte contenute nello Statuto. Così per il voto alle donne (XVI), la nazione armata (XXXXVII e seguenti), il suffragio universale e la proporzionale (XXIX), l’istruzione popolare e la laicità della scuola (LIV), il voto ai soldati, i principii di iniziativa, referendum, petizione, la revocazione e responsabilità dei funzionari.
Indichiamo ora le più note rivendicazioni di carattere sociale e riformistico, come il minimo di salario, unito alla garanzia statale contro la disoccupazione, l’assistenza agli infermi ed invalidi, le pensioni di vecchiaia (art. VIII), la statizzazione del Porto e delle ferrovie, i collegi di arbitri tra lavoratori e datori di lavoro, o Giudici del Lavoro (art. XXXIX).
Qualche altra norma è presa a prestito da programmi di altre tendenze, anche se in contrasto con talune nelle disposizioni indicate, come certi accenni liberistici e il principio di affrancamento del porto, che possono sembrare mal conciliabili con un indirizzo economico di intervento statale nelle vertenze sindacali e di statizzazione di talune gestioni, tra cui il porto stesso; e, da un altro lato, il riconoscimento di una larga autonomia comunale, non del tutto intonato con il carattere centralistico della democrazia classica, e delle recenti teorie nazionaliste, di cui la Carta è in certo senso la filiazione.
Ma di tutto ciò, considerato come un programma di amministrazione statale in Italia, non ci occuperemo molto, perché è noto che questi postulati fanno parte, tutti o quasi tutti, di ciascuno dei programmi di rinnovamento politico agitati negli ultimi anni, senza poter dare a nessuno una sicura fisionomia. Senza richiamare qui la critica di tanto riformatorismo, in fatto di applicabilità pratica e di effettiva utilità per le masse, basta ricordare che non mancano affermazioni analoghe nei programmi di socialisti unitari, di popolari, di democratici di vario grado, di repubblicani; e che con un programma del genere apparve sulla scena lo stesso fascismo, la cui natura era... quella che è.
La Carta contiene però alcune affermazioni in riguardo alla questione sociale e alla proprietà che vanno attentamente esaminate, anche se non sono così originali come si potrebbe credere.
Il citato articolo IV dopo aver stabilito la eguaglianza di diritti dei cittadini di tutte le classi, il che è la perfetta antitesi del concetto comunista della dittatura, che significa: diritti politici per i membri della sola classe lavoratrice, soggiunge: “ma [la Reggenza] amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori”. La espressione può giudicarsi piuttosto vaga, ma certo essa ha un valore tendenziale nel dichiarare che la eguaglianza teorica dovrebbe essere mitigata da una preferenza per i cittadini “produttori”. Resta a vedersi, e si vedrà poco oltre chi siano, nel concetto dello Statuto, i produttori.
Intanto l’art. IX ci fornisce la definizione della proprietà. Eccone il testo integrale:
“Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali.
“Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può essere lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte e ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro.
“Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro.
“Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all’economia generale”.
Notiamo anzitutto che le moderne democrazie capitalistiche non hanno adottato rigidamente, né in teoria né in pratica, il “jus utendi et abutendi” del diritto romano. La formula dannunziana ha qualche parentela con quella che i giacobini proposero per la costituzione del 1793, dettata da Robespierre, e che così suonava: “La proprietà è il diritto che ha ogni cittadino di godere e disporre della porzione di beni che gli è garantita dalla legge. Il diritto di proprietà è limitato, come tutti gli altri, dall’obbligo di rispettare i diritti altrui. Esso non può recar pregiudizio né alla sicurezza, né alla libertà, né all’esistenza, né alla proprietà dei nostri simili”. È vero che la Convenzione non accettò questa formula senza notevoli mutilazioni. Ma resta chiaro, senza cercare altri esempi, che una limitazione sociale della proprietà non è poi in contrasto coi canoni della classica democrazia borghese. Quanto al concetto che non è lecito lasciar inerte la proprietà, è noto che da esso non rifuggono, come direttiva di un insieme di riforme, anche politici ed economisti borghesi.
Per chiarire poi quale valore abbia il concetto che solo titolo di dominio sui mezzi produttivi è il lavoro, guardiamo più oltre, all’art. XVII: “saranno privi dei diritti politici... i parassiti incorreggibili a carico della società, se non siano incapaci di lavorare per malattia o per vecchiezza” - all’art. XVIII: “soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini...” - all’art. XIX, che assegna alla IV Corporazione: “i datori d’opera in impresa d’industria, d’agricoltura, di commercio, di trasporti, quando essi non siano soltanto proprietari o comproprietari ma - secondo lo spirito dei nuovi statuti - conduttori sagaci e accrescitori assidui dell’azienda”.
Non neghiamo che queste formule contengono l’abbozzo, o sono il prodotto, di una certa critica del sistema di proprietà borghese. Ma ha questa critica una parentela con la critica socialista e comunista, ed un indirizzo che sbocchi nella eliminazione del capitalismo?
Dobbiamo premettere subito che non ogni critica del capitalismo borghese è socialismo, anche quando ne assuma il nome. I lati criticabili del capitalismo sono tanto evidenti, che esso è stato condannato dai più svariati punti di vista, dando luogo alle più opposte dottrine, molte delle quali sono in antitesi con quella del socialismo moderno classista, la sola che abbia colto le ragioni e possa potenziare le forze che determineranno la caduta del regime borghese. Ad esempio, una critica degli orrori prodotti dal regime industriale consisteva nell’invocare il ritorno all’assetto pre-borghese e feudale; come una reazione analoga conduceva i lavoratori alla distruzione delle macchine apportatrici di disoccupazione: tali critiche e tali reazioni non cessano di essere anticapitaliste, ma sono condannate dai marxisti come antirivoluzionarie. Altre critiche, come i sistemi dei socialisti utopistici, sono poi superate dalla dottrina marxista dimostrandone la sterilità pratica agli affetti dell’abbattimento del regime borghese. Altri metodi sono da noi denunziati come insufficienti, come avviene per l’anarchismo, il sindacalismo, il revisionismo riformista, il cooperativismo puro, e così via.
La critica marxista del capitalismo consiste nel comprendere e fissare le ragioni e le tappe dello sviluppo di esso, e nel dimostrare non solo possibile, ma logicamente inserita nello sviluppo storico, una organizzazione dell’economia opposta e superiore a quella della società borghese. Questa nuova organizzazione si differenzia per la abolizione della azienda privata e della economia individuale concorrentistica, e la istituzione di una amministrazione centrale e collettiva delle forze di produzione. La superiorità del rendimento di questa nuova organizzazione sta nella sua corrispondenza alla utilizzazione scientifica delle risorse di cui oggi la umanità dispone, vantaggio anche più lato di quello che conseguirebbe numericamente dalla abolizione dello sciupio di ricchezza causato dal parassitismo dei capitalisti viventi a spese del lavoro espropriato al proletariato. Il problema di giustizia distributiva è messo nella luce più vasta di un problema di organizzazione superiore. La critica del capitalismo marxisticamente svolta dimostra che questo, per appropriarsi di un plusvalore dato a danno della classe proletaria, instaura e mantiene con tutti i mezzi un meccanismo sociale che disperde utili sforzi produttivi in una misura molto superiore a quel margine di defraudazione.
Più che accusare il regime borghese di essere ingiusto e crudele, il marxismo lo denunzia come irrazionale, e, più che denunziarlo, lo condanna dimostrandolo destinato a cedere il posto a forme superiori di vita sociale. Una critica, invece, puramente “morale” del capitalismo, non potrà mai intendere come le sue crudeltà al un certo punto dello sviluppo siano state necessarie, e non capirà - quel che è peggio - perché altri atti di crudeltà e di apparente ingiustizia saranno inevitabili nella lotta per distruggere il capitalismo medesimo.
Noi vediamo, nel tipo dannunziano di critica al capitalismo, o ad un certo aspetto di esso, una critica a tipo morale e non scientifico. Infatti non vi è traccia di critica scientifica del capitalismo laddove non è condannato, sia pure teoricamente, il tipo economico della azienda privata e l’ambiente della libera concorrenza. Queste figure di un economismo individualistico non sono eliminate nemmeno per poco dal pensiero sociale che ha dettato la Carta, la quale, oltre al parlare in termini in equivoci del sussistere della azienda privata, all’art. IV elogia “il gioco armonico delle diversità” per il rinvigorimento della vita comune, concetto letteralmente non ripudiabile, ma che dimostra la sua filiazione individualista in modo evidente.
Rimane una condanna del capitalista parassita puro, del rentier, del proprietario che non conduca o diriga egli stesso la sua azienda. Ma questa condizione, se può servire a sanare da un punto di vista ideale la figura morale del cittadino datore d’opera, nulla cambia alla natura del capitalismo, e nemmeno alla sua fondamentale ingiustizia distributiva. Infatti, che vi sia a dirigere l’azienda un tecnico o amministratore retribuito con una piccola frazione di profitto totale o vi sia il proprietario stesso, ciò non cambia per nulla la ingiustizia della ripartizione del guadagno a danno di tutti i lavoratori dell’azienda stessa. Sarebbe preferibile, anche dal punto di vista del calcolo più banale, un parassita che prelevasse dall’azienda il frutto dieci, e lasciasse il resto ai lavoratori, che un conduttore proprietario che, dando l’opera propria che valga dieci o venti, prelevi poi un guadagno di cento o di mille a suo benefizio. Senza contare che il problema della migliore organizzazione collettiva contrapposta a quella capitalista non viene qui nemmeno sfiorato. Non occorre notare che socialismo, anche nella più modesta accezione, significa impossibilità del dominio privato sui mezzi produttivi, mentre l’articolo esaminato, anche nella sua formula che pare più audace, attribuisce al lavoro la qualità di titolo per conservare tale dominio. Non siamo neppure in presenza della formula di riconsegnare a ciascun lavoratore la sua parte di strumenti di produzione, che ci respingerebbe verso l’artigianato, né di quella che vuole trasformare l’azienda borghese privata in cooperativa di coloro che vi lavorano, e che per altro verso noi marxisti consideriamo insufficiente e irrealizzabile.
Si può dire che la Carta non poteva sancire che realizzazioni modeste, ma noi facciamo notare al lettore che nella dizione del documento stiamo contentandoci di ritrovare le linee di una dottrina sociale, e in fatto di realizzazioni, per ragioni che non prendiamo a discutere, è certo che nessuna misura antiborghese venne adottata a Fiume, come nessuna ne viene chiaramente precisata per la attuazione programmatica altrove, meno quella assai poco audace della condanna del puro parassitismo personale, di cui in pratica non si troverebbero mai gli estremi, dato che ogni cittadino ricco “lavora”, il più delle volte a far traffici e speculazioni che gabella poi come contributo alla comune attività produttiva, mentre non sono che le arti e i mezzi per la defraudazione sociale.
Il pensiero anticapitalistico che dal documento si desume in modo non equivoco è quello della condanna morale - tradotta socialmente in una formula incompleta - della appropriazione del lavoro altrui da parte del ricco non produttore di alcuna ricchezza. Neppure in una sanzione severa in materia ereditaria si traduce questa condanna.
La dottrina che ha dettata la costituzione dannunziana non partecipa dunque delle ragioni positive e materialistiche che noi comunisti marxisti adduciamo contro il capitalismo. E non vi è da stupirsene, perché il pensiero dannunziano non è materialista, ma idealista. La esaltazione dello spirito ricorre ad ogni passo saliente di questo e di tanti altri documenti dettati o ispirati dal D’Annunzio. Ora, anche la concezione di una elevata ed eroica vita morale, non conduce ad una critica feconda del regime capitalista o di altra forma di organizzazione sociale. Se la borghesia potesse dimostrare - come pretende - che il suo regime è necessario per assicurare la produzione e la vita dell’umanità, che non vi sono altre soluzioni possibili e mature del problema dell’assetto economico, se non esistessero argomenti contro questa asserzione solidamente fondati su considerazioni tecniche e scientifiche, bisognerebbe mandarle per buoni tutti gli orrori di cui si circonda. Vinta la battaglia polemica sul terreno positivo e realistico, non sarebbe che un gioco, per i difensori dell’attuale assetto sociale, il tracciarne una giustificazione idealistica, morale, spirituale: non vi è da scegliere che tra i sistemi già pullulanti, fino a quelli religiosi. Del resto ogni epoca e ogni classe ha le sue formulazioni di valori spirituali, e la stessa dialettica storica spiega la morte eroica del sanculotto sulle barricate e il ghigno cinico del grande profittatore industriale tra gli stravizi e le orge; il tenentino che infrange sorridendo la sua giovinezza credendo nel mito della Patria, e il pescecane che accumula oro nel retrofronte.
La posizione metafisica di questo anticapitalismo dei dannunziani, può ispirare qualche simpatia sentimentale anche a noi, ma non può non preoccuparci. Come vedremo, una delle ragioni che differenziano i dannunziani dai fascisti è la ripugnanza ai mezzi violenti nel valorizzare le ideologie nazionali e patriottiche, l’appello alla concordia e contro la guerra civile. Ma questa stessa posizione ideale toglie ogni possibilità di sviluppo alla lotta contro i nefasti del presente regime sociale, che non si potrà fare vittoriosamente senza abbracciare mezzi di azione brutti e crudeli, e allestire apertamente la guerra di classe.
Il motto che ricorre negli scritti politici dannunziani: “si spiritus pro nobis, quis contra nos?” se può determinare convinzioni sincere e generose di militanti che noi possiamo ammirare, non dice nulla a noi marxisti. Non si può pensare, nel campo delle dottrine, il pensiero dannunziano come un ponte di passaggio tra la ideologia borghese e quella proletaria e rivoluzionaria.
Questa posizione venne in luce nel colloquio tra D’Annunzio e Cicerin, di cui riferisce D’Annunzio stesso in Per l’Italia degli italiani (pag. 286). L’ospite “affettava di non voler parlare dello spirito e delle cose spirituali”. Ed è ragione di conforto per noi, comunisti dell’ala più ortodossa, il vedere come Cicerin, reputato per un manovratore situato molto sui margini del comunismo, e suscettibile di transigenze ed accomodamenti, ponesse sorridendo il problema nel modo più chiaro e reciso dicendo che “in nessun atto del suo governo si trova la parola spirito, la parola anima”.
Questa parola non si troverà negli atti della vera, della sola rivoluzione anticapitalista, quella in cui il proletariato proclamerà la sua dittatura e prenderà a costruire la società comunista. A noi essa non serve, mentre è servita e serve a tutti i filistei.
Resta da esaminare il carattere che sembrerebbe fondamentale nella costituzione dannunziana, ossia la introduzione negli organi statali della rappresentanza delle “Corporazioni professionali”. Le considerazioni da farsi su tale argomento sarebbero molte e di molta importanza, ma noi ci contenteremo di alcune osservazioni essenziali. Cominciamo con il riportare integralmente l’art. XIX:
“Alla prima Corporazione sono iscritti gli operai salariati dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, dei trasporti; e gli artigiani minuti e i piccoli proprietari di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che abbiano aiutatori pochi e avventizi.
“La Corporazione seconda raccoglie tutti gli addetti ai corpi tecnici ed amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi i comproprietari di essa azienda.
“Nella terza si radunano tutti gli addetti alle aziende commerciali, che non siano veri operai; e anche da questa sono esclusi i comproprietari.
“La quarta Corporazione associa i datori d’opera in imprese d’industria, d’agricoltura, di commercio, di trasporti, quando essi non siano soltanto proprietari o comproprietari ma - secondo lo spirito dei nuovi statuti - conduttori sagaci e accrescitori assidui dell’azienda.
“Sono compresi nella quinta tutti i pubblici impiegati comunali e statali di qualsiasi ordine.
“La sesta comprende il fiore intellettuale del popolo: gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornative.
“Della settima fanno parte tutti quelli che esercitano professioni libere non considerati nelle precedenti rassegne.
“L’ottava è costituita dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo, industriali ed agrarie; e non può essere rappresentata se non dagli amministratori alle Società stesse preposti.
“La nona assomma tutta la gente di mare.
“La decima non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. È riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. È quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all’apparizione dell’uomo nuovissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l’ansito penoso e il sudore di sangue.
“È rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un’antica parola toscana dell’epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano: Fatica senza fatica”.
Riportiamo anche quanto concerne la composizione del Consiglio dei Provvisorii, organo che insieme al Consiglio degli Ottimi, eletto coll’ordinario suffragio esercita il potere legislativo:
“XXXI. - Il Consiglio dei Provvisorii si compone di sessanta eletti, per elezione compiuta nel modo del suffragio universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale.
“Dieci Provvisorii sono eletti dagli operai di industria e dai lavoratori della terra; dieci dalla gente di mare; dieci dai datori d’opera; cinque dai tecnici agrari e industriali; cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private; cinque dagli insegnanti delle scuole pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della Sesta Corporazione; cinque dalle professioni libere; cinque dai pubblici impiegati; cinque dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e consumo”.
Il programma di sostituire in Italia al Senato una assemblea composta di rappresentanze delle categorie sociali e professionali non è nuovo in Italia: faceva parte del primo bagaglio fascista, e fu nel 1919 affacciato dai riformisti della Confederazione del Lavoro, che proponevano una “Costituente professionale”. Tale parola non era in realtà che un espediente contro la parola rivoluzionaria della dittatura del proletariato che acquistava credito tra le masse. Ma la proposta di allora era forse ancora più modesta di quanto enuncia la Carta del Carnaro, poiché quando essa prese aspetto concreto se ne diede una definizione di questo genere: ogni categoria di industria e di aziende economiche in genere eleggerà rappresentanti di datori d’opera e dei lavoratori con parità di suffragio, ossia se gli operai metallurgici voteranno per duecentomila, voteranno per duecentomila anche gli industriali della loro categoria. Si fa invece dai dannunziani notare che le corporazioni dei lavoratori avrebbero una netta prevalenza per il modo con cui si compone il Consiglio dei Provvisorii. A ciò si possono obiettare i poteri limitati che a questo sono lasciati: si raduna solo due volte l’anno per discutere “al modo laconico” delle questioni economiche, quasi che queste potessero separarsi da quelle politiche, e non elegge direttamente che due soli componenti del Governo, su sette, ossia il Rettore della Economia pubblica e quello del Lavoro.
Se la conquista del potere fosse per i lavoratori una questione di maggioranze, anzitutto basterebbe a conseguirla la ordinaria democrazia politica, e in secondo luogo è evidente che essa non potrebbe essere raggiunta attraverso le rappresentanze delle Corporazioni, che possono tutt’al più dare una rappresentanza minoritaria agli interessi del lavoro come tanti altri istituti. Quanto alla nostra posizione critica di marxisti, non occorre ricordare che essa nega che vi sia potere proletario fin quando vi è la sola possibilità della rappresentanza delle classi abbienti, che sono di fatto una minoranza, ma il cui potere sarà eliminato solo da mezzi extralegali e impedito dalla dittatura operaia.
Ma diciamo qualche altra cosa, e che non concerne solo la Carta del Carnaro, su questa rappresentanza delle categorie. Anzitutto non è vero di fatto che essa stia a base della Costituzione della Repubblica dei Soviet. Se anche ciò fosse, il carattere distintivo del Soviettismo resterebbe nella esclusione dei non produttori dal diritto elettivo; in questo sarebbe tutta la novità e la originalità da respingere o imitare. Ma il Soviet, di più, non è affatto un organismo sindacale e professionale, e tutta la rete delle rappresentanze soviettiste si fonda su di una base territoriale, e solo nel primissimo grado, per un carattere che è più che altro di comodità pratica, ha deleghe elettive di gruppi divisi per ragioni di consultazione, in aziende, caserme, scuole, uffici, etc. In ogni caso si ha non un delegato di categoria, ma di azienda, ossia ad esempio in una fabbrica votano assieme lavoratori di diversa specialità di mestiere, impiegati, tecnici, etc. Ma quello che è sostanziale è che negli organi superiori, fino al Congresso dei Soviet e al Comitato esecutivo, che sarebbe il sostituto del Parlamento democratico, si compone di varie centinaia di membri, ed elegge il governo, non vi è traccia di origine corporativa dei delegati. Tutto ciò vale per dire che il principio corporativo non può significare la immissione, in un programma politico, di una dose di pepe bolscevico.
Guardiamo la questione, sia pure sobriamente, in modo più generale, in rapporto cioè alla dottrina del comunismo. Si è resa frequente, e vorrebbe sembrare una trovata moderna, la invocazione di questa formula della delega professionale, e l’uso e l’abuso delle parole “sindacale” e “sindacalismo”, da quando si è da diverse parti constatato che il veicolo fondamentale delle idee rivoluzionarie socialiste era, come deve essere, la organizzazione economica dei lavoratori. A tutte le scuole politiche “intermedie” è parso allora possibile e conveniente, ben guardandosi dall’accettare quanto nel marxismo ha sapor di forte agrume politico, ossia la conquista rivoluzionaria del potere e la dittatura proletaria, con la costituzione, quale fondamentale strumento di tali conquiste, di un forte partito di classe, di sposare il principio e il metodo della organizzazione sindacale, che sono purtroppo suscettibili di un impiego grettamente utilitario e reazionario.
Le formule variano all’infinito. Le più timide ed equivoche pongono sullo stesso piano le organizzazioni di operai e di padroni. Ed è già questo un passo innanzi rispetto alla tradizione delle corporazioni medievali, così spesso invocate a sproposito, che erano corporazioni di soli padroni, e che con la esclusione dalla direzione politica dei liberi comuni dei lavoratori giornalieri e spesso anche dei più miseri maestri artigiani, costituivano una vera dittatura della borghesia, diretta talvolta all’esterno contro le forze reazionarie dominanti del feudalesimo, ma diretta all’interno contro il nascente proletariato, che solo a sprazzi e con rivolte informi, più o meno alleato alla piccolissima borghesia, può venire alla luce come nei Ciompi di Firenze e in alcune lotte delle maestranze nelle arti tessili di Fiandra, rivendicando proprio il negato diritto a sindacarsi.
Ritornando alle formule “sindacaliste”, vi sono poi quelle del socialismo riformista, che danno alla organizzazione dei lavoratori un compito preminente considerando come avversarie le organizzazioni padronali, ma escludono dalle forme del conflitto mezzi e fini rivoluzionari, e, ammettendo il partito, ne riducono la politica a una pura funzione parlamentare di fiancheggiamento delle rivendicazioni economiche e di conseguimento di facilitazioni per il proletariato da parte degli organi statali. Infine la più estrema e audace è la formula del sindacalismo rivoluzionario, che ebbe nel Sorel il massimo esponente, e si atteggiò a superatrice del marxismo. Qui noi vediamo conservato ed esaltato il concetto della violenza, nella lotta tra sindacato e padronato, sindacato e Stato capitalistico, e preconizzata una società dei sindacati in cui questi abbiano una autonomia massima, e il regime politico sia della massima libertà. A questa formula si vengono a riallacciare le ideologie anarchiche, che tra le forme di associazione, sono propense ad accettare quella almeno del sindacato economico.
Tutte queste formule sono dal punto di vista comunista affatto insufficienti. Il sindacato non è per noi organo bastevole né alla lotta di classe liberatrice del proletariato, né alla organizzazione di una economia collettivista. A più forte ragione non possiamo riconoscere tendenza socialista a quelle delle varie formulazioni anzidette che escludono puranco la lotta di classe e l’uso dei mezzi extralegali.
Siamo disposti a riconoscere che la linea dannunziana ha rassomiglianze col metodo sindacalista, ma queste rassomiglianze sono proprio in quelle parti che dissimigliano dal nostro metodo comunista: infatti la rappresentanza è concessa ad organizzazioni sindacali delle opposte classi, il conflitto sociale vuole essere ridotto alla risoluzione legale di organi dello Stato; e non può bastare come aspirazione ad una società di emancipazione del produttore quanto è scritto per la “decima Corporazione” auspicante a forme superiori di organizzazione sociale in cui il lavoro non sia più una ingiusta condanna. Abbiamo già detto perché la aspirazione puramente ideale ad un miglioramento dei rapporti della vita collettiva in ciò che oggi hanno di cattivo e di odioso, non è attitudine rivoluzionariamente sufficiente, trattandosi di far vedere metodi e vie concrete per giungere al mutamento delle basi della società.
Anche un sindacalismo più accentuato e magari diretto alle forme insurrezionali, non risponde, dal punto di vista teoretico (di quello politico e tattico diremo nella parte seconda di questo articolo) ad una parentela con quello che vogliono i comunisti ed alle necessità della lotta proletaria.
Dove il sindacalismo esalta la categoria, noi esaltiamo la unità della classe che ha due ragioni fondamentali: la costituzione di una forza unitaria da opporre alla resistenza e alla reazione capitalistica, che nel dirigere gli sforzi comuni di tutti gli sfruttati faccia tacere interessi secondari ed appetiti proclivi ad essere isolatamente e temporaneamente tacitati; la direzione della nuova economia, che si contrappone a quella borghese in quanto non risulta dal libero gioco di aziende produttrici, ma dalla attuazione di un piano unico, dettato da un interesse superiore a quelli delle categorie e che abbracci domani la classe, nell’avvenire più lontano la nuova umanità. Questa unità della classe non si ritrova in una Federazione di sindacati ma in un partito politico rivoluzionariamente capace che ad essi sovrasti, e non vince nella singola illusoria espropriazione di ciascun capitalista, ma nel consolidamento del proletariato intero di uno Stato politico agente illuminato e centrale dello spossessamento capitalistico.
Non si può invocare dunque una vaga formula sindacale come embrione della vittoria proletaria, in forme che si contrapporrebbero dall’Occidente al bolscevismo russo, laddove è il bolscevismo la applicazione in condizioni particolarmente difficoltose della formula - che ha dato così dimostrazione trionfale della sua potenza - sorta nella coscienza marxista della grande classe lavoratrice dei paesi più avanzati industrialmente.
Il sindacalismo, rimproverando ai comunisti di essere “politici” e “giacobini” perché parlano di partito, di governo di terrore rivoluzionario, e tacciando tutto questo di borghese, compie un grossolano errore storico e teoretico che ha permesso però molte speculazioni demagogiche per cui dottrine - parliamo qui in modo generale - affatto controrivoluzionarie hanno potuto, pigliando a prestito alcune espressioni soreliane, darsi un falso colore di sinistra, atteggiarsi a movimenti favorevoli al proletariato.
Della critica di questo errore non possiamo ora parlare, per mostrare ciò che è evidente al lettore cui non sia ignota la dottrina di Marx, che i criteri di conquista del potere politico col partito come strumento, e di istituzione di una rappresentanza “territoriale” politica anche al di sopra di pretese esaltazioni di fattori tecnici ed economici (la politica proletaria, dopo aver schiacciato la borghesia, non sarà più altro che tecnica ed economia unitarie, ossia su ben altra scala di rapporto che gli appetiti professionali), che questi concetti non sono affatto una filiazione delle dottrine della rivoluzione borghese democratica, ma sono applicazioni di lezioni storiche che è rovinoso non intendere. E la originalità del metodo marxista sta in ben altro che nella invenzione di una “forma di organizzazione” come il sindacato o uno dei suoi tanti surrogati, ma nell’aver sviscerato la dimostrazione dialettica che per fondare la libertà umana nel senso più razionale, meno metafisico e bigotto della parola, occorre impiegare in modo intelligente la violenza e l’autorità rivoluzionaria, che col partito e il governo della classe ribelle si spiana la strada alla società senza classi, partiti e Governo politico.
La somiglianza tra il pensiero dannunziano e il sindacalismo non è del resto senza rispondenza alle origini filosofiche del primo e del secondo. Abbiamo mostrato il carattere spiritualistico della ideologia che dettava la Carta del Carnaro ed altri testi affini. Ora anche il sindacalismo ha un contenuto filosofico tendente allo spiritualismo, e il suo spirito di categoria è imparentato coll’individualismo. Il sindacalismo è un po’, non la scienza della palingenesi del corpo sociale, quanto la regola di azione del singolo proletario, la soreliana “Morale del produttore”. Lo spiritualismo dannunziano sente come poco la società attuale sia moralizzabile e “eroicizzabile”, se non nelle vergini forze che erompono dal proletariato: esso non sa andare più oltre del saluto che leva a questi fermenti del domani.
Quanto a noi comunisti e marxisti, noi conosciamo delle questioni di necessità e di migliore rendimento nelle vie da prendere nello svolgersi della storia. Se queste rispondano ai canoni dell’Etica e dell’Estetica, non ci importa per nulla. La nostra dialettica ci spinge ad esaltare oggi il valore del ribelle, anche crudele, anche incolto, per rompere le barriere del divenire dell’umanità verso le forme più pacifiche, armoniche e coscienti della convivenza dei singoli. Chi vuole considerare i problemi storici nello spirito dell’uomo attuale considerato come una compiuta entità, e in esso risolverli potenzialmente, è ancora lo schiavo di un metodo da cui noi ci siamo liberati per sempre, e che consideriamo come una posizione inferiore. Nessuna revisione sconfiggerà su questo terreno la potenza della valutazione marxista.
II. La politica
Il lettore non esigerà che, per dire in breve delle origini del movimento di cui ci occupiamo, abbiamo a rifare la storia delle manifestazioni politiche del suo condottiero. Si sa che il Poeta fu, molti anni fa, deputato; che passò in una memorabile seduta dalla destra alla sinistra dichiarando di andare verso la vita; che poi non si occupò di politica fino alle sue Canzoni di Gesta dedicate alla esaltazione della guerra in Libia, e quindi della grande guerra, a cui partecipò nei modi ben noti, dopo essere apparso come colui che precipitò l’intervento nel conflitto della nazione italiana. Queste attitudini di esaltazione bellica lo collocavano nettamente tra gli avversari del movimento proletario e socialista italiano.
Ma sono i fatti del dopouerra che hanno rapporto coll’argomento da noi trattato. L’occupazione dannunziana di Fiume prende il periodo dal Settembre 1919 al Gennaio 1921. In tutta questa fase D’Annunzio appare come l’antagonista dei governi “neutralisti” di Nitti e Giolitti, e il campione del nascente movimento fascista, che si pone alla testa dell’agitazione a suo favore in Italia. Il Popolo d’Italia, però, aveva verosimilmente già disgustato il Poeta per la sua attitudine di quasi accettazione di quel Trattato di Rapallo, in seguito al quale i legionari furono sloggiati colla forza da Fiume; e si è più volte sussurrato che dei fondi raccolti per la causa fiumana sia stato fatto uso, non certo legittimato dal Comandante, per fondare su vasta base il movimento fascista nel Paese.
Registriamo questi fatti, su cui in ogni caso non a noi toccherebbe fare la luce completa, nel nostro intento obiettivo di stabilire il momento in cui si può cominciare a distinguere, tra i tradizionali “interventisti” del 1914-1919, una divisione tra fascisti e legionari, Mussoliniani e Dannunziani, distinzione i cui termini, come vedremo, non è sempre dato di fissare con soddisfacente nettezza.
Usciti da Fiume i legionari di D’Annunzio, essi non si disperdono, ma conservano una loro organizzazione, la Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani, e pubblicano anche a Bologna un vivace settimanale: La Riscossa. Il loro movimento è molto vicino a quello della Associazione Nazionale Arditi d’Italia, che si dichiara dannunziana, salvo a tener poi l’attitudine che vedremo. Ci si consenta di ricordare come, prima ancora dell’apparizione del fascismo vero e proprio sulla scena, fosse l’arditismo ad impersonare le prime gesta violente dell’offensiva antiproletaria: tra di esse il primo incendio dell’Avanti!
La linea di divergenza dei dannunziani puri dai fascisti pare essere questa: i dannunziani rappresentano quegli elementi delle classi medie, nutriti di una ideologia di guerra, che fecero proprio il primo programma del fascismo, che ostentava attitudini a tendenze di sinistra. Non possiamo qui inserire una critica interpretativa del fascismo in generale, ma ci limiteremo a dire che questo, a nostro avviso, costituisce una “mobilitazione” delle classi medie ed intellettuali, operata da parte ed a beneficio dell’alta borghesia industriale, bancaria ed agraria, mobilitazione che le classi medie medesime scambiano dapprincipio col problematico avvento di una loro funzione storica autonoma e decisiva, quasi di arbitre nel conflitto fra borghesia tradizionale e proletariato rivoluzionario. Così il fascismo, che appare il concentramento di tutte le forze antiproletarie a difesa del fortilizio antico del capitalismo (sia pure a difesa assai modernamente e vigorosamente organizzata che non fosse nei vecchi metodi liberali, democratici, giolittiani, la cui epoca è tramontata) trova i suoi effettivi e i suoi quadri in tutta una gamma di elementi sociali, messi in moto dal grande sconvolgimento bellico, che si illudono di compiere uno sforzo originale, e in certo senso rivoluzionario. Al centro della organizzazione fascista si trova l’affarismo e il parassitismo padronale, e la macchina statale, per quanto apparentemente dedita alle manovre di sinistra del nittismo parlamentare: alla periferia tutto quel misto di idealismi e di appetiti, caotico ed informe, del quale nulla di meglio le classi intermedie sapranno mai portare sul terreno del conflitto sociale.
Vigoreggiando la organizzazione fascista, se sempre meglio appare il suo carattere di meccanismo maneggiato dalle solite classi parassitarie, difficile riesce agli elementi piccolo-borghesi il distaccarsene per seguire una propria via, mancando ad essi i mezzi adeguati ad un compito indipendente, e restando la più parte dei loro capeggiatori soddisfatti o imprigionati nei posti di direzione del complesso movimento fascistico. Ma qualche nucleo di idealisti sinceri o di concorrenti delusi nella spartizione della torta, rimane e tende a differenziarsi: con questo si può dire di aver tratteggiato una certa spiegazione del formarsi del movimento dannunziano.
La formula: la direzione della vita politica a coloro che hanno voluto e fatta la guerra, accomuna all’inizio fascisti e dannunziani. Ma mentre per i primi la formula non è che il passaporto della difensiva borghese contro il proletariato rosso, che la guerra non voleva, e che dalle conseguenze di essa è spinto alla lotta per la sua dittatura rivoluzionaria, per i secondi la formula è accettata come autentica, come affermazione volta anche contro le vecchie caste dirigenti borghesi e imbevuta di un certo spirito eroico di rinnovamento, come condanna non tanto del disfattismo estremista quanto di quello degli speculatori e dei parassiti del fronte interno, veri profanatori del sacrificio e della vittoria. Questa seconda ala, sia pure in modo molte volte equivoco, vorrebbe orientarsi verso le forze libere del proletariato: la prima organizza i pretoriani del capitale e gli schiavisti dell’Agraria.
Nel periodo della prevalenza delle forze rosse, la distinzione non è sensibile: se le classi medie forniscono dei simpatizzanti per il proletariato, lo fanno attraverso altri movimenti piccolo-borghesi, e sotto la specie insidiosa del riformismo. Ma il distacco di cui ci occupiamo si comincia a delineare nel periodo successivo. Pare che D’Annunzio non abbia approvata la partecipazione fascista alle elezioni del Maggio 1921, ritenendo egli che il metodo per la conquista del potere dovesse essere quello insurrezionale, da parte di forze nuove ed orientate a sinistra, e scorgendosi nell’attitudine di Mussolini la rinuncia a tutta una parte del primitivo programma e l’orientamento a destra, a servizio aperto del capitalismo. Certo è che in quell’epoca i legionari ricevono ordine di uscire dai fasci: ma non tutti lo eseguono, ché non pochi preferiscono seguire la più forte corrente. Nel periodo successivo la Federazione dei legionari dà scarsi segni di attività: ma nella seconda parte del 1922 sembra annunziarsi un suo atteggiamento antifascista. Si inizia da parte dei dannunziani un lavoro di carattere sindacale tra i lavoratori, contrapposto in un certo senso a quello fascista, ma tendente a creare un nuovo organismo operaio, diverso da quelli rossi, col noto programma della convocazione di una Costituente sindacale per la Unità proletaria.
Questa attitudine non poteva e non doveva apparire chiara agli elementi rivoluzionari del movimento operaio, e fu infatti diffidata, soprattutto dal partito comunista. Al centro del pensiero dei dannunziani stava un proposito di pacificazione generale in Italia, e se anche questo non era concepito nell’interesse e per fare il gioco della parte borghese, la impossibilità stessa della conciliazione lo rendeva suscettibile di produrre un tale risultato. Tutti i partiti italiani, per lavorare tra le masse operaie, avevano costituita una loro propria organizzazione sindacale divisa dalle altre e infeudata al movimento politico: gli anarchici avevano la Unione Sindacale Italiana, i socialisti la Confederazione del Lavoro, i repubblicani la Unione Sindacale di Parma, a tendenza interventista, i popolari la loro Confederazione dei Lavoratori. Tutti questi partiti, o almeno quelli della sinistra, si dichiaravano fautori della unità proletaria, ma in fondo ognuno di essi poneva la tacita pregiudiziale del suo predominio nella organizzazione unificata. Il partito comunista, invece, fin dalla sua costituzione, non fece altrettanto: pur ponendosi apertamente lo scopo di guadagnarsi una influenza predominante nel seno dei sindacati, faceva di questo obiettivo il punto di arrivo di tutto un lavoro di penetrazione e di propaganda a base dei suoi gruppi o cellule comunisti, ma si schierava anzitutto per la unità sindacale senza porre pregiudiziali esplicite od implicite di alcuna specie, pronto ad accettare con entusiasmo la situazione di un organismo unico delle masse sindacate economicamente, anche se in questo dovevano essere in maggioranza altri indirizzi politici. Il metodo dei dannunziani per giungere alla unità operaia era invece quello sbagliato e sfatato di partire dalla creazione di un’ennesima centrale sindacale nazionale scissa dalle altre e con esse concorrente per poi tutte condurle alla mille volte tentata unificazione.
Si aggiungeva a questo un altro pericolo, non essendo chiaramente escluso che alla costituente per l’Unità avessero a partecipare i sedicenti sindacati fascisti: il pericolo di giungere, attraverso il tentativo dei dannunziani, magari senza che questi stessi lo capissero, all’infeudamento di tutto il movimento operaio a controlli ed influenze statali e padronali che gli avrebbero tolto, con ogni vigore rivoluzionario, anche ogni capacità di difesa effettiva dalla rapacità capitalistica. Poteva darsi che le masse si illudessero di poter resistere allo smantellamento dei sindacati di classe, commissionato allo squadrismo dai grandi interessi padronali, sotto una etichetta meno provocatrice, come quella dannunziana poteva essere; mentre per noi era chiaro che una simile tattica non avrebbe salvato, come non le ha salvate la volontà di collaborazione e di sottomissione dei riformisti confederali, le libere e gloriose organizzazioni del proletariato italiano.
Per tutte queste ragioni il movimento sindacale dannunziano era considerato dai rivoluzionari come un equivoco, se non una insidia. Quanto meno esso si basava su di una tattica errata, e le forze che esso ha potuto spostare dalla piattaforma delle organizzazioni rosse, sono cadute malgrado i dannunziani stessi nell’orbita delle Corporazioni fasciste: di questa situazione è stata una presa di atto la recente dichiarazione di scioglimento del movimento sindacale dannunziano, anche se non ha valore generale e si riferisce specialmente alle organizzazioni fiorentine, passate, a poco a poco, in balia del fascismo.
Non ritorneremo sulla valutazione limitata del sindacalismo operaio che è propria della concezione dannunziana. Un libero movimento di organizzazione dei produttori non è possibile se esso non si basa su una aperta dichiarazione ed attitudine di lotta di classe, e sconfessa i movimenti che irreggimentano operai sotto etichette “nazionali” e controlli effettivi della minoranza capitalista e del suo naturale strumento: lo Stato. La formula dell’unità estesa al di là di questi limiti sbocca immancabilmente nella soggezione e nella castrazione del movimento operaio. In uno Stato della borghesia, come per eccellenza è quello fascista, le Corporazioni ufficiali dei produttori non possono essere che strumenti dello sfruttamento contro di essi: solo lo Stato rivoluzionario del proletariato potrà riconoscere le organizzazioni proletarie veramente tali ed anche per questo è in un primo periodo una necessità evidente il lasciare autonomi i sindacati nel senso di non considerarli come organi stabiliti dalla Costituzione, alla guisa delle Corporazioni previste nella Carta del Carnaro (pur essendo i sindacati stessi diretti dal partito comunista, detentore del potere e guida dello Stato). Il lavoro sindacale dannunziano, basato su una vaga simpatia per il proletariato e una reazione morale contro i negrieri, da parte di quegli elementi piccolo-borghesi ed ex combattenti cui abbiamo accennato, per la scarsa chiarezza delle sue premesse e la scarsa comprensione dell’antitesi che ora abbiamo tratteggiata, si risolse in una indiretta valorizzazione delle Corporazioni fasciste, che opportunamente presero a prestito il loro stesso nome dai programmi dannunziani, per organizzare la sottomissione dei lavoratori ai loro parassiti.
Il piano del padronato, di spezzare le file della rete di organizzazioni economiche operaie per ritogliere ai lavoratori i vantaggi conquistati, come non si arrestò dinanzi alle formule di compromesso offerte dal riformismo ultraconciliatorista, così non fu paralizzato dalla tattica sindacale dannunziana. I saggi di questa, nella organizzazione dei ferrovieri ed in quella dei lavoratori del mare, confermano la nostra critica. Il sindacato dei ferrovieri in molti dei suoi ultimi atti è sembrato ispirarsi all’equivoco che noi deploriamo, ostentando di volere rinunziare ad ogni carattere “antinazionale” per ottenere qualche transazione dal governo fascista. Per quanto mortificanti, questi passi sono falliti: ciò che l’offensiva fascista-capitalista, nelle aziende di Stato quanto in quelle private, deve colpire, non è la bestemmia contro la patria, ma quella contro la borsa della classe dirigente.
La organizzazione dei lavoratori del mare, diretta dal Giulietti con metodi contro i quali non abbiamo bisogno di ripetere la nostra aspra critica, ha voluto anche essa proteggere le conquiste puramente economiche della classe dei marittimi sacrificando alle trionfanti deità patriottiche, e offrendo la garanzia del nome di D’Annunzio per mostrar di non essere coll’Antinazione... Ciò a nulla è servito, quando si è trattato per il governo fascista di eseguire un mandato della classe armatoriale, ai cui appetiti dava fastidio l’esistenza stessa di un Sindacato indipendente. La difesa dei lavoratori del mare può ora essere condotta solo sulla via sempre indicata dai comunisti, chiamando i marittimi stessi a dire la loro parola e schierare le loro forze sul terreno della lotta classista, ossia contro gli armatori come contro il governo, contro l’unica cosa concreta che si può riconoscere sotto le abusate astrazioni di Italia, Patria, interessi della nazione... Se Giulietti e D’Annunzio si liberano da tale equivoco, la lotta sarà utile anche se sarà perduta, se essi pensano di salvare la situazione con formule che dissimulano la crudezza del conflitto degli interessi tra le opposte classi, noi non potremo che ripetere la nostra sfiducia per la infecondità di una simile linea di condotta.
La situazione sindacale in Italia, in conclusione, rappresenta la prova evidente della impossibilità di stipulare col governo fascista, strumento direttissimo del capitale nelle varie sue forme, un compromesso che consenta di vivere ad organismi sindacali autonomi nella loro azione economica, anche dichiarando di voler levare su questi una bandiera tricolore ed ispirarsi ad un proposito di conciliazione sociale. Giungeranno i dannunziani a dichiarare di aver constatato questo?
Una versione insistentemente ripetuta del dietroscena della marcia su Roma è questa: il 4 Novembre 1922 D’Annunzio doveva effettuare egli un “colpo” del genere: i fascisti lo avrebbero appreso, e avrebbero precipitata la loro azione nel modo ben noto, per non essere preceduti. Pur sapendo che in tale giorno il Poeta doveva parlare a Roma, e che in quell’epoca egli accentuò le sue manifestazioni di dissenso dal fascismo, noi ci rifiutiamo di ammettere che un piano simile, se pur esisteva nella mente di qualcuno, avesse anche un minimo grado di probabilità di successo. L’avvento al potere del fascismo, pur avendo avuto tutt’altro carattere che quello di un assalto frontale alla macchina dello Stato, ed essendosi svolto attraverso un compromesso, era un fatto di tale portata da essersi reso possibile solo in forza di una lunga preparazione e con la formazione di una organizzazione completa e potente. Che il fascismo nel cogliere i frutti della sua vasta campagna potesse essere soppiantato da altre forze, che non erano lontanamente paragonabili ad esso per efficienza, solo per l’effetto di un gesto compiuto in un momento piuttosto che in un altro, è cosa affatto incredibile. Ma il credere alla possibilità di simili “beffe” alla storia, se è proprio di certe sfere di politicanti piccolo-borghesi italiani, ci pare caratteristico della mentalità dei dannunziani. Essi senza dare la giusta importanza alle vaste organizzazioni di effettivi interessi di classe, pensano di poter spostare le situazioni coi riflessi di attitudini puramente spirituali, e vedono in certi colpi di scena della politica, cari alla sensibilità emotiva dei lettori della stampa provinciale, non le efflorescenze, ma il contenuto stesso dei fatti storici. Chi avrebbe seguito i dannunziani nel Novembre 1922? Tutti, si può rispondere, ma tutti è troppo poco, dove contano gli inquadramenti delle minoranze efficienti, e le loro influenze concrete su quell’inquadramento fondamentale di forze che è la macchina statale. Il proletariato, se pur fosse stato in quel momento capace di una azione decisiva, non avrebbe accolto un appello partito da D’Annunzio se non come una mascheratura del colpo fascista; tanto più che si era a poca distanza dal discorso dal balcone di Palazzo Marino: e le masse non si addentrano nelle chiose di certi testi, bensì giudicano dal significato semplicistico delle posizioni assunte: e quella era posizione di celebrazione di una conquista antiproletaria.
Dopo la marcia su Roma i fascisti hanno accentuato il loro boicottaggio del movimento autonomo dei dannunziani e non senza successo. Molte altre defezioni si sono avute tra i legionari: la Associazione Arditi d’Italia è passata ai fascisti, assumendo il nome di F.N.A.I. (Fed. Naz. Arditi d’Italia) col suo organo Fiamme Nere. I dannunziani conservano un vestigio nella A.N.A.I. e nella Associazione dei combattenti hanno una opposizione quella dei gruppi Italia Libera, che però risulta dalla confluenza di altre correnti oppositrici del fascismo e vicine ai dannunziani: socialisti unitari, repubblicani, massoni...
Con l’ordine governativo di scioglimento dei corpi armati la organizzazione dei Legionari si trasformò nella attuale “Unione Spirituale Dannunziana”, la quale, pur dichiarandosi un movimento non politico ed elettorale, ma “spirituale”, comprende tutti i cittadini che chiedano di aderirvi, e professa i principi della Carta del Carnaro, proclamando suo capo Gabriele D’Annunzio. La organizzazione è stata diretta finora da elementi che non sempre, come parrebbe, hanno potuto interpretare a titolo legittimo la volontà del Poeta. Nel recente Congresso tenuto a Ronchi, il vecchio leader, capitano Coselschi, elemento che può ritenersi della “destra”, ossia con qualche simpatia per il fascismo, non ebbe buone accoglienze: i convenuti proclamarono che non intendevano disciogliere la loro organizzazione, come con falsa interpretazione dei voleri del Comandante erasi accennato di voler fare. I dirigenti attuali, delegati dal Congresso a visitare il Poeta, rappresenterebbero una corrente, predominante, tendente a sottolineare la opposizione al fascismo. La U.S.D. conta in Italia un centinaio di sezioni e circa duecento gruppi, con una organizzazione discretamente efficiente: ma essa non ha affatto stampa, neppure un settimanale o una rivista, che ne sia organo ufficiale.
Che cosa rappresenta effettivamente questo movimento nel quadro della politica italiana?, dobbiamo ora domandarci. Date le origini che ne abbiamo accennato, il movimento dannunziano può assumere il carattere di una forza di opposizione al governo attuale, ma indubbiamente esso attraversa un periodo di incertezza, come è legittimo dedurre dalla scarsezza e dalla poca chiarezza delle sue manifestazioni. Noi abbiamo tutta una serie di riserve da fare sulla efficacia delle opposizioni al fascismo che non siano a carattere classista e rivoluzionario, e queste riserve generali sono evidentemente applicabili anche ai dannunziani. I gruppi e gruppetti di opposizione borghese al fascismo si agitano in questa contraddizione: non sanno fare neppure platonicamente e accademicamente delle recise manifestazioni di condanna del presente governo, non osano neppure spingere alle estreme conseguenze la opposizione “legalitaria” e la critica teoretica, mentre paiono poi pervasi dall’illusione che in qualche modo misterioso la situazione stia per essere da un giorno all’altro rovesciata con metodi magari insurrezionali, o almeno con colpi di scena come quelli cui abbiamo accennato più sopra. Queste correnti sembrano dire: quanto noi siamo profondamente antifasciste non è il caso ora di dirlo e di scriverlo, ma lo grideremo ben alto ad un certo momento, ed allora Mussolini se ne andrà a gambe levate. Prima, non è il caso di comprometterci e compromettere i nostri piani.
In molti gruppi oppositori, democratici, massoni, e simili questa attitudine è pura ipocrisia e viltà, mentre non crediamo sia così per i dannunziani. Probabilmente i più sinceri tra essi credono alla utilità di questo coefficiente del mistero, e convinti di questo subiscono talvolta il gioco di elementi più infidi che li tengono così prigionieri dell’equivoco.
Noi, che siamo i più recisi oppositori del fascismo, sappiamo che in Italia non esiste nessuna forza che possa farci svegliare domattina con un altro governo. Nessuna stregoneria dell’alta politica può produrre questo risultato. Per nostro conto, avendo ben altre concezioni del processo rivoluzionario, non abbiamo nessuna ragione di nascondere alcune semplici verità. Primo: il nostro proposito è il rovesciamento colla violenza del regime attuale e quindi del governo fascista. Secondo: non abbiamo oggi una organizzazione che permetta di fare questo, e sappiamo che per costruirla occorre un lungo lavoro politico e tecnico, che si comincia così: dichiarando senza esitare che il nostro programma è quello ora detto, e attirando intorno alla necessità di farlo proprio la massima attenzione delle masse. Il metodo non è comodo come un incantesimo tramato nella caverna delle streghe, ma è l’unico che condurrà a qualche risultato.
Il movimento dannunziano dovrebbe cominciare col precisare il suo programma di opposizione al fascismo attraverso chiare manifestazioni. Sebbene non si tratti di una vasta organizzazione, le sue tradizioni e il nome del suo capo darebbero a un tale atto un notevole peso politico. Non compiendo questo minimo di apertura di ostilità, non possono i dannunziani pretendere di trovar credito presso il proletariato.
Insieme alla questione del fine, si presenta quella del metodo. Tutte le recenti manifestazioni di D’Annunzio pare abbiamo una portata di pacificazione, di invocazione alla concordia, di sconfessione della violenza “da qualunque parte essa venga” secondo una formula molto abusata. Si tratta dunque di invitare le masse a subire passivamente la violenza avversaria, non solo in quanto la strategia più elementare sconsigli la controffensiva, ma in nome del principio che le forze spirituali avranno ragione della prepotenza degli oppressori? Questa è nell’ipotesi più benevola un’illusione, ed è attitudine di cui il proletariato ha imparato a diffidare, attraverso tanti esempi in cui i conciliatori, anche più vicini di D’Annunzio alle masse operaie nella scala politica, sono nel momento dell’invano deprecato conflitto passati sotto le bandiere della violenza, sì, ma contro il proletariato.
Noi ci domandiamo se l’antifascismo dannunziano consista non nel condurre una azione attiva contro il fascismo, ma solo nello stigmatizzare che il movimento degli “artefici della vittoria” si sia incanalato nella violenza partigiana e antiproletaria, per dedurne solo uno sterile invito a tornare indietro da questa via e tendere la mano a tutti gli “italiani”. Questo sarebbe troppo poco, anche tenendo per escluso che sia una cosciente insidia.
Tutto questo merita di essere chiarito, prima che da ricerche critiche nostre e di chicchessia, da dichiarazioni ufficiali di responsabili del movimento dannunziano, i quali dovrebbero capire che questa chiarificazione è premessa indispensabile ad ogni azione fortunata. Il mistero non serve ad un movimento rivoluzionario, anche insurrezionale, e tanto meno poi ad un movimento solo “spirituale”. Noi, rivoluzionari, per tornare a questo confronto, usiamo del segreto non per i nostri scopi (fin dal Manifesto del 1847 diciamo che “i comunisti sdegnano di nascondere i loro scopi”) ma solo per proteggere il “meccanismo” materiale della nostra organizzazione ed azione, insidiato dall’avversario. Il mistero sulle posizioni politiche non è mai un coefficiente di successo - per i movimenti di avanguardia - ma solo la prova dell’equivoco, della effettiva natura conservatrice delle correnti che ostentano un semi-estremismo per la platea.
In mancanza di una risposta “ufficiale” ai nostri interrogativi, mal possiamo coi mezzi della nostra analisi critica spingerci più oltre, e prevedere quale sarà la sorte e il compito del movimento dannunziano nella politica italiana. Movimento di intellettuali, di professionisti, di antichi combattenti, esso ci pare assommi quanto questi strati possono dare di non antiproletario, in una situazione in cui il proletariato sia sconfitto. È qualche cosa. In queste situazioni è molto difficile che gruppi delle classi medie non optino, tra le due dittature, per quella della borghesia. Un movimento come quello dannunziano potrebbe avere una funzione opposta e simmetrica a quella del fascismo: come la massa degli elementi sociali medi usciti dalla guerra hanno abbandonata la via di un’azione autonoma per gettarsi nel solco della grande borghesia, questo gruppo potrebbe - dopo aver tentato invano, per vie opposte, di perseguire quella ipotetica funzione indipendente, nella vita politica della “intelligenza” - essere spinto dalle sue simpatie per le forze del lavoro a gettarsi al seguito in un proletariato movente alla riscossa. Va da sé che questa non è che una possibilità, e che ve ne sono altre, dipendenti anche dal dubbio su quanto verrà e potrà fare D’Annunzio stesso nell’agone politico. E va anche da sé che noi non crediamo ad un compito preminente, ad un intervento con forme originali, di questo movimento “spirituale”, in quanto esso pretenda di fungere da guida alla classe dei lavoratori su altre e “nuove” vie che non siano quelle della lotta classista e rivoluzionaria, di aprire alla storia altri e diversi sbocchi, sia pure fecondando il suo sforzo con la fede, che dovrebbe essere il suo connotato specifico, nella onnipotenza mistica dell’eroismo e del sacrificio.
In ogni modo non potremmo non vedere con soddisfazione, integri restando tutti i punti teoretici e politici della nostra critica e del nostro chiaro dissenso, un movimento di agitazione di idee e di aperta discussione, che svolgesse su vasta scala questo tema: del disinganno di molti elementi intellettuali ed ex-combattenti sulla portata del fascismo, che oggi si svela come strumento della crassa materialità degli interessi parassitari più pesanti e più spietati, e mostra la miseria delle sue pretese restaurazioni di valori intellettuali, morali, spirituali.