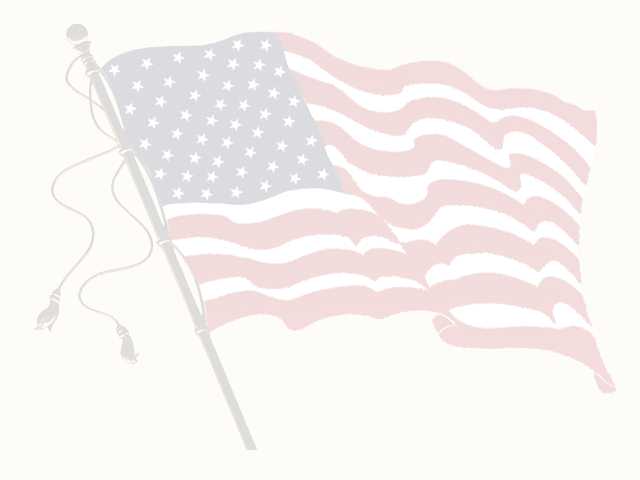 Massimo
Bacigalupo
Massimo
Bacigalupo
Anne Tyler, l’America vista da
Baltimora
Di Anne Tyler si sa che ha 63 anni, che ha scritto decine di romanzi ambientati per lo più a Baltimora, che ha studiato russo alla Columbia University e lavorato per qualche tempo come bibliotecaria, che ha sposato un medico iraniano e tirato su una famiglia. Si sa che non si presta a interviste e presentazioni, dichiarandosi timida, dicendo che esponendosi alle gaffes delle occasioni pubbliche brucia per giorni l’energia e l’attenzione necessaria per scrivere. E in effetti davanti a un romanzo come Un matrimonio da dilettanti (trad. Laura Pignatti, Guanda, pp. 306, €15,00) si resta senza parole e qualsiasi spiegazione sarebbe ridondante.
E’ un’opera costruita con scioltezza e perfezione, che segue i casi dei due protagonisti, Michael Anton e la moglie Pauline, dal giorno del loro incontro da ventenni nel 1941, su un arco di sessant’anni, chiudendosi nell’autunno 2001. Un bello scorcio di Novecento raccontato in soli dieci capitoli, di cui l’ultimo breve, una sorta di Edipo a Colono, con il banale Michael che zoppicante come sempre per la sua “ferita di guerra” (in realtà procurata durante un’esercitazione da un commilitone, che gli ha involontariamente risparmiato il fronte e consentito un precoce e sfortunato matrimonio) si avvia verso la casa divisa per decenni con Pauline, nel frattempo separata (dal giorno del loro trentesimo anniversario, 26 settembre 1972) e morta in un incidente balordo.
Anne Tyler possiede l’arte di evocare un mondo a tre (quattro?) dimensioni con la massima economia. Ha detto di aver provato piacere a immaginare una giornata del 1941, quando Michael sta aiutando la madre nella bottega di alimentari nella Baltimora etnica, a pensare a quali fossero le marche dei prodotti in vendita (sapone Woodbury) e delle automobili che sgusciano per strada (Chrysler Airstream). Ma a differenza di connazionali come John Updike e Philip Roth, che ci inondano di dettagli e particolari uggiosi facendo sfoggio di virtuosismo, la saggia Tyler usa pochi tratti sempre significativi, non si ripete e non si parla addosso (Roth), non è fatua né preziosa (Updike). Guarda il suo oggetto, quella istantanea del 1941, ed entra nelle teste dei personaggi.
La tecnica è quella del racconto in terza persona, ma il punto di vista cambia lievemente di capitolo in capitolo, spostandosi da lui a lei a uno o l’altro dei figli. Gli eventi sono pochi quanto la vita è lunga. Un matrimonio precipitoso, da “dilettanti”, caratteri male assortiti che continuamente si danno sui nervi a vicenda. (Quando il fidanzato è in caserma Pauline civetta con qualche altro soldatino, trascurando di rassicurare Michael che sordamente infelice provoca il litigio col commilitone che poi gli sparerà in un incidente che incidente non è, così rimandandolo a casa anzitempo al campo da guerra della vita coniugale.) Il lavoro di Michael nel negozio di alimentari della madre, poi sostituito da un altro negozio in un quartiere più agiato, con prodotti più ricercati: lavoro che dà da vivere alla famiglia. Il nervosismo e l’insoddisfazione dell’impulsiva Pauline, che dopo aver avuto tre figli, Lindy, George e Karen, ha un flirt sbadato con una conoscenza occasionale, scoperto subito da Michael che non le rinfaccia la bugia con cui ha cercato di nascondere la visita peraltro innocente nella casa dell’altro. La sbandata all’epoca di On the Road della figlia maggiore Lindy, che ancora adolescente scompare da un giorno all’altro e non dà più notizie di sé, rivelando di essere della stessa stoffa ostinata e impulsiva dei genitori.
Come in un testo teatrale, la vicenda è narrata attraverso una serie di giornate e scene e (come spesso rileva la critica), gli eventi sono visti indirettamente. Non sappiamo molto dello stato di mente della fuggiasca Lindy (“Sputava parole come ‘borghesia’ e ‘domestico’ quasi fossero bestemmie”), ma vediamo come i genitori e fratelli reagiscono o ignorano il semplice fatto che quella notte non è tornata a casa.
“La domenica di solito cenavano prestissimo, ma nessuno aveva avuto voglia di mangiare in attesa di chiamare la polizia. Dopo che i due poliziotti se ne furono andati, però, la madre disse: ‘Io sto morendo di fame!’ e il padre: ‘Anch’io. Che ne dite se preparo dei panini con il formaggio fuso?’ Era la sua unica specialità, in cui si prodigava solo un paio di volte all’anno. Così andarono tutti in cucina, dove lui estrasse la grande griglia quadrata e un mattone gigante di formaggio; in pochi minuti nella stanza si diffuse un profumo delizioso di burro fuso che diede subito a Karen una sensazione di festa, anche se sentiva ancora quel peso allo stomaco e con un orecchio continuava ad ascoltare se dalla porta venisse qualche rumore. (‘Secondo me vostra figlia tornerà a casa questa sera con la coda tra le gambe’ aveva pronosticato il poliziotto più vecchio.) Eppure si sentì invadere da una strana sensazione di festa. Forse era il sollievo di avere di nuovo la casa tutta per loro – quei due testoni se n’erano finalmente andati, la radio del più anziano finalmente taceva. E il resto della famiglia sembrava pensare la stessa cosa. Suo padre faceva il buffone davanti ai fornelli brandendo la spatola e imitando un accento da chef francese. La madre si era tranquillizzata e a tratti perfino rideva. Suo fratello se ne stava stravaccato su una sedia in cucina, stranamente partecipe della vita familiare”.
Un momento di massima tensione (“il mistero principale delle nostre vite” definirà la sparizione di Lindy il fratello George verso la fine), eppure le reazioni dei sentimenti procedono imprevedibili per la tangente, una cosa dopo l’altra, e il punto di vista in questo caso è quello abbastanza distaccato della sorella minore Karen. Dettagli significativi di un episodio emergono a volte solo più tardi nella narrazione.
Così i personaggi sono sempre calati nella Vita, sono suoi fenomeni ed espressioni, ed Anne Tyler è una discendente di Tolstoi e Proust, e sicuramente sa qualcosa dell’élan vital, dello spirito del mondo (qualche suo scritto sfiora il tema del misticismo). Ma, ed è straordinario, non ci dice mai nulla del senso di tutto ciò, lo presenta alla nostra attenzione e compassione. E’ un mondo registrato-inventato che lei così raffigura con precisione cristallina, come una Jane Austen ha raffigurato il suo mondo, o Hemingway il suo (e Hemingway sosteneva appunto che l’arte del narratore stesse nel portarci là dove egli era stato).
Ma oltre all’America di Pearl Harbor e dell’11 settembre, egualmente immutata davanti a questi eventi così come la vita personale muta e insieme non muta davanti alle catastrofi familiari, Tyler ci mostra un’umanità non limitata dallo spazio e dal tempo, giacché i suoi personaggi banali, prigionieri di vite che sarebbe facile liquidare come prive di interesse (la suburbia di Baltimora!), respirano e vivono degli stessi pensieri e sentimenti e turbamenti interpersonali che ritroviamo ogni giorno vicino a noi.
E soprattutto Tyler si è data uno stile trasparente che riesce a non sembrare più stile, a lasciare agire i suoi Michael e Pauline, a dargli anche dignità senza mai stonare. Sono piccole realizzazioni, ma a ben pensarci è raro incontrare oggi un’opera di tale semplice e commovente perfezione. Tanto che non sappiamo nemmeno di esserne commossi.
“Il Manifesto-Alias”,
15 gennaio 2005