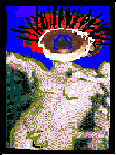
Massimo Bacigalupo
Wallace Stevens, la riscoperta del poeta
della realtà
60 anni or sono, il 2 agosto
1955, moriva a 75 anni Wallace Stevens, un gigante della poesia americana, che
negli ultimi decenni ha persino oscurato in patria gli astri più bizzosi dei
coetanei Frost, Pound ed Eliot. E persino da noi è accolto come una
rivelazione, a giudicare dal coro unanime dei recensori che ha salutato la
recente uscita del Meridiano di Tutte le
poesie da me curato per Mondadori (pp. CLX+1325)
Il Meridiano contiene 332
poesie tanto lucide quanto misteriose, lunghe dai 2 ai 659 versi – così il
poema vagamente dantesco Note per una
finzione suprema, scritto nel 1942, in piena guerra, e che alcuni giudicano
il capolavoro.
Poesie, poemi, finzioni... Non
è forse un mondo lontano dalle nostre preoccupazioni a quotidiane? Sono passati
giusto cent’anni da quando Stevens pubblicava le prime opere fondamentali,
cent’anni in cui se ne sono viste di cose e guai. Dunque dovremmo leggere una
poesia come “Peter Quince al clavicordo” o “Domenica mattina” (che sono appunto
due testi del 1915)? La prima comincia: “Come le mie dita su questi tasti /
fanno musica, così gli stessi suoni / sul mio spirito fanno anche musica. //
Musica è dunque sentimento, non suono...”. Peter Quince (che poi era un
personaggio di Shakespeare) si diletta di queste fantasticherie, e continua venendo
al tema erotico: “ed è perciò che quel che sento / qui in questa stanza,
desiderando te, / pensando alla tua seta dalle ombre azzurre / è musica...”.
Stevens è un poeta edonista e
ragionatore, che mescola severità, sensazione, musica. Qualcuno ha citato
D’Annunzio. Ma l’estetismo di Stevens non ha nulla di esibizionistico, è severo
e ironico, e si vale di un vocabolario che persino un non anglofono può
sondare.
Si sa che nella vita era
vicepresidente della più grossa compagnia di assicurazioni americana, e non
amava parlare di poesia, e nemmeno leggerla, per non esserne influenzato,
diceva. Infatti non c’è dubbio che le sue mille pagine sprizzino un’originalità
non ricercata ma spontanea. Come il nuovo mondo americano di cui è il
paradossale esponente (non fu mai in Europa, a differenza di pressoché i suoi
coetanei scrittori globetrotter).
Qualcuno ha detto di essersi
insospettito quando ha scoperto che Stevens è amato da coloro che dicono di non
amare la poesia. Eppure l’eterno tema di Stevens è proprio il ruolo della
poesia e dell’immaginazione in un mondo che la schiaccia, e che pure non può
non essere suo fondamento. Lo apprendiamo leggendo gli aforismi raccolti nel
Meridiano. “La realtà è solo la base. Ma è la base”. Oppure: “Il denaro è una
sorta di poesia”.
Stevens ci guarda serenamente con
la sua perfetta cravatta e camicia a righe dalla copertina del Meridiano e dal
suo grande ufficio nell’America degli anni ’50.
Sembra non nutrire dubbi sulla possibilità di affrontare il reale, e
infatti i lettori lo venerano per la sua capacità di “staccare” e richiamare al
compito della conoscenza e della vita, con concreta astrazione. Le sue poesie
sono come degli indovinelli, o dei disegni giapponesi. Non si capiscono ma si
guardano, con inesausta soddisfazione. Ecco, sappiamo che a Stevens possiamo
sempre tornare e trovare una parola lucidissima e misteriosa che ci parrà di
non aver mai letto prima, per quanto lo abbiamo frequentato. L’inafferrabilità
dei suoi testi così solidi ne fa il fascino inesauribile.
“Secolo XIX”, 2 agosto 2015