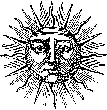
Massimo Bacigalupo
Emerson. L’individuo illumina ogni cosa, prima del
fuoco universale
“Chi oserà pensare di essere giunto in ritardo nella natura, o di avere
perso qualcosa di straordinario nel passato, a vedere le meravigliose stelle di
possibilità e il continente ancora inesplorato di speranza che brilla con tutte
le sue montagne nell’immenso Occidente?” Ralph Waldo Emerson pronunciava queste
parole nel corso di una lezione tenuta l’11 agosto 1841 in un remoto college
del Maine. La conferenza, Il metodo della
natura, oggi riproposta con testo a fronte da Anna Banfi (La Vita Felice,
pp. 83, euro 9,50), risale al periodo aureo in cui Emerson pubblica alla
vigilia dei quarant’anni il primo volume
dei decisivi Essays, contente
capisaldi della visione americana, fra tutti “Self-Reliance”, la “fede in se
stessi”, in cui invitava a rigettare precedenti e tradizioni e affidarsi alle
proprie intuizioni: meglio sbagliare da soli che andar dietro al gregge. Una
tesi a suo modo rivoluzionaria, alla base di ogni biografia americana che
importi. Si pensi solo ai due maggiori poeti di quel mondo: Whitman (che
conobbe personalmente Emerson) e Dickinson (che probabilmente lo sbirciò da
dietro le tendine della sua camera in occasione di una visita del pensatore ad
Amherst). Entrambi scrivono in un modo che nessuno aveva visto prima, di cose
note solo a loro. “Perché io vedo al modo della Nuova Inghilterra” dichiara
Emily. “La regina discerne, come me, provincialmente”.
La benedizione di essere provinciali. Provinciali immersi però nella cultura
del tempo, e insieme da essa distaccati. “Non accetto ciò che passa per buono ma
indago se sia buono”. La storia conta poco.
Emerson ha anche fama di essere
piuttosto vaporoso. Non per nulla egli è il filosofo del “trascendentalismo”.
E’ un idealista assoluto, per cui siamo tutti immersi nello spirito. “La natura
non esiste per realizzare uno o più fini personali, bensì innumerevoli e
infiniti benefici; non vi è in essa una volontà particolare, una foglia o un
ramo ribelle, tutto è invece oppresso dall’incombere di una sola tendenza,
obbedisce a quell’esubero o eccesso di vita che negli esseri coscienti
chiamiamo estasi”. La chiave del
tutto è l’estasi: “C’è una vita che non
possiamo descrivere che possedendola”.
Nonostante la sua passione per
l’astrazione, Emerson ha una grande capacità espressiva, inventa frasi
memorabili, e soprattutto tende a galvanizzare l’uditorio con il senso della
possibilità e della grandezza dell’individuo, a scapito delle istituzioni
sociali. Svaluta i dibattiti parlamentari, celebra l’uomo di genio, che è
l’eroe romantico e costruttore (e distruttore), Napoleone, ma è anche
democraticamente ciascuno degli studenti che ascoltano la sua lezione e
ciascuno dei suoi lettori.
Per cui leggere Emerson è un po’
un dovere culturale data la sua importanza come fonte ideale non solo
americana, ma è anche stimolante come per un testo insieme speculativo e
poetico. La natura innerva il tutto e l’uomo trova in lei la sua collocazione
esaltante : “Da lui ogni cosa è illuminata fino al suo centro”. Ma per svolgere questa funzione occorre il
genio: “La natura è muta e l’uomo, suo eloquente fratello, ecco! anche lui è
muto. Eppure quando arriva il Genio, il suo parlare diventa fiume; non deve
sforzarsi di esprimersi, più di quando la natura si sforzi di esistere”.
Se Emerson non fosse riuscito a
comunicare queste convinzioni ci sarebbe quel poeta immenso e diseguale che
è Whitman che le ha espresse a non
finire nelle sue rapsodie, con la sicurezza (giustificata quando era in vena
come nel “Canto di me stesso”) che ogni cosa del mondo potesse essere detta e
diventare immediatamente rivelazione.
Queste e altre pagine di Emerson sono affascinanti da leggere come una sorta di
programma o libretto da cui l’incolto Whitman fu trascinato e (come disse) “portato
all’ebollizione”. Ma l’entusiasmo non basta a scrivere buoni saggi e buone
poesie. E’ per questo che c’è un solo Whitman.
E magari un solo Dante. Il colto
e curioso Emerson si occupò spesso di Dante e viaggiò in Italia. Nel 1843,
dunque nel periodo più ispirato, stese la prima traduzione inglese della Vita nuova, pubblicata postuma nel 1957
e ora edita in Italia per la cura meticolosa di Igor Candido (Aragno, pp.
XXX+305, euro 15,00). E’ un libro elegante, di interesse specialistico. La
traduzione si basava sull’edizione del 1576, molto manchevole, che Candido
ristampa a fronte del testo inglese. A parte qualche fraintendimento, Emerson
se la cava bene nel leggere le scrupolose annotazioni da diario intimo della Vita nuova, che data la sontuosità dell’edizione
Aragno fa piacere rileggere. Quante
volte Dante parla della sua camera dove va a riflettere sul saluto dato
o ricusato di Beatrice...
Pubblicare una traduzione d’autore accanto al
testo di partenza nel paese d’origine del secondo è un lusso riservato a poche
delle tante importanti traduzioni dei nostri classici, tanto più sorprendente
dato che in Italia mancano affatto
edizioni correnti dei principali lavori di Emerson. Che pure, come
ribadisce Banfi nella prefazione a Il
metodo della natura, meriterebbero di essere ponderati e potrebbero
svolgere una funzione animatrice addirittura politica per il loro franco
insistere sulla necessità di ricominciare sempre. Ogni nuovo individuo è
precipitato in un caos sconosciuto di cui deve dar conto prima di scomparire
nel gran fuoco universale.
Ma l’edizione italiana di questa Dante’s New Life contribuisce
significativamente alla storia del dantismo anglosassone (altro argomento
esoterico, si dirà). Igor Candido infatti racconta in un saggio di 175 pagine
tutto ciò che si può scoprire sul rapporto Emerson-Dante, citando i testi in
cui il “saggio di Concord” si pronuncia
sul tema del grande uomo “rappresentativo” (Shakespeare, Milton, Goethe, Dante
ecc.) e fornendo anche un ricco contesto che va dai contemporanei a George
Santayana giù giù fino a Eliot e Pound che a differenza del più timido
conterraneo (loro venivano dal West!) erano pronti a gettare alle ortiche
Milton per seguire l’esempio luminoso del fiorentino e la sua “amorosa
erranza”, giudicandolo perlomeno non secondo a Shakespeare e migliore modello
da imitare. Shakespeare sarebbe secondo Eliot inimitabile se non goffamente,
Dante invece con le sue semplici immagini dichiarative non costituisce un
pericolo per il giovane poeta. Da ciò ad
esempio questa similitudine del neo-inferno di Pound: “un puzzo come di oli a
Grasse” (canto 15). “Quale ne l’arzanà de’ Viniziani”,
scriveva Dante. Oppure: “come la mosca cede alla zanzara”.
Il saggio introduttivo di
Candido, quasi un libro a sé, offre un florilegio di scritti emersoniani, tutti
citati in inglese, il che lo rende più prezioso per lo specialista ma forse
meno fruibile dall’italianista. Vediamo Dante rinascere in America dove avrà
una lunga fortuna, e sentiamo anche le voci di Singleton e altri interpreti
nostri contemporanei. Verso la conclusione Candido si sorprende che in età
avanzata Emerson dia un giudizio apparentemente limitativo di questo
“mastodonte” (“un uomo da mettere in un museo, ma non in casa tua”), e concluda:
“Indeed I never read him, nor regret that
I do not”. Candido pensa che questo significhi “non l’ho mai letto e non lo
rimpiango”. In realtà direi che la frase va letta al presente: “Non lo leggo
mai e non me ne dolgo”. Questo naturalmente potrebbe dirsi di ognuno di noi che,
più o meno dolendosi, non torna più di tanto a queste grandi fonti, distratto
dalle incombenze che Emerson appunto biasimava. “Il manifesto-Alias”, 20 gennaio 2013