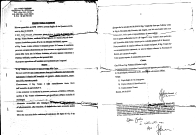|
|
Estratti
di “Mobbing Sociale” Sui fatti accaduti nel periodo 2009-2013 e in particolare sui DANNI SUBITI A CAUSA Di INTERVENTI IRRAZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO. [Versione Agosto
2013] |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
PREMESSE Il famoso etologo Konrad Lorenz utilizzò per primo
il termine mobbing per definire “un attacco di un gruppo di animali nei
confronti di un solo individuo della stessa specie”. Il termine fu ripreso poi da Leymann
definendo con mobbing “una comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo
sistematico da uno o più persone principalmente contro un singolo individuo
che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di
difesa, e qui costretto a restare da continue attività ostili…” Il mobbing sociale è un mobbing che avviene in un
contesto sociale e dunque in un ambiente più vasto di quello lavorativo, pur
potendo aver origine in questo, e ne assume le stesse caratteristiche. Il
mobber agirà dunque per i suoi fini non limitatamente all’interno dell’ambiente
lavorativo, ma anche all’esterno utilizzando ad esempio la sua posizione
sociale. Anche se nell’ambiente sociale il mobbing ha
caratteristiche simili allo stalking (persecuzione continuata, art 612bis
c.pen) , nel mobbing sociale non è più l’azione di un singolo individuo ad
agire , ma l’azione o l’inazione di più persone, che tollerano o favoriscono
il fenomeno, sovente diventa dunque un fenomeno di gruppo. Il mobbing sociale è un’azione subdola e, sovente
impalpabile per compiere, con altri metodi
un’azione altrimenti illegale, come l’allontanamento da un’azienda o
da un territorio. Il documento, suddiviso in due parti, presenta
nella parte I un’esecuzione di mobbing sociale, consistente in un
allontanamento dalla società civile della parte scrivente tramite strumenti
apparentemente legali di “difesa sociale”. Apparentemente legali ma sostanzialmente illegali
per quanto descritto nella parte stessa. Le origini e le cause sono trattate
nella parte II. Nella parte III si sottolinea come il mobbing sociale
continui a perpetrarsi anche nel nuovo territorio. Parte I.
.1 PREMESSE: Una sera d’agosto del 2010, io e mia moglie, uscimmo verso le 18:00, ci salutammo verso le 21:00 pensando che ci saremmo rivisti di lì a poche ore a casa. Io tornai per primo a casa, verso mezzanotte e pochi minuti dopo irruppero nella stanza tre poliziotti. Mi accusarono di essere un fannullone, uno che vive sulle spalle della comunità che doveva essere rieducato. Mi portarono via con le manette, mi tennero in carcere la notte e al mattino mi portarono in Questura. Nel pomeriggio, mi si presentò da un delegato del questore un foglio di via con rimpatrio obbligatorio nel comune di residenza. Mi si disse di firmarlo in fretta: alla mia opposizione l’ufficiale si limitò a dire che ormai era stato già tutto preparato e dovevo attenermi a firmare ed ad eseguire quanto deciso senza fare opposizioni. Sostanzialmente il foglio indicava che alcuni cittadini avevano riferito che ero una persona dedita a comportamenti delittuosi, fatto dunque rientrare dalla polizia nella fattispecie di persone socialmente pericolose regolate dalla legge 1423 del 1956, dunque fu attivato un provvedimento di rimpatrio a motivo di “difesa sociale”... In genere nei cosiddetti paesi civili è consentita la difesa, un dibattito, un dialogo o un processo ed in effetti l’art.4 della legge 1423 del 1956 prevede l’applicazione della proposta di pericolosità avvenga dopo che il questore ha provveduto ad avvisare oralmente la persona dei sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Invita inoltre la persona a tenere una condotta conforme alla legge. Solo dopo essere trascorsi almeno sessanta giorni dall’avviso, il questore può avanzare proposta motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione. Quanto stabilito dalla legge è per permettere all’accusato di potersi difendersi. Nel mio caso questo però non accadde perché il provvedimento della polizia fu eseguito con un’addizionale clausola “d’urgenza”: senza rispettare in pieno tale normativa, a detta della polizia, si doveva compiere tale operazione, passando sopra anche al basilare diritto della difesa ed allo stesso articolo 4, per il pericolo di «reiterazione di comportamenti pericolosi e della conseguente lesione della sicurezza pubblica». Ripeto: i poliziotti irruppero nella mia dimora nel pieno della notte, mi portarono via all’insaputa di mia moglie che doveva ancora rincasare, scalzo: mi portarono in Questura, là mi accusarono, in breve, di essere un delinquente abituale socialmente pericoloso, e mi spedirono al comune di residenza con l’obbligo di non poter tornare nel comune ove dimoravo, per tre anni, senza nemmeno poter fare le valigie. Dal momento che la polizia irruppe al momento che mi consegnarono il foglio di via, erano passate circa 14 ore, e nessuno, ribadisco, nessuno della polizia mi chiese o diede spiegazioni: mi insultarono e basta. Dunque un po’ di luce sui quello che stava accadendo, lo vidi solo dopo quelle interminabili ore. Impresso nel foglio di via vi era scritto: «numerose sono le proteste inoltrate da operatori turistici e commerciali nonché da semplici cittadini, a causa della presenza di persone dedite ad attività delittuose, che costituiscono fonte di enorme turbamento per la sicurezza pubblica». Quelle persone sopra citate eravamo noi due parte scrivente. Ma che cosa abbiamo fatto? Mi chiesi. Oltre a non aver avuto l’avviso orale, previsto dalla legge e la cui mancanza può essere pena di nullità dell’intero provvedimento, le accuse sul foglio di via non specificavano di quali delitti i cittadini ci avevano accusato. Le accuse erano inconsistenti, essendo state nominate attività delittuose senza indicare quali e in quali occasioni si erano verificati tali fatti . Vi erano indicate anche altre informazioni, ma sempre fatti remoti o non attinenti non applicabili al caso suddetto. Io dunque ero stato portato via dalla polizia —e avrebbero fatto lo stesso con mia moglie se l’avessero trovata a casa quella sera— in base a semplici proteste di persone. Non furono verificati i fatti, non furono formulati reati e/o denunce querele per tali supposti fatti, non furono indicati nemmeno gli estremi di eventuali atti immorali dei quali ci saremmo resi colpevoli ma soprattutto non si fece quello che è previsto dalla legge, cioè un’indagine completa sulla personalità del soggetto, cosa che normalmente fa un giudice tramite persone competenti e che nel mio caso fu completamente saltata per i motivi già menzionati da noi contestati nel presente documento. Come si evince delle varie sentenze della Cassazione (vedi CASSAZIONE 1O MARZO 1993), un’applicazione coscienziosa e assennata richiede: § Valutazione della personalità di chi sospettato per pericolosità; § Valutazione del contesto sociale in cui questo accade e sua influenza. Un
avvocato intuì immediatamente l’azione descrivendola come un sistema veloce per liberarsi di persone
scomode dal territorio, e siccome in ballo vi era la volontà di sfrattarci dalla stanza che
occupavamo, quello era un sistema veloce ed economico, senza ricorrere alle
normali leggi di sfratto che invece richiedono mesi di applicazione. Difatti ai fini pratici, la polizia non solo mi sottrasse la chiave dell’appartamento sostenendo che ero un abusivo senza contratto —in realtà non eravamo abusivi, semplicemente non potevamo avere un regolare contratto perché il posto non aveva la necessaria abitabilità— , ma la polizia mi asporto pure a forza dall’immobile portandomi in cella. Per tirarmi fuori a “norma di legge” mi si accusò di resistenza a pubblico ufficiale. Noi avevamo una sola chiave dell’appartamento e l’operazione di sottrazione della chiave fu sufficiente per impedirci di rientrare: evidentemente non potevamo nemmeno rivolgerci al responsabile dell’immobile per ottenere una copia, in quanto si trattava di quella parte che aveva attivato la polizia per lo “sfratto spiccio”. “Un caso di spiaccia azione amministrativa invece di sentenze regolari” lo definiamo noi prendendo a prestito una definizione letta in pubblicazione sull’utilizzo dei campi di lavoro in Russia. In ogni caso, ormai l’azione amministrativa, legale o no, era stata attivata e pure il risultato dello sfratto spiccio era stato ottimamente raggiunto. Non solo, mia moglie rincasando non trovò nessuno ad aprirle la porta e non avendo telefoni o recapiti reciproci ci fu impossibile per i giorni successivi mettersi in contatto. Preoccupato incaricai i carabinieri di cercarla, ma passarono giorni senza avere notizie. Del provvedimento non si poteva nemmeno fare opposizione al questore o al giudice: ciò è possibile solo con l’iter normale, quello previsto dal punto 4 della legge 1423 del 27/12/1956 e sue modifiche. Preoccupato anche per le sorti di mia moglie, volevo cercarla direttamente nel territorio e anche per tale motivo si fece dunque ricorso gerarchico al prefetto chiedendo di sospendere l’esecutività del provvedimento e in via principale di dichiararlo nullo, annullabile e di nessun effetto. I motivi citati furono sostanzialmente tre: la presunta resistenza a Pubblico Ufficiale ascrittami era stata fatta per giustificare l’asportazione forzata dall’immobile; mancavano le condizioni di emissione del foglio di via; nei miei confronti non era stato emesso alcun provvedimento giurisdizionale legittimante il rilascio dell’immobile. Tabella T1 sulle azioni compiute in agosto 2010 per
allontanare marito e moglie dal territorio
.2 EFFETTIQuanto fatto dalla polizia narrato nelle premesse (punto precedente) ebbe degli effetti ben precisi, che non vennero risolti con il ricorso gerarchico. In pratica: 1. L’esecuzione dei provvedimenti a “difesa sociale” rimase pendente e cioè rimanemmo nel periodo successivo fino a tutt’oggi in pericolo che la polizia reiteri il provvedimento già fatto. Primo, perché era evidente che il provvedimento doveva essere attivato anche su mia moglie, e che non lo si attivò solo perché non riuscirono a trovarla né quella sera né i giorni successivi. Secondo, perché non sono state smontate completamente le tesi accusatorie, non avendo avuto la possibilità finora di esercitare il nostro diritto di difesa. Cioè la polizia è ancora convinta che siamo persone pericolose. 2. Fummo sbattuti in strada, in condizioni di indigenza e non potemmo più rientrare nell’appartamento e prendere le nostre cose. 3. Fummo infangati dall’azione della polizia, la quale andò a rinforzare quanto già di ingiusto avevano riferito i cittadini implicati. La tesi della polizia sulla nostra “pericolosità sociale” si andò poi a spalmare su tutte le autorità locali e non, compresi i carabinieri e polizia municipale, creando un clima ostile generale e influendo indirettamente sugli organi preposti ad aiutare le persone in stato di bisogno, cioè, assistente sociale e organismi umanitari. In pratica, per la nostra pericolosità ci lasciarono senza aiuti sociali, in linea con chi doveva allontanarci, come narrato nella parte III. In generale dunque, fummo accusati in modo ingiusto senza possibilità di difesa, fummo screditati, ci fu infangato il nostro nome, fummo estromessi dalla vita sociale e additati come persone pericolose socialmente. Fummo e siamo tutt’ora confinati ad una vita ai bordi della società. Peggio dei criminali. Dopo l’azione della Polizia nessuno ci aiutò più, né Caritas né i Comuni e vivemmo senza casa in rifugi di fortuna. Alla data che vi sto scrivendo, sono passati più di tre anni, e permane questa situazione. Furono fatti degli esposti e/o denunce ai CC e alla Polizia e alla Procura della Repubblica: nessun esito! Parte II. DIFESA.3 In generale(A) IntroduzioneAncora prima dell’operazione di “spiccia amministrazione” messo in atto dalla polizia, ancora un anno prima, cioè da quando cominciammo a vivere nella provincia in cui si verificarono i fatti in oggetto, eravamo in contatto con i carabinieri di un comando fuori regione. Questi conoscevano bene la nostra situazione, e noi avevamo continuato ad aggiornarli sui fatti che ci stavano accadendo anche nella nuova provincia, tentando anche di individuare il “filo nero” che collegava fatti vecchi a nuovi... Già in settembre ‘09 segnalammo la nostra situazione, in poco meno di una decina di pagine, e cioè di come in zona non si riusciva ad ottenere un aiuto sociale e un lavoro, e spiegammo per filo e per segno come dovemmo arrangiarci a procurarci cibo per campare. Già in dicembre 2009 segnalammo come erano sorte in loco diffamazioni sul nostro conto e avevamo chiesto un intervento per risolvere alcuni problemi legati alla privacy e sicurezza. Seguirono altri contatti. Le diffamazioni ad un certo punto raggiunsero un tale ardore che qualcuno pensò di utilizzare i carabinieri per farci sloggiare, insinuando anche in questi convinzioni assurde. Nel momento in cui i carabinieri intervennero con molto impeto, credendosi di trovarsi davanti a criminali di mestiere, spiegammo la situazione, ci fu dato modo di difenderci: questi si misero in contatto con i carabinieri umbri che erano al corrente dell’intera situazione. L’intermediazione dei carabinieri bloccò l’insensatezza delle accuse. Questi CC erano una pattuglia del vicino paese. Vi fu un secondo intervento dei CC, questa volta proprio quelli del paese in cui dimoravamo: questi non riuscivano ad avere una visione obiettiva dell’intera questione per la loro appartenenza all’ambiente. Tuttavia non si prestarono completamente ad essere utilizzati per farci allontanare: consegnammo loro una lettera scritta a mano, descrivendo come vivevamo, chiedendo aiuto per fare chiarezza. E’ da evidenziare che I CC, intervenuti due volte, non trovarono mai elementi che giustificassero le accuse rivolteci, come nemmeno prove di reati o atteggiamenti immorali. Chi si era prodigato a chiedere l’intervento dei CC, non ottenendo i risultati, escogitò dunque ad un’altra strada. Alcuni cittadini andarono dal sindaco e ci accusarono di vivere tramite delitti. A questo punto tutti assieme si attivarono presso la polizia. (B) DunqueNon ci rimase altro che star distante dalla polizia, e da tutto ciò che ne è correlato. Tentammo di capire come funziona la legge sulla pericolosità. La nostra difesa è espressa in due direzioni principali: la prima diretta a dimostrare che il provvedimento attuato dalla polizia non è avvenuto secondo le prescrizioni di legge. La seconda diretta a raccontare la nostra vita, evidenziando “etichette negative”attribuiteci nel passato, o desunte attualmente dal comportamento di alcune persone. .4 Contestazioni: sull’illegittimità del provvedimento(A) In generaleScoprimmo che seppur non si poteva adire al giudice per opporsi al giudizio stabilito dal questore, una sentenza della CASSAZIONE del 29/10/1993 stabiliva che «al giudice è consentito esercitare su detto provvedimento il solo sindacato di legittimità consistente nella verifica della conformità di esso alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo della motivazione sugli elementi da cui scaturisce il giudizio di pericolosità del soggetto» (Cass. mass.dec. pen. 1994, n. 195.337). Ci rendemmo dunque conto che l’atto della polizia non conteneva motivazioni concrete limitandosi a riportare accuse generiche e non corrette. Il punto principale che fece scaturire l’operazione di rimpatrio furono le proteste dei cittadini, che sono riportate nel provvedimento in termini generici. Gli altri punti iscritti a spiegazione del provvedimento sono strumentali, semplicemente perché l’esecuzione della polizia partì proprio dalle proteste suddette, finalizzate alla nostra cacciata: in pratica chiacchiere di paese che intravedevano in me e mia moglie due delinquenti a causa di una situazione del tutto particolare. La cacciata doveva essere semplicemente eseguita, senza possibilità di appello o ricorso: di conseguenza la polizia utilizzò la “scusa” di una pericolosità sociale, definendomi “riconducibile all’articolo 1 punto 3 della legge 1423 del 27/12/1956. Si tratta della strumentalizzazione di un incidente accaduto nei territori di Padova, ancora nel 2005. Ci fu qualcuno delle forze dell’ordine che all’epoca tentò di dare un suo giudizio psicologico al problema, comunque per il fatto io non rientrai mai nell’articolo 1.3. Qualora fossi rientrato nell’articolo sopra citato, per pericolosità sociale, l’operazione avrebbe dovuto essere attuata dalle istituzioni di Padova. Invece gli agenti di queste zone si arrogarono il diritto di inserirmi in tale livello di pericolosità, pur non essendo competenti per loro funzione e per territorialità. (B) Contestazione-1:mancanza della competenza territorialeLa prima contestazione riguarda dunque proprio l’uso di tale fatto del 2005, qualcuno tento di attribuire spiegazioni psicologiche al fatto:ma non rientrai mai nelle leggi di prevenzione. La polizia non può utilizzare un fatto remoto, successo in altra regione, per farmi ricondurre a una persona socialmente pericolosa delle fattispecie previste dalla legge. A fare ciò dovrebbe essere stata una sentenza emessa da qualche organismo competente territorialmente, cioè Padova. Quindi manca il requisito della competenza territoriale.per stilare l’affermazione contenuta nel foglio di via. Dunque il fondamento di partenza su cui si basa il provvedimento non è a norma di legge al fine per cui è stato usato. (C) Contestazione-2:fatti non attualiIl fatto utilizzato a fondamento del foglio di via, già descritto nella contestazione precedente, non è applicabile ai fini del foglio di via perché non costituisce, come stabilisce la legge, fatto attuale né tanto meno accaduto nel territorio. (D) Contestazione-3:mancanza categoriaLa legge stabilisce che nel provvedimento debba essere specificato il soggetto in quale categoria di persone rientri: l’indicazione dell’articolo 1 punto 3 della legge 1423 del 1956 è infondata, perché è una loro attribuzione, non un misura effettivamente presa nel territorio in cui si è verificato l’evento. Accogliendo anche solo una delle contestazioni precedenti, anche la categoria indicata non avrà più significato. Risulterà dunque il provvedimento orfano di uno degli elementi essenziali per la sua validità. (E) Contestazione-4:motivazioni genericheLe motivazioni sono riportate nel provvedimento in termini generici: di fronte a queste non si può esercitare un serio diritto alla difesa, perché troppo ampie ed ambigue. La polizia non ha seguito quindi quanto stabilito dalla Cassazione dove dice:”Il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale e ad esso sono applicabili le garanzie previste per il giudizio di cognizione a tutela dei diritti di difesa, dell’assistenza e della rappresentanza dell’imputato… Ne deriva che la contestazione non può essere attuata… dalla mera indicazione della misura di cui si chiede l’applicazione, ma con l’indicazione,precisa e chiara, del tipo criminologico (ozioso, vagabondo, sospetto di appartenenza ad organizzazione mafiosa), riferibile ad una delle fattispecie previste dalla legge, nonché con l’esposizione, sia pure succinta, degli elementi indiziari che sorreggono la proposta (CASSAZIONE: 12 GENNAIO 1987.Cass. pen., 1988 1100). Si trattava ovviamente di chiacchiere e null’altro perché alle ipotetiche attività delittuose delineate dai misteriosi cittadini, non seguì mai una denuncia precisa o fatti circostanziati di reati o comportamenti contrari alla Costituzione o immorali! Condannare una persona o limitare la libertà della persona prevista dall’.Art 13 della Costituzione senza che vi siano prove a riguardo e senza un regolare processo è una cosa grave e allarmante: situazioni del genere capitano o capitavano nei regimi totalitari durante le persecuzioni politiche e/o razziali e hanno sempre costituito un grave avvertimento. La mancanza di accuse specifiche mi impedì di fatto, e mi impedisce tuttora, di poter esercitare il mio diritto della difesa, contrapponendo alle accuse un’adeguata difesa. Ad esempio, mi si accusa di furto, di spaccio, di atti osceni in luogo pubblico? Cosa turba così tanto le persone del luogo, in zone dove lo spaccio di droga o l’offerta di prestazioni sessuali è notevole, data la presenza di locali, night e discoteche e luoghi di divertimento? (F) Contestazione 5: mancanza dell’avviso di oraleCome recita la legge e sue modifiche del 1988, “l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l’avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.” L’azione della polizia doveva essere una cacciata, semplicemente eseguita: ne consegue l’esigenza di consegnare foglio già pronto, di impachettarci con la “scusa” di una falsa precedente pericolosità sociale. Nessuno ci ha avvertito dell’apertura di tale procedimento con relativi sospetti a nostro carico: non è quindi consentita l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3. Il senso della legge è infatti consentire alla persona sospettata la sua discolpa e/o il ripristino di un comportamento congruo alla società civile ed alla morale: nel caso questa non voglia operare in tal senso, si prendono adeguati provvedimenti, come previsto. La cassazione conferma il valore dell’invito, necessario come strumento per la stessa accusa: se l’invito non porta accuse ben formulate, il provvedimento è annullabile. CASSAZIONE: 29 GENNAIO 1990. — L’invito ai sensi dell’art. 4 L. 27 dic. 1956 n. 1423 alla persona nei cui confronti e` chiesta l’applicazione di una misura di prevenzione e` da considerare, come la citazione a giudizio, un veicolo di contestazione dell’accusa, e pertanto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione non solo della misura di cui si chiede l’applicazione, ma anche della forma di pericolosità posta a fondamento della richiesta (Cass. pen., 1991, 815). (G) Contestazione 6: reato strumentaleIl [xxxxxx] di agosto 2010, ancora prima di emettere il foglio di via, la polizia mi contestò il reato di “resistenza a Pubblico Ufficiale”. Fu un reato fittizio e strumentale per giustificare l’asportazione a forza dall’immobile e l’emissione del foglio di via. Non era stato emesso nessun provvedimento giurisdizionale legittimante il rilascio dell’immobile: ad esempio sfratto esecutivo, sequestro civile, sequestro penale. Il reato è da considerarsi dunque puramente infondato e strumentale al fine di liberare la stanza e essere portato via in manette. Non è da considerarsi nemmeno laddove è inserito nel foglio di via come elemento legittimante il provvedimento stesso: “un caso di spiaccia azione amministrativa invece di sentenze regolari”. (H) Mancata valutazione della destinazioneNell’emettere il
foglio di via è stato scelto di rimandare la parte scrivente automaticamente nel relativo comune di
residenza, senza valutare se questo fosse il luogo più idoneo e opportuno. Si
veda la narrazione a “le etichette del passato, numero 8.B. .5 Le etichette del passato(A) In generaleLa storia che siamo persone che si dedicano ad attività delittuose, così come riportato nel foglio di via non è nuova, è nata in altre regioni e già in passato qualcuno ha tentato di utilizzare le forze di polizia per mettere in atto un’azione simile a quella che è accaduta in agosto 2010, come narrato nelle premesse (punto .1). Da vari anni per proteggere la nostra vita abbiamo dovuto cambiare spesso paese e siamo entrati in varie Questure a chiedere una mano. Di accuse senza fondamento né abbiamo avute tante, e più di qualcuna in questura o dai carabinieri, davanti ad un colloquio o dibattito, è stata svelata per quello che era: chiacchiera e/o diffamazione. Le etichette con le quali siamo stati descritti si sono sprecate: i motivi di questo fenomeno non stanno nella sintomatica valenza delle stesse diffamazioni, ma per delle situazioni mai risolte dalla polizia, che continuano a produrre malintesi in ogni posto ove andiamo, oltre che un’azione di fondo diretta a screditarci o a renderci la vita impossibile. Questi argomenti sono già stati affrontati in altri documenti inviati all’autorità! Per capire cosa sia successo e abbia portato la polizia ad agire in tale maniera in agosto è dunque necessario ripercorre le tappe di quanto accaduto precedentemente, e cioè l’uscita dalla regione natia e la situazione vissuta in centro-Italia. Lo facciamo nei prossimi punti. (B) Costretti a lasciare la regione natiaDall’anno 2000 incominciò una persecuzione di un imprenditore in ambiente lavorativo. L’azione fu diretta sia alla ditta dove lavoravamo io e mia moglie, sia a titolo personale. L’apice dell’azione avvenne tra il 2004 e il 2005 quando riuscì a mettere in crisi la ditta e a farci perdere ad entrambi il lavoro Questo uomo d’affari condusse un’azione diffamante all’interno sia degli ambienti lavorativi veneti sia del comune di residenza. Non potemmo difenderci perché: non vi era una legge contro lo stalking come invece in altri stati; in aggiunta lo stato di povertà indottoci rendeva difficile un’adeguata difesa, nei confronti di chi era ben dotato di soldi, avvocati ed amicizie. Su tutta la storia incise profondamente l’impossibilità di ottenere un’assistenza dai parenti e affini. Noi non avevamo più contatti con i parenti dall’anno 2001, vivevamo completamente indipendenti e senza rapporti, per gravi ragioni portate a conoscenza all’autorità. Il nostro comune di residenza non solo non si adoperò per difenderci, ma evitò pure di aiutarci socialmente per la sopravvenuta condizione di povertà. Contestualmente a ciò si verificò un incidente, nel 2005, che vide coinvolto Aleandro*: qualcuno delle forze dell’ordine, più che una ricostruzione sistematica, predilessero un’interpretazione psicologica del fatto, nonché priva delle competenze mediche, ipotizzando scenari apocalittici futuri di commissione di chissà che reati. Per quanto riguarda gli scenari apocalittici previsti per Aleandro*, non si verificò nulla. ma non vi era modo per ristabilire la verità: se avessero lavorato correttamente, il fatto sarebbe costituito un caso civile, nemmeno penale. La fuga dal paese senza aiuti fu inevitabile. Senza lavoro e ben presto senza soldi, senza più un automobile, senza dei parenti o affini che potessero aiutarci, e senza l’appoggio dei servizi sociali, l’uscita dalla regione natia fu l’unica scelta possibile. in nessuna casa d’accoglienza o ente collegato direttamente alla Pietas*. Parte III. Emergenza abitativa.6Dopo l’operazione di “sfratto” spiccio di agosto 2010, narrato nella parte I del presente documento, ci trovammo ad essere senza un posto dove vivere e senza la possibilità economica di pagarci una stanza. Ovviamente non potevamo più stare nel Comune ove erano accaduti quegli spiacevoli fatti, non potevamo nemmeno cercare una soluzione negli ambienti della chiesa, per quanto già detto nella parte II, e non potevamo nemmeno vivere in regione natia. Cominciammo dunque a vivere nel Comune confinante, più grande del precedente, ed è qui che si verificarono i fatti successivi. “Emergenza abitativa” viene definita dal Comune la situazione di chi si trova, per varie ragioni, senza un posto dove dormire, e non sia in grado di risolvere il problema da solo, per vari motivi, come lo sfratto. A noi è capitato proprio quello che andiamo narrando: presentatici agli uffici del Comune di giovedì per un’emergenza abitativa, ci è stato fissato un appuntamento per lunedì, 25 ottobre 2010, e il lunedì l’assistente sociale non ha preso l’incarico di risolvere il problema. Ci ha rimandato a provare a bussare alla chiesa. Per esperienza precedente, sapevamo che avere un posto al dormitorio gestito dalla chiesa occorreva però parlare prima con il responsabile e si va dunque al successivo mercoledì, per sapere infine mercoledì che non c’era posto perché le strutture erano piene, ed essere rincuorati di provare venerdì che forse se qualcuno va via prima un posto lo troveranno… Intanto passano i giorni, e il comune o la chiesa sembrano sperare che uno si abitui a dormire fuori, tanto lo fanno già in tanti, e magari capita pure che ti dicono “tanto è solo una questione di abitudine, non si muore mica…”. Forse se ci si presenta separatamente nei dormitori, un posto uno dei due l’avrebbe trovato prima o poi, ma noi di separarci non ne avevamo voglia visto, che la nostra unione era l’unica cosa che ci era rimasta dopo aver perso lavoro, auto e casa. Era improponibile che fosse entrato nel dormitorio solo uno dei due, mentre l’altro sarebbe rimasto fuori esposto al pericolo, almeno in due ci facevamo coraggio e ci davamo assistenza reciproca, che poi, se qualcuno ricorda bene, è anche una delle cose che si promettono durante il matrimonio. Per capire queste cose non è necessaria la laurea dell’assistente sociale, occorreva invece un po’ di esperienza e un po’ di cuore. I dormitori costituiscono delle soluzioni per le persone disadattate, per gli ubriaconi, per i barboni…; dopo che sono stati chiusi i manicomi, si rifugiarono le persone con problemi psichici non gravissimi, poi vi sono spacciatori, prostitute, delinquenti, badanti che transitano nel territorio… ed in ultima analisi anche qualcuno che ha perso il lavoro ed ha divorziato, lasciando l’appartamento alla moglie. Diciamo che sono posti per single, non per una famiglia, ma sembra non volerlo capire nessuno. Quei servizi per i civili cittadini che sono catalogati con il termine “emergenze”, sono fasulli, perché non trattati con tali modalità: sono destinati ad ispirare false aspettative: cioè tempestività nel risolvere il problema sollevato e compimento del servizio con un sano senso del dovere. Dai giornali ogni tanto si apprendono queste situazioni, di gente che è rimasta in strada, ma i giornali riportano solo pochi casi rispetto a quelli che accadono, ad esempio non il nostro. Dunque il servizio “emergenza abitativa” si comporta come, pur avendo il nome, una non emergenza! Poco importa sia erogato da servizi sociali o da organismi della chiesa. E questo è successo a noi, ma anche ad altri. Non vogliamo dire con questo che il sistema non funzioni mai, funziona solo in parte e non nei termini che sarebbe normale aspettarsi. Inoltre i vari uffici sono gestiti come gli sportelli di banca, con degli orari prefissati, e come questi subiscono una burocratizzazione che annulla l’essenza del servizio stesso. Anzi peggio delle banche, perché queste hanno degli sportelli bancomat aperti a tutte le ore che risolvono il problema dei contanti. Le conseguenze furono ovvie: noi dormimmo fuori. Considerato quanto esposto nella prima e seconda parte di questo documento, non abbiamo alcuna intenzione a recarci presso le strutture caritative, essendo questa una della principali cause di tanti nostri problemi. Sembra che l’assistente sociale non abbia voluto capire nemmeno questo, pur avendole consegnato un documento con la narrazione dei fatti di Agosto 2010: questa è la pressi, assurda, come se un medico per prassi assegna la stessa medicina a tutti i pazienti, anche a chi ne è allergico. Lo Stato italiano non intervenne in nostro aiuto in qualità di cittadini, Si legge infatti all’Art. 3 della Costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Si legge che è compito della Repubblica e non della
chiesa! A questo punto l’assistente sociale trasformò il nostro caso da “emergenza abitativa” a condizione normale, semplicemente facendo diventare casa la strada. Non risolse l’emergenza abitativa, ci lasciò in strada, ma non rifiuto di aiutarci del tutto: disse che il comune comunque poteva assisterci in un progetto più lungo termine, ad esempio poteva fornirci dei soldi per la caparra e primo mese di affitto, nel caso avessimo trovato un lavoro ed un appartamento dove stare, e ci avesse conosciuto meglio… Sembra, dunque, dalle parole dell’assistente sociale, che solo i lavoratori in Italia abbiano diritto alla casa, dal momento che non hai più un lavoro non hai nemmeno più diritto ad un tetto. Ed il lavoro te lo devi pure trovare, e mantenere, con i mezzi che la “strada” ti dà. “Battendo”, come prostitute? Fingendosi improbabili “artisti di strada”? Dovevamo arrangiarci. Preoccupati di non farcela per il freddo, le intemperie, andarsene in giro con la valigia e le coperte, i segni evidenti di una certa fatica sul volto…..cercammo di argomentare la nostra difesa. E poi soprattutto, come si fa a trovare lavoro e tenerselo quando non sai neanche dove e come passerai la notte? Non hai neanche un domicilio da dare al datore di lavoro: con che faccia ti presenti? Inutile argomentare la nostra causa: l’assistente sociale ci rispose che non si muore mica vivendo fuori, :- “E’ solo questione di abitudine” ci replicò. Ribattemmo che non fanno il necrologio sul giornale per chi crepa perché il fisico non regge più, e non fanno statistiche serie per vedere che fine fa le gente in queste condizioni ed in che tempi. Così l’emergenza abitativa fu trasformata dalle operatrici del comune in “condizione normale”, la normalità di chi “è abituato a vivere fuori”. È prassi di molti comuni comportarsi così. Il sistema adottato dall’assistente sociale è stato dunque lo stesso che si usa nel buttare una persona in acqua, per farla imparare a nuotare: se crepa si fa un funerale, se sta male si arrangerà l’ospedale, se sopravvive si arrangerà a galleggiare; in ogni caso il problema è risolto o non è più di competenza. Cosa e’ successo poi Una persona del Comune, con un ruolo diverso da quello dell’assistente sociale, non riuscendo a trovare soluzioni, ci consigliò di provare a parlare con persone facoltose o commercianti, per vedere se potevano interessarsi al nostro caso. Ma in pratica noi dormimmo fuori, fino a che la mattina di lunedì primo novembre ci trovarono dei muratori e degli impresari, che dopo una grossa imprecazione, si mostrarono più pratici, e decisero di farci dormire dentro il capannone. La sera seguente di martedì pioveva a dirotto e gli impresari ci aspettarono: ci diedero delle coperte da mettere sul pavimento perché fosse meno freddo, il loro capo ci offrì una bottiglia di vino, una di acqua e un pezzo di pane, con la promessa di interessarsi in Comune; lasciarono aperto il bagno affinché potessimo usarlo. Tra queste persone vi erano gente con soldi e fabbriche nella provincia: sembrava in un primo momento che potevamo restare lì almeno fino alla fine dei lavori verso il 13 novembre. Potevamo utilizzare quel tempo per mettere giù le borse, che ci portavamo sempre appresso, per lavarci in un bagno con l’acqua calda, un tempo necessario per riorganizzarci, cercare qualche lavoro in zona in condizioni decenti; avevamo nuove speranze, anche la sensazione di non essere più da soli. Il capo degli impresari, un uomo pelato, ebbe la malaugurata idea di chiedere aiuto al parroco del paese. Mercoledì sera il capo ci disse di aver parlato con il parroco e ci invitò a spingerci nel capoluogo nelle strutture della chiesa: ribattemmo che là non vi erano soluzioni. Dopo il colloquio il capo ci promise comunque che potevamo restare nel capannone fino al 13-14 novembre, data in cui avrebbero chiuso le porte esterne del capannone. Già quella sera avevamo individuato come il parroco aveva gelato la situazione, e altri possibili interventi: la gente ci guardava schifata. Nel giro di un giorno quei facoltosi signori avevano cambiato atteggiamento nei nostri confronti. Giovedì non vedemmo nessuno, ma venerdì mattina degli operai ci dissero che dovevamo prendere la nostra roba e andare via, perché loro la sera avrebbero chiuso tutto. Avevano avuto l’incarico dal capo, il testa pelata. Noi ci trovammo dunque i termini cambiati nuovamente. Il modo di comunicarci quello “sfratto” e i tempi ristretti (mattina per sera) furono di una violenza gratuita, perché noi eravamo usciti senza borse e con dei progetti ben specifici. Ci trovammo di nuovo tutto il mondo addosso, a causa di un prete che senza nemmeno averci visto, aveva dato disposizioni sulla nostra vita. Noi non trovammo altre soluzioni e continuammo a dormire in quel posto perché per fortuna, nonostante quanto detto, non buttarono fuori le nostre borse e lasciarono la porta aperta. Non vedemmo più il “testa pelata” fino alla mattina del 12 novembre quando lo incontrammo per caso per strada. Incominciò dunque una discussione durante la quale ci disse che era molto offeso perché non gli avevamo raccontato la verità, e cioè, che eravamo stati sfrattati da 3 mesi e che stavamo conducendo quel tipo di vita da agosto: proferiva tali parole come se fossimo della gente abituata a tale tipo di vita “vagabonda”. Replicammo che non avevamo nascosto nulla, che il tipo di vita che fummo costretti a subire lo raccontammo all’assistente sociale, e che ne avevamo parlato pure con uno che pareva essere un suo socio da come si era a noi presentato. E avevamo informato anche i carabinieri. Non credette alla nostra informazione, ci disse:- “Ai carabinieri? Non raccontate balle, li ho chiamato io stesso e si sono detti pronti a intervenire per mandarvi via…”. Ancora prima che spiegassimo che eravamo in contatto con carabinieri fuori paese, aggiunse che aveva parlato della nostra situazione anche con il vice-sindaco, che è capo dei vigili e che si era accordato, che se nel caso non avessimo portato via le nostre borse di spontanea volontà, i vigili sarebbero intervenuti ad asportarle. Dal colloquio risultò chiaro che il “testa pelata” aveva ricevuto notizie poco rassicuranti nei nostri confronti e questo alimentò il suo voltafaccia. Questo accadde il giorno che incontro il prete, e fu certamente tale fonte a fargli fare il cambiamento repentino: difatti risultò chiaro che egli non parlò né con l’assistente sociale né con altre persone del comune da noi informata in proposito. Risultò che qualcuno, dopo che il prete venne a sapere che eravamo nel capannone, mandò i vigili a controllare il capannone e questi fecero varie storie al “testa pelata” per aver trovato la nostra valigia nei locali. In quei locali vi era di tutto, comprese varie coperte che erano usate per i lavori dagli operai, tavoli, sedie, una cucina nel mezzo del capannone… una valigia poteva passare del tutto inosservata in quell’ambiente. I vigili vennero a controllare la situazione, ma noi sappiamo che non lo fanno di propria spontanea volontà, soprattutto se è socio del capannone il vicesindaco: era certo che qualcuno li aveva mandati e aveva mosso tutto quel casino. Il prete o chi per esso, innescò dunque un processo denigratorio nei nostri confronti che coinvolse come una reazione a catena, il testa pelata, il vice-Sindaco, la Polizia Municipale e i carabinieri locali: TUTTI COINVOLTI IN UNA AZIONE DI PULIZIA SENZA SAPERE ESATTAMENTE LA VERITA’. Paradossale
l’accusa che le autorità e la gente come il “testa pelata” ci muoveva contro:
quella di vivere quel tipo di vita “all’aperto”, quando erano state proprio
le autorità, il Comune e la gente stessa a creare le suddette condizioni,
diventando dunque causa diretta e indiretta. Arrivammo alla seguente concessione: fino a quando non ci sarebbero state le serrature, potevamo entrare nel capannone, così il “testa pelata” non avrebbe dovuto giustificare la nostra presenza, in caso di qualche malaugurato incidente. In fondo era tutto aperto. Era solo un trabocchetto: alle 6:30 del 16 novembre 2010 irruppero due pattuglie, una composta da un paio di carabinieri ed una da tre vigili urbani: ci sbatterono fuori dal posto, che non aveva le serrature, e ci portarono in caserma, facendo discorsi infondati ed offensivi. Rimanemmo là, nella sala dei fermati, fino alle 11:00. Nessuno ci diede spiegazioni: ci mandarono via, sotto la pioggia con le nostre borse, e con il consiglio di non avvicinarci più ai luoghi del capannone. Ora se vogliamo sopravvivere, dobbiamo arrangiarci: evitiamo come la peste le strutture della Chiesa, per tutto quel male che ci hanno fatto. Della gente non ci si può fidare: non sai chi te li manda, a che fine e se cambieranno idea. Non ce la sentiamo di coinvolgere persone anche in buona fede, in una vicenda intricata come la nostra, che andrebbe sbrogliata da chi di competenza. Viviamo sempre con l’incubo di trovare un riparo, di trovare da mangiare, di non stare troppo male, di non incontrare delinquenti o altri zelanti giustizieri. Se questa si può chiamare vita…. Dunque di fatto il Comune a tutt’oggi non ci ha dato nessuna forma di assistenza, adducendo che non siamo residenti o perché non abbiamo un lavoro. E’ vero che non siamo residenti e abbiamo per questo meno diritti di altri ma è parimenti vero che il “cavillo” della residenza —usato molte volte per giustificare la mancanza di attivazione di aiuti nei nostri confronti— è stato introdotto nella legge per evitare abusi. Lo sappiamo bene, perché in Regione2* un assistente sociale di un paesino aveva deciso di aiutarci, affittandoci una stanza a spese del Comune: la pratica per i non residenti in loco è solo un po’ più lunga, non è contro la legge aiutare i non residenti. Poi alcune sigle sindacali si erano offerte per la ricerca di lavoro. I posti che il Comune affittava erano di proprietà della Curia, in possesso di molti fabbricati: la Curia non ne volle sapere, preferiva perdere un affitto piuttosto che dare un posto a noi, come ben previsto dal direttore di Gubbio. Quindi, una volta verificato che il nostro è un caso atipico, e che non si vuole commettere alcun abuso, dovrebbe essere possibile scavalcare tale limite generale. Diversamente l’applicazione della legge diventa un’applicazione incivile e insensata e in contrasto addirittura con la Costituzione, perché il requisito della residenza, applicato a chi per motivate ragioni non può essere aiutato in tale Comune, diventa una disparità sociale. .7 Una civiltà che nasconde i problemiQuando si vive fuori si deve nascondere la propria condizione, perché la nuova situazione di debolezza è in grado di per sé di attirare le situazioni più subdole. Vi può essere chi si avvicina per offrirti dei soldi, in cambio di prestazioni sessuali, in ogni caso si è esposti alla crudeltà umana, all’ingiustizia, all’ignoranza e alla delinquenza. La cosa che fa più rabbia è la condizione di chi trovandosi a dormire dove capita riceve il disprezzo gratuito degli altri. Parte di quel disprezzo proviene dalla convinzione che uno abbia deciso di fare tale tipo di vita, e nel caso cambiasse idea, si pensa che la civiltà gli offra tutte le possibilità di inserimento in un tessuto sociale normale. Magari a volte questo accade, ma noi abbiamo sperimentato il contrario, cioè come due persone siano spinte a disinserirsi dalla società, dal sistema produttivo con il ricatto che “se non ti trovi un lavoro, io non ti aiuto, perciò te ne puoi stare ai margini”. Non è un momento in cui si trova lavoro facilmente, questo ricatto non serve per spronare “i fannulloni”: si è trattati come figli viziati, ai quali è negata la paghetta, ma qua di viziata c’è solo la burocrazia o l’incapacità, che ti lascia privo del necessario. L’opinione pubblica è all’oscuro di come funzionano realmente i servizi per i poveri, o per quelle persone diventate povere a causa di fatti improvvisi, o perdita di lavoro. Non hanno coscienza di come funzionano le strutture che si occupano dei poveri e non hanno la minima idea di che cosa significa entrare in tali contesti. In tutto questo, dunque questo documento rappresenta un atto dovuto, un dovere che si siamo sentiti di esprimere per sopprimere quel senso di omertà che sta attanagliando l’Italia e che sta dividendo i cittadini, compresi quelli che ci guardano male, vedendoci girare con la valigia, convinti che siamo gente oziosa, alla quale piace vivere in suddetta maniera. Anche quest’ultimi sono liberi di guardarci come vogliono, ma almeno sapessero realmente come sono andate le cose. Quanto costa allo stato non risolvere un’emergenza Sembrerebbe che far a meno di risolvere un’emergenza come la nostra corrisponda a un risparmio per le casse del Comune e dello Stato, ma è proprio così? Nutriamo seri dubbi in proposito, e vediamo perché. Una famiglia che è lasciata in strada difficilmente uscirà da quella condizione, più facile che subisca problemi gravi alla salute, che necessiteranno un ricovero in ospedale, o che si rivolga alla malavita per risolvere i propri problemi: dunque spaccio o manovalanza criminale. Nel primo caso, un ricoverò all’ospedale, che oggi è garantito a tutti, costa da un minimo di 600 euro a un massimo di 2000 euro a giornata. Solo pochi giorni in ospedale superano l’affitto di una stanza per alcuni mesi. Nel caso della malavita è difficile quantificare il danno allo Stato ma credo che sia ancora maggiore. Un cittadino potrebbe anche non farcela a sopportare tutti i pesi sulle proprie spalle, potrebbe anche decidere di farla finita. Oppure potrebbe decidere di vendicarsi su chi l’ha costretto a fare tale tipo di vita, facendosi giustizia da sé: magari alla fine andrà a finire in galera, e graverà sul bilancio dello Stato e sulla comunità per un importo infinitamente superiore ad un eventuale aiuto. Detto questo si capisce subito che non è ragionevole non aiutare una persona, e non è neppure conveniente per la comunità! Ovviamente le cose non capitano sempre secondo la logica della ragionevolezza, dipende dagli interessi economici in gioco. Cito un esempio emblematico: quello del trafficante di droga che oltre ad avere come clienti i consumatori, gestiva anche un’attività di recupero tossicodipendenti. Un tossicodipendente diventava fonte di guadagno due volte: prima come consumatore e poi come paziente. Certamente non conviene allo Stato avere tossicodipendenti, per tutta la comunità sono un costo sociale elevato, però possono essere convenienti per una persona o gruppo, ed è per questa ragione che esistono tante anomalie nello Stato. La gestione della povertà e dei poveri rientra tra queste, come la gestione dei rifiuti: paradossalmente viene a dire che ci troviamo in entrambi i casi davanti a rifiuti: umani i primi, inanimati i secondi. Sono anomalie, forse marcatamente italiane, visto che negli altri paesi europei sembra che questi problemi siano ben gestiti. I DANNI SUBITI A CAUSA DELLA POLIZIA DI STATO non furono
mai riparati! [Agosto 2013] |
||||||||||||||||||