Amarcord scolastici (e non)
del secondo Dopoguerra a Rimini.
Memorie di Tama in sette puntate.
"il Ponte", settimanale, Rimini 1991-1992
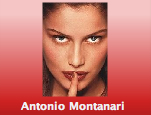
1. Camicia nera della ricreazione ["il Ponte", 19, 19.5.1991]
Primo giorno di scuola della prima elementare. Primo ottobre 1948. Al primo piano di un vecchio edificio del Borgo San Giovanni, la via XX Settembre. Scala senza ringhiera. Bui i locali. Si sente nei corridoi la puzza dei gabinetti. Dentro le aule trionfa l'odore dell'inchiostro, posto nei grossi calamai di vetro, che sono infilati in vecchi banchi di legno.
La maestra Ghelfi ved. Pattuelli ha l'aspetto solenne di un'insegnante ottocentesca, è il suo ultimo anno di servizio.
La guerra è finita da quattro anni, almeno per noi riminesi. Per gli altri, dal 25 aprile '45, di anni ne sono passati appena tre. In giro c'è tanta miseria. La vedi disegnata sui volti della gente, nei panni che indossa. Le differenze sociali le noti già dal vestito. I bambini portano pantaloni corti anche d'inverno, e zoccoli ai piedi, ricoperti sul davanti da una mascherina di cuoio, per attenuare il freddo. Le calze sono di lana grossa, fatte in casa, a cento colori, con gugliate purchessia.
I bambini poveri li distingui anche perché non hanno mai il fazzoletto. Tirano su con il naso, ed il naso manda giù candele, che procurano rimbrotti e soccorsi ufficiali della maestra, nella pulizia del viso.
Per gli scolari più poveri, c'è poi la refezione: al termine delle lezioni, restano in aula, dove viene servita una minestra con una piccola pietanza. A loro, le maestre regalano anche i quaderni.
I muri ed i corridoi della scuola sono di un colore neutro, freddi e severi. La disciplina che ci viene imposta, non scherza.
Noi che siamo nati durante la guerra, non sapevamo nulla degli asili. L'entrata in un'aula scolastica, era il passo inesperto e traumatico che ci separava dalla famiglia. Non eravamo preparati al "primo giorno". C'erano soltanto le amicizie che si facevano a casa, dove si formavano le bande. Se si voleva acquistare un ruolo, si imparava a menarsi o a distruggere le cose, tirare ad esempio fiondate ai nidi delle rondini.
Non ho mai posseduto una fionda. Quell'oggetto andava confezionato a regola d'arte, con lunga pazienza. Alla ricerca del ramo biforcuto, seguiva la preparazione dell'elastico, ricavato da qualche camera d'aria di biciclette, e poi c'era il montaggio finale, con ampi giri di corda per fissare le estremità dell'elastico.
Ho provato ammirazione per l'abilità tecnica di chi la costruiva. Ma l'uso a cui la fionda era destinata, ha sempre suscitato in me un inconsapevole rifiuto. Stavo dalla parte delle rondini. Una volta piansi per loro, quando vidi che il nido sotto il tetto di casa, era stato sbriciolato con un colpo magistrale dal mio coetaneo del pianterreno.
S'andava a scuola malvolentieri. Le quattro ore di lezione erano come un carcere obbligatorio. Non c'erano bambini che dovessero vivere la loro infanzia. Esistevano soltanto regole da rispettare.
Abbiamo cominciato con le aste. Pagine e pagine di quaderni, per apprendere come si maneggiava la penna. La penna era composta da una cannuccia di legno e da un pennino metallico, che doveva essere bagnato nel calamaio dell'inchiostro.
Il calamaio era una zona franca della fantasia infantile. Carte, mosche, ragni e gessetti contribuivano ad intorbidire quel liquido nerastro che le bidelle versavano da grosse bottiglie, asciugando le gocce dai bordi con stracci neri che rivelavano la loro origine di rifiuti domestici.
Il pennino intinto nell'inchiostro, faticava a procedere sui fogli dei quaderni. C'era imperizia nel maneggiare la cannetta, ma c'era anche l'ostacolo rappresentato dalla porosità della carta. Il pennino spesso s'impennava sui fogli, e s'imbizzarriva come un cavallo, non volendo più procedere. La spinta che lo scolaro dava alla penna, provocava uno scatto improvviso ed imprevisto del pennino che lanciava la sua macchia d'inchiostro nel raggio di qualche decina di centimetri.
Poteva esser colpita la pagina del quaderno. Un veloce intervento con la cartasciuga neutralizzava parte del colore dell'inchiostro, non troppo resistente. Seguiva poi il rapido sgretolamento dell'impronta, con quelle gomme ruvide che dovevano essere maneggiate con estrema attenzione. Il più delle volte, l'imperizia spingeva la mano a sfregare la carta, sino ad annullare un pezzo del foglio. E così si apriva un occhio curioso sulla pagina successiva, facendo agitare la maestra che diceva: «Non si fa così».
Non succedeva nulla di male, in fin dei conti, se ad esser colpita era la pagina del quaderno. Le cose andavano peggio, se la macchia andava a depositarsi sul collettino bianco. Nel qual caso, i conti erano da farsi a casa, con problemi di smacchiatura, per far scomparire un'ombra indegna sull'immacolato lindore dell'indumento, o per meglio dire dell'appendice necessitata dell'indumento.
La nostra divisa scolastica era infatti composta da tre parti. Un grembiule nero, un colletto bianco ed un fiocco azzurro. Il colletto era concepito come indipendente dal grembiule.
Il grembiule aveva una sua antica caratteristica, oggi scomparsa: doveva inevitabilmente chiudersi sul retro. Chi avrà mai inventato questa straordinaria divisa, priva di ogni praticità? L'apertura posteriore del grembiule, per i maschi poneva un problema funzionale, perché in taluni frangenti non coincideva con quella anteriore dei calzoni.
Il colletto girava perennemente su se stesso, per cui il fiocco cedeva a posizioni oblique, volando da ogni parte, tranne che in quella giusta. Sul petto, dalla parte sinistra, infine, la decorazione della riga doveva indicare la classe che si frequentava. Ricordo qualcuno che si fregiava della decorazione sul braccio, come i militari. E tali forse erano i padri dei figli che così venivano esibiti.
Il mio grembiule, con quale stoffa fosse stato confezionato, me lo spiegò mia madre pochi anni fa. Era la camicia nera di mio padre.
La fortuna volle che io fossi stato soltanto "figlio della Lupa". Mi avevano dichiarato tale alla nascita, nel 1942. La guerra, con le sue tragiche pagine, mi evitò di salire ai gradi superiori del "cursus" fascista. Così, non sono mai stato "balilla". Tuttavia, ho portato in me il segno del passato regìme con il candore dell'innocenza, pari a quello con cui mio padre aveva indossato la camicia nera, obbligatoria per mangiare, quando la tessera del fascio veniva chiamata la tessera del pane.
Candore che capisco soltanto ora, ripensando che mio padre non ricordava mai "lui", e che non ha poi avuto "nostalgie" politiche. Aveva capìto durante la guerra (penso io), quanto fossero state scioccamente illusorie le sfilate, le parole d'ordine, che nessuno tranne pochi, sul finire di quegli anni Quaranta, voleva rammentare o riproporre a noi giovani, a conflitto mondiale concluso.
C'era stato dopo la guerra, nella gente, come un blocco psicologico, un trauma. Gli scampati contavano le macerie, quelle dei loro cuori e delle loro giovinezze, e non ci dicevano nulla. A scuola, che cos'era la Storia? La lupa scendeva dal piedistallo che l'aveva elevata a simbolo di una vicenda grandiosa. I fatti erano successioni di immagini, Orazi e Curiazi, Muzio Scevola, Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Carlo Magno. Così come la cultura era successione di dati. Tre per tre, otto per sette (e sette per otto: cioè, il massimo dell'ambiguità matematica), venti diviso quattro, ed ancora sette per otto. E poi le massime, "Lozio è il padre dei vizi", oppure "Lo zio è...", dove un'improbabile parentela veniva giustificata di fronte alla pubblica moralità che tuttavia voleva regole ben precise, almeno nelle apparenze.
Regole severe come quelle che applicavano a noi poveri allievi di prima elementare. Attenti, riposo, mani "in prima" (appoggiate sul banco), mani "in seconda" (dietro la schiena), che erano il viatico a punizioni severe, lunghi silenzi che dovevano essere sopportati stoicamente, perché così voleva la Scuola.
Cadente di fuori, questa Scuola aveva dentro di sé una forza inimmaginabile, il vigore dell'imposizione. In questo modo, siamo cresciuti uomini d'ordine, o ci hanno predisposto alla ribellione? E' difficile rispondere, come è arduo capire quei tempi, che segnavano il passaggio da un mondo all'altro.
I nostri vecchi maestri, che cosa volete che si chiedessero. Pedagogicamente, si erano formati nell'Italietta giolittiana. Poi avevano visto trionfare il fascismo, e chissà quante baggianate avranno dovuto dire o sentire, sempre in nome della "tessera del pane". Finita la guerra, democrazia che parola era?
Anche le parole hanno un sapore. I nostri primi giorni di scuola, sembravano da reggimento deamicisiano. Leggere, scrivere e far di conto: questa la meta prima (e forse ultima) che la classe insegnante si poneva nella sua attività didattica.
Stanchi della Storia, invecchiati per l'età, i nostri maestri ci coccolavano con un sorriso e ci torturavano con la regola, l'imposizione, il dover fare i compiti, gli esercizi, i disegni così come volevano loro, anzi come volevano i princìpi della Scuola di quei giorni.
Forse guardavano a noi bambini invidiandoci il futuro che ci stava davanti. Ripensavano ai loro sogni. Si erano realizzati? Rivedevano le loro speranze. Dov'erano finite? Ma il patto segreto della convenzione sociale, faceva sì che nessuno dicesse nulla. Il passato? Dov'era finito?
Quel passato, lo avevamo indosso, ognuno di noi, non soltanto io, con la camicia nera di mio padre.
2. Obbedite al capoclasse ["il Ponte", 23, 16.6.1991]
La divisa scolastica diventava un pò ridicola per gli alunni ripetenti. Nonostante la forzata frugalità che caratterizzava i pasti della gente in quei giorni, i corpi di alcuni fanciulli crescevano a dismisura. Le stoffe invece restavano ferme in un disegno primitivo che spesso risentiva di un'ereditarietà mortificante, trasmessa da un precedente fratello maggiore a quello minore che, a sua volta, precedeva qualcun altro, e che non si sa se concludesse la serie.
Non era colpa di nessuno, se l'ultimo nato in famiglia aveva avuto uno sviluppo osseo superiore a chi lo aveva preceduto. In questi casi, il grembiule restava come la sintesi di se stesso, un accenno di indumento che lasciava trasparire la sua crudele insufficienza da tutte le parti. Il contenuto eccedeva il contenente, contro ogni regola di fisica elementare.
C'era in ogni classe un buontempone più fortunato degli altri, perché la sua appartenenza ad una famiglia contadina gli forniva alimenti sostanziosi a poco prezzo. Era sempre rubizzo e s'ingrassava in continuazione. Quando faceva la prima, quelli che non lo conoscevano, gli chiedevano: «Farai mica la terza?».
Un altro effetto provocato da quella maggiorazione del fisico del bambino che s'ingrandiva come un ragazzo, era nei voti che raccoglieva nelle pagelle, in modo inversamente proporzionale alla crescita. Più invecchiava, meno riusciva nel lavoro scolastico.
Ai nostri tempi, c'era ancora l'abitudine di mettere nei libri di testo le immagini pinocchiesche degli studenti asini, con il cappello della berlina che spuntava da dietro la lavagna. Non esisteva allora lesa maestà infantile, per i maestri, nel definire asino un proprio scolaro. E questi bambini poco capivano, poco avevano voglia di fare. Spesso lavoravano tutto il pomeriggio a casa per i bisogni della famiglia, e quando finalmente potevano riposarsi a scuola, accettavano di buon grado qualsiasi offesa alla loro dignità intellettuale, pur di riposarsi, se non dormire spudoratamente alla faccia di tutta l'Istituzione.
Se piangevano, lo facevano di nascosto, umiliati ma non offesi, senza meditare vendette, senza pregustare vittorie sindacali o rivendicazioni sovversive.
Il sapere si trasmetteva con una stratificazione sociale che era alla base di quello stesso sapere. La scuola rispecchiava il mondo nelle sue varie fette, ogni classe dipingeva entro le mura di un'aula scolastica la realtà esterna, le sue differenze e le sue ingiustizie.
Ma a vincere questi scompensi, bastava l'amicizia, non quella deamicisiana del ricco che doveva amare il povero per spirito cristiano e compassione borghese, ma l'istinto che lega i fanciulli nel gioco, nella birichinata, nell'affascinante avventura che la fantasia sa creare pure dentro una grigia stanza scolastica.
Anche a chi sentiva come sacro dovere della patria rispettare la Massima Rappresentanza dell'Istituzione, cioè l'Insegnante, faceva tuttavia sommo piacere vedere che si poteva tentare di creare norme diverse da quelle imposte dalla Cattedra.
I birichini, i ribelli, erano simpatici eroi d'un momento, ammirati ma non celebrati, contesi nelle "bande", non invitati però nelle case di chi non voleva far sfigurare il proprio bambino con le cattive compagnie. Con la loro voce rauca, ti scimmiottavano se recitavi bene la poesia, si divertivano a spingerti nel gomito per farti fare sgorbi ed errori sul foglio del disegno o del quaderno di «bella».
L'ordine, la precisione erano una fissazione nella didattica dei nostri maestri, che poi mi hanno trasmessa e che mi è rimasta come abitudine di vita. Ma non tutti apprezzavano il lavoro scolastico così come era imposto. Le ribellioni erano piccole piccole, gli scherzi che la severità poteva permettere, erano cose molto modeste che tuttavia apparivano inconcepibili agli insegnanti, forse soltanto per effetto di quella finzione pirandelliana del "gioco delle parti", che è la vita.
I maestri ci recitavano il loro ruolo di guardiani severi. Tifavano per chi osava non condividere tutte le regole della clausura scolastica? Regolarmente, a scherzi e ribellioni, seguivano le punizioni in nome della Norma e della Legge.
Il sistema vigente aveva le sue basi ferree nel potere dell'insegnante che veniva talora delegato momentaneamente ad un capoclasse, il quale però, nelle emergenze, doveva sempre vedersela con un altro superiore istituzionale, la Bidella. Quando il maestro si assentava per qualche minuto dall'aula, imponeva agli alunni: «Obbedite al capoclasse». (Perché parlo di Bidella, e non anche di Bidello? La guerra aveva fatto tante vedove: alle elementari, ho incontrato soltanto donne in questa funzione).
I capiclasse erano di due tipi. C'erano quelli transitori e quelli permanenti. Per i transitori vigeva una regola di rotazione (quasi sempre settimanale), su base elettorale. I permanenti invece erano prescelti dall'insegnante, a suo insindacabile giudizio.
Quali criteri venissero adottati, in tali occasioni, non si sa. Prevalevano metodi lombrosiani che, per quanto odiosi e superati, una loro certa validità debbono pur avercela, nonostante tutto, se chi appare ligèra nel suo aspetto, ligèra poi di fatto è. Madre natura ha fatto bene i suoi calcoli, fornendo a noi suoi figlioli prediletti una specie di targa, con la quale presentarci agli altri, facilitando loro il compito di riconoscerci, e a noi togliendo l'obbligo di dire tante parole, oltre ad una frase modesta come: «Guardatemi in viso, son tutto qui».
Il capoclasse doveva avere, per soddisfare questa scelta, una faccia intelligente. E non so da che cosa si capisse allora l'intelligenza, se dalla pulizia delle persona o se dal modo con cui si costruivano sul quaderno i «pensieri» che erano obbligatori per tutti, come la bontà e la diligenza, specialmente nelle occasione delle feste, quando si dovevano scrivere le letterine ai «Cari Genitori...».
L'insegnante, con una specie di diritto d'origine divina come ai tempi dell'assolutismo, non solo delegava al capoclasse il potere dell'Istituzione di imporre la propria volontà agli altri; ma gli lasciava anche esercitare una sorta di sapienza sacra, consistente nella distinzione tra bene e male, quando si obbligava l'alunno incaricato della sorveglianza, a dividere su due colonne, nella lavagna, i buoni dai cattivi.
Erano i momenti in cui la recita della vita aveva gli effetti meno educativi e più esilaranti. O perché esilaranti, essi erano anche (o soprattutto) educativi?
I buoni gareggiavano con ipocrisia, senso della convenienza, egoismo e superbia nell'esercitare il proprio ruolo, per ricevere una ricompensa inesistente, forse il voto in condotta (morale e civica, come stava scritto sulle pagelle), un plauso che doveva essere l'immaginaria medaglia appuntata sul petto del meritevole.
I cattivi erano tali non per predisposizione naturale. Nell'inevitabile contrasto dialettico che anima l'esistenza, davanti a tante mummie (che, se avessero potuto, avrebbero trattenuto il respiro fino a diventar cianotiche, perché così voleva la Regola), erano gli unici a dimostrare che la sofferenza del silenzio non valeva alcunché. Era meglio ridersela alla faccia di tutti, in primis del capoclasse, simbolo dell'Ordine, mentre notoriamente il mondo deriva dal Caos.
In quella divisione manichea tra buoni e cattivi, c'era il riflesso di vicende pubbliche e private. Chi sono i buoni della Storia? «Quelli che comandano, Signora Maestra, che si sacrificano per il Bene di tutti», poteva essere una risposta immaginaria, pensata oggi e considerata adatta a quei tempi. Ma quelli che comandano chi sono? «La gente comanda uno alla volta, e chi comanda ha sempre ragione, è sempre il più buono, il più giusto, il più bravo».
Queste cose non le diceva nessuno, ma un dialogo così non era del tutto impossibile, in quei giorni nei quali il recente frastuono della guerra avrà pur suscitato nei maestri qualche ricordo meditativo, qualche riflessione pedagogica, facendogli forse chiedere che cosa ci si aspettasse dal domani.
Ma quei vecchi insegnanti, ne avevano probabilmente viste troppe per chiedersi qualcosa, ed allora si procedeva per inerzia. Come si era sempre fatto, così si poteva continuare: chi li obbligava a cambiare le regole del Gioco?
In seconda classe, il maestro Feliciangeli, anche lui alla soglia della pensione, era un'alta figura severa, come la maestra della prima, che aveva sostituito: sembrava un fantasma. Si animava accendendo il sigaro, e poi combatteva gli effetti del fumo, succhiando le compresse di Formitrol, confezionate in un tubetto di latta verde.
Mio padre mi aveva insegnato che quando ci si rivolgeva al Maestro, bisognava dire: «Sissignore». Soltanto per questo motivo, fui fatto una volta capoclasse?
Ma nel momento di scrivere alcuni nomi nella lista dei cattivi, qualche bastiano che era il doppio di me, con una semplice occhiata, mi convinse a lasciar perdere.
3. Ci curavano alla Molière ["il Ponte", 36, 13.10.1991]
Nel grigio repertorio esistenziale d'ogni fanciullo di prima o seconda elementare, sul finire degli anni '40, un capitolo sconosciuto, e perciò affascinante e per questo anche decisivo nella comprensione della precarietà del vivere, era quello delle malattie infantili. Un'esperienza diversa dalla routine quotidiana.
Le madri che s'incontravano tra loro, per strada o nei tetri negozi del tempo, all'ora della spesa, sfoderavano tutta una serie di variazioni sul tema, a proposito di morbillo o di tosse cattiva, detta pure pertosse, se non addirittura (con crudele ironia caricaturale), tosse asinina. «Il mio ha già avuto tutto». «Beata lei, lui ancora niente». E "lui" veniva additato al pubblico disprezzo, con uno sguardo tra il compassionevole e l'ironico, come se fosse stata colpa sua se, gli eventi previsti da madre Natura, non si erano ancora verificati.
Sarò stato magari un poco ritardato, da bambino, il che spiegherebbe il futuro, ovverosia il presente; ma non ho mai compreso perché dovesse essere inevitabile ammalarsi tutti della stessa malattia, come strada obbligata per poter crescere e ricoprirsi di un orgoglio che, a prima vista, mi appariva del tutto inutile nel dire agli altri, come suprema testimonianza di una perfezione biologica : «Gli orecchioni? Già passati».
«Meglio così», dicevano le nonne, «perché se vengono da grandi, non si sa mai». Quel «non si sa mai», non si seppe mai, perché gli adulti spesso (se non quasi sempre), colloquiando con noi bambini, si parlavano da soli, con il loro linguaggio preciso, serio, incomprensibile, intessuto com'era di enigmi che poi nessuno si degnava di spiegarci nella loro scientifica realtà.
Le piante dei cavoli erano tutt'altro che destinate alla gastronomia, così le cicogne avevano un'imperscrutabile funzione postale, non verificabile di fatto, perché nessuno ha mai visto volare una cicogna nei nostri cieli. Ed allora, ci si diceva che la cicogna viaggiava di notte (come i ladri, pensavamo noi), chissà perché non voleva farsi vedere da nessuno: e se sbagliava indirizzo? Quali tragedie sentimentali avrebbe provocato un errore di recapito? Ne accadevano, ma venivano anch'essi accuratamente mascherati, ricorrendo ad una presupposta incomprensibilità dell'Esistenza che celava i suoi misteriosi accadimenti ai comuni mortali. Questa era l'educazione, anzi la "buona" educazione che si pretendeva di impartirci.
Quelli degli adulti, erano monologhi che non ammettevano replica. La dialettica pedagogica non ha beneficiato la nostra generazione. L'unica chiarezza era nella spiegazione di cose che non compromettessero nessuno, come il quadrante dell'orologio che si doveva conoscere prima di andare a scuola, anche se non ci volevano sforzare a leggere prima che si entrasse in un'aula delle elementari, perché «ogni cosa deve avvenire al momento giusto».
A proposito del linguaggio degli adulti: nei primi mesi di scuola, mi rimase impressa un'espressione che il nonno aveva usato una volta con mio padre: «Lei allora gli scriva una lettera, dicendo che..., eccetera, eccetera».
«Eccetera, eccetera» fu per me, durante un lungo periodo, una formula misteriosa di cose dette ma non espresse, un segreto impenetrabile, una specie di formula che apriva mondi inaccessibili, dove potevano circolare soltanto gli adulti, i quali si comprendevano tra di loro, lasciando gli altri nell'incertezza di cose appositamente oscure. Si creava una finzione dalla quale noi bambini eravamo esclusi.
Loro, gli adulti, intervenivano con noi e su di noi, soltanto per lo stretto necessario. I vecchi si erano tramandati una serie di notizie che custodivano gelosamente, dall'alto del loro ruolo di depositari della saggezza, fino al momento opportuno, in cui quell'arcana sapienza doveva tradursi in realtà.
Morbillo o scarlattina che fosse, la nonna assumeva la direzione sanitaria dell'emergenza famigliare. Stanza buia, uso di borotalco delicatamente soffiato sul corpo, come in un cerimoniale da favola, e poi, a rinfrescare e proteggere la pelle, delle pezzuole di lino, di cui veniva vantata la finezza e l'origine antica risalente a qualche ava che aveva lasciato in eredità il suo prezioso corredo. Ma, forse, era soltanto uno straccetto salvatosi sotto i bombardamenti.
La nostra è stata anche la generazione delle tonsille asportate obbligatoriamente, con la stessa rigidità normativa con cui a ciascun cittadino (maschio, di solito: a mia madre giunse che mi attendeva da sette mesi...), arriva la cartolina rosa per il servizio militare. Era un rito crudele come quello della corrida.
Anche quella volta, venni affidato alle mani ferme di nonna Lucia che in casa s'era fatta la fama di donna molto coraggiosa, perché in età giovanile era stata operata "da sveglia": quel suo atto di sprezzo del dolore, ce lo ricordava con grande tranquillità ogni volta che, finito un pranzo di festa con riunita tutta la famiglia, si procedeva al lavaggio delle posate. Il che immancabilmente le faceva ritornare alla memoria il rumore dei ferri chirurgici usati con quella paziente (e la definizione appare veramente appropriata).
Tonsille, a Rimini, nell'immediato dopoguerra, volevano dire dottor Candi, il quale aveva studio in piazza Cavour. L'attesa nell'ambulatorio precedeva il rito della vestizione, consistente nell'applicazione di un lungo telone di gomma cerata, legato attorno al collo. Ti facevano sedere, e appena aprivi la bocca e spalancavi la gola, eri già servito. Poi, mi hanno fatto stendere su di un sofà nell'ingresso dello studio, con due cubetti di ghiaccio in gola, che dovevano aiutare a cicatrizzare la ferita.
A quell'operazione è legata, come strana e straordinaria contropartita, una prelibatezza terapeutica. «Dategli del gelato», aveva ordinato il dott. Candi, che era una figura altissima, e rassomigliava al Mangiafuoco di certe figurine che apparivano allora sui nostri libri. Mai fu più dolce obbedire all'ordine di un medico.
Le gelaterie di Rimini erano poche, e vendevano solo prodotto sfuso: mio padre faceva molta strada, per andare da "Santo Spirito" alla piazza Tre Martiri, al bar Dovesi, con in tasca un bicchiere che poi, colmo di quell'insperata medicina, riportava a casa, ansimando e sudando a causa della sfacchinata compiuta in fretta, per non far squagliare il rimedio sanitario che, infine, vittoriosamente approdava a placare il palato ancora offeso dal trauma post-operatorio.
In altre occasioni, il farmaco era di opposto sapore. Per noi, nati nei primi anni '40, vigeva una scienza che aveva canoni successivamente cancellati, se non smentiti da nuove conoscenze. (D'altro canto, liberi dal Fascio, siamo stati gli ultimi bambini vittime della "fasce", un rituale medievale senza dubbio, che forse risale a qualche popolo barbarico: venivamo immobilizzati, nella illusoria convinzione che la rigidità del corpo favorisse la perfezione dello sviluppo osseo. Più che un sistema igienico, era il segno d'una pedagogia che voleva imporci la passività, insegnandocela concretamente sin dai primi giorni di vita).
Dunque. In caso di febbre, succedeva questo. Venivamo protetti da tante coperte, mentre oggi si suggerisce di stare con pochi panni sul letto, affinché il corpo possa disperdere il calore in eccesso. Oggi, si obbliga l'ammalato a reintegrare i liquidi che si perdono con la sudorazione prodotta dalla febbre. A noi, invece, venivano imposti sistemi completamente opposti. Si doveva procedere ad una pulizia interna che faceva perdere altri liquidi e che, quindi, in teoria, peggiorava le nostre condizioni.
Si usava quel sistema che lo scrittore Roberto Ridolfi ha definito, in una sua godibilissima pagina, «il mattinal purgatorio», pensando al quale tornano in mente i celebri versi che Torquato Tasso ha posto all'inizio della «Gerusalemme liberata»: «a l'egro fanciul porgiamo aspersi / di soavi licor gli orli del vaso». Il metodo purificatorio (e propiziatorio del recupero della salute), era prescritto dal medico con la massima serietà e puntualità, ad ogni rialzo febbrile.
E si sa che, chi abbia un abbonamento a qualche bronchite cosiddetta recidivante, ha diritto alla conseguente grata esenzione dalla frequenza scolastica, a causa di quel malanno che si sarebbe tradotto in una pura gioia ascosa, se il contrappasso (inevitabile) non avesse poi provocato un perfido risveglio, antelucano più del solito, onde favorire l'effetto lubrificante e temporalesco del tremendo olio di ricino. Bisognava soprattutto cogliere la vittima con ancora gli occhi chiusi, in maniera che non tentasse alcuna ribellione.
Allora, non esisteva il prodotto rettificato ed inodoro, ma quello grezzo e puzzolentissimo, simbolo di un disprezzo che si era quantificato storicamente nelle dosi punitorie di fascistica memoria. Ignoro quali colpe dovesse far scontare alla nostra innocenza bambina, la medicina del tempo che non aveva neppure il senso del ridicolo, acquisibile ove fosse il caso, come in effetti lo era, attraverso la lettura del molièresco dottor Purgone nell'«Ammalato immaginario».
L'astuzia ingannatrice di cui parlava già il Tasso sul finire del '500 (vecchio trucco, dunque, che però funzionava sempre), consisteva nel mascherare il fetidume oliaceo con un amarissimo caffè in una tazza poi strofinata al bordo con del limone, per ingannare gusto ed olfatto nel momento supremo del sacrificio digestivo, in cui venivo imboccato rapidamente, seguendo una formula fisica per cui la velocità dell'assunzione venefica doveva essere direttamente proporzionale al suo grado di perfidia odorosa.
Postilla. Che il discorso sulle "fasce", abbia una sua dignità pedagogica, nonostante lo si faccia qui, l'attesta un passo dell'«Emilio» di Gian Giacomo Rousseau (1782): «Donde viene quest'usanza irragionevole? Da un'altra contro natura. Quando le madri, disprezzando il loro primo dovere, non hanno più voluto allattare i loro bambini, è stato necessario affidarli a donne mercenarie, che trovandosi così madri di bambini estranei, per i quali la natura non dettava loro nulla, non han cercato altro che risparmiar fatica. Su di un bambino lasciato in libertà sarebbe stato necessario esercitare una continua sorveglianza. Ma quando è ben legato, lo si getta in un angolo senza curarsi dei suoi pianti...».
4. I piombi di Viserba ["il Ponte", 41, 17.11.1991]
La stessa ferrea disciplina che accompagnava il decorso delle malattie, doveva guidare anche la convalescenza, secondo un rigido repertorio di precauzioni. Ciò favoriva un ritardato rientro a scuola, grazie allo scrupolo sanitario di chi doveva certificare l'avvenuta guarigione dai morbi infantili, onde evitare la diffusione del contagio. Ma se è vero che era meglio adempiere l'obbligo naturale di quelle patologie, tale diffusione non avrebbe dovuto esser favorita, onde sbrigare tutto nel minor tempo possibile? Stranezze di pensieri della vecchiaia che proietto, con l'illusione della memoria, nella mente del fanciullo di allora, che chissà cosa meditava. Forse nulla, arrendendosi all'inevitabilità dei fatti che accadono.
Resta viva nel ricordo, l'immagine di un paio di calzoni. Dopo un terno secco, fatto di morbillo, orecchioni e "tosse cattiva", essi mi vennero presentati come premio per la riacquistata salute. Mi si disse che erano di stoffa pregiata, la vigogna, una rarità in quel 1948, un inverno uguale agli altri, ma con in più la minaccia che "vontasse" l'Ausa, come diceva la gente. Oggi di questo ex fiume, ridottosi a puro scampolo di nomenclatura urbana, restano vaghe e pacifiche tracce. Il suo corso verso il mare è stato nascosto. Nessuno ne sa nulla. Ma in quei giorni del Dopoguerra, le sue piene invernali facevano paura a chi, come noi, abitava a poche centinaia di metri dal suo letto, vicino alla fornace Fabbri, dove oggi è tutto case e parchi.
In quell'inverno, dunque, i miei calzoni nuovi dovevano significare un'occasione di profonda felicità. Così me li presentarono, come amorevole conforto dopo tanti giorni trascorsi a letto, e come nobile testimonianza dell'affetto famigliare.
Purtroppo, lasciai delusi tutti, quando indossai quei calzoncini lunghi, come al solito tagliati "alla zuava" da una sarta che abitava proprio vicino al fiume. (A noi non erano permessi quelli interi ad imitazione degli adulti, come usa oggi, così come alle donne erano proibiti fin dai tempi del fascismo i calzoni da uomo, tutt'al più esse potevano aggirare l'ostacolo con apposite gonne dette a pantalone. Mistificazione palese e sommersa soddisfazione si avviluppavano attorno al pilastro dell'ipocrisia sociale).
Non sopportavo quella stoffa che mi veniva declamata come pregiata, e che invece mi appariva parente prossima della carta vetrata. Si sa che le opinioni infantili non godevano, un tempo, delle approvazioni da parte del mondo adulto. Il dottor Spock non aveva ancora pubblicato i suoi libri. E così, non fui creduto: si scambiò per un capriccio bambinesco il mio parere, solidificatosi poi in un reciso rifiuto di quei pantaloni. E dai calzoni, qualche anno dopo, venne ricavata a malincuore una sciarpa per mio padre. Lui non la indossò mai: «raspava troppo», diceva. Avevo avuto ragione, finalmente. Ma quale delusione avevano provato allora i miei che avevano speso tanto per quei calzoni. La vigogna ai loro occhi era parsa, senza dubbio, come un segno della sopraggiunta libertà, della fine dei sacrifici della guerra. Di sacrifici, ce ne sarebbero stati altri nel nostro futuro, ma in tempo di pace era tutt'altra faccenda. Non sapevo nulla di queste cose, né dell'autarchia che, ai tempi delle «inique sanzioni», aveva propagandato la lana del coniglio come «la vera lana dell'italiano», con uno slogan poco guerriero, sùbito ritirato dalla circolazione. L'ignoranza della storia, a sei anni, giustificò la mia ingratitudine verso quel paio di calzoni che potrei pomposamente chiamare «della ricostruzione». Resta comunque il fatto che nelle mie cellule cerebrali, i calzoni di vigogna del '48 si sono fusi con il ricordo delle tre malattie infantili che avevo sopportato.
Nel comportamento degli adulti, davanti a questi eventi sanitarî, confluivano salde cognizioni igieniche e consuetudini che risalivano alle precedenti generazioni. In queste consuetudini, poi, si potevano rintracciare i segni di modelli più o meno inconsci di comportamento collettivo, secondo cui la malattia non era soltanto un fatto biologico legato alla vita dell'uomo, ma aveva in sé anche un qualcosa di diverso, una specie di aspetto magico, al quale si ricorreva in particolari situazioni, soprattutto per propiziare la guarigione.
Faccio un esempio, legato ad un'esperienza vissuta da protagonista. Usava in Romagna in quegli anni, "curare" i vermi infantili con l'impiombatura. Il mio fatto personale accadde nel 1946, a Viserba, ultimo dei nostri sfollamenti e prima del rientro a Rimini, avvenuto l'anno successivo. Avevo 4 anni. La signora Tranquilla (che ai miei occhi apparve, e resterà, personaggio che nel comportamento tradiva clamorosamente il nome che portava), era una negoziante di bellissimi giocattoli, che s'adoprava anche nel fare iniezioni a domicilio e a curare in maniera non ortodossa certe situazioni come appunto quella dei vermi, che è statisticamente molto frequente nei fanciulli.
Il metodo usato dalla signora Tranquilla consisteva nel porre sopra il capo del disgraziato un catino di acqua fresca, in cui versare del piombo fuso. La scienza ci spiega che il piombo (come ben sanno i cacciatori), a contatto con l'acqua, si rapprende e forma dei pallini più o meno regolari. Si attribuiva, invece, a quegli oggetti una specie di consolidamento trasmigratorio dei vermi, secondo una teoria che rassomiglia vagamente alla metempsicosi platonica: i vermi, secondo questa teoria, uscivano dal corpo in cui si trovavano insediati, e si raggrumavano in un'altra materia, restando per sempre estinti.
Non so per quale interna agitazione od altra causa, la signora Tranquilla sbagliò mira nel momento cruciale del "getto del piombo" fuso nel catino, per cui ne cadde una sbavatura sulla mia innocente gambetta sinistra che poi venne fasciata vistosamente, a testimonianza che, come già aveva sperimentato Galileo, l'ignoranza scientifica provoca sempre le sue vittime.
La natura ci fa nascere con un distacco dalle cose del mondo, che vien poi a mancare con la crescita. Grazie a questa qualità innata, credo di aver potuto superare lo choc provocato da quell'operazione di magia. Grazie al cielo, nessuno poi ritentò la pratica purificatoria. Ciò, d'altro canto, non mi spinge a ritenere che essa fosse veramente riuscita nell'intento. Con sano realismo, forse, ci si arrese ai vermi più che all'evidenza, magari ricorrendo ad altri riti sterminatorî, con spicchi d'aglio ritenuti utili allo scopo, nella medicina popolare, fin dalla notte dei tempi.
Si fa presto a sorridere di queste cose, relegandole con antica semplicità nel campo della pura superstizione. Probabilmente, esse sono invece risposte elementari a quell'eterno bisogno dell'uomo di avere certezze e strumenti con cui credere di poter rimediare all'irrimediabile. Se Severino Boezio scrisse il suo «De consolatione philosophiæ», la cultura comune (usando il termine in senso sociologico), ha abbozzato da sempre una specie di «De consolatione magiæ», scritta od orale che sia, non importa granché.
Uno specialista di queste cose, Umberto Foschi ha scritto la prefazione a «Medicina popolare romagnola» di Vittorio Tonelli (1981), limitando sbrigativamente il problema ad una sola categorie di persone: «I contadini romagnoli non avevano certo molta fiducia nell'arte medica e nei medici, come del resto non apprezzavano tutto ciò che non capivano».
La mia famiglia non aveva origini contadine; almeno nelle due ultime generazioni, era di stampo medio-borghese, cittadino. La guerra ci aveva lasciato in brache di tela, senza una lira ed una cosa, ma con il cane vivo come tutti noi. Quindi, l'impiombatura operata dalla signora Tranquilla non può giustificarsi con la sola origine sociale di chi fa ricorso a certi rituali. Il problema è un altro, e oggi gli studiosi lo sottolineano con chiarezza. Certe domande, contadini o impiegati, se le pongono tutti, sia in dialetto che in lingua nazionale. Il dottissimo Leopardi quando interroga la luna per conoscere i misteri dell'universo e della vita, si maschera da «semplice pastore».
La distinzione per categorie sociali, esisteva allora per altri motivi, al di là di quello sanitario, ed in tutti i settori. La gente faceva la scampagnata in bicicletta, le auto erano poche: si ammiravano i campi al tramonto, li si definiva belli, ma si capiva poco la fatica del lavoro agricolo, anche se i nostri libri delle elementari erano pieni di retorico elogio di chi coltivava quel grano che poi finiva sulle nostre mense. Ma l'opinione comune faceva del contadino un moderno primitivo che non capiva il mondo, ed era capace soltanto di vivere secondo modelli tutti propri.
Quella frase di Toschi deriva da questa concezione del contadino, e spiega male il problema che oggi viene affrontato da un'angolazione scientifica. ("Si veda", come dicono gli esperti, il volume di Eraldo Baldini «Riti del nascere», Longo editore 1991, su "gravidanza parto e battesimo nella cultura popolare romagnola": leggende, superstizioni e miti vi sono interpretati secondo le moderne teorie etnologiche che cercano di cogliere il simbolismo dei gesti compiuti).
La nostra era una famiglia religiosa, quindi nessuno in casa attribuiva a quel rito dell'impiombatura un significato magico nel senso pagano del termine. Ciò vuol dire che anche in una famiglia non contadina e religiosa, l'inspiegabile poteva essere una categoria intellettuale da non accantonare, e a cui far ricorso, per collocarvi come antidoto ciò che non si sapeva come funzionasse?
Forse, il verme non era visto soltanto come un fastidioso animaletto parassita dell'intestino, ma quale segno misterioso di una indecifrabile realtà che opera diabolicamente nell'uomo. Ed il piombo fuso era interpretato come il chiodo-schiaccia-chiodo, la fiamma contro il fuoco infernale rappresentato simbolicamente dal verme.
Certo, la signora Tranquilla ignorava che, in tempi di Controriforma, era finito sul rogo chi aveva creduto l'uomo nato dalla terra come il verme nasce dal formaggio. Ma sia lei, esecutrice del misfatto, sia i mandanti dell'impiombatura, erano tutti in buona coscienza di compiere un atto lecito, con una sua misteriosa o misterica validità scientifica. D'altro canto, mia madre racconta di una ragazzina sua coetanea che aveva regolarizzato la propria crescita, salendo a piedi da Morciano a Montefiore Conca, alla capanna di un vecchio stregone che l'aveva segnata con una triplice Croce sulla fronte. Non c'erano le Usl, e la gente s'arrangiava come poteva.
Per mia condanna, una cartolaia di Viserba doveva sbagliare la mira. Ma di quell'esperienza, rammento chissà perché non il dolore provocatomi dall'ustione, ma soltanto il profumo del negozio della signora Tranquilla, con i giocattoli e le prime figurine mai viste. Ecco, lampante, ciò che dicesi l'incoscienza infantile.
5. E l'aquilone volava ["il Ponte", 15, 12.04.1992]
Quando da Viserba ci sfrattarono, tornammo a Rimini, ospiti dei nonni materni ai quali era stato assegnato un appartamento "popolare" in una casetta a due piani, appena finita di costruire. Era il 1947. Dalle finestre s'apriva un panorama tranquillo. In lontananza, il camino della fornace, e sotto il naso una strada polverosa con a lato i marugoni su cui le donne stendevano "la bucata", rimediando alquanto di sovente uno strappo di qualche spino, il famoso "sette", perfezione geometrica di un danno talora riparabile con facilità su stoffe di scarso valore, ma talvolta vergogna perpetua per la casalinga che non aveva usato tutta l'astuzia possibile nel ritirare i panni da quello stenditoio naturale, e traditore.
La nostra era l'ultima casa della strada, dopo si schiudeva un podere con un campo di grano dove in primavera, quando rosseggiava di papaveri, piaceva a noi bambini nasconderci di contrabbando tra le spighe, pungendo con dolcezza le nostre carni, e facendo attenzione all'insidia dell'ortica, contro la quale non c'era remissione. Finita la mietitura, si poteva scorrazzare in quel campo liberamente, con i sandali che inciampavano tra le zolle e le stoppie. Era il momento di lanciare gli aquiloni.
Più tardi, alla scuola media credo, avremmo imparato a memoria i versi di Zvanì: «Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento...». In quei giorni piccini, a cinque anni, l'aquilone era una cosa enorme ed ignota, così strana da potersi innalzare da terra, volare come una farfalla, disegnare sullo sfondo dell'azzurro, o negli arancioni dei tramonti, le trame di un sogno, quello antico dell'uomo di staccare i propri piedi dal suolo, essere simile ad una rondine, o ad un passero, e guidare la propria corsa così, girando attorno ad un filo che ci sembrava niente, ed invece era tutto: ecco come non si capisce mai nulla delle cose.
In un volume di Vittorio Bagnari (edito da Berti di Lugo), Zug d'una völta, c'è in copertina un volo d'aquiloni disegnato dal pittore Giulio Ruffini, e nel testo trovo la ricetta per costruire questa modesta ma miracolosa macchina volante. Occorre carta "oleata", quella usata allora per ricoprire i libri, che era di vari colori, un blu intenso, un rosso vivo, un verde scuro ed un giallo peperone, che oggi chiamerei più propriamente van Gogh. «Era a forma quadrangolare, con coda, bilanciere, archetto di canna...».
Aquilone per me, piccolo com'ero, significava confidare nell'aiuto di nonno Romolo. Le canne crescevano tutte all'intorno, la carta si comprava con poche lire (ed allora una lira era tanto), e poi sulla tavola di cucina iniziava l'operazione. La maestrìa del costruttore anzitutto era provata da come si legavano in croce le canne, prima di ritagliare il rombo colorato della carta, che veniva ribattuto e rafforzato negli angoli, dove lo scheletro doveva reggere tutta la struttura.
Il nonno usava una colla resistentissima che si preparava in casa, sciogliendo sul fuoco, in un pentolino, una specie di sapone. Era la «còla garavèla», o come spiega l'antico vocabolario dialettale di Antonio Mattioli (1879), «colla caravella», chiamata anche «cervona» da Benvenuto Cellini. Il nome deriva proprio dalle navi caravelle, in cui si usava per gli assiti.
Poteva bastare la più domestica (ed ovvia) colla con farina, ma il nonno era previdente, oltre che abile nel lavorare la carta, fossero aquiloni, quaderni che lui inventava per ogni bisogna, o rilegature di libri.
Pensionato, dopo una vita trascorsa sulle scartoffie comunali, aveva passato i settant'anni. Prima della guerra, le fotografie ed i racconti di casa, lo descrivevano elegantissimo. Adesso, trascorreva la mattinata nell'orto, ed il pomeriggio passeggiando con il suo cagnolino Garbì, così chiamato in onore del vento di garbino che domina spesso la nostra terra. Rifiutava di indossare la cintura dei pantaloni, che teneva sù con una corda.
Sotto le bombe aveva salvato la pelle, e perso tutto. La svalutazione aveva bruciato i risparmi della nonna, il tenore di un'esistenza borghese era scivolato verso un decoro fatto di povertà, e di vestiti regalati da un parente ricco. Da uomo d'ordine, prima liberale e poi fascista, era diventato di idee (allora considerate) rivoluzionarie, alla Marcia reale aveva sostituito Bandiera rossa. La sua è anche un pò la storia d'Italia, da Giolitti a Mussolini, e poi al secondo Dopoguerra.
A fargli mutare idea, erano stati non soltanto gli eventi storici collettivi, ma anche la vicenda personale del figlio Guido. Il quale, come tutti i giovani nati attorno al '20, era stato tirato sù a «libro e moschetto», ma poi aveva scelto una strada diversa, finendo in galera nel gennaio '43, per aver distribuito dei volantini intitolati «Non credere, non obbedire, non combattere», ma l'imputazione del mandato di cattura (l'arresto avvenne a Bologna, dove Guido stava svolgendo il servizio militare), comprendeva anche il possesso di libri proibiti dal regime, romanzi di London e Gor'kij che peraltro erano regolarmente venduti anche sulle bancarelle. I libri, li aveva prelevati la polizia nella casa dove abitavamo, al palazzo Lettimi, ed io ero nella culla, avevo la bellezza di cinque mesi.
Fu un arresto che fece clamore in città, perché mio zio fu tra i primi studenti di tutta la regione a finire dentro per motivi politici, ha scritto Sergio Zavoli in Romanza, e perché era uno dei leader su cui «cominciava ad orientarsi la bussola dell'antifascismo riminese», come lo stesso Zavoli ha raccontato in una tavola rotonda: «La notizia attraversò la città e fece correre, soprattutto in noi giovani, un piccolo brivido».
Si dice spesso che i figli copiano dai padri, ma nel caso del nonno era avvenuto tutto il contrario.
Se le carte che raccogliamo (carte nel senso di cose scritte da altri), hanno un senso anche per la nostra storia individuale, e dicono qualcosa dei nostri gusti e delle preferenze che ci guidano nella vita, posso sostenere che il nonno, conservando in un quaderno magistralmente inventato con le sue mani, poesie e discorsi del divin Gabriele, si fosse sentito dannunziano, negli anni della Grande Guerra?
Sono ritagli della «Tribuna» e del «Corriere»: «Salva il Re che partisce il pane scuro / col combattente e non isdegna il duro / macigno alla sua sosta...»; «Prega pel re la figlia sua regina / che in sogno sta tra due fiumane calde...»; «O Dio d'Italia, tieni la tua mano su questa fronte che facesti dura...». Dura la fronte, o anche tutta la testa: si parla di Cadorna (dicembre 1915), ma poi nel '17 sarebbe giunta Caporetto, e la retorica («la forza degli uomini respira / in lui, palpita in lui, freme e s'adira...»), e la retorica avrebbe ceduto il passo al dramma, e lui Cadorna avrebbe lasciato il posto a Diaz. È tutto uno sferragliare di armi, tra notti di città (dove trema «l'imagine cara della Patria», mentre «il ricco ha rossore degli agi suoi»), ed albe di guerrieri armati di dolore.
C'è il discorso di Quarto (5 maggio 1915), per ricordare la partenza dei Mille di Garibaldi, nel 1860: «Beati i puri di cuore, beati i ritornanti con le vittorie, perché vedranno il viso novello di Roma, la fronte incoronata di Dante, la bellezza trionfale d'Italia». D'Annunzio era allora il supermarket culturale della mitologia politica a buon mercato: in centomila lo accolgono a Roma inneggiando alla guerra, il 13 maggio 1915: «L'Italia s'arma, e non per la parata burlesca, ma per il combattimento severo». Prima ancora che finisca il conflitto, comincia la tiritera della «vittoria mutilata» che ispirerà tante rivendicazioni nazionalistiche. In un brano dell'agosto 1918, si legge: «Sfidiamo il domani e l'ignoto, o compagni, col nostro grido di battaglia: Eia! Eia! Alalà!».
Sono le ultime parole incollate in quel quaderno. Diventeranno un grido fascista. Il ritaglio meno antico, è qualche pagina indietro, dal «Popolo d'Italia», il giornale di Mussolini, del 5 agosto 1922: «La grande Nazione italiana è in marcia», discorso di Milano. Dove s'invoca «sulla stanchezza di figli fragili il soffio divino dell'Italia eterna».
Non so perché il nonno amasse costruirmi gli aquiloni, a settant'anni. Per ritornare bambino anche lui? O per sognare qualche ricordo dannunziano: il volo di un aquilone poteva richiamargli alla mente il volo su Vienna? O per poter guardare finalmente in pace quel cielo da cui, qualche anno prima, era arrivata la distruzione per Rimini?
Anche noi bambini avevamo sentito i rumori terribili della guerra? Nei ricordi, non mi è rimasto nulla. Avevo poco più di un anno per i primi bombardamenti, due quando la guerra finì. Ma dove, dentro di noi, si scava come fa la sgorbia quando incide la scultura, lì ci sono i segni dei quali oggi nella vecchiaia nessuno tiene conto, perché nessuno allora, o poi, ne parlò. Oggi, per traumatizzare un fanciullo, ci spiegano gli esperti, basta una trasmissione televisiva sulla guerra. E noi, che ci siamo passati sotto, non avremmo diritto a vederci riconosciuto un danno psichico? («Eh! a me, m'ha rovinato la guerra», posso dire come il celebre Gastone di Ettore Petrolini).
Quando arrivarono, li chiamarono liberatori: era la verità della storia. Ma loro dovevano vendicarsi su di noi, volevano farci fuori tutti: bambini, donne, uomini. I greci regolarono i conti spaccando la metà delle cose che trovavano. Ai miei, il letto matrimoniale venne privato del pezzo dappiedi. Del mio seggiolone azzurro, restò miseramente soltanto una parte simbolica.
A mia madre, che chiedeva ai soldati inglesi qualcosa da dar da mangiare a me, fu risposto sotterrando il cibo e gli avanzi del rancio: «No a te, perché dopo dare a lui, a lui e a lui...».
Dovevamo morire di fame. Libera nos, Domine.
A mio padre, che era funzionario comunale, un ufficiale inglese disse con fare sprezzante: «Troppi riminesi». Avrebbero voluto fare piazza pulita, e avevano avuto l'intenzione di spianare San Marino, con tutti noi rifugiati e persi come formiche impazzite.
La fatica di vivere era ripresa, dopo la guerra, ma pesava di meno, era come quell'aquilone che il nonno a settant'anni faceva volare per il nipote di cinque. Dal cielo non cadevano più le bombe, la morte; ma per la mia imperizia precipitava soltanto, sbriciolandosi, quella colorata macchina volante: «E adesso, non te ne faccio più», borbottava il nonno, e poi andava a mettere a scaldare la «còla garavèla» per le necessarie riparazioni.
6. Smanie per la villeggiatura? ["il Ponte", 24, 21.06.1992]
(«Chi scrive non racconta le cose come sono ma le modifica o le maschera per dar credito alla sua opinione e, per convincere gli altri, aggiunge volentieri qualcosa alla materia originale e l'allunga e l'amplifica». Giovanni Macchia)
Smanie per la villeggiatura? Neanche a pensarci, pensando soprattutto al magro portafoglio postbellico di quel 1948. Più semplicemente, era una terapia consigliata per combattere l'inappetenza. Così suggeriva la scienza medica del tempo ai bambini classificati linfatici, cioè magri. L'aria della collina sembrava la più adatta per contrastare gli effetti negativi del clima marino, accusato di rendere nervosi e considerato colpevole del nostro rifiuto di rimpinzarci di cibo, come invece ogni famiglia degna di questo nome desiderava per il bene della propria prole. (Quando poi, finalmente, l'appettito venne, sorsero preoccupazioni diametralmente opposte, per un'obesità incipiente, contro cui prolungati bagni nulla poterono, anche perché essi rendevano ancora più desiderosi di riempire lo stomaco).
Non so come, la scelta cadde su Montefiore Conca, paese dolce e tranquillo, che sembro l'ideale per le nostre necessità. Oggi, la gente si muove soprattutto per divertirsi lietamente in libertà. A noi, il divertimento veniva imposto sub specie di una quasi clausura collinare, con varie ore del giorno dedicate alle pratiche religiose. Questione di punti di vista.
Per raggiungere Montefiore, si compiva un viaggio in corriera, partendo da piazza Malatesta. Allora, le auto private erano pochissime, le possedevano soltanto le persone cosiddette facoltose. (Anche acquistare una bicicletta, comportava una spesa rilevante). Le persone «normali» dovevano ricorrere ai mezzi pubblici. (Pure i viaggi di nozze li compivano in treno: la partenza dalla stazione era in quell'occasione l'ultimo momento della festa collettiva, dopo la cerimonia in chiesa ed il pranzo al ristorante).
Ai miei occhi fanciulli, l'itinerario in corriera da Rimini a Montefiore si disegnava come una lunga e straordinaria avventura, con quei paesaggi nuovi, lontani. Oggi, c'è un tiro di schioppo tra le due località, ed il viaggio si percorre con la propria vettura, in pochissimo tempo. Per me, la novità di quella trasferta rassomigliava a quella che un ragazzino di oggi proverebbe volando sul Mediterraneo, per andare in Tunisia. Altri tempi.
Non per colpa nostra, né per merito della nostra generazione, fummo educati a misurare lo spazio con i passi: «Andiamo a piedi alle Grazie?», «Andiamo a piedi alla Colonnella, alla festa della Madonna dei fichi?» (erano le estreme periferie della città). Per i funerali, l'ultima parte del corteo fino al Cimitero era percorsa a bordo di carrozze a noleggio. La domenica, s'andava a piedi fino a Marina centro (e poi si prendeva il tram per il ritorno, o viceversa), o a piazza Tripoli.
Tanto per dire come sono cambiate le cose. Nel 1973, quando per l'emergenza nei rifornimenti di petrolio (che stava al largo sulle navi, in attesa che i prezzi salissero), fummo costretti ad andare a piedi tutti, per decreto governativo, ci furono i soliti fantasiosi che si esibirono su velocipedi, cavalli, pattini a rotelle. E ci furono i giovanotti depressi, incapaci di adattarsi al mondo, che maledicevano tutto e (li ho sentiti con le mie orecchie), sostenevano: «Se si va avanti così, è meglio morire».
Nella nostra infanzia appiedata, il sogno era la bicicletta. La radio portava in tavola all'ora di pranzo le notizie della guerra di Corea, 1950. Mio padre temeva che riscopiasse un conflitto anche in Europa. Non lo capivo. Soltanto ora comprendo quale paura il dramma della guerra avesse lasciato nel suo animo. E lui diceva i suoi timori quando io gli chiedevo una bici per me, e mia madre il fornello a gas di bombola, da sistemare in cucina, sopra la «rôla», al posto di quello a carbone, utile soprattutto d'estate, perché d'inverno si accendeva la stufa economica.
La bici arriverà tra un anno. Intanto, andavamo avanti a misurare il mondo con il numero dei passi. I calzolai tentavano inutilmente di ridurre il consumo delle scarpe, mettendo una mezzaluna metallica sotto la punta. I buchi nella parte centrale della suola per primi annunciavano la necessità di una irrinunciabile riparazione.
Anche a Montefiore si camminava parecchio. Le salite invitavano al gioco, e si faticava in letizia, sotto il sole di un caldo estivo che incrementava dovunque la diffusione delle mosche, contro le quali abbondavano le innaffiate del «flit»: così la gente chiamava il «ddt», giunto dall'America con i liberatori.
Una colonia forlivese del Centro italiano femminile, garantiva la salubrità dell'aria. Quando ti sedevi a tavola, dopo qualche giorno dall'arrivo, ti tenevano gli occhi addosso per vedere quanto cibo ingurgitavi, con la speranza che la cura facesse effetto.
Sbrigata velocemente la faccenda alimentare, si correva con gli altri bambini, a giocare sulla piazza. Alcuni di loro avevano attrezzato un veicolo classico nel mondo infantile di allora, un carriolino con i cuscinetti a sfera, trainato da un amico, oppure lasciato andare in discesa, fino a che un fosso od un marugone ti fermava, al posto dei freni che non c'erano. Lo spirito di amicizia verso il nuovo arrivato, li spingeva ad accoglierti sul traballante aggeggio. Temendo di non reggersi bene, l'ospite allungò la mano sulla strada, mentre l'entusiasmo di chi guidava la corsa faceva riprendere a trascinare viaggiatore e carriolino che, su quella mano, passava lasciando il segno di lacrimoni di dolore. Era decisamente meglio andare a piedi, anche nel gioco.
La piazza assolata aveva i suoi occhi sonnolenti nelle botteghe che cupamente vi si affacciavano.
Al mattino, puntuale, il vecchio prete del Santuario di Bonora, don Sanchini, entrava nella piazza dalla salita della sua chiesa, con l'affanno dell'età che lo costringeva ad un passo lento, e con un ombrello già stagionato da molti viaggi e dal molto aiuto prestatogli nel percorrere quel lungo sentiero fatto di polvere e sassi. Cordiale e sorridente, aveva per noi fanciulli una parola di amicizia, nel suo fare modesto e tranquillo, frutto (ci spiegavano) di quella saggezza che a noi bambini veniva insegnato di identificare con l'anzianità stessa.
Era un prete giovane, invece, il parroco del paese, don Sisto, la cui chiesa lungo la salita verso il castello, ai miei occhi appariva maestosa. Lì si radunava ogni sera per la Benedizione un gran numero di donne, mentre gli uomini salivano alle case dai campi o dagli altri mestieri.
Una terza chiesa, quella dei Cappuccini domina Montefiore, dall'alto di un'impennata che permetteva gioiose rincorse.
Sembrava quasi che i tre campanili avessero una diversa voce, in quel panorama dove ognuno di essi costituiva come la punta di un triangolo tutto spirituale, quindi proiettato nel cielo, come quelle nuvole su cui sedevano santi e beati delle popolari illustrazioni contenute nei «santini», veicoli di pietà religiosa e di immaginazione ultraterrena. Forse le campane, senza saperlo, si rincorrevano, con i loro rintocchi, come ad esempio ogni mezzogiorno, quando l'ora batteva anche per informare su quel che già il sole a picco annunciava. Era il tempo di pensare alle necessità del corpo, sedendosi a tavola.
All'interno del santuario di Bonora, brillavano argentei gli ex voto, e attraverso lettere, fotografie, immagini e dipinti si narravano storie di quell'umano dolore che ai bambini appare come qualcosa di strano, inspiegabile come un fatto mitologico. Era la chiesa dove la speranza prendeva corpo nell'attesa del «miracolo» per chi andava a pregare, ad invocare «l'aiuto della Madonna».
Sembrava invece che la chiesa parrocchiale fosse quella dell'ordinaria amministrazione, della vita d'ogni giorno, la casa quotidiana. Più severa quella dei cappuccini, nell'intonazione scura degli altari: così lontana, in cima a quella salita, fuori del paese, quasi intimoriva, forse anche per colpa delle barbe lunghe dei frati. E del vicino cimitero.
Dopo la chiesa parrocchiale, proseguendo verso la sommità del castello, s'incontrava il rustico laboratorio d'un vasaio. Ce n'era un altro, ma sinceramente non ricordo più dove.
Le terraglie non erano per le nostre famiglie né folclore né oggetti-ricordo, ma rispondevano a necessità pratiche. I vasai lavoravano prodotti di cui la gente aveva bisogno. Spazio per il superfluo, non c'era.
Ad uso e consumo di qualche giovanissimo che eventualmente si fosse avventurato in queste righe, faro un esempio. Per noi, i calzoni rotti, come ora vanno di moda, erano impensabili. Al primo accenno di cedimento di una stoffa, la "donna di casa" provvedeva con pezze rinforzi rattoppi. Come in tutte le occasioni della vita, anche questa aveva la sua scala di valutazione della maestrìa di chi compiva il lavoro. Il massimo dell'abilità consisteva nell'attaccar pezze agli abiti, in maniera tale che la geometria del tessuto non venisse né scombinata né compromessa. Con innocente incoscienza, consapevoli che di problemi più importanti ne esistevano a bizzeffe, fingevamo del tutto che, tra la stoffa antica e quella nuova, non esistesse differenza di colore. E nessuno pensava ovviamente a protestare. Grazie a Dio che ci si potesse difendere dall'inclemenza del tempo, con quei panni addosso.
E le stoviglie, se si rompevano, non venivano gettate via, ma le si affidava all'esperienza di un artigiano riparatore detto «spranghìn». Non tutti i vocabolari della nostra lingua registrano la corrispondente voce italiana «sprangaio»: la trovo, ad esempio, nel «Dizionario ragionato» per indicare l'«ambulante che un tempo ricongiungeva con la spranga le terraglie rotte». Il lavoro consisteva nel ricomporre l'antica unità del manufatto con punti di spranga (appunto), che passava attraverso fori praticati con paziente trapanatura a mano. Il lavoro degli artigiani costava poco. Ma forse costava parecchio, per le tasche normali, anche il catino o il catinone: il primo per vari usi, il secondo da utilizzare per lavare i piatti o sbrigare altre faccende di pulizia casalinga dentro la «scàfa» che il vecchio dizionario romagnolo del Mattioli (1879), spiega così: «Pila dell'acquajo. Vaso quadrilatero, per lo più di pietra, con un buco da una parte, per il quale si scarica la rigovernatura delle stoviglie nell'acquajo».
Quei catini e catinoni di Montefiore avevano l'interno colorato a bolle verdi bottiglia, più o meno intense. Di uso comune, erano anche gli orci ed i boccali: questi ultimi erano di varie dimensioni, i più grandi per l'acqua, i piccoli da tavola per il vino. E poi, altro prodotto dell'arte vasaia per la vita d'ogni giorno, c'erano le «suore», cioè gli scaldini bassi a bocca larga con manico, entro i quali venivano sistemate le braci tolte dalla cucina economica o dalla «rôla», con le quali si scaldava il letto. Ma la «suora» a nulla serviva da sola: essa veniva utilizzata entro un arnese fatto di legni incurvati, una specie di ponte che permetteva allo scaldino di svolgere le sue funzioni tra le lenzuola, senza bruciarle. Questo arnese, dalla fantasia popolare che è sempre dissacratoria nelle sue definizioni, veniva chiamato con nome che doveva costituire ad un tempo completamento ed opposizione dello scaldino, il quale era appunto la «suora», per cui «prete» dissero l'aggeggio che permetteva il riscaldamento serale dei letti, in stanze gelate, dove quando bufava la neve s'udiva il vento fischiare le sue melodie che a noi bambini suggerivano scene di lupi, come si erano viste in qualche libro della scuola.
7. Gli anni Cinquanta ["il Ponte", 30, 02.08.1992]
(«Considero la memoria, il ricordo, un'enorme ricchezza, un rifugio e uno stimolo continuo...» Lella Costa, attrice e scrittrice.
«Non mi piace guardarmi indietro. Il passato è passato».
Mario Monicelli, regista.)
In terza elementare, anno scolastico 1950-51, finalmente cominciò a cambiare qualcosa. Dopo i due anziani insegnanti delle classi precedenti, arrivò un giovane maestro con il quale, pur non mutando granché il concetto generale di disciplina, che rimase quello tipico del clima storico in cui vivevamo, si introdussero delle novità molto apprezzate da noi bambini. Per esempio, l'insegnante non saliva più in cattedra, ma portava la sua sedia tra i banchi, avvicinandosi un pò alla classe. Egli, poi, aveva una faccia meno lontana nel tempo. I suoi figli erano più piccoli di noi che così abbandonavamo il ruolo dei nipoti o pronipoti: si erano accorciate le distanze generazionali.
La terza elementare era allora la classe conclusiva del cosiddetto «primo ciclo», e c'era un esame finale interno da sostenere con tutti i crismi della legalità. Occorreva, quindi, lavorare sodo. Mens sana in corpore sano, era stato sempre predicato (lo avremmo saputo da grandi), fin dai tempi antichi. Per la prima volta, incontrammo chi voleva tradurre la massima latina in concreta esperienza pedagogica. Cominciammo così a fare Educazione fisica, che avrebbe dovuto irrobustire le nostre membra, e permettere un maggior sviluppo intellettuale. Su questo secondo aspetto, sono ragionevoli forti dubbi, col senno di poi.
Gli esercizi dovevano svolgersi, per forza di cose, all'interno dell'aula scolastica, dove lo spazio era ripartito in base alla disposizione dei banchi monoblocco a due piazze, sui quali sedevamo, anzi entro i quali eravamo imprigionati. Questi banchi (anteguerra) decrescevano in altezza dal fondo verso la cattedra, per cui erano beati gli ultimi che potevano accomodarsi in spazi più ampi, mentre i primi venivano sacrificati entro una volumetria astratta, che cioè non teneva conto delle esigenze individuali.
Se in una classe tutti erano slungagnoni, i bambini delle prime file dovevano incastrare gambe e ginocchi contro l'asse portacartella che sporgeva da sotto la tavoletta su cui si scriveva. Il sedile spesso offriva un appoggio alle gambe, più che alla parte fisiologicamente deputata alla bisogna, mentre il fondoschiena si arrampicava ribelle verso il banco successivo, scombinando ogni geometrica necessità di ordine scolastico, e ribellandosi ai superiori ammonimenti a «stare composti». Con i corpi che crescevano entro grembiuli generalmente sempre più striminziti ed i banchi che non riuscivano a contenere i corpi stessi, quasi che fossero in reciproca opposizione, la disarmonia sembrava regnare nelle nostre classi di bambini esuberanti.
Per aiutarci a sgranchire le ossa, così costrette in quelle angustie spaziali, l'Educazione fisica poteva essere l'occasione più favorevole. Ovviamente, per eseguire gli esercizi, non era possibile spostare i banchi (il che avrebbe richiesto un pò di fantasia didattica, non imposta dai programmi, e avrebbe provocato del rumore o l'intervento delle anziane e bisbetiche bidelle, per un aiuto veloce). Quindi, bisognava regolarsi tra i corridoi lasciati liberi nell'aula, ove il massimo della licenza possibile ci permetteva di agire con un'attenta strategia, che doveva tener conto di un complesso di circostanze: messi sull'attenti, potevamo alzare le braccia soltanto verso l'alto od in avanti. Ogni altra mossa (laterale) era interdetta dalla mancanza di spazio: o si sbatteva nel banco o si urtava nel compagno. I banchi (miracolosamente salvati dalla distruzione generale della città, o provenienti da chissà quali altri luoghi), insomma impedivano che, in quella cosiddetta Educazione fisica, si realizzasse l'aggettivo e si verificasse il sostantivo: ci si accontentava di quello che poteva passare il convento, e nella partite a pallone sulle strade o nei prati si cercava un surrogato di soddisfazione personale.
Comunque, i momenti più esaltanti per i nostri maestri, erano quelli del «dettato», e quelli punitivi quando ci costringevano a stare "in prima" (con le mani appoggiate al banco) o "in seconda" (con le braccia dietro la schiena), per lunghi minuti che avrebbero dovuti esser votati ad una meditazione spirituale sulle nostre colpe, una specie di confiteor laico (anzi laido), in cui era però proibito battersi il petto, se non mentalmente, perché altrimenti si sarebbe violata l'imposizione a stare in posizione immobile.
Il «dettato» era invece lo scontro tra la saggezza (altrui) e l'ignoranza (nostra). Ovviamente, la prima doveva imporsi per forza di legge, mentre la consuetudine faceva trionfare la seconda. Frasi come «nell'alveare c'era la cera delle api», facevano brillare gli occhietti furbeschi dei nostri maestri, verso i quali si rivolgevano le pupille dei più bravi, in un ammiccamento d'intesa, come per dire, da parte di questi ultimi: «Io so come si scrive, e non mi freghi». Mentre gli ignari, e gli ignavi, che tra «c'era» e «cera» non facevano nessuna differenza sostanziale ed esistenziale, disperavano aguzzando lo sguardo verso qualche compagno da cui copiare, oppure sfregavano la penna sul foglio, nei ripetuti andirivieni in cui l'apostrofo viaggiava da una parola all'altra, e non sapeva mai dove prendere stabile dimora, a testimonianza che la vita è quell'«errare» che Francesco Petrarca chiamava anche «errore»: ma siffatta citazione, neppure se una miracolosa folgorazione pedagogica avesse attraversato la mente dei nostri maestri, avrebbe potuto evitare poi la sentenza finale, riassunta condensata e sublimata in una sola parola: «Male».
Erano i momenti conclusivi del «dettato», in cui sembrava ripetersi la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre: «E tu scolaro asino, gronderai sudore su questo quaderno. Ricopiare trenta volte!». Repetita iuvant. Ai più asini, si aggiungeva la punizione dell'immobilità. Se non una bella bacchettata sulle dita, che andavano convertite a scrivere senza commettere errori. Qualche fanciullo, in quei frangenti, veniva portato a dubitare, come certi aristotelici del '600, sulla centralità della funzione cerebrale: ci si diceva infatti che ragionavamo con i piedi, ecco il perché di tanti sbagli. (E perché, allora, punire con il righello di legno le dita inchiostrate da una penna che spesso era pesante?).
Il sadismo pedagogico aveva però un suo effetto positivo. Ci faceva lentamente crescere gli anticorpi verso le difficoltà della vita, ci abituava a resistere. La scuola diventava una vera e propria palestra di sopravvivenza, dove non contavano tanto i risultati culturali acquisiti, ma i "calli" con cui ci si avvezzava a sopportare tutto, il che era probabilmente la miglior forma di ribellione. Certo, l'unica consentita.
Ma c'erano anche i momenti consolatori, almeno in apparenza. La Radio italiana trasmetteva tutte le mattina una rubrica «per le scuole», che noi non potevamo ascoltare perché ci mancava l'apparecchio ricevitore, né il ministero aveva i soldi per fornircelo. Allora, il maestro scatenò una gara entusiasmante: dovevamo esser noi (orgogliosamente Noi), a racimolare i soldini, dieci lire dopo dieci lire, per creare nel nostro edificio un impianto con apparecchio centrale e altoparlanti (che noi, invariabilmente chiamavamo autoparlanti), in ogni aula.
Passò l'inverno nella raccolta, a primavera arrivò finalmente l'impianto, e così potemmo ascoltare ogni mattina la nostra trasmissione, ovviamente ben rigidi con le mani sul banco, ed in perfetto silenzio. Alla voce del maestro si aggiunse così quella che proveniva dalla piccola scatola metallica attaccata dietro la cattedra. Noi, potevano parlare ancora di meno.
Altra novità, per quella terza, ed occasione per poterci fare aprire la bocca, furono le esercitazioni di Canto corale, che venivano eseguite con l'accompagnamento di una fisarmonica, manovrata da un giovane che aveva dei gravi problemi alla vista e che, una volta seduto, più che guardare sembrava annusare l'aria per capire se il maestro era pronto a guidarci nell'esecuzione e gli scolari ad emettere quelle che diremmo le note, se non corressimo il rischio di confondere le pie intenzioni con la verità delle cose. Quel fisarmonicista rassomigliava vagamente alla figura analoga che Fellini ha raccontato, sotto specie di caricatura, in certe scene di Amarcord, ma era molto meno anziano e poi stava composto, con un fare ispirato come se la musica che usciva dal suo strumento fosse veramente il parto sofferto della genialità. Noi, disgraziati ed ignoranti, non sapevamo apprezzare tutto ciò: e molti s'impegnavano a strapazzare la melodia, quasi fosse una stoffa da lacerare in tante strisce che testimoniassero non partecipazione ma accanimento.
Si eseguivano canti popolari classici, come la Montanara, quasi fossimo degli aspiranti alpini; si andava sul versante patriottico, con quei Fratelli d'Italia così marziale nella melodia e così ostico nel testo, dove si incolpava (a nostro modo di udire) l'Italia per esser stata messa incinta da Scipio, e si saliva al ricordo del passato remoto con la Leggenda del Piave di E.A. Mario, il cui testo era stampato in un depliant pubblicitario di «Bruno Marcaccini - Rimini - completo assortimento di articoli scolastici», nella prima della quattro pagine che lo componevano. Nelle altre tre, c'erano rispettivamente la tavola della moltiplicazione, quella dell'addizione e sottrazione, e quella della divisione.
La musica dal vivo ci invitava ad emulare i cori che trasmetteva la radio. Per acquistare quell'apparecchio, tra gli alunni di ogni classe, come ho detto, era stata ingaggiata (astutamente) una piccola gara a chi offriva di più. Il premio consisteva in un gioco tutto infantile, una tombola, sul cui coperchio il maestro scriveva una dedica, con la sua perfetta ed elegante grafia: «Al bravo alunno...». Non si trattava, però, di una tombola qualsiasi, bensì di un veicolo di propaganda politica. Nel 1949 era nato il Patto atlantico, nel '47 il Piano Marshall. Un manifesto del '48 diceva: «Gli aiuti d'America - grano carbone viveri medicinali - ci aiutano ad aiutarci da noi». La nostra tombola-premio era in sintonia con quelle parole, s'intitolava appunto all'ERP, European Recovery Program, piano di ricostruzione europea.
Quella tombola ERP della primavera 1951, testimoniava tante cose: la pace raggiunta, dopo la terribile avventura bellica, la divisione del mondo in due blocchi (dopo Yalta, febbraio 1945), la conseguente "guerra fredda". All'interno dell'Italia, nel '48 era nato il "fronte democratico popolare" di socialisti e comunisti, dopo il loro allontanamento dal governo, avvenuto l'anno prima. L'Italia tifava De Gasperi o Togliatti (e un pò Nenni), Bartali o Coppi. Di Bartali, si diceva che nel '48, vincendo una tappa al Tour de France, aveva salvato il Paese dalla rivoluzione, quando era stato ferito Palmiro Togliatti. Dei comunisti, si ipotizzava che mangiassero bambini. L'Italia era veramente divisa in due. Come la strada dove sorgeva la nostra scuola. La Chiesa apostolica romana celebrava a San Giovanni Battista. Quella di rito moscovita, come avrebbe detto don Camillo, funzionava nel palazzo Ghetti, sotto l'ombra (anzi, la luce radiosa) di una falce e martello.
Don Lino Grossi (in «Vita da prete», ed. «Il Ponte»), ricorda quei giorni del Dopoguerra: «La parrocchia di San Salvatore non aveva poderi, il giovane parroco era povero e per questo molto rispettato. Alcuni facinorosi gridavano: "Coi padroni anche i preti vogliamo fare fuori, solo salveremo i parroci di San Salvatore e Vecciano, perché sono poveri come noi"».
Altri programmavano il futuro politico all'insegna di un motto che non ammetteva dubbi: «Con le budelle dell'ultimo prete, strozzeremo l'ultimo signore».
Queste pagine sono poi state ridotto in volume, che si legge qui.
Antonio Montanari, 47921 Rimini, via Emilia 23 (Celle), tel. 0541.740173
il Rimino
Creata
04.03.2013.
Aggiornata
04.03.2013, 17:45