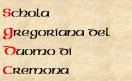LITURGIA E MUSICA SACRA
Premessa
Tra la liturgia e la musica sin dagli inizi c’è stato un rapporto fraterno. Quando l’uomo loda Dio, la sola parola è insufficiente. La parola rivolta a Dio trascende i limiti del linguaggio umano. Per questo motivo tale parola in ogni tempo, proprio in forza della sua natura, ha invocato in aiuto la musica, il cantare e la voce del creato nel suono degli strumenti. Infatti, alla lode di Dio non partecipa soltanto l’uomo. La.liturgia quale servizio di Dio è l’inserirsi in ciò di cui parlano tutte le cose.
Per quanto la liturgia e la musica in forza della loro natura siano strettamente congiunte tra di loro, la loro relazione è sempre stata difficile, soprattutto nei momenti nodali di transizione nella storia e nella cultura. Non v’è perciò da meravigliarsi, che anche oggi sia di nuovo posto in discussione il problema di una forma adeguata della musica nella celebrazione liturgica. Nelle dispute del Concilio e subito dopo pareva che si trattasse semplicemente della divergenza tra persone dedite alla prassi pastorale da un lato e musicisti di chiesa dall’altro lato. Questi ultimi non volevano lasciarsi coartare da una formalità puramente pastorale, mentre si sforzavano di affermare la dignità intrinseca della musica quale misura di un proprio valore pastorale e liturgico. Si aveva pertanto l’impressione che il conflitto per la massima parte riguardasse unicamente l’ambito dell’uso della musica. Nel frattempo, tuttavia, la spaccatura si fa più profonda.
La seconda ondata della riforma liturgica spinge il problema sino a raggiungere i suoi fondamenti. Si tratta ora della natura dell’azione liturgica in quanto tale, delle sue basi antropologiche e teologiche. Il conflitto che investe la musica sacra è sintomatico e scopre un problema più profondo, e cioè: che cosa sia la liturgia.
1. SUPERARE IL CONCILIO? UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA LITURGIA
La nuova fase in cui si afferma la volontà di una riforma liturgica considera esplicitamente suo fondamento non più le parole del Concilio Vaticano Il, bensì il suo «spirito». Utilizzo quale testo paradigmatico l’articolo ben informato e coerente, su «Canto e musica nella Chiesa» del Nuovo Dizionario di Liturgia. Qui non si mette affatto in discussione l’alto valore artistico del canto gregoriano o della polifonia classica. E non si tratta neppure di opporre l’una contro l’altra l’attività dell’assemblea e un’arte di élite. Punto nodale della discussione non è neanche il rifiuto di un irrigidimento storico che copia soltanto il passato e perciò stesso rimane senza presente e senza futuro. Si tratta piuttosto di una nuova concezione di fondo della liturgia, con cui si vuole superare il Concilio, la cui Costituzione Iiturgica avrebbe racchiuso «due anime» (p. 211 a, cE 212 a).
Gruppo o Chiesa?
Cerchiamo brevemente di conoscere questa concezione nelle sue linee maestre. Il punto di partenza della liturgia — così ci viene detto —è il riunirsi di due o tre che stanno insieme nel nome di Cristo (199 a). Questo riferimento alla parola del Signore (Mt 18, 20) di primo acchito sembra innocuo e tradizionale. Ma tale parola acquista una portata rivoluzionaria per il fatto che la citazione biblica è tolta dal suo contesto e viene fatta risaltare per contrasto sullo sfondo di tutta la tradizione liturgica. Perché i «due o tre» sono messi ora in opposizione nei confronti di un’istituzione con ruoli istituzionalizzati e nei confronti di ogni «programma codificato ». Così tale definizione significa quanto segue: non è la Chiesa che precede il gruppo, bensì il gruppo precede la Chiesa. Non la Chiesa nel suo insieme fa da supporto alla liturgia dei singoli gruppi e comunità, bensì il gruppo stesso è il luogo dove di volta in volta nasce la liturgia. La liturgia perciò non si sviluppa neppure partendo da un modello comune, da un «rito» (ridotto, in quanto «programma codificato», all’immagine negativa della mancanza di libertà); la liturgia nasce nel momento e nel luogo concreto grazie alla creatività di quanti sono riuniti. In tale linguaggio sociologico il sacramento del sacerdozio viene considerato un ruolo istituzionalizzato che si è procurato un monopolio (206 w) e, grazie all’istituzione (cioè alla Chiesa) ha dissolto l’unità primitiva e la comunitarietà dei gruppi. In tale contesto la musica, così ci viene detto, come pure il latino, sono divenuti un linguaggio da iniziati, «la lingua di un’altra Chiesa, cioè dell’istituzione e del suo clero».
Due Chiese?
L’aver isolato il passo di Mt 18, 20 dall’intera tradizione biblica ed ecclesiale della preghiera comune della Chiesa, come si vede, mostra ora gravi conseguenze: a partire dalla promessa che il Signore ha fatto a quanti pregano in ogni luogo, si è fatta una dogmatizzazione dei gruppi autonomi. La comunanza della preghiera è stata esasperata sino a divenire un appiattimento che considera lo sviluppo del ministero sacerdotale il sorgere di un’altra Chiesa. Da questo punto di vista ogni proposta che viene dalla Chiesa universale è giudicata una catena contro cui bisogna insorgere per amore della novità e libertà della celebrazione liturgica. Non l’ubbidienza di fronte a un tutto, bensì la creatività del momento diviene la forma determinante.
Mistificazioni?
E’ evidente che insieme all’adozione di un linguaggio sociologico si è avuta pure l’assunzione di valori: la gerarchia di valori che ha dato forma al linguaggio sociologico costruisce una nuova visione della storia e del presente. Così alcuni concetti consueti (per di più anche conciliari!) — come «il grande patrimonio della musica sacra ». «l’organo re degli strumenti », «l’universalità del canto gregoriano» — sono bollati quali «mistificazioni» usate allo scopo di «conservare una determinata forma di potere e di visione ideologica» (p 200 a).
Un certo modo di amministrare il potere (così ci viene detto) si sente minacciato dai processi di trasformazione culturali e «reagisce, fino a mascherare come amore alla tradizione il desiderio di autoconservazione» (p 205 n). Il canto gregoriano e Palestrina sarebbero i «numi tutelari» di un antico repertorio mitizzato (210 b), elementi di una «contro-cultura cattolica» che si appoggia ad essi Quali «archetipi remitizzati e supersacralizzati” (208 a), come d’altronde alla liturgia storica sta a cuore più la rappresentazione di una burocrazia del culto che non l’azione corale di un popolo (206 a). Il contenuto del Motu proorio di Pio X sulla musica sacra viene infine considerato «una ideologia culturalmente miope e teologicamente fumosa di una «musica sacra» (211 a). Qui, evidentemente, non è più soltanto il sociologismo all’opera, ma siamo di fronte a una totale separazione del Nuovo Testamento dalla storia della Chiesa, che si unisce a una teoria della decadenza caratteristica di molte situazioni illuministiche: le realtà nel loro stato puro si incontrano soltanto negli inizi primordiali gesuanici; tutto il resto della storia appare una «vecchia avventura musicale» con «esperienze disorientate ed impazzite», che ora deve «essere chiusa», per riprendere finalmente la via giusta (212 a).
Materialismo
Ma come si configura questa realtà nuova e migliore? I principi base sono già stati sfiorati in precedenza; ora dobbiamo prestare attenzione alla loro concretizzazione particolare. Sono formulati in modo chiaro due valori di fondo. Il «valore primario» di una liturgia rinnovata, come ci è detto, sarebbe «l’agire delle persone (tutte) in pienezza ed autenticità» (211 b). Di conseguenza la musica di Chiesa in primo luogo significherebbe che il «popolo di Dio” rappresenta la sua identità cantando. Con ciò è chiamato in causa anche già il secondo criterio di valore che qui è attivo: la musica risulta essere la forza che opera la coesione del gruppo (217 xv). I canti familiari a una comunità ne diventano, per così dire, il suo distintivo. Da queste premesse scaturiscono le categorie principali della strutturazione musicale della liturgia: il progetto, il programma, l’animazione, la regia. Più importante del che cosa (così ci è detto) sarebbe il come (217 w). Essere in grado di celebrare sarebbe soprattutto «essere in grado di fare ». La musica dovrebbe soprattutto essere «fatta »...
Per non essere ingiusto, devo aggiungere che si mostra tuttavia nell’articolo in questione comprensione per le diverse situazioni culturali e che rimane anche dello spazio aperto per l’assunzione del patrimonio storico. E soprattutto è sottolineato il carattere pasquale della liturgia cristiana il cui canto non soltanto rappresenta l’identità del popolo di Dio, ma dovrebbe rendere anche conto della speranza e annunciare a tutti il volto del Padre di Gesù Cristo.
Errata interpretazione del Concilio
Permangono così elementi di continuità nella grossa rottura: essi permettono il dialogo e infondono speranza che si possa ritrovare l’unità nella comprensione basilare della liturgia che tuttavia minaccia di sfuggire, quando si fa derivare la liturgia dal gruppo invece che dalla Chiesa — non soltanto sul piano teoretico, bensì nella prassi liturgica concreta. Non mi dilungherei tanto su questo testo pubblicato in un dizionario prestigioso, se pensassi che tali idee siano da attribuire unicamente ad alcuni singoli teorici. Ancorché sia fuori dubbio che essi non si possono appoggiare a nessun testo del Vaticano II. in alcuni uffici e organi liturgici si è consolidata l’opinione che lo spirito del Concilio orienta in tale direzione. Un’opinione fin troppo diffusa suggerisce oggi le concezioni or ora esposte che, cioè, le categorie proprie della comprensione conciliare della liturgia siano appunto la cosiddetta creatività, l’agire di tutti i presenti e il riferimento a un gruppo di persone che si conoscono e interpellano a vicenda. Non solo giovani preti, ma talvolta anche vescovi hanno la sensazione di non essere fedeli al Concilio, se pregano tutto così come sta nel Messale. Deve esserci almeno una formula «creativa», per banale che sia. E il saluto «civile» dei presenti, possibilmente anche i cordiali saluti al congedo, sono già divenuti parti d’obbligo dell’azione sacra, cui quasi nessuno osa sottrarsi.
2. IL FONDAMENTO FILOSOFICO DEL CONCETTO E LA SUA MESSA IN QUESTIONE
Con tutto ciò non si è tuttavia ancora sfiorato il nocciolo del problema, della mutazione cioè di valore. Tutto quanto si è detto deriva dall’aver preposto il gruppo alla Chiesa. Ma perché mai è avvenuto ciò? Il motivo sta nel fatto che si è sussunta la Chiesa nel concetto generico di «istituzione» e che il termine «istituzione» nel tipo di sociologia qui adottato, reca in sé una qualità negativa. Essa incarna il potere e il potere è il contrario della libertà. Dato che la fede (la sequela di Gesù) è concepita quale valore positivo, deve stare dalla parte della libertà e per sua natura deve quindi essere anche anti-istituzionale. Di conseguenza anche la liturgia non può essere un sostegno o una parte dell’istituzione; deve invece costituire una forza contrastante che aiuti a rovesciare i potenti dal trono. La speranza pasquale, di cui la liturgia deve dare testimonianza, sviluppandosi da questo punto di partenza può divenire molto terrena. Essa diviene speranza nel superamento delle istituzioni e diventa pure mezzo di lotta contro il potere. Colui che conosce la Missa Nicaraguensis anche per averne soltanto letto i testi, può farsi un’idea di questo slittamento della speranza e del realismo che la liturgia acquisisce qui in quanto strumento di una promessa militante. Si può anche vedere quale significato e importanza si attribuisce alla musica nella nuova concezione. La forza d’urto dei canti rivoluzionari comunica un entusiasmo e una convinzione che non potrebbero derivare da una liturgia semplicemente recitata. Qui non vi è più nessuna opposizione alla musica liturgica. Essa ha ottenuto un nuovo ruolo insostituibile nel risvegliare le energie irrazionali e lo slancio comunitario cui tutto tende. Ma parimenti la musica è formazione delle coscienze, perché la parola cantata si comunica in modo progressivo e molto più efficace allo spirito che non la parola letta o solo pensata. Del resto, nel cammino che porta alle liturgie di gruppo intenzionalmente si supera il limite della comunità locale: grazie alla forma liturgica e alla sua musica si costituisce una nuova solidarietà, per mezzo della quale deve formarsi un nuovo popolo, che si autodefinisce popolo di Dio, mentre di fatto per Dio intende se stesso e le energie storiche, che si sono sviluppate in sé.
Liturgia e libertà
Ritorniamo ancora all’analisi dei valori che sono diventati determinanti nella nuova coscienza liturgica. Si tratta da un lato della qualità negativa del concetto di istituzione e della considerazione della Chiesa esclusivamente sotto questo aspetto sociologico, per di più non nell’ottica di una sociologia empirica, bensì da un punto di vista che deriva dai cosiddetti maestri del sospetto. Si vede che hanno compiuto la loro opera in modo molto efficace. Hanno infatti raggiunto una determinazione delle coscienze che è attiva anche là dove non si sa nulla di questa origine. Il sospetto d’altronde non avrebbe potuto avere una tale forza incendiaria, se non fosse accompagnato da una promessa, il cui fascino è quasi inevitabile: dall’idea, cioè, della libertà quale diritto autentico della dignità dell’uomo. Sotto questo aspetto il nocciolo della discussione deve essere la domanda: Che cosa è il vero concetto della libertà? Con ciò la disputa sulla liturgia è ricondotta al suo punto essenziale, poiché nella liturgia, infatti, si tratta della presenza della salvezza, dell’adito alla vera libertà. Nell’aver messo in luce il nocciolo della questione sta senza dubbio l’elemento positivo della nuova disputa.
Liturgia senza la Chiesa?
Contemporaneamente si è manifestato ciò che oggi costituisce il vero disagio dei cristiani cattolici. Se la Chiesa ora appare soltanto come istituzione, come detentrice del potere e perciò come controparte della libertà, come impedimento alla salvezza, allora la fede contraddice se stessa; perché da un lato non può fare a meno della Chiesa, ma dall’altro è schierata fondamentalmente contro di essa. Ciò costituisce anche il paradosso davvero tragico di questo orientamento della riforma liturgica, perché la liturgia senza la Chiesa è in sé una contraddizione. Là ove tutti agiscono affinché tutti diventino soggetto, svanisce — con la Chiesa soggetto comune — anche il vero «attore» della liturgia. Si dimentica, infatti, che essa dovrebbe essere «Opus Dei», in cui Egli stesso agisce per primo e in cui noi, proprio per mezzo della sua azione, siamo redenti. Dove il gruppo celebra se stesso, celebra in realtà un nulla, perché il gruppo non è un motivo per celebrare. Ed è per ciò che l’agire di tutti produce noia: non avviene in realtà nulla, se rimane assente Colui, che tutto il mondo attende. Il. passaggio ad intenti più concreti, come si riflettono nella Missa Nicaraguensis, è così soltanto logico.
Morti seppelliscono altri morti
I sostenitori di questo modo di pensare devono perciò essere interrogati con ogni franchezza: E’ la Chiesa davvero soltanto istituzione, burocrazia del culto, apparato di potere? E’ il ministero sacerdotale soltanto monopolizzazione di privilegi sacrali? Se non si riesce a superare queste concezioni anche sul piano affettivo e a vedere col cuore la Chiesa in un altro modo, la liturgia allora non sarà rinnovata, bensì morti seppelliscono altri morti, e definiscono ciò riforma.
Riscoprire la Chiesa
Allora, naturalmente, non c’è neanche più la musica da Chiesa. Anzi, di diritto non si può neanche più parlare di liturgia, dato che essa presuppone la Chiesa: ciò che rimane sono rituali di gruppo che si servono più o meno abilmente di mezzi espressivi musicali. Se la liturgia deve sopravvivere o persin essere rinnovata, è di necessità elementare che la Chiesa sia riscoperta nuovamente. E aggiungo: Se l’alienazione dell’uomo deve essere superata, se egli deve ritrovare la sua identità, è indispensabile che ritrovi la Chiesa. Essa, infatti, non è una istituzione misantropica, bensì quel nuovo Noi in cui finalmente l’Io può acquisire la sua base e la sua dimora.
Cristo e la Chiesa
Sarebbe benefico rileggere in questo contesto con molta attenzione il libretto con cui Romano Guardini, il grande pioniere del rinnovamento liturgico, ha concluso la sua opera letteraria nell’ultimo anno conciliare. Egli stesso sottolinea di aver scritto questo libro preoccupato dell’amore per la Chiesa, della quale conosceva benissimo la condizione umana e i suoi rischi. Ma egli aveva imparato a scoprire in quella umanità lo scandalo dell’incarnazione di Dio: aveva imparato a vedere in essa la presenza del Signore che ha reso la Chiesa suo corpo; Soltanto se così è, esiste una contemporaneità di Gesù Cristo con noi. E soltanto se c’è questa, esiste una liturgia reale che non è soltanto un ricordare il mistero pasquale, bensì è la sua presenza vera. E ancora, soltanto se così è, la liturgia è partecipazione al dialogo trinitario tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Soltanto in questo modo la liturgia non è il nostro «fare», bensì opus Dei, l’agire di Dio su di noi e in noi. Perciò Guardini ha sottolineato espressamente che nella liturgia non importa fare qualcosa bensì essere. Pensare che l’agire di tutti sia il valore centrale della liturgia è il contrario più radicale che si possa immaginare alla concezione di Guardini della liturgia. In verità, l’agire di tutti non soltanto non è il valore fondamentale della liturgia, ma come tale non èaffatto un valore.
Le tre dimensioni della Liturgia
Mi astengo dall’approfondire ulteriormente questi problemi; dobbiamo concentrarci allo scopo di trovare il punto di partenza e la norma per una giusta unione di liturgia e musica. Infatti, anche da questo punto di vista, è di grande portata la constatazione che il vero soggetto della liturgia è la Chiesa e, più precisamente, la communio sanctorum di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Ne risulta non soltanto — come Guardini nel suo scritto giovanile «Liturgische Bildung» ha mostrato in modo particolareggiato — l’indisponibilità della liturgia nei confronti dell’arbitrio del gruppo e del singolo (anche del clero e degli specialisti), insomma ciò che Guardini chiamava la sua oggettività e la sua positività. Ne risultano soprattutto anche le tre dimensioni ontologiche in cui essa vive: il cosmo, la storia e il mistero. Il richiamo alla storia comprende uno sviluppo, cioè l’appartenenza a qualcosa di vitale, che ha un inizio, il quale continua a operare, rimane presente senza essere conchiuso, e vive nella misura in cui si sviluppa ulteriormente. Qualcosa si atrofizza, qualcosa viene dimenticato e ritorna in seguito sotto nuova forma, sempre però lo sviluppo significa partecipazione a un inizio aperto in avanti. Con questo abbiamo già toccato una seconda categoria che, messa in relazione col cosmo, acquisisce la sua importanza specifica: la liturgia compresa in tale modo viene nella forma fondamentale della partecipazione. Nessuno è il suo primo e unico creatore, per ognuno essa è partecipazione ad una realtà più ampia, che lo supera, ma ognuno è altrettanto anche un «attore», proprio perché è ricettore. Il riferimento al mistero, infine, significa che l’inizio dell’avvenimento liturgico non sta mai in noi stessi. E’ risposta a una iniziativa dall’alto, a un appello e ad un atto d’amore che è mistero. I problemi esistono per essere chiariti; il mistero invece non si dischiude alla chiarificazione, bensì soltanto quando lo si accetta nel Sì, che, sulla traccia della Bibbia, possiamo tranquillamente chiamare ubbidienza, anche oggi.
Creatività assurda e falsa
Con ciò siamo giunti ad un punto di grande importanza per il collegamento con il fattore artistico. La liturgia di gruppo, infatti, non è cosmica in quanto vive appunto dall’autonomia del gruppo. Non ha storia, ma è caratterizzata proprio dall’emancipazione dalla storia e dal fare da sé; anche se si lavora con scenari storici. Non conosce neppure il mistero, perché in essa tutto viene chiarito e deve essere chiarito. Perciò anche lo sviluppo e la partecipazione le sono altrettanto estranee quanto l’ubbidienza, cui si dischiude un senso che è più grande di quanto può essere spiegato.
Al posto di tutto ciò si colloca ora la creatività in cui l’autonomia dell’emancipato tenta addirittura di confermarsi. Una tale creatività che vorrebbe essere la messa in atto di autonomia ed emancipazione, proprio per questo contrasta nettamente con ogni partecipazione. I suoi segni distintivi sono l’arbitrio quale forma necessaria di rifiuto di ogni forma o norma esistente: l’irripetibilità, perché la ripetizione sarebbe già dipendenza; l’artificialità, perché deve ben trattarsi di pura creazione dell’uomo. Così però diviene manifesto che la creatività umana, che non vuole essere né ricevere né partecipare, nella sua essenza è assurda e falsa, perché l’uomo unicamente ricevendo e partecipando può essere se stesso. Tale creatività è fuga dalla conditio umana e perciò falsità. Per questo motivo inizia la decadenza della cultura là dove, con la perdita fede in Dio, deve essere contestata anche una ragionevolezza che ci precede, inerente dall’essere.
Conseguenze
Riassumiamo quanto abbiamo finora acquisito, per poter poi tirare le conseguenze per il punto di partenza e per la forma fondamentale della musica da Chiesa. Si è visto che il primato del gruppo viene da una comprensione della Chiesa quale istituzione, basata su una idea di libertà che non si presta ad essere collegata con l’idea e con la realtà dell’istituzione e che non è più in grado di percepire la dimensione del mistero nella realtà della Chiesa. La libertà viene compresa a partire dalle idee guida di autonomia e di emancipazione. E si concretizza nell’idea della creatività, che su questo sfondo si pone in un contrasto netto con quella oggettività e positività che sono essenziali della liturgia ecclesiale. Il gruppo deve ogni volta inventarsi ex novo, soltanto allora è libero. Abbiamo pure visto che a ciò è radicalmente opposta la liturgia, che merita questo nome. Essa sta contro l’arbitrio astorico, che non conosce alcuno sviluppo, camminando perciò nel vuoto; sta contro una irripetibilità che è anche esclusivismo e perdita di comunicazione al di là di ogni raggruppamento; non sta contro la tecnologia, bensì contro l’artificiosità in cui l’uomo si crea il suo contro-mondo perdendo di vista e dal cuore il creato di Dio. I contrasti sono chiari; nel suo punto di partenza è anche chiara la motivazione intrinseca del modo di pensare del gruppo, dettato da un’idea di libertà compresa in modo autonomistico. Ora però dobbiamo interrogarci positivamente circa la concezione antropologica su cui si basa la liturgia nel senso della fede della Chiesa.
3. IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA LITURGIA ECCLESIALE
Due parole della Scrittura si presentano quali chiavi per rispondere alla nostra domanda. Paolo ha coniato il termine Loghiché latreia (Rom 12, 1), che si può difficilmente rendere in una delle nostre lingue moderne perché vi manca un equivalente reale del termine Logos. «Servizio liturgico determinato dallo Spirito» potremmo dire, rimandando pure alle parole di Gesù relative all’adorazione in Spirito e verità (Gv 4, 23). Ma si potrebbe anche tradurre «venerazione di Dio plasmata dalla Parola», e in tal caso è naturale che il termine «Parola» nella sua accezione biblica (e anche del mondo greco) è più del semplice linguaggio: è una realtà creatrice. E tuttavia è anche più di una semplice idea e di mero spirito: è lo Spirito che si esprime, che si comunica. Da questa realtà di fondo in ogni epoca sono stati derivati, quali principi preliminari, il riferimento alla Parola, la razionalità, la comprensibilità e la sobrietà della liturgia cristiana e della musica liturgica. Sarebbe un’interpretazione restrittiva e falsa, se si volesse comprendere con ciò un rigido riferimento al testo di ogni musica liturgica e se si volesse dichiarare la comprensibilità del testo quale suo presupposto generale. La Parola, in senso biblico, è infatti più di un «testo” e la comprensione è più ampia e profonda della banale comprensibilità di quanto uno vede subito con chiarezza, di quanto si può sistemare forzatamente nella razionalità più generica.
Giusto è però che la musica che serve l’adorazione «in spirito e verità» non può essere estasi ritmica, non suggestione sensuale o stordimento, non sentimentalismo soggettivo, non intrattenimento superficiale, bensì è associata a un annuncio, a un’asserzione spirituale e nel senso più nobile ragionevole. Con altre parole: è dunque giusto che dal suo intimo la musica deve fondamentalmente corrispondere a questa «Parola», anzi, deve mettersi al suo servizio.
Incarnazione della Parola
Con ciò siamo però già condotti ad un altro testo biblico, quello fondamentale per il problema del culto. Questo testo ci dice più precisamente che cosa significa la «parola” e quale rapporto abbia con noi. Alludo al passo del prologo giovanneo: «E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria» (Gv 1, 14). Parlando della «Parola» a cui si riferisce il servizio liturgico cristiano non si tratta in primo luogo di un testo, ma di una realtà viva: di un Dio, che è senso che si comunica e che si comunica diventando uomo egli stesso. Questa incarnazione è ora tenda sacra, punto di riferimento di ogni culto, che è un guardare la gloria di Dio e dargli onore. Queste asserzioni del prologo di Giovanni non sono però ancora tutto. Esse sono state malintese se lette disgiunte dai discorsi di commiato in cui Gesù dice ai suoi: Io vado e ritornerò da voi. Se vado, di nuovo vengo. E’ bene che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore (Gv 14, 2 s; 14, 18 s; 16, 5 ss ecc.). L’incarnazione è soltanto la prima parte del movimento. Essa acquista senso e diventa definitiva soltanto sulla croce e nella resurrezione: dalla croce il Signore attira tutto a sé e porta la carne, cioè l’uomo, e tutto il mondo creato nell’eternità di Dio.
La Parola si fa musica
A questa traiettoria è sottomessa la liturgia e questo movimento è, per così dire, il testo fondamentale a cui si riferisce ogni musica Iiturgica, quale sua misura. La musica liturgica è una conseguenza risultante dall’esigenza e dalla dinamica dell’incarnazione della Parola, perché questa significa che anche tra di noi la Parola non può essere semplice parlare. Il modo centrale con cui l’incarnazione continua ad operare sono in primo luogo certamente gli stessi segni sacramentali. Ma essi vengono a mancare di un contesto vitale, se non sono immersi ina una liturgia che nella sua totalità segue questa espansione della Parola nella corporalità e nella sfera di tutti i nostri sensi. Da qui viene, a differenza dai tipi di culto giudaico ed islamico, il diritto, anzi, la necessità di usare delle immagini. E da qui viene anche la necessità di chiamare in causa quelle sfere più profonde del comprendere e del rispondere che si dischiudono nella musica. La fede che diventa musica è una parte del processo dell’incarnazione della Parola. Ma questo divenire musica è contemporaneamente in modo del tutto unico abbinato a quella svolta interiore dell’evento dell’incarnazione, cui poc’anzi cercavo di accennare: sulla croce e nella risurrezione, l’incarnazione della Parola diviene carne fattasi Parola. Ambedue si compenetrano. L’incarnazione non viene ritratta, diventa definitiva soltanto nel momento in cui il movimento, per così dire, si inverte: La carne stessa viene «fatta logos», ma proprio questo divenir Parola della carne crea una nuova unità di tutta la realtà, cui Dio evidentemente teneva talmente da pagarla con la croce del Figlio. Il divenir musica della Parola è da un lato incarnazione, un trarre a sé forze prerazionali e metarazionali, che vengono anche rese sensibili, il trarre a sé il suono nascosto del creato, lo scoprire il canto che riposa sul fondo delle cose. Ma così questo stesso divenire musica è anche già la svolta nel movimento: non è soltanto incarnazione della Parola, ma nello stesso tempo spiritualizzazione della carne. Il legno e il metallo diventano suono, l’inconscio e l’insoluto diviene sonorità ordinata piena di significato. Si alternano una corporeizzazione che è spiritualizzazione e una spiritualizzazione che è corporeizzazione. La corporeizzazione cristiana è sempre anche spiritualizzazione e la spiritualizzazione cristiana è corporeizzazione che penetra nel corpo del logos incarnato.
4. LE CONSEGUENZE PER LA MUSICA LITURGICA
a) Considerazioni fondamentali
In quanto nella musica avviene questa coincidenza dei due movimenti, essa serve in misura ottimale e in maniera insostituibile a quell’esodo interiore che la liturgia vuole sempre essere e divenire. Ciò però significa che la conformità della musica liturgica si misura in base alla sua corrispondenza intrinseca a questa forma-base antropologica e teologica. Una tale asserzione a tutta prima sembra essere ben lontana dalla concreta realtà musicale, ma diventa concreta immediatamente se prestiamo attenzione ai diversi modelli di musica cultuale cui prima ho già brevemente accennato. Pensiamo un momento al tipo di religione dionisiaca e alla sua musica che Platone ha esaminato nell’ottica della sua religione e filosofia. In non poche forme religiose la musica è abbinata all’ebbrezza, all’estasi. Il superamento del limite della condizione umana cui è indirizzata la fame dell’infinito insita nell’uomo, deve essere raggiunta per mezzo di frenesia sacra, di delirio del ritmo e degli strumenti. Una musica simile abbatte le barriere dell’individualità e della personalità; l’uomo si libera così dal peso della coscienza. La musica diviene estasi, liberazione dall’Io, unificazione coll’universo.
Oggi sperimentiamo il ritorno profanizzato di questo
modello nella musica Rock e Pop, i cui festivals sono un anticulto nella
stessa direzione — smania di distruzione, abolizione delle barriere del
quotidiano e illusione di redenzione nella liberazione dall’Io, nell’estasi
furiosa del rumore e della massa. Si tratta di pratiche redentive simili alla
droga nella loro forma di redenzione e fondamentalmente opposte alla concezione
di redenzione della fede cristiana. Di conseguenza perciò dilagano oggi sempre
di più, in questo ambito, culti e musiche satanistiche il cui potere
pericoloso, in quanto volutamente tendente alla distruzione e al disfacimento
della persona, non è preso ancora abbastanza sul serio. La disputa che Platone
ha condotto tra la musica dionisiaca e quella apollinea non è la nostra,
poiché Apollo non è Cristo. Ma la questione che egli ha posto ci tocca molto da
vicino. In una forma che la generazione a noi precedente non poteva neppure
immaginare la musica è diventata oggi il veicolo determinante di una
controreligione e pertanto il palcoscenico della divisione degli spiriti. Cercando
la salvezza mediante la liberazione dalla personalità e dalla sua
responsabilità, la musica Rock da un lato si inserisce perfettamente nelle idee
di libertà anarchiche che oggi in occidente dominano più che non in oriente; ma
proprio per questo si oppone radicalmente alla concezione cristiana della
redenzione e della libertà, è anzi la sua perfetta contraddizione. Perciò non
per motivi estetici, non per ostinazione restaurativa, non per immobilismo storico,
bensì per motivi antropologici di fondo, questo tipo di musica deve essere
esclusa dalla Chiesa.
Potremmo concretizzare ulteriormente la nostra questione, se continuassimo ad analizzare la base antropologica di vari tipi di musica.
Abbiamo della musica d’agitazione che anima l’uomo in vista di vari fini collettivi. Esiste della musica sensuale, che introduce l’uomo nella sfera erotica oppure tende in altra maniera essenzialmente a sensazioni di piacere sensibili. Esiste della semplice musica leggera che non vuole dire nulla, bensì rompere soltanto il peso del silenzio. Esiste della musica razionalistica in cui i suoni servono soltanto a delle costruzioni razionali, ma non avviene una penetrazione reale dello spirito e dei sensi. Parecchi canti inconsistenti su testi catechetici, parecchi canti moderni costruiti in commissioni, sarebbero probabilmente da classificare in questo settore.
La musica invece adeguata alla liturgia di Colui che si è incarnato ed è stato elevato sulla croce, vive in forza di un’altra sintesi molto più grande e ampia di spirito, intuizione e suono. Si può dire che la musica occidentale dal canto gregoriano attraverso la musica delle cattedrali e la grande polifonia, la musica del rinascimento e del barocco fino a Bruckner e oltre proviene dalla ricchezza intrinseca di questa sintesi e l’ha sviluppata in un grande numero di possibilità. Questa grandezza esiste soltanto qui, perché poteva nascere soltanto dal fondamento antropologico che collegava elementi spirituali e profani in un’ultima unità umana. Essa si dissolve nella misura in cui svanisce tale antropologia. La grandezza di questa musica rappresenta per me la verifica più immediata e più evidente dell’immagine cristiana dell’uomo e ella concezione cristiana della redenzione, che la storia ci offre. Colui he da essa è realmente colpito, sa in qualche modo, dal suo intimo, che la fede è vera, pur dovendo fare ancora molti passi per completare questa intuizione a livello razionale e volitivo.
Ciò significa che la musica liturgica della Chiesa deve soggiacere a quell’integrazione dell’essere umano, che ci si presenta nella realtà di fede dell’incarnazione. Questa redenzione richiede più fatica che non quella dell’ebrezza. Ma questa fatica è lo sforzo della verità stessa. Da un lato deve integrare i sensi nell’intimo dello spirito, deve corrispondere all’impulso del Sursum corda. Non vuole, tuttavia, la pura spiritualizzazione, bensì l’integrazione di sensi e spirito, di modo che ambedue insieme diventino la persona. Lo spirito non si avvilisce ricevendo in sé i sensi, bensì soltanto questa unione gli apporta tutta la ricchezza del creato. E i sensi non vengono privati della loro realtà, se vi penetra lo spirito, bensì soltanto in questo modo possono partecipare alla sua dimensione di infinito. Ogni piacere sensuale è strettamente limitato e, in ultima analisi, non suscettibile di accrescimento, perché l’atto dei sensi non può oltrepassare una determinata misura. Colui che da esso si aspetta la redenzione, viene deluso, «frustrato” — come si direbbe oggi —. Ma essendo integrati nello spirito, i sensi acquistano una nuova profondità e penetrano nell’infinito dell’avventura spirituale. Là solo essi si realizzano totalmente. Ciò però presuppone che anche lo spirito non rimanga chiuso. La musica della fede cerca nel Sursurn corda l’integrazione dell’uomo, ma non trova questa integrazione in se stessa, bensì soltanto nell’autosuperamento, nell’intimo della Parola incarnata. La musica sacrale, ancorata in questa struttura di movimento, diventa purificazione dell’uomo, la sua ascensione. Non dobbiamo però dimenticare che questa musica non è l’opera di un momento, bensì partecipazione a una storia e suppone la comunione dal singolo individuo con le intuizioni fondamentali di questa storia. Così si esprime proprio in essa anche l’ingresso nella storia della fede, l’essere tutti membra del corpo di Cristo. Dietro di sé lascia gioia, una modalità più alta di estasi, che non cancella la persona, bensì la unisce e nello stesso tempo la libera. Ci fa presentire ciò che è la libertà, che non distrugge, bensì raccoglie e purifica.
b) Rilievi sulla situazione attuale
Al musico ora si presenta naturalmente un problema: Come si ottiene questo? In fondo, le grandi opere della musica sacra possono sempre soltanto essere donate, perché vi è in gioco quel superamento di se stessi di cui l’uomo da solo non è capace, mentre il delirio dei sensi, grazie ai noti meccanismi dell’ebbrezza, si può produrre. Il fare finisce dove inizia ciò che è veramente grande. E’ questa linea di demarcazione che per prima dobbiamo vedere e riconoscere. Pertanto all’inizio della grande musica sacrale sta necessariamente il tremore, l’accettazione, l’umiltà che è disposta a servire nella partecipazione a ciò che di grande è già stato. Soltanto colui che almeno fondamentalmente vive in base alla struttura interiore di questa immagine di uomo, è in grado di creare anche la musica ad essa pertinente.
La Chiesa ha dato altre due indicazioni. La musica liturgica deve, nel suo carattere intimo, corrispondere alle esigenze dei grandi testi liturgici: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Ciò non vuoi dire che debba essere soltanto musica per un testo; già l’ho detto. Ma essa trova nell’orientamento interno di questi testi una indicazione per la sua propria espressione. La seconda indicazione è il rimando al canto gregoriano e a Palestrina. Questo rimando non significa però che tutta la musica della Chiesa debba essere imitazione di questa musica. Su questo punto, di fatto, vi sono state interpretazioni anguste nel rinnovamento della musica sacra nel secolo scorso, e anche nei documenti pontifici basati su di esso. Interpretando in modo giusto, si vuole così semplicemente dire che sono dati degli esempi che possono servire da orientamento. Non si può però stabilire in precedenza ciò che può nascere dall’assimilazione creativa di un tale orientamento.
Rimane ancora aperta questa domanda: possiamo, parlando umanamente, attenderci in questo campo ancora nuove possibilità creative? E in che modo ciò potrà avvenire? La risposta alla prima domanda è facile; cioè se questa immagine dell’uomo è inesauribile, al contrario di quell’altra, essa apre sempre delle nuove possibilità, anche all’espressione artistica, e ciò tanto più quanto più vivamente determina lo spirito di un’epoca.
Ma proprio qui sta la difficoltà per la seconda questione. Nel nostro tempo la fede ha perduto molta della sua capacità di dare un’impronta alla realtà della vita pubblica. Come potrà essere creativa? Non è stata emarginata dappertutto come semplice sottocultura? Non di meno occorre dire che, almeno a quanto sembra, in Africa, in Asia e nell’America Latina ci troviamo davanti a una nuova fioritura della fede, da cui potrebbero anche scaturire nuove forme di cultura.
Ma anche nel mondo occidentale il discorso della sottocultura non dovrebbe farci paura. Nella crisi culturale che viviamo, una nuova purificazione e unificazione culturale può svilupparsi soltanto da isole di raccoglimento spirituale. Là ove in comunità vive vi sono nuovi risvegli della fede, si vede anche già formarsi una nuova cultura cristiana; si vede come l’esperienza comunitaria sia fonte di ispirazione e apra vie che prima non potevamo vedere, Del resto, F. Doppelbauer ha giustamente fatto notare che la musica liturgica ha spesso e non a caso il carattere dell’opera tardiva, presuppone maturazioni precedenti. Inoltre è importante che ci siano gli spazi preliminari della religiosità popolare e della sua musica, come della musica religiosa in senso lato, che devono essere sempre in fecondo scambio con la musica liturgica. Da un lato esse vengono fecondate e purificate da questa, ma dall’altro lato preparano anche nuovi tipi di musica liturgica. Dalle loro forme più libere potrà maturare ciò che potrà entrare nel patrimonio della liturgia di tutta la Chiesa. Questo è poi anche l’ambito ove il gruppo può cimentare la sua creatività, nella speranza che ne nasca ciò che in futuro potrà fare parte del tutto.
Osservazione conclusiva: liturgia, musica e cosmo
Vorrei concludere le mie considerazioni con una bella parola di Mahatma Gandhi che ho trovato poco tempo fa su un calendario. Gandhi evidenzia tre spazi di vita del cosmo e mostra come ognuno di questi tre spazi vitali offra anche un proprio modo di essere. Nel mare vivono i pesci e tacciono. Gli animali sulla terra gridano, ma gli uccelli, il cui spazio vitale è il cielo, cantano. Del mare è proprio il tacere, della terra il gridare e del cielo il cantare. L’uomo però partecipa di tutti e tre: egli porta in sé la profondità del mare, il peso della terra e l’altezza del cielo; perciò sono sue anche tutte e tre le proprietà: il tacere, il gridare e il cantare. Oggi vediamo che all’uomo privo di trascendenza rimane solo il gridare, perché vuole essere soltanto terra e cerca di far diventare sua terra anche il cielo e la profondità del mare. La vera liturgia, la liturgia della comunione dei santi, gli restituisce la sua totalità. Gli insegna di nuovo il tacere e il cantare, aprendogli la profondità del mare e insegnandogli a volare, l’essere dell’angelo; elevando il suo cuore fa risuonare di nuovo quel canto che in lui si era come assopito. Anzi, possiamo dire persino che la vera liturgia si riconosce proprio dal fatto che essa ci libera dall’agire comune e ci restituisce la profondità e l’altezza, il silenzio e il canto. La vera liturgia si riconosce dal fatto che è cosmica, non su misura di un gruppo. Essa canta con gli angeli. Essa tace con la profondità dell’universo in attesa. E così essa redime la terra.
Joseph Card. Ratzinger