|
Amedeo Ferri è nato
a Belforte del Chienti, abita a Caldarola e trascorre dei periodi a
Roma. É tra gli ultimi veterani della seconda guerra mondiale e reduci
dalla prigionia a voler ricordare e poter raccontare le sue
vicissitudini che i giovani considerano ormai “d’altri tempi”. Vicende
umane che lo hanno visto, suo malgrado, vittima, ma anche protagonista
di episodi d’altruismo. Io ritengo che queste Storie siano meritevoli di
attenzione anche per chi viaggia da turista.
Il padre era un mezzadro, fiero repubblicano ed avverso alla dittatura.
Per non aver voluto firmare una petizione, lo stesso giorno della
nascita di Amedeo Ferri (il 22 novembre 1923) subì la purga con il sale
inglese. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il giovane Ferri
viveva a Caldarola; gli giunse qui la cartolina di leva e il 9 gennaio
1943 dovette partire dal Distretto Militare di Macerata per il “Deposito
Misto Truppe Egeo” di Barletta, aveva compiuto da poco 19 anni. Qui fu
assegnato al 9° Reggimento fanteria della divisione Regina con
destinazione ignota; l’equipaggiamento (per modo di dire) era per la
Russia. In ogni caso con le scarpe dalle suole di cartone non sarebbero
arrivati lontano: è noto che il vestiario e l’equipaggiamento dei
soldati italiani erano carenti da tutti i punti di vista.

- - -
Amedeo Ferri, in treno, da Barletta via Trieste e Lubiana, giunse a
Lárissa, antica città della Tessaglia (Grecia orientale). Poiché in zona
i partigiani greci avevano fatto saltare tre ponti ferroviari, il
contingente fu dirottato verso Rodi, Lero e Cefalonia. Da Lárissa
giunsero al Pireo, porto a 10 km a sud di Atene, dove sostarono per un
mese. Verso aprile-maggio del 1943 il contingente fu imbarcato per le
isole di Lero e Rodi (reparti della div. Regina presidiavano anche
l’isola di Coo). Perla del Dodecanneso, isola del sole o delle rose,
questi sono alcuni dei nomi che, sin dall’antichità, decantano le
splendide caratteristiche paesaggistiche di Rodi, la più grande isola
del Dodecanneso (colonia italiana dal 1912 al 1943).
Amedeo aveva un buon carattere, era il più giovane della Compagnia e la
mascotte, a volte ne approfittava per qualche scherzo. La giovane età
non gli impedì di notare i litigi che avvenivano nelle fila davanti alle
case di tolleranza dell’isola tra i militari del Regio Esercito e i
volontari della Milizia Nazionale Sicurezza Nazionale le “camicie nere”:
tra di loro non correva buon sangue. La sede del 3° Battaglione era a
Salaco. Durante le frequenti marce "accelerate" di esercitazione verso
la costa, intese a tenerli allenati per un eventuale sbarco degli
Inglesi, Amedeo e altri a volte si dissetarono con l’acqua delle pozze.
A causa della malaria fu ricoverato all’ospedale da campo di Campochiaro.
Frequenti furono i bombardamenti di aerei britannici. Nonostante ciò, il
clima era ottimo, i pochi mesi trascorsero in fretta; di certo il peggio
doveva ancora venire.
I Greci, i Turchi ed anche gli Italiani dell’isola erano d’accordo nel
sostenere che da quando era stato governatore Cesare Maria De Vecchi
(dal 2 dicembre 1936 al 9 dicembre 1940), la situazione locale era
notevolmente peggiorata. Era terminata la tranquilla convivenza tra le
varie etnie dell’isola e regnava il malcontento generale. Forse qualche
militare italiano se ne sarà anche accorto, ma i contingenti tedeschi
della divisione corazzata Sturm Rhodos del gen. U. Kleemann, fornita di
carri Tigre affluiti nei primi mesi del 1943, erano aumentati ed avevano
assunto via via il controllo dei più importanti punti strategici di
Rodi: nodi stradali e due aeroporti. Il 25 luglio del 1943 quando il
duce fu messo in minoranza e fatto arrestare dal Re un sottotenente
della milizia, preso dal panico, decise di cedere la divisa; Amedeo per
scherzo la indossò e cedette la sua all’ufficiale. Lo incontrò il
colonnello che gli disse bonariamente: «Ferri anche stavolta ne hai
combinata una delle tue!».
Giunse presto il fatidico 8 settembre dell’armistizio che fu fatale ai
militari italiani. Alle 19,30 venne ricevuto il comunicato radio di
Badoglio sull’armistizio che colse impreparati ufficiali e soldati
italiani. I teutonici, invece, avendo previsto l’evento (piano Achse),
anche qui come a Cefalonia, non persero tempo a riflettere, sopraffecero
subito gli ex alleati. L’indecisione dell’ammiraglio Inigo Campioni,
governatore dell’isola e comandante delle forze armate dell’Egeo, fu
disastrosa; il promesso aiuto inglese non fu efficace. Dopo poco più di
due giorni di resistenza, che costarono 143 morti tra ufficiali e
soldati e 300 feriti, sopraggiunse l’ordine di resa; alcuni soldati, con
le lacrime agli occhi, spezzarono i calci dei fucili prima di
ammucchiarli sulla catasta! Fu così che 40 mila italiani dovettero
arrendersi a 7 mila tedeschi. Numerosi italiani, sottrattisi alla
cattura, continuarono nella clandestinità la lotta ai tedeschi.

Verso l’11 settembre il reparto di Amedeo fu disarmato a Pisito (Psinthos),
sede del comando di Reggimento. I tedeschi evacuarono subito gli
ufficiali italiani per evitare che scatenassero la rivolta tra le
truppe. I soldati furono radunati in campi di prigionia con guardie
armate. Il tentativo di “resistere senza sparare”, voluto
dall’Ammiraglio Campioni, fu fatale: messo agli arresti, portato nei
campi di concentramento polacchi, fu infine fucilato in Italia nel 1944
con Mascherpa. Al contrario nell’isola di Lero, importante base per
sommergibili, i marinai e i fanti della stessa divisione Regina di
presidio opposero un’accanita resistenza ai nazisti fino alla mezzanotte
del 16 novembre 1943. Amedeo e gli altri soldati del suo reparto, dopo
circa 50 giorni, furono trasferiti in nave al Pireo. Qui vennero a
sapere che il 23 settembre precedente, la nave mercantile italiana
Donizetti, era stata silurata dai cacciatorpediniere britannici, colando
a picco a largo di Prassonissi con un carico 1.825 uomini prigionieri.
Raggiunto il Pireo, gli italiani provenienti da Rodi si trovavano nei
pressi dei magazzini portuali, quando le sirene d’allarme annunciarono
un bombardamento aeronavale; gli italiani furono lasciati liberi di
mettersi in salvo con l’obbligo di radunarsi a “cessata esigenza”.
Ognuno di loro sciamò per proprio conto; il giovane Amedeo Ferri,
vagando, raggiunse addirittura il centro d’Atene fin sotto l’Acropoli.
La fame cominciò a farsi sentire, fu costretto a bussare in più porte in
cerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Una donna greca, il cui
marito era morto sul fronte italiano e il figlio era prigioniero dei
tedeschi, si commosse e, non avendo cibo, gli regalò un lenzuolo, dalla
cui vendita avrebbe potuto ricavare qualcosa. Dopo due, tre giorni quasi
tutti si ritrovarono dove erano stati lasciati liberi.
Oggi, conoscendo i successivi sviluppi, non è facile comprendere e
condividere la loro scelta, ma Amedeo sostiene che fuggire in un paese
straniero, occupato militarmente, non era davvero facile, inoltre tutti
speravano in un’imminente fine del conflitto. Restarono al Pireo per
qualche settimana e poi furono trasferiti in varie località dei Balcani
su carri bestiame. Ospiti indesiderati quali zecche e pidocchi
ovviamente non pagavano il biglietto: essi insieme alla mancanza
d’igiene erano tra le principali cause di malattie. A Belgrado, nei
pressi della confluenza del fiume Sava con il Danubio, aveva sede un
campo di smistamento (Dulac 171 o 172) per prigionieri di varie
nazionalità: Italiani, Bulgari, Polacchi, Rumeni, Greci, Russi, ecc. Il
campo fu confuso dagli Alleati per un acquartieramento di truppe
tedesche. I bombardieri americani, con base a Foggia, iniziarono un
lungo bombardamento di 5-6 ore che provocò centinaia di morti tra i
prigionieri. Uno spezzone colpì all’addome l’amico Giovanni Rapaccioni
di Pallorito (San Severino Marche). Amedeo lo soccorse prontamente e
chiamò subito un ufficiale medico tedesco, ma questi gli comunicò
brevemente che il suo compagno d’armi non aveva nessuna possibilità di
sopravvivenza e gli disse: «Prendi la fede a portala ai suoi familiari».
Non la prese, ma l’amico lasciò la moglie e due bambine.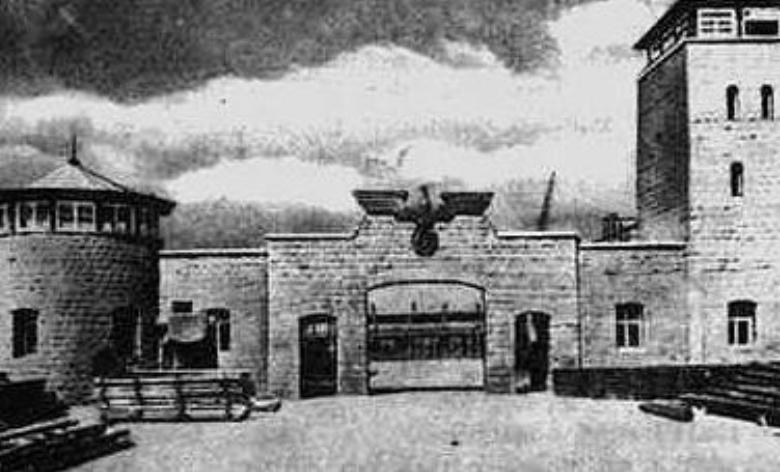
Dopo la quarantena, furono trasferiti in un’altra località sulle alture
di Belgrado; rimasero accampati in una grandissima fornace e dormirono
sotto le pensiline d’asciugatura dei mattoni. Una partigiana
montenegrina di 18 anni fu catturata e portata nel campo, i tedeschi non
si erano accorti che la ragazza sotto i vestiti aveva nascosto una
pistola. Alla prima occasione favorevole la giovane cercò di uccidere il
comandante del campo, ma riuscì solo a ferirlo di striscio ad una
spalla. Presa come esempio, fu fucilata alla presenza di tutti; la
giovane morì coraggiosamente al grido di “Viva la libertà”. A causa
della forte sorveglianza dei campi di prigionia, i pur attivi partigiani
slavi non tentarono mai di liberarli. Nell’ala a loro riservata, i
Russi, un giorno riuscirono a far saltare con l’esplosivo un tratto di
recinzione, suonarono le sirene dell’allarme ma diversi prigionieri
riuscirono a svignarsela. I Russi, una volta fuggiti, difficilmente
venivano ripresi, sia per la buona conoscenza della lingua che per il
decisivo aiuto fornito dalle popolazioni slave. Nel campo i forzati più
deboli si appartavano, non avevano più nemmeno la forza di andare a
prendere il rancio, Amedeo, quando poteva, provvedeva a portare loro
qualcosa con la gavetta. In quel tunnel di disperazione ogni tanto
trapelava qualche barlume di luce: c’erano anche degli austriaci
antinazisti e qualche tedesco che non condivideva il duro trattamento
riservato ai prigionieri. Un sottufficiale dell’esercito tedesco, che
distribuiva il rancio, consigliò più volte ad Amedeo di trovarsi una
gavetta più capiente per ricevere una maggiore razione. Al costo di 500
dinari, riuscì a trovare una gavetta degli Alpini che conteneva oltre il
doppio della sua.
In seguito Amedeo fu prelevato, insieme con altri 150 prigionieri,
dall’organizzazione Todt per scavare camminamenti, trincee, per
costruire ferrovie e oleodotti fino ai monti Carpazi. L’organizzazione
Todt, un servizio del Genio della Wehrmacht, aveva reclutato con forza
nei paesi europei occupati e presi dai campi di prigionia ben 14 milioni
di lavoratori (dal 1941 solo un quinto erano tedeschi). Orari
massacranti, ferrea disciplina e tremende condizioni di vita, erano la
ricetta di Albert Speer, l’architetto di Hitler, che, grazie a questa
mobilitazione forzata, riuscì a prolungare di almeno due anni la guerra,
causando ulteriori milioni di morti. In Grecia nel 1942 la Todt aveva
costruito la rotabile asfaltata Atene-Salonicco.
Sui monti Carpazi l’inverno del 1944 raggiunse temperature di - 40° C. I
nostri forzati si appoggiarono su fattorie semi abbandonate e vi
restarono per circa 40 giorni. Erano fortunati quando riuscivano a
dormire sulla paglia di qualche stalla. Ai confini orientali
dell’Ungheria, Amedeo fu vittima di un principio di congelamento alle
gambe. Fu salvato dal decisivo intervento di alcuni collaboratori russi
che lo presero di peso nudo e lo deposero sulla neve frizionandolo e
facendogli così riprendere la circolazione del sangue a mani e gambe.
In quella regione, una mattina d’inizio ‘44, Amedeo con alcuni compagni
si allontanò dalla fattoria per recarsi alla ricerca di cibo, senza aver
chiesto il dovuto permesso. Riuscirono a trovare due sacchi di pane,
alcune mele e un po’ di lardo. Al loro rientro tutto questo ben di Dio
fu gettato dai tedeschi nel fango e calpestato. Inoltre Amedeo e il suo
amico brigadiere di Chiavari della Guardia di Finanza furono frustati a
sangue. Una donna della fattoria fece poi loro degli impacchi con acqua
e sale. Il lavoro forzato non proseguiva secondo le aspettative tedesche
perché i prigionieri cercavano di rallentarlo e contrastarlo per quanto
possibile. Questo finché giunsero le nuove leve delle SS (classi 1926-
’27-17 anni) dopodichè il controllo divenne ancora più insopportabile.
La Pasqua del penultimo anno di guerra (9 aprile 1944) trovò Amedeo e
gli altri accampati in una fattoria abbandonata vicino a Nova (provincia
di Zala) in Ungheria, un paese nei pressi del lago Balaton.
 In quel
periodo stavano costruendo degli snodi ferroviari. Un pomeriggio,
accompagnato da un anziano austriaco dell’organizzazione Todt, di
ritorno dal lavoro, malato, per recarsi alla visita medica dovette
percorrere 6-7 chilometri sulla neve. Nell’infermeria, che aveva sede in
un vecchio teatrino, fu visitato dal dr Secondino Tricarico di Troia
(FG), ufficiale medico, anche lui prigioniero. Il buon sanitario gli
diagnosticò una bronchite con pleurite, ma aveva pochissimi farmaci.
Un’aspirina, probabilmente scaduta, gli causò un’intossicazione.
L’anziano austriaco ad un certo punto non fu più in grado di
sorreggerlo; trovò una zingara nascosta in un tugurio nella boscaglia e
lo affidò a lei. La donna si prese amorevole cura di Amedeo: lo riscaldò
con il focolare, lo rifocillò con bevande calde e lo coprì con degli
stracci. Grazie alla provvidenza divina, la notte di riposo al caldo gli
fece bene. Il mattino seguente ritornò l’austriaco, accompagnato da un
commilitone e lo trasportarono con due bastoni e un telo, a mo’ di una
rudimentale slitta indiana. In quel
periodo stavano costruendo degli snodi ferroviari. Un pomeriggio,
accompagnato da un anziano austriaco dell’organizzazione Todt, di
ritorno dal lavoro, malato, per recarsi alla visita medica dovette
percorrere 6-7 chilometri sulla neve. Nell’infermeria, che aveva sede in
un vecchio teatrino, fu visitato dal dr Secondino Tricarico di Troia
(FG), ufficiale medico, anche lui prigioniero. Il buon sanitario gli
diagnosticò una bronchite con pleurite, ma aveva pochissimi farmaci.
Un’aspirina, probabilmente scaduta, gli causò un’intossicazione.
L’anziano austriaco ad un certo punto non fu più in grado di
sorreggerlo; trovò una zingara nascosta in un tugurio nella boscaglia e
lo affidò a lei. La donna si prese amorevole cura di Amedeo: lo riscaldò
con il focolare, lo rifocillò con bevande calde e lo coprì con degli
stracci. Grazie alla provvidenza divina, la notte di riposo al caldo gli
fece bene. Il mattino seguente ritornò l’austriaco, accompagnato da un
commilitone e lo trasportarono con due bastoni e un telo, a mo’ di una
rudimentale slitta indiana.
Il prigioniero Ferri, risanato e ritemprato, era di nuovo al lavoro in
un centro dove si riparavano ponti, ferrovie e oleodotti. Ritornato poi
nella capitale serba fu messo a riparare scarpe insieme con altri otto
calzolai, vi erano anche sarti e barbieri. La baracca aveva sede a
fianco del reparto disinfezione. Vedeva passare i nuovi arrivi del campo
seminudi nonostante il freddo intenso, tra loro vi erano anche i
partigiani delle brigate “Garibaldi” (aveva anche tentato di
raggiungerli una volta ma era stato preso). Neanche le privazioni e le
sofferenze erano riuscite a far diventare Amedeo indifferente e
insensibile: solidarizzava con i feriti e i malati. Un giorno, mosso a
compassione, si appropriò di un pacco di pastrani militari francesi per
riparare dal freddo quei prigionieri. Il parapiglia della distribuzione
fece accorrere i tedeschi che decisero di fucilare Ferri. Si salvò solo
grazie all’intermediazione di un colonnello di Venezia, collaboratore
dei nazisti. Il 20 giugno del 1944 a Belgrado si diffuse la notizia
dell’attentato a Hitler, creando gran confusione e attesa di libertà
deluse in breve. Amedeo cercò di approfittarne ritentando la fuga, ma
dopo soli 3-4 giorni fu ripreso dai Cetnici, che lo riconsegnarono allo
stesso campo. I Cetnici (il cui nome deriva da un’antica organizzazione
militare per la lotta contro i Turchi) del col. Mihailović erano
nazionalisti serbi fedeli al re, dapprima alleati degli Italiani poi dei
tedeschi quando dopo l’8 settembre vennero scaricat ida Londra a favore
della Leadership comunista di Tito che non prevedeva un regno. In questo
panorama politico molto variegato si svolse la sanguinosa guerra di
liberazione iugoslava che si lasciò dietro un seguito di odi etnici,
razziali e religiosi, mai sopiti. Josip Broz detto Tito sconfisse sì,
per ora, i vari nazionalismi ma la guerra costò la vita di quasi 2
milioni di iugoslavi più diversi milioni di senza tetto: alla fine
rimase un paese in rovina!
Anche a causa dell’ultima fuga, Amedeo fu spedito al campo di
concentramento di Mauthausen in Austria. Qui la fortuna volle che,
durante la distribuzione del mestolo di brodaglia, fu riconosciuto
dall’ufficiale medico che era stato con lui al 3° Battaglione di stanza
a Rodi. Nel lager avveniva lo sfruttamento intensivo dei deportati
utilizzati come schiavi in una vicina cava di granito. Oggi si sa che
tra le varie uccisioni (che voglio risparmiare ai lettori), alcuni
deportati furono semplicemente bagnati e lasciati morire al gelo del
rigido inverno austriaco. Amedeo e il suo gruppo di prigionieri, per una
dozzina di giorni, dovettero dormire seduti perché non c’era spazio
sufficiente per le brande.
 Dopo lo sgombero di due baracche occupate dai
Rom (zingari) e dai testimoni di Geova, lo spazio aumentò. A qualche
centinaio di metri vi era una ciminiera che a volte emanava un lezzo
mortale. Loro non erano a conoscenza di ciò che accadeva in quel luogo;
oggi sappiamo bene cosa significava “sgombero”! Dei 200.000 deportati in
questo lager solo la metà sopravvisse. Fu merito dell’ufficiale medico
italiano se Amedeo, anziché finire in una doccia a gas, fu aggregato ad
una colonna di forzati diretta nuovamente in Jugoslavia ad una miniera
non lontana da Cettigne (Cetinje), antica capitale del regno
montenegrino. Nel Montenegro operavano unità partigiane del maresciallo
Tito e della divisione italiana partigiana “Garibaldi”. Forse si
trattava di una miniera di bauxite, l’alluminio era di vitale importanza
per la macchina bellica tedesca.. L’ingegnere tedesco addetto che passò
in rassegna i nuovi arrivati, osservando Amedeo commentò sarcastico: «Mi
hanno mandato dei cadaveri?». Mesi di lavoro forzato, denutrizione,
freddo e malattie avevano ridotto Amedeo Ferri al fantasma di se stesso.
Lo dichiararono non idoneo al lavoro in miniera e insieme ad altri
cinque fu aggregato a delle colonne di prigionieri dirette nelle
retrovie. Ricorda che durante questa dura marcia percorse 50-60 km al
giorno, anche sotto la pioggia battente. In lontananza sibilavano i
razzi Katiuscia russi (chiamati anche “gli organi di Stalin” in uso ai
partigiani di Tito) che martellavano le truppe tedesche in ritirata. Tra
i prigionieri, Amedeo incontrò due compaesami: Mario Pieroni e Carlo
Sparvoli. Durante la terribile marcia il giovane Ferri cadde sul margine
della strada sfinito dalla fame, fu soccorso e si riprese grazie ad un
tozzo di pane, offertogli dai due caldarolesi, avuto in cambio delle
fedi. Era il 31 marzo 1945, sabato santo dell’ultimo anno di guerra.
Amedeo Ferri si trovava con una colonna di prigionieri in ritirata a
circa 30 km da Wiener Neustadt in Austria dove stavano giungendo le
avanguardie russe del generale Tolbuchin. Il nostro prigioniero era allo
stremo delle forze e quindi poco controllato, decise così di tentare
nuovamente la fuga. Si camminava a fianco di un fiumiciattolo e ogni ora
si faceva sosta. Avrebbe provato da solo ad attraversarlo all’imbrunire
e, nel caso non fosse ritornato, altri dieci prigionieri l’avrebbero
seguito. Stava sopraggiungendo la notte, quando si allontanò di
soppiatto, ma nell’attraversare la vegetazione fluviale produsse dei
rumori e i tedeschi se ne accorsero. Si salvò grazie ad un brigadiere
napoletano della Guardia di Finanza, impiegato come aiuto interprete. I
tedeschi gli chiesero di tradurre: «Digli di ritornare che non gli
facciamo nulla», ma il coraggioso brigadiere urlò: «Hanno lasciato i
cani, cerca un posto sicuro e non farti trovare!». Guadagnata con
notevole ansia l’agognata libertà, non fu però facile mantenerla. Rimase
nascosto per due giorni in una pineta tra i ginepri e i rami dei pini
spezzati dalle bombe, finché la sete e la fame cominciarono a farsi
sentire. Memore delle precedenti catture, evitò accuratamente i luoghi
abitati e si avvicinò con estrema cautela alla carrozzabile. Vide
transitare un plotone di guastatori tedeschi in ritirata. Ad un
austriaco di passaggio chiese se erano arrivati i russi, l’uomo rispose
di no. Transitò poi un soldato russo a cavallo che, credendolo un
tedesco, gli puntò il mitra, riuscì con qualche parola e gesti a fargli
capire che era un prigioniero italiano fuggito dai nazisti. Il sovietico
saltò giù da cavallo, lo abbracciò, gli diede dei viveri di conforto e
gli raccomandò vivamente di non bere acqua che poteva essere stata
avvelenata. Non ricorda il grado del benefattore, perché sulle divise
dell’Armata Rossa era assai difficile distinguerli. Si rimise in cammino
di buona lena verso occidente e dopo qualche ora vide transitare una
divisione corazzata russa diretta a Vienna. Incontrò un polacco e un
greco, pure loro prigionieri e poco dopo due soldati russi, tornando
verso le retrovie, li portarono al loro comando che aveva sede in una
pineta. I russi erano assai diffidenti e prevenuti nei confronti degli
italiani. Dopo un lungo, pressante interrogatorio, quasi un lavaggio del
cervello, lo fecero salire su di un piccolo mezzo blindato e lo
portarono in un’infermeria dove lo pesarono: 43 chili; era rimasto pelle
e ossa. Da lì, a bordo di camion con feriti lievi, lo portarono a
Budapest e lo abbandonarono in città solo, dove trascorse quasi cinque
mesi. Dopo lo sgombero di due baracche occupate dai
Rom (zingari) e dai testimoni di Geova, lo spazio aumentò. A qualche
centinaio di metri vi era una ciminiera che a volte emanava un lezzo
mortale. Loro non erano a conoscenza di ciò che accadeva in quel luogo;
oggi sappiamo bene cosa significava “sgombero”! Dei 200.000 deportati in
questo lager solo la metà sopravvisse. Fu merito dell’ufficiale medico
italiano se Amedeo, anziché finire in una doccia a gas, fu aggregato ad
una colonna di forzati diretta nuovamente in Jugoslavia ad una miniera
non lontana da Cettigne (Cetinje), antica capitale del regno
montenegrino. Nel Montenegro operavano unità partigiane del maresciallo
Tito e della divisione italiana partigiana “Garibaldi”. Forse si
trattava di una miniera di bauxite, l’alluminio era di vitale importanza
per la macchina bellica tedesca.. L’ingegnere tedesco addetto che passò
in rassegna i nuovi arrivati, osservando Amedeo commentò sarcastico: «Mi
hanno mandato dei cadaveri?». Mesi di lavoro forzato, denutrizione,
freddo e malattie avevano ridotto Amedeo Ferri al fantasma di se stesso.
Lo dichiararono non idoneo al lavoro in miniera e insieme ad altri
cinque fu aggregato a delle colonne di prigionieri dirette nelle
retrovie. Ricorda che durante questa dura marcia percorse 50-60 km al
giorno, anche sotto la pioggia battente. In lontananza sibilavano i
razzi Katiuscia russi (chiamati anche “gli organi di Stalin” in uso ai
partigiani di Tito) che martellavano le truppe tedesche in ritirata. Tra
i prigionieri, Amedeo incontrò due compaesami: Mario Pieroni e Carlo
Sparvoli. Durante la terribile marcia il giovane Ferri cadde sul margine
della strada sfinito dalla fame, fu soccorso e si riprese grazie ad un
tozzo di pane, offertogli dai due caldarolesi, avuto in cambio delle
fedi. Era il 31 marzo 1945, sabato santo dell’ultimo anno di guerra.
Amedeo Ferri si trovava con una colonna di prigionieri in ritirata a
circa 30 km da Wiener Neustadt in Austria dove stavano giungendo le
avanguardie russe del generale Tolbuchin. Il nostro prigioniero era allo
stremo delle forze e quindi poco controllato, decise così di tentare
nuovamente la fuga. Si camminava a fianco di un fiumiciattolo e ogni ora
si faceva sosta. Avrebbe provato da solo ad attraversarlo all’imbrunire
e, nel caso non fosse ritornato, altri dieci prigionieri l’avrebbero
seguito. Stava sopraggiungendo la notte, quando si allontanò di
soppiatto, ma nell’attraversare la vegetazione fluviale produsse dei
rumori e i tedeschi se ne accorsero. Si salvò grazie ad un brigadiere
napoletano della Guardia di Finanza, impiegato come aiuto interprete. I
tedeschi gli chiesero di tradurre: «Digli di ritornare che non gli
facciamo nulla», ma il coraggioso brigadiere urlò: «Hanno lasciato i
cani, cerca un posto sicuro e non farti trovare!». Guadagnata con
notevole ansia l’agognata libertà, non fu però facile mantenerla. Rimase
nascosto per due giorni in una pineta tra i ginepri e i rami dei pini
spezzati dalle bombe, finché la sete e la fame cominciarono a farsi
sentire. Memore delle precedenti catture, evitò accuratamente i luoghi
abitati e si avvicinò con estrema cautela alla carrozzabile. Vide
transitare un plotone di guastatori tedeschi in ritirata. Ad un
austriaco di passaggio chiese se erano arrivati i russi, l’uomo rispose
di no. Transitò poi un soldato russo a cavallo che, credendolo un
tedesco, gli puntò il mitra, riuscì con qualche parola e gesti a fargli
capire che era un prigioniero italiano fuggito dai nazisti. Il sovietico
saltò giù da cavallo, lo abbracciò, gli diede dei viveri di conforto e
gli raccomandò vivamente di non bere acqua che poteva essere stata
avvelenata. Non ricorda il grado del benefattore, perché sulle divise
dell’Armata Rossa era assai difficile distinguerli. Si rimise in cammino
di buona lena verso occidente e dopo qualche ora vide transitare una
divisione corazzata russa diretta a Vienna. Incontrò un polacco e un
greco, pure loro prigionieri e poco dopo due soldati russi, tornando
verso le retrovie, li portarono al loro comando che aveva sede in una
pineta. I russi erano assai diffidenti e prevenuti nei confronti degli
italiani. Dopo un lungo, pressante interrogatorio, quasi un lavaggio del
cervello, lo fecero salire su di un piccolo mezzo blindato e lo
portarono in un’infermeria dove lo pesarono: 43 chili; era rimasto pelle
e ossa. Da lì, a bordo di camion con feriti lievi, lo portarono a
Budapest e lo abbandonarono in città solo, dove trascorse quasi cinque
mesi.
I russi, considerato lo sbandamento e i furti perpetrati in città dai
reduci, dagli sfollati e dagli ex prigionieri, diramarono un bando che
comparve anche sui quotidiani: in sostanza chi non rientrava nei campi
di raccolta veniva denunciato al tribunale militare russo e poi spedito
in Siberia. Era vivamente consigliabile non farsi prendere dalla GPU (la
polizia segreta russa). Amedeo entrò in un campo di raccolta di tutte le
nazionalità, già sede dell’accademia militare ungherese. Fu curato da
una dottoressa russa che aveva studiato a Padova, la quale gli
diagnosticò una tubercolosi, acuita dal deperimento e dal freddo.
 Il
medico prese a benvolere Amedeo e gli confidò che, se non avesse reagito
alle cure, avrebbe dovuto inviarlo a Sochi o Yalta sul mar Nero, dove si
trovavano i sanatori per malati di TBC. Dopo due o tre mesi di terapie a
base d’iniezioni sembrò migliorare. Amedeo lavorò alla costruzione di
ponti di barche sul Danubio, consumando i pasti forniti dalla Croce
Rossa; le buone razioni di cibo gli consentirono di riprendersi
fisicamente, almeno in parte. In un giorno di libertà decise di recarsi
in treno presso il lago di Komárom. Sulla carrozza fu avvicinato da
alcuni soldati sovietici della Mongolia che s’impossessarono del suo
zaino, credendo contenesse oggetti di valore. Nella sacca teneva quel
poco a cui si era affezionato come gli indirizzi di persone conosciute
durante la guerra e prigionia e un lasciapassare russo. Il su è giù per
i territori, già appartenenti all’Impero Ottomano, per Amedeo non era
ancora terminato. Il contingente di prigionieri italiani doveva
inizialmente essere rimpatriato per mare da Odessa via Dardanelli, ma
alla stazione ferroviaria di Bucarest la Croce Rossa Internazionale
decise di farli rientrare con il treno via Austria. Furono predisposte
le tradotte e dopo 15 giorni giunsero ad Innsbruck. Qui una colta
signora, rimasta vedova di guerra, gli fornì un paio di pantaloni, una
camicia e vitto e alloggio per 3-4 giorni. Raggiunto il confine
italiano, gli ex prigionieri furono presi in consegna dagli inglesi che
provarono ad inquadrarli, ma molti preferirono fuggire (di inquadramenti
ne avevano abbastanza, ormai erano in Italia): ognuno ritornò a casa per
conto suo con mezzi di fortuna e senza nulla: Amedeo Ferri riuscì
finalmente a rientrare a Macerata il 25 agosto 1945. Qualcuno aveva
erroneamente riferito alla madre di aver visto in Abruzzo il figlio
Amedeo rimasto con una sola gamba. La madre disperata si recò in Abruzzo
e vi rimase per dieci giorni nelle vane ricerche del figlio. Amedeo
Ferri si ritiene fortunato di essere riuscito a sopravvivere a
Mauthausen con quello che si seppe dopo. Tra gli ottomila italiani
deportati è uno dei sopravvissuti. I superstiti di quel campo, il 16
maggio 1945 prima del rimpatrio, giurarono di combattere per “un mondo
nuovo, libero, giusto per tutti”. Per cercare di curare le malattie
contratte in quegli anni terribili, Amedeo fu ricoverato al
convalescenziario partigiani e reduci “Mario Pasi” di Lavarone Cappella
(Trento). Il
medico prese a benvolere Amedeo e gli confidò che, se non avesse reagito
alle cure, avrebbe dovuto inviarlo a Sochi o Yalta sul mar Nero, dove si
trovavano i sanatori per malati di TBC. Dopo due o tre mesi di terapie a
base d’iniezioni sembrò migliorare. Amedeo lavorò alla costruzione di
ponti di barche sul Danubio, consumando i pasti forniti dalla Croce
Rossa; le buone razioni di cibo gli consentirono di riprendersi
fisicamente, almeno in parte. In un giorno di libertà decise di recarsi
in treno presso il lago di Komárom. Sulla carrozza fu avvicinato da
alcuni soldati sovietici della Mongolia che s’impossessarono del suo
zaino, credendo contenesse oggetti di valore. Nella sacca teneva quel
poco a cui si era affezionato come gli indirizzi di persone conosciute
durante la guerra e prigionia e un lasciapassare russo. Il su è giù per
i territori, già appartenenti all’Impero Ottomano, per Amedeo non era
ancora terminato. Il contingente di prigionieri italiani doveva
inizialmente essere rimpatriato per mare da Odessa via Dardanelli, ma
alla stazione ferroviaria di Bucarest la Croce Rossa Internazionale
decise di farli rientrare con il treno via Austria. Furono predisposte
le tradotte e dopo 15 giorni giunsero ad Innsbruck. Qui una colta
signora, rimasta vedova di guerra, gli fornì un paio di pantaloni, una
camicia e vitto e alloggio per 3-4 giorni. Raggiunto il confine
italiano, gli ex prigionieri furono presi in consegna dagli inglesi che
provarono ad inquadrarli, ma molti preferirono fuggire (di inquadramenti
ne avevano abbastanza, ormai erano in Italia): ognuno ritornò a casa per
conto suo con mezzi di fortuna e senza nulla: Amedeo Ferri riuscì
finalmente a rientrare a Macerata il 25 agosto 1945. Qualcuno aveva
erroneamente riferito alla madre di aver visto in Abruzzo il figlio
Amedeo rimasto con una sola gamba. La madre disperata si recò in Abruzzo
e vi rimase per dieci giorni nelle vane ricerche del figlio. Amedeo
Ferri si ritiene fortunato di essere riuscito a sopravvivere a
Mauthausen con quello che si seppe dopo. Tra gli ottomila italiani
deportati è uno dei sopravvissuti. I superstiti di quel campo, il 16
maggio 1945 prima del rimpatrio, giurarono di combattere per “un mondo
nuovo, libero, giusto per tutti”. Per cercare di curare le malattie
contratte in quegli anni terribili, Amedeo fu ricoverato al
convalescenziario partigiani e reduci “Mario Pasi” di Lavarone Cappella
(Trento).
Nel 1950, dopo sei mesi di matrimonio, emigrò con la moglie e il figlio
in Argentina dove rimase fino al 1953. Abitava a Berazategui (a sud est
di Buenos Aires), vicino a Quilmes dove aveva sede la più grande
birreria del Sud America. Per questioni di lavoro si recava spesso a San
Fernando (vicino a San Isidro), con un collega che forniva pelli per
scarpe a un russo originario di Tbilisi (Georgia). Lì incontrò varie
volte un tedesco, il cui volto gli rimase fortemente impresso. Qualche
anno dopo vide la foto dell’uomo sui giornali e venne a sapere che si
trattava di Adolf Eichmann ufficiale nazista responsabile dell’uccisione
di milioni di ebrei che, trovato da Simon Whiesenthal, rapito dal Mossad
fu in seguito processato e condannato a morte a Tel Aviv. Un altro
incontro lo riporto ai più recenti ricordi di guerra. Sul treno per
Buenos Aires notò un uomo che gli sembrava di conoscere. Dopo alcuni
giorni decise di rivolgergli la parola. Scoprì che si trattava di tale
Nicola Stella, originario della provincia di Catanzaro e operaio alla
Todt in Ungheria. A questo punto si abbracciarono fortemente con grande
commozione. Ogni tanto riaffiorano in lui, pensionato di guerra con
croci, i ricordi delle passate sofferenze che non gli fanno però perdere
l’ottimismo. Concludo con una sua bella frase: «In tutto il mondo si
trova sempre qualcuno buono!
|

