A
AC Newman - The Slow Wonder (2004
Matador)
tra gli anni '90 e l'inizio dei '00 Carl Newman s'è rivelato tra i compositori
pop più talentuosi e incontenibili in circolazione. AC Newman non è
che l'ennesimo progetto tirato in ballo dal nostro, dopo Zumpano e i giustamente
celebri New Pornographers, ancora in attività. Tutti pretesti per liberare
nuove esplosive pop songs, ancora e sempre costruite con sapienza e senso
emozionale esemplari.
Questo "The Slow Wonder" è meno indirizzato a concept come gli album di Bejar. Le attraenti armonie dei brani, richiamandosi reciprocamente vanno a comporre un efficace, affiatato sgargiante collage. Non ci saremmo stupiti se questo fosse stato il terzo album del supergruppo campione del pop-rock canadese.
La surreale nevrosi power-pop di New Pornographers torna in massa su parecchi brani, su tutti "Miracle Drug", ove taglienti riff di chitarra e batteria marziale attraversano trasversalmente il tessuto musicale tirando l'ascoltatore nel mezzo. Non da meno la poderosa organica carica di "On the Table": piano, batteria e riff implementano la performance di Newman. O poi la furente "The Battle for Straight Time", e "The Town Halo", condensata dalla corona di violoncello.
"Secretarial" non avrebbe sfigurato affatto su un album degli Shoes.
O preferire forse, le soavi mollezze di "Drink to Me, Babe, Then" costruita con abili armonie vocali, l'ibernata suadente vigoria di "Come Crash", simili afflati vocali, piano, chitarra e tromba.
Un paio di brani troppo plagiati d'enfasi non condiziona l'integrità d'insieme più di tanto.
Carl Newman rimane un autore lucido, con una singolare abilità di sintesi; "The Slow Wonder" è tra i più creativi, avvincenti e meglio scritti recenti album di rock melodico.
(2004)
Aden - Topsiders (TeenBeat, 2002)
indubbiamente il migliore Aden ascoltato sinora.
Questo è un pop imbevuto di effluvi post-rock, invenzioni strumentali folk e tonalità jazz un pò alla maniera dei Sea & Cake di Sam Prekop.
Indubbiamente l'incontro con la Teenbeat ha giovato al quartetto washingtoniano.
Alla soprannaturale spontaneità melodica "sebastiana" per cui Aden sono apprezzati va ad aggiungersi una sezione ritmica dal senso incantato, surreale e straniante, il tutto in un un suono opportunamente minimalista che non suona mai lezioso. (primavera 2005)
African Suite vede il futuro parlando la lingua del passato: la disco music abbagliante e cinetica, ardente e congenita di Ritchie Family e Chic, piombata in un Eldorado molteplice, emozionale, allucinato e distorto di libertà. Ibridatasi senza più ritorno, maculandosi spavalda, esuberante, casuale, voluttuosa, questa musica è ora diversamente consapevole.
Una nuova origine, fieramente umana, umanamente fiera (cfr. copertina), massiccia e reale, astratta e concreta, cerimonia e caos selvaggio di battiti tribali inconsulti, che monta desiderio e rabbia, vitalità sguaiata e complice.
“African Suite” è un marziale allegorico mimo dell’eternità, è istinto viscerale che ridefinisce ancestrale l’immagine del corpo danzato ipoteticamente, senza più limiti. Una “Fear of Music” esorcizzata da uno sciamano evapora in desiderio, anelito, ansia di eterno.
Ed è già, assieme, ciò che sarà.. world music, house…forse. Ma anche ciò che mai più, sarà.
In questo cromatico caleidoscopio iscritto nel corpo, in questi segni incisi sulla pelle il passaggio, l’inequivocabile metamorfosi in atto. Nell’atto, rado e irripetibile, del segno transeunte.
Oracolo, prodigiosa finestra su un futuro possibile, varco dell’Eden concesso per trenta minuti.
Idrofobia rappresa e sbrogliata in una danza ‘omnibus’ che a immaginarla con gli occhi sulle ali di questa musica, è spettacolo inesausto, panico espressivo. È orgia isterica, lussuria cadenzata e robotica.
Rigenerazione, purificazione dal peccato, redenzione di carne e voce, rinascita di figure, risveglio di curve: segue la reazione in un incessante riappagamento del piacere, e conseguente abbandono.
È sogno e incubo dell'uomo, desiderio di vedere chiaro, oltre il limite dei propri sensi. Sovverte l’abituale stato di coscienza e favorisce allerta. Nelle sequenze musicali, paure ataviche ed emancipazione catartica, flusso di suoni a mancare il respiro, a indurre ogni sguardo a colore, fiammeggiante e perverso, panico, umano, continuamente allusivo. Tragedia e commedia simulate in un rutilante diluvio fisico, senza possibile posa.
Sensuale e funky, compatta come poche cose mai udite, musica di tutte le forme e tutte le lingue.
Air Miami: Me.Me.Me. (TeenBeat, 1995)

TeenBeat Records è una gloriosa etichetta statunitense, il cui titolare il chitarrista e compositore Mark Robinson progettò tra '80 e '90 timbri avveniristi e suoni distintivi e anticipatori del pop-rock.
Proveniente dalla scena garage-punk, Robinson con gli Unrest inventa una miscela sonora rudimentale ma innovativa, che dal punk perviene a suoni più pop.
Air Miami è il progetto di Robinson assieme alla bassista Bridget Cross l'indomani dello scioglimento di Unrest. "Me.Me.Me." resta unica testimonianza del gruppo, Robinson si conferma scaltro navigatore e infonde tutti i tipici, sgargianti suoni chitarristici; psichedelici, frenetici e molto melodici, già nei colpi di coda di Unrest (l'eccelso "Imperial FFRR" e il meno efficace "Perfect Teeth").
In più s'aggiungono synt e drum machine: "Me.Me.Me." è l'ennesima irresistibile raccolta pop che nessuno in Teenbeat saprà migliorare se non True Love Always, alcuni anni dopo.
"Seabird" é forse la migliore creazione di Mark: Feelies, Polyrock e B'52's sotto uno stesso tetto, a Washington DC.
(2003, 2005)
Albert Marcoeur (Atlantic 40546)
Esponente piuttosto insolito persino nel panorama europeo dei primi settanta, questo francese poco più che ventenne finisce abbastanza casualmente nel calderone progressive (il boss della Cuneiform lo inserisce nella sua personale Top 10 assieme con mio plauso ad Hatfield & The North - The Rotter's Club ). La grandezza e il vigore avvenirista di Marcoeur a mio avviso sta in questa perenne ininterrotta enigmaticità caratteriale, in questa temeraria, volontaria segregazione artistica.
E nonostante tutto, riuscire a restare appetibile.
L'esordio del '74 e il seguito Album a colorier del '76 mostrano una creatività disarcionata ed audacia non indifferenti in questo mattatore apprendista zappiano affascinato da ogni forma comunque fuori squadra, per cui ogni sagoma avviata a farsi canzone viene lucidamente dirottata verso un caos secondo un suicidio commerciale programmatico compiaciuto, per cui provo una sorta di ammirazione/esaltazione.
Alternative Tv - Vibing Up The Senile Man
Alternative TV : dai prodromi del punk ad entità estranea. Quanto più in questo Vibing Up the Senile Man si cerchi di inquadrarli tanto più sfuggono a catalogazioni. Certo è che questo lavoro primitivo e spettacolare congiunge immaginari ancestrali e apocalittici fatti di folate di tastiera alienante già filosofia TG e poi di Nocturnal Emissions e Factrix/Monte Cazazza .
In più e oltre, si avvista un limbo, gli stessi non-luoghi tragici di This Heat e Neu! 2 .
Dall'agghiacciante gravità dell'epopea “The Radio story” traspare il grande talento d'un immaginario deviato. Voci da sciamano psicotico soffocate e distorte da transistor onde radio, tastiere in loop che gravano, nastri a varia velocità, note libere di sax e frammenti di piano come un Satie in visita a Kafka. Scarti decontestualizzati di nastri cut-up/suoni concreti: fobie ataviche, torbidi flash di paranoia metropolitana.
“Facing Up To The Facts” è controscena, risvolto quieto, dopo il cataclisma. Su “The Good Missionary” linee sdraiate di impro-pianoforte ‘scordato' e contemporaneo, viene attentato come le Shaggs , impunemente, rendevano batteria e corde.
Una recita atonale ondeggia sul caos, cronaca ora alticcia, ora glaciale, isolata.
The Aluminum Group - Plano (1998
Minty Fresh)
John e Frank Navin, in arte Aluminum Group, sono due fratelli di Chicago che col loro secondo album attuarono un modello di chamber-pop definitivo, "Bacharachiano", di sconvolgente e irripetibile avvenenza.
"Plano", il titolo, diffonde anzitutto l'idea di questo fatale e appassionante trasvolo, libero e fluttuante nelle onde della memoria delle prime ardenti note e liriche dell'album, "chocolates".
Saremo sempre grati ai due fratelli per averci donato un'opera come questa (assieme alla magistrale naiveté del seguente "Pedals", altro album tra i più perfetti degli ultimi anni, prodotto con Jim O'Rourke), per queste canzoni magnifiche e avvolgenti.
Le luminose candide ali di tastiera di "angel on a trampoline", "sugar and promises", "the mattachine society", "star wish". "Plano" è il tanto ambito approdo all'Eldorado Steely Dan vanamente inseguito per un decennio da tanti esploratori pop, scozzesi in primis.
Arduo descrivere, cercar parole per riprodurre immagini di equilibrio che ispirano tali istantanee di bellezza, memoria, fatalità, eleganza.
Little Happyness (Minty Fresh) 2008
Come un soave libeccio, si propaga ineffabile e confortante il nuovo atto di Aluminum Group, redivivi dopo un lustro di silenzio. Il duo chamber-pop di Chicago, formato dai fratelli John e Frank Navin, completa così in “Little Happyness” la propria trilogia sulla “felicità” iniziata nel 2002 con “Happyness” e bissata da “Morehappyness” l’anno dopo.
Felicità come inesplicabile repentino raggio luminoso di gioia e sollievo, fulminea rifrazione che attira risposte emozionali ridipingendo il colore sui volti e sui corpi.
Una candida spontaneità rasserenante rispecchia per frammenti nella musica dei Navin. Un’ansia di sogno, spleen euforico contagiante: “Little Happyness” è un balsamo lieve e dilatato, che si percepisce subliminale, che subdolo descrive emozionalità e, galeotto, tradisce debolezze.
La sinuosa arte dei fratelli Navin si sparge periferica, traccia per traccia in questo nuovo lavoro, e rinnova nella lievità paesaggista della formula del nuovo corso, che ammicca con l’elettronica.
L’esperto John McEntire (Bastro, Tortoise ecc.) co-produce il tutto in gran confidenza, esaltando, nella modernità del proprio stile sincopato e liquido, i valori e i colori innati dei fratelli Navin, senza interferire sui loro tratti caratterizzanti né sui naturali spazi espressivi.
Sicché il duo muove felino e vivace entro tessiture venate di frammenti elettrici, di fluidità tastieristiche, sciorinando spesso, nella magia delle corde chitarristiche e in duetti vocali d’eleganza d’antan, la classe delle più vivide pagine dei loro paradigmatici esordi.
Il brano che avvia il disco, “Milligram Of Happiness” torna infatti a contemplare i fasti luministici dei capolavori orchestrali e complessi “Plano” (1998) e “Pedals” (1999); ripristinando quelle coreografie strumentali elegiache e abbacinanti, e sgargianti cori misti (come pure la meditativa, vespertina “Atlantic”).
Per poi far giorno e virare in swing ammiccante, su “Post It”, o nel cielo terso e nel puntillismo di “Lovely Day”, nelle levità diffuse e stuzzicanti di “Headphones” e “Checking Out”.
Come infine avvalora il colpo di coda “The World Doesn't Spin On Us”, nei Navin l’avvenenza melodica è fatalità appassionata, felicità impulsiva. È un atto d’istinto non riducibile, è destino.
Non c’è verso che sfumi o trascolori qualcosa, nei loro versi. Come solo è dato ai grandi scrittori pop.
Ci troviamo in ambiti Steely Dan, Prefab Sprout, Aztec Camera, The Bible, China Crisis. Ora l’uno, ora l’altro, simbolicamente affiora ammiccando, a presiedere un cerimoniale vincolante in questo nuovo significativo tassello per il pop dell’ultimo ventennio. (marzo 2008)
 AM/FM Getting Into Sinking (2002)
AM/FM Getting Into Sinking (2002)
Un duo autogestito, come nella seconda metà degli anni novanta furono Aluminum
Group, Ben Folds Five, Cardinal, quesi tutti loro connazionali, e putativi
mentori.
Getting Into Sinking, opera matura e compatta, più dell'esordio, rimanda idealmente
agli autori già citati, ma anche e soprattutto a Phil Spector e Beach Boys,
non solo per affinità melodico ritmiche, ma soprattutto per perfezione artigianale,
per le impeccabili, soavi melodie, che dentro il guscio inquieto tipicamente indie, si conservano miti, pacate e sensitive, gioiose, infantili,
naif, e la convivenza tra i poli, all'apparenza antitetici, è perfetta.
Gli arrangiamenti sono bilanciati e ponderati, il mood è avvolgente, a fianco delle
gustose, irriverenti sporcature, trovano posto nobili e onorevoli fiati, archi
e clavicembalo, frequenti falsetti e vocalismi a cappella.
(gennaio 2002)
Antena - Camino Del Sol (Disques Du Crepuscule, 1982, Numero Group, 2004)
La cantante francese Isabelle Antena esordì nei primissimi '80 nei tour di Paul Haig, Tuxedomoon e Cabaret Voltaire.
Nel 1982 si mise in proprio, e aiutata dagli strumentisti Sylvain Fasy e Pascale
Moiroud fondò Antena: voce, sintetizzatori, drum machines, harpsichord,
percussioni...
 "this
record almost didn't happened. It was an accident. A cheap gamble"
"this
record almost didn't happened. It was an accident. A cheap gamble"
"before there was Air or Stereolab, there were three french kids running around
streets of Brusells making a record that no one wanted to hear"
(su "Camino del Sol", dal sito di Numero Group).
Le ristampe infondono passione filologica. Da anni questo delizioso e misterioso
dischetto campeggiava nella mia collezione di cd, e, come per l'omonimo dei
Fantastic Something, mai m'ero chiesto dell'origine, nonostante l'ascoltassi
spesso.
Semplicemente stava lì, senza troppi perché. Lo avevo comprato usato da Dark
Star (facciamo un po' di pubblicità), per via della copertina, senza prima
ascoltarlo, garante il marchio "Disques Du Crepuscule", dei Paul Haig, Tuxedomoon,
Joy Division, Durutti Column.
L'omissione della data di pubblicazione originaria nel CD in mio possesso,
intricava la matassa. Infiniti dubbi sorsero riguardo Antena, tanto ampiamente
quegli eterei, minimali, obliqui elettro-bossa erano de-contestualizzati,
oscuri, sorprendenti, niente affatto seguaci di futili mode.
Mi dicevo: sarà fine '80? inizio'90? Poi, quando lessi 1982, trasalii.
Isabelle Antena e soci furono una one album band, in grado di lasciare profonde,
distintive orme, sia pure immaginarie e inconscie, come Young Marble Giants
di "Colossal Youth".
Il fatto è che riuscirono nell'impresa con un singolo e un Ep.
Se "Camino del Sol" avesse prodotto un qualsivoglia seguito, discografico
o di pubblico, staremmo a citare Antena diffusamente, da almeno un ventennio.
Ab initio fu un singolo ("The boy from ipanema", maggio 1982), seguito da
un telegrafico, sfuggente Ep di cinque brani ("achilles", "silly things",
"camino del sol", "bye bye papaye", sisséxa", la scaletta originaria, settembre
'82), entrambi targati Crepuscule.
Nel 1988 l'Ep venne accorpato coi brani ex singolo, e stampati su Cd. Nel
2004, la nuova definitiva ristampa.
L'indimenticabile la copertina di Benoît Hennebert ritrae la terrazza di una
villa, estremamente simile a quella del "Che?" polanskiano. Vuoto e spettrale,
questo ambiente, nel proprio biancore silenzioso e sinistro violato da squarci
d'ombra, sembra attendere qualcuno.
La musica: tristi tropici, letteralmente. Una straniante, onirica atmosfera
strumentale creola, tribaloide, sovente kraftwerkizzata. Flussi di synt autobahn
percorsi dalla calda carezzevole voce di Isabelle.
La scaletta è del tutto inconsueta e pregevole, sin dalla incipiente "boy
from Ipanema"; indispensabile lussuosa rilettura della Girl Jobimiana, un'elettro-samba
dell'assurdo, patrocinata da nient'altri che John F oxx.
oxx.
 Altrettanto spiazzanti "achilles" (il brano che inaugurava l'ep), rammentante
l'inquieto synt-pop da Orchestral Manouvres in the Dark esordienti. Sulle
ambigue eccelse "silly things", "noelle a hawaii", "to climb the cliff", Isabelle
è un'Astrud Gilberto che si racconta sul lettino dello psicanalista (anzi,
sull'amaca, nella terrazza che dà sul mare, in vacanza).
Altrettanto spiazzanti "achilles" (il brano che inaugurava l'ep), rammentante
l'inquieto synt-pop da Orchestral Manouvres in the Dark esordienti. Sulle
ambigue eccelse "silly things", "noelle a hawaii", "to climb the cliff", Isabelle
è un'Astrud Gilberto che si racconta sul lettino dello psicanalista (anzi,
sull'amaca, nella terrazza che dà sul mare, in vacanza).
Su "les demoiselles de rochefort" (altra disorientante cover), "spiral staircase"
e "unable" sembra di udire una Laetitia-Stereolab... turned to hysteria.
Prima o poi qualche santo di turno (segnatamente Numero Group) si occupa
sempre di una ristampa. Non senza travagli, in questo caso. Ma ciò che conta
è il risultato.
Questa è una ristampa sontuosa e tirata a lucido; con brani inediti o varianti
ipanemiche. Io intanto recensisco il vecchio album Crepuscule in mio possesso
(non mi si tacci di superficialità!).
Se oggi il mondo può ri-scoprire il valore di "Camino del Sol", gran merito
va attribuito ai tipi di Numero Group, Ken Shipley e Tom Lunt (già responsabili
della ristampa degli Eccentric Soul). Come stregoni voodoo, con un sortilegio
i due hanno destato questa evasiva sulfurea opera dallo stato comatoso, zombesco,
in cui versava.
Grazie al restauro (peccato solo per la copertina, in origine quasi monocromatica,
qui rivisitata perde d'ambiguità), quest'album diventa oggi un piccolo, irrinunciabile
classico del pop anni '80 o anche omnibus, tanto riottosi questi suoni erano
e restano, a posarsi, e risolversi.
"Camino del Sol" è un suono, una situazione, un'esperienza, assolutamente
fascinosa e perturbante. Mai del tutto compreso, scorre imperscrutabile, dissonante,
integro, intrigante.
Una volta che girerà sul piatto, rischierà l'heavy rotation per molto tempo
a venire.
(agosto 2004)
69 (1988)
Esempio di manipolazione ‘rock’ come capovolgimento silenzioso e straniante, che costantemente altera ambiente e visuale. Un camaleontismo figurativo mosso tra destrutturazione in assurdo e senso di impotenza. “69” assurge a prototipo magico, tragico, un potenziale inesauribile, offuscante e alienante.
Una bellezza velenosa in contemplazione, attratta dal suo stesso movimento, è intravista in vapori spettrali, paralizzata in una nebbia sulfurea; lunghe ombre proiettate dagli strumenti come cineprese mostrano, illuminano una marcia tragica in un eremo distante e rarefatto, in un’atmosfera assorta e sinistra. “Baby Milk Snatcher”, pezzo di rapinante bellezza, gelida e sensuale, è un ultimo vibrante assalto allo spazio sconfinato, una chiosa mirabile per il decennio al suo volgere.
"i" (1989)
“i”, un profetico e immaginario pastiche musicale, un costrutto onirico che muove da limpidi campi visivi di invitanti ‘ritornelli’ e che sovverte, sconvolge la rappresentazione.
L’occhio di A.R. Kane così ancora trama, sposta e svia, celebra sogno e mistero; conturba amplificando spazi musicali orchestrando illusioni e policromia. Proiettando, riversando esso stesso quell’universo interiore allucinato, tormentoso, alienato, costante ‘Dominus’ della musica.
Ventisei estratti da concerti da un utopico anfiteatro, in quello scompiglio sistematico di stati e moti d’animo caro alla formazione. Con l’intento surreale e ribelle di invertire simboli, figure cromatiche come dinamici trapezisti che producono, scambiandosi, volute originarie, forme autonome.
Arcade Fire – Funeral (Merge, 2004)
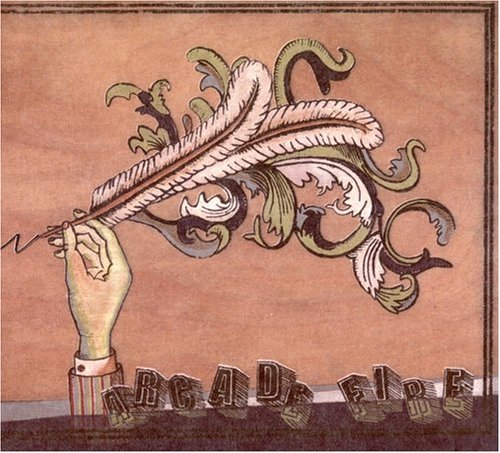 Curioso esordire con un funerale. Ma questo gruppo canadese ha avuto le proprie ragioni, sulle quali non mi dilungo in questa sede. Artefici di un esordio poprock-wave di rara visceralità -quasi imbarazzante e ingestibile tanto è ponderoso, ma pur sempre, altamente fruibile- Arcade Fire (in primis i coniugi Win Butler e Régine Chassagne) hanno trionfato nelle classifiche “indie” un po' ovunque. Funeral è uno degli album più passionali e sconvolgenti degli ultimi anni. Un insieme denso, magmatico, straniante, prepotente, spirituale, che proclama questo gruppo tra gli ideali prosecutori di quell'arte schizoide, di angoscia e euforia, di David Byrne (Talking Heads), Jeff Magnum (Neutral Milk Hotel) e Luke Haines (leader degli The Auteurs, Baader Meinhof).
Curioso esordire con un funerale. Ma questo gruppo canadese ha avuto le proprie ragioni, sulle quali non mi dilungo in questa sede. Artefici di un esordio poprock-wave di rara visceralità -quasi imbarazzante e ingestibile tanto è ponderoso, ma pur sempre, altamente fruibile- Arcade Fire (in primis i coniugi Win Butler e Régine Chassagne) hanno trionfato nelle classifiche “indie” un po' ovunque. Funeral è uno degli album più passionali e sconvolgenti degli ultimi anni. Un insieme denso, magmatico, straniante, prepotente, spirituale, che proclama questo gruppo tra gli ideali prosecutori di quell'arte schizoide, di angoscia e euforia, di David Byrne (Talking Heads), Jeff Magnum (Neutral Milk Hotel) e Luke Haines (leader degli The Auteurs, Baader Meinhof).
Arrangiamenti poderosi, voci spesso tonanti, un ponte tra anni '80 e '00.
Una delle più appassionanti raccolte di canzoni del 2004.
(dicembre, 2004)
ARCHITECTURE IN HELSINKI
Gruppo di Melbourne allestito da Sam Perry bassista, e Cameron Bird voce,
chitarra e synt conosciutisi a scuola negli anni ottanta.
Jamie Mildren è la chitarra e Kellie Sutherland voce, clarinetto e synt, James
Cecil batteria e Isobel Knowles fiati, a completare il sestetto.
Iniziano a suonare assieme nell'inverno del 2000.
Quanto al nome, Cameron ricorda che venne fuori provando a gridare alcune
parole o frasi improvvisate, per vederne l'effetto...
In Case We Die (Tailem Bend/Remote Control, 2005)
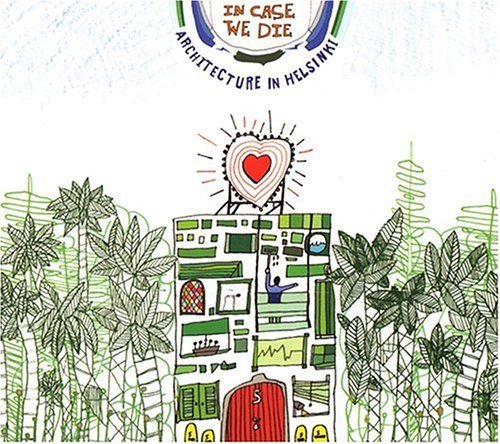 A due anni esatti dall'esordio, Architecture in Helsinki tornano con passi da gigante senza necessariamente valicare e compromettere i limiti del proprio reame lillipuziano.
A due anni esatti dall'esordio, Architecture in Helsinki tornano con passi da gigante senza necessariamente valicare e compromettere i limiti del proprio reame lillipuziano.
Ciò che spicca immediatamente di questa musica è il balzo in avanti della forma, l'estro sfrenato per cui queste canzoni vengono concepite e avvolte assieme, come assumono fogge impreviste.
Un processo di bizzarra de-normalizzazione in chiave teatrale e architettonica, basata su continui collage di frammenti, sbalza il corpo canzone senza sgualcire mai, giocando con l'attesa dell'ascoltatore e raggirandola puntualmente.
Un sistema trasversale e schizoide, “benigno” e senza dubbio innovativo, già avviato tempo fa, forse con più presunzione, da Fiery Furnaces e il primo Cornelius di “Fantasma”: la dimostrazione che ogni struttura è contenuto-contenibile, potenzialmente in-finita, infinitamente operabile e plasmabile
. Agendo al proprio interno i protagonisti coinvolgono, attenti a non smarrire mai, di un'anima costitutiva, ciascun carattere distintivo e peculiare.
L'effetto sorpresa fa dunque da padrone su “In Case We Die”. Difficilmente si sarebbe potuto fiutare un sì sconvolgente seguito per quel “Finger Crossed”, che fu esordio di culto del 2003, non tradito nel proprio spirito “twee”, bensì arricchito di suoni ed effetti saccheggiati da ogni dove subcosciente, atti ad allungare o alterare.
Più che Helsinki o Melbourne, questi otto sono apolidi musico-architetti anarco freak, di mente libera e ampio respiro, con fiori nei loro cannoni.
Gran parte della sezione ritmica si presta a ogni sorta d'invenzione casalinga: battiti di mani, di ciottoli, suoni di giocattoli, da restituire al nipotino, una volta terminate le sessioni di registrazione. A tutto ciò si aggiungono sensi folk (corde opportune, viola, banjo, ma anche trombette) e cori gioiosi intorno (gli Stranger Danger/Danger Stranger ecc...su “it's 5!”sono indimenticabili) la resa è straordinaria.
il primo brano “Nevereverdid” è sintomatico: nei suoi quattro minuti accade di tutto, in appassionanti sequenze e continui cambiar di peso e colore.
Temibili rintocchi di campane a morto, anziché processioni, aprono inopinati e prodigiosi crescendo marziali (batteria, strumenti acustici e tradizionali), passando per effettini, cincischi e quant'altro. Vorticose comunioni di sensi, passaggi infantili euforici.
In questa chiave, le varie “It's 5!”, “the cemetery”, “Frenchy, I'm Faking” e “Tiny Paintings” appaiono logiche successioni, quantunque di “logico” o prevedibile sia lecito attendersi poco.
“Wishbone”, poi offre, in caso di trapasso, il testamento più dolce e gioioso disponibile: incipit d'organetto, seducente agrodolce apparizione femminile, misto di cori tenore e bambinesco, archi a suggello.
“Maybe You Can Owe Me” è poi fulgido commovente compromesso di ABBA e Carly Simon; “Need to Shout” rilegge incrociando sfere di pop '70 britannico più pregiato, da Caravan a 10cc.
Tirando le somme, questo sussultante “In Case We Die” degli australiani Architecture in Helsinki verrà ricordato come uno dei più straordinari e creativi album pop, e non solo, del 2005.
(primavera, 2005)
Fingers Crossed (2003 Trifekta)
Fingers Crossed é il debutto di questi australiani alle prese con un pop minimale,
flebile e bisbigliato con l'inflessione languida e sensualmente cantilenante
della ragazza.
Le canzoni non superano i tre minuti e mezzo, eppure come altri colleghi del
Nuovissimo mondo (si pensi a Cat's Miaow e limitrofi) anche Architecture in
Helsinki riescono a coinvolgere nello spazio ristretto, angusto, attraverso
risvolti e vaghezze, impressioni, trepidazioni.
La verità è che questo linguaggio di comunicazione "irrisolto", fatto di dimensioni
modeste, di preziose intimità strumentali e di segreti passionali rivelati
in fil di voce affratella moltissimi abitanti e spiritelli delle lande pop
del nuovo millennio.
A volte il tono riservato si contamina con un'elettronica primordiale giocosa,
appena accennata e in linea col resto, e ricorda qualcosa dei Trembling Blue
Stars. Altre volte (e per la maggior parte del lavoro) si prediligono informali
strumenti da camera e struggenti armonie vocali (scissor paper back, the
owls go, spring 2008), che accrescono con efficacia la lunghezza emozionale
e fanno di questo gruppo una mimesi infantile e disimpegnata della Penguin
Cafe Orchestra.
Un'operina davvero graziosa e suggestiva, tra avanguardia, pop e gioco puro.
(primavera 2003)
Ariel Pink è un giovane stralunato e visionario musicista dalle colline di Los Angeles. Un autarchico che, dai fine '90, compone e incide (nello stesso tempo?) tutto da solo, servendosi di voce (voci, cut-up), chitarra, basso, e d'un 8 piste Yamaha MT8 cassette.
Veniamo poi a sapere che: “the drum sounds are all unbelievably created with his mouth”.
E lui: “It's just this weird tic that I've had since I was a kid. I do that into a microphone, with a little distortion and I get the sound I want in my head".
Worn Copy (Paw Tracks, 2005)
 Si batte il ferro finchè è caldo. Per non far sgonfiare una preziosa “new sensation” come Ariel Pink, in seguito a “The Doldrums/Vital Pink” i tipi di Paw Tracks saggiamente ristampano anche “Worn Copy”, altro capitolo del genietto californiano, edito in principio nel 2003 da Rhystop.
Si batte il ferro finchè è caldo. Per non far sgonfiare una preziosa “new sensation” come Ariel Pink, in seguito a “The Doldrums/Vital Pink” i tipi di Paw Tracks saggiamente ristampano anche “Worn Copy”, altro capitolo del genietto californiano, edito in principio nel 2003 da Rhystop.
Per quanto mi riguarda rinnovo i favori per questo giovane vulcanico freak auspicando, entro breve, anche la riedizione di “House Arrest”, il capitolo che più ci ha entusiasmati.
Un dato su cui riflettere: Ariel Pink è amato o odiato, senza condizioni.
Ancora prevalgono gli scettici. Pink è, insomma, poco coccolato dalla critica(ccia) musicale più insensibile e allineata.
Scherzi a parte: l'atteggiamento della critica è comprensibile. E' anche vero che Pink sta crescendo artisticamente, ma anche in quanto culto, tra conoscenti e scrittori di musica insospettabili.
Ammetto altresì una bendisposizione a stranezze e follie assortite, in ambito pop-rock. Ma una cosa ancora non capisco: come alcuni siano rimasti completamente immuni innanzi a un tale contagio.
Potrei ripetere il discorso generale della recensione precedente: le pubblicazioni pinkiane non si scostano granchè l'una dall'altra, essendo state realizzate, grosso modo, nel lasso di tempo che va dalla fine del secolo scorso ai primi anni del nuovo.
Se un brano può progredire appena, e aderire più, rispetto a un altro, al formato più idoneo, l'insieme poi torna puntualmente a sfaldarsi, ad ammassarsi, alle antiche estasi catatoniche. E'un processo entropico che va sfacendosi e componendosi di nuovo, instancabilmente.
E allora buttiamola giù una definizione: questo è pop del subconscio.
Flusso opaco, come memoria fatta emulsione organica, sgorgo coagito e improbabile, irriso, esibito e compiaciuto, ma sempre in via istintuale.
Questa musica si ciba di scorie, ma anche di spiriti e di sensi, che appartennero a canzoni “hits”, celebrate e dimenticate. Qui si rianimano e rivivono zombescamente, non ancora se stesse ma neppure più “nulla” (la suite in apertura, oscura e primordiale, “Trepanated Earth”, pioi "Somewhere in Europe/ Hotpink! ", “creepshow” -appunto-, “one on one”, o la messe spacey-psichedelica di "Life In L.A.”).
“Worn Copy” è saccheggio dalla mitologia rock più riconoscibile (pop, folk, psychobilly, dance, funk) quanto della boscaglia musicale meno battuta e confortante (distorsioni feedback, noise).
Questa musica è reinvenzione distorta, un fondo ammassato non identificabile (affascinante un'altrui immagine pinkiana, Daniel Johnston che rifà i Cure di “Disintegration”), in cui ci si può perdere dentro intere ore: ma il fatto straordinario è che ciò non pesa affatto.
Dunque, quel che parrebbe un insulto, diventa un complimento: è difficile ricordare quale album di Ariel Pink si stia ascoltando.
Il genio andrà fortificandosi (in sé, di sè), o non andrà. Meglio una serie di dischi a fianco all'altro o piuttosto un progresso "decisivo" che comprometta la gradualità cromatica?
Spostiamoci sulla questione della forma: i motivi per stuzzicare, Pink li possiede eccome. In particolare il vecchio R. Stevie Moore, artista tra i più incrollabili e coerenti prìncipi indipendenti, può sperare d'aver trovato in questo folle giovanotto il proprio testimone ed erede, il prosecutore ideale delle proprie bizzarre elucubrazioni viniliche.
Nell'eclettismo sistematico di Pink si riversano istintivamente le topiche Moorian-zappiane, di album storici come “What's The Point?” a “1952-19??”.
Come una filiazione, un passaggio artistico se non una vera e propria clonazione.
Ma non solo Moore: in questo flusso di detriti musicali distinguiamo gli spontanei, rivelatori assembramenti subconsci di Doo-dooettes, La Forte Four, Bonzo Band, Flossie & The Unicorns, il primo Beck.
Oggi Ariel Pink è ancora in un limbo, è il Beck Hansen pre-“Mellow Gold”.
Qualora uscisse dalla propria cantina e udisse le sirene del marketing, la propria vampirica creazione alchemica si sfalderebbe incontrovertibilmente, a contatto con l'atmosfera.
Può darsi che una data sia già stata fissata e avverrà la metamorfosi per questa magica crisalide. Può darsi altresì che siano solo futili catastrofismi e la "Pink farfalla" sorprenderà comunque il mondo. O anche, esauritosi il serbatoio, si volatilizzerà.
Riflessione in calce: i nostri tempi sono costantemente (im)maturi, privi ormai di ogni malizia per originare, alimentare -e favorire!- equivoci d'artista come il nostro Ariel.
(primavera, 2005)
