Prologo.
Ci sono storie che sembrano romanzi. Films, addirittura.
Grandi storie con personaggi eccezionali. Avvenimenti incredibili e coincidenze.
Colpi di scena ed intrighi, ma soprattutto misteri. Strani, stranissimi misteri.
Sono storie che sarebbero romanzi da leggersi tutti d’un fiato; oppure sarebbero
films da vedere e rivedere, ricordandoli passo dopo passo. Come quando si esce
da un cinema o si chiude un romanzo ben scritto.
Solo che con queste storie non si può fare così. Non si possono ricordare con
soddisfazione come se fossero avventure della fantasia. E per due motivi: perchè
sono storie brutte... e perchè sono storie vere.
Capitolo 1 – Si parte da lontano.
Ecco, se
la nostra storia fosse un romanzo si aprirebbe con l’immagine di una donna che
cammina. Cammina piano, tranquillamente. E’ stata una bella giornata ed ora è
sera. Una fresca sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo
compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.
Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.
Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una
brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,
quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.
sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo
compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.
Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.
Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una
brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,
quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.
Adesso la nostra donna sta tornando verso casa dopo aver gettato la spazzatura.
E c’è quasi arrivata; deve solo attraversare la strada ed è davanti al cancello
del vialetto del suo palazzo. Non c’è ragione che si volti indietro. Non quel
giorno in particolare; non in quel momento. Non si volta e non si accorge,
invece, che dietro di lei ci sono due uomini che la stanno seguendo.
Fermiamoci
qui e torniamo indietro. Un flashback. Come si fa nei film e nei romanzi.
Bari. 11
giugno 1969. Aula della prima sessione della corte d’assise. E’ un lunedi e
sono le 11.30. Il presidente di quella corte sta per leggere la sentenza a
carico di sessantaquattro persone. Non sono persone da poco. Non sono semplici
delinquenti comuni. Sono la mafia di Corleone. Sono i boss ed i soldati dei
corleonesi accusati di una serie impressionante di delitti e di associazione a
delinquere. Non di mafia. L’associazione a delinquere di stampo mafioso ancora
non esiste. Anche
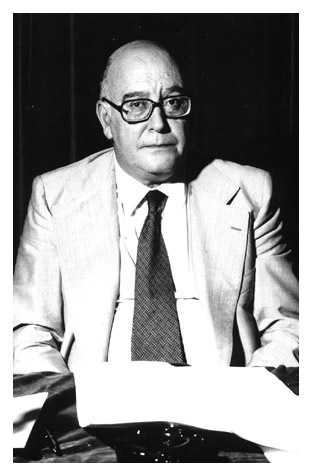 perchè
c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I
delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice
istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a
Corleone.
perchè
c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I
delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice
istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a
Corleone.
Bari. 11 giugno 1969. ore 11.30. Il presidente del tribunale sta per
leggere la sentenza. I sessantaquattro imputati, la mafia di Corleone, gli
avvocati, il pubblico ministero aspettano in silenzio e trattengono il fiato.
Liggio Luciano, capo della famiglia dei Corleonesi: assolto! Riina Salvatore,
detto Totò, il suo braccio destro: assolto! Provenzano Bernardo, detto Binnu u
tratturi: assolto! Bagarella Leoluca, detto Luchino: assolto! E con loro anche
gli altri sessanta imputati. Con formula piena o per insufficienza di prove.
Come era sempre successo in quasi tutti i processi di mafia. A Bari, a Lecce, a
Viterbo a Catanzaro. Spostati da Palermo per legittima suspicione... e poi...
tutti assolti! Tutti a casa. Come se non fosse mai successo niente.
Ma perchè
tutto questo? Come è possibile? Come potevano tutti essere ciechi o corrotti? La
realtà non è così semplice. La realtà è più complessa di così: la ragione è
legata al fatto che i tribunali valutavano i singoli reati, spesso non ne
trovavano le prove ed ancor più spesso non ne capivano le logiche perchè le
logiche erano legate a quanto accadeva all’interno dell’organizzazione mafiosa.
Tutto accadeva a seguito di un conflitto nell’organizzazione stessa ed era
necessario riconoscere questo elemento ma non era facile all’epoca e quindi si
finiva con un nulla di fatto. Niente
prove, niente testimoni, nessuno che abbia visto o sentito niente. Nessuno che
sappia dire cos’è questa mafia e neanche se esista davvero. Nemeno per gli
avvocati. Per loro non esistono i mafiosi ed i loro clienti sono solo degli
imputati accusati di essere mafiosi. Ma, partendo loro dal presupposto che tutti
i clienti sono innocenti...
Restiamo
però in quell’aula di tribunale, a Bari, nel 1969. Ecco, se fosse davvero un
film la nostra storia, a questo punto la macchina da presa si sposterebbe.
Lascerebbe gli imputati che esultano per l’assoluzione; lascerebbe il pubblico
ministero, costretto, per l’ennesima volta, ad ingoiare la rabbia di una nuova,
ingiusta, sconfitta, e si fermerebbe su un altro uomo poco distante. Un uomo
dalla fronte molto ampia, vestito in modo poco appariscente, che se non avesse
un blocco note in mano potrebbe benissimo essere
 semplicemente un uscere. E’ un
giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e
meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a
capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di
nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una
passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e
ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere
al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato
responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,
solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.
Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava
solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle
taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei
mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di
Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,
come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,
lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i
corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,
Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne
vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.
Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto
prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi.
semplicemente un uscere. E’ un
giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e
meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a
capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di
nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una
passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e
ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere
al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato
responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,
solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.
Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava
solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle
taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei
mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di
Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,
come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,
lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i
corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,
Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne
vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.
Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto
prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi.
Capitolo 2 – I personaggi.
Sulla sua carta d’identità,
sopra la fotografia che lo ritrae da giovane, con i baffetti ed i capelli ricci
fissati dalla brillantina, c’è scritto Salvatore Riina ma tutti lo chiamano
Totò. Totò u curtu per la sua corporatura massiccia e per la sua bassa statura.
Totò Riina non è colto, non ha studiato. Come dirà in un processo: “Sono un
quinta elementare!”. Ma per fare carriera in Cosa Nostra non c’è bisogno di una
laurea. Lui comincia presto: uccide il suo primo uomo a diciannove anni in una
rissa; finisce in carcere, si fa sei anni, poi esce, torna a Corleone e continua
con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c’è un
aneddoto: Totò Riina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un
attentato, molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare,
rispettosamente e con molta cautela, perchè è difficile muovere un appunto a
Totò Riina, che per compiere quell’attentato bisogna sparare d’estate sulla
spiaggia e ci sono
processo: “Sono un
quinta elementare!”. Ma per fare carriera in Cosa Nostra non c’è bisogno di una
laurea. Lui comincia presto: uccide il suo primo uomo a diciannove anni in una
rissa; finisce in carcere, si fa sei anni, poi esce, torna a Corleone e continua
con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c’è un
aneddoto: Totò Riina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un
attentato, molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare,
rispettosamente e con molta cautela, perchè è difficile muovere un appunto a
Totò Riina, che per compiere quell’attentato bisogna sparare d’estate sulla
spiaggia e ci sono
 molti bambini. Potrebbero morire dei bambini. “E allora?”
dice Totò Riina. “Anche a Sarajevo muoiono i bambini!”. Ecco, questo è il modo
di concepire gli affari di Cosa Nostra che ha Totò Riina: come una guerra; una
guerra da vincere a tutti i costi e contro tutti. Questo è Riina Salvatore; e
Leoluca Bagarella è il suo braccio destro. E’ anche lui un personaggio da
romanzo; uno dei capi più sanguinari di Cosa Nostra. Per raccontare Luchino
Bagarella c’è una fotografia: Bagarella assieme a sette carabinieri che faticano
a tenerlo fermo. Siamo negli anni settanta: Leoluca Bagarella è all’inizio della
sua carriera nella mafia ma è già latitante. E’ stato fermato dai carabinieri
per un controllo casuale, insieme ad una ragazza, e poi portato in caserma ma
non è stato riconosciuto. Bagarella ha fretta di andarsene, non vuole farsi
riconoscere. Soprattutto non vuole compromettere la ragazza che è con lui e che
poi diventerà sua moglie. Ma proprio mentre sta uscendo dalla caserma, nel
corridoio, incontra un maresciallo dei carabinieri che lo riconosce. Ce ne
vogliono sette di carabinieri per bloccarlo, immobilizzarlo e riportarlo dentro.
molti bambini. Potrebbero morire dei bambini. “E allora?”
dice Totò Riina. “Anche a Sarajevo muoiono i bambini!”. Ecco, questo è il modo
di concepire gli affari di Cosa Nostra che ha Totò Riina: come una guerra; una
guerra da vincere a tutti i costi e contro tutti. Questo è Riina Salvatore; e
Leoluca Bagarella è il suo braccio destro. E’ anche lui un personaggio da
romanzo; uno dei capi più sanguinari di Cosa Nostra. Per raccontare Luchino
Bagarella c’è una fotografia: Bagarella assieme a sette carabinieri che faticano
a tenerlo fermo. Siamo negli anni settanta: Leoluca Bagarella è all’inizio della
sua carriera nella mafia ma è già latitante. E’ stato fermato dai carabinieri
per un controllo casuale, insieme ad una ragazza, e poi portato in caserma ma
non è stato riconosciuto. Bagarella ha fretta di andarsene, non vuole farsi
riconoscere. Soprattutto non vuole compromettere la ragazza che è con lui e che
poi diventerà sua moglie. Ma proprio mentre sta uscendo dalla caserma, nel
corridoio, incontra un maresciallo dei carabinieri che lo riconosce. Ce ne
vogliono sette di carabinieri per bloccarlo, immobilizzarlo e riportarlo dentro.
Riina Salvatore, Bagarella
Leoluca... e Provenzano Bernardo? Lui in aula non c’è; lui è latitante già fin
dal 1963! Di lui, sino al momento dell’arresto, si ha solo una foto segnaletica
che lo ritrae come un giovane di 26 anni, alto e robusto, con i capelli lucidi
di brillantina come se fosse appena uscito dal parrucchiere. Lo chiamano “il
ragioniere” e questo potrebbe far pensare che sia una persona più moderata, meno sanguinaria dei suoi compagni. Però lo chiamano anche “Binnu”, che significa
Bernardo, “u tratturi”, il trattore; per la sua volontà ferrea ma anche perchè
dove passa lui non cresce nemmeno più l’erba. Ci penserà poco più avanti a
dimostrare la proprietà di quel soprannome, quando un gruppo di mafiosi
travestiti da agenti di polizia fa irruzione nel covo di una famiglia rivale in
Viale Lazio a Palermo. Devono uccidere tutti, recuperare dei documenti
compromettenti e poi dare fuoco a tutto l’appartamento. Vogliono giocare sulla
sorpresa, su quel travestimento, come Al Capone a Chicago nella strage di San
Valentino; ma uno dei mafiosi travestiti ha troppa fretta e si mette a sparare
subito bruciando l’effetto sorpresa e facendo saltare la trappola. In
quell’appartamento si scatena l’inferno: passano tre minuti in cui tutti sparano
contro
sanguinaria dei suoi compagni. Però lo chiamano anche “Binnu”, che significa
Bernardo, “u tratturi”, il trattore; per la sua volontà ferrea ma anche perchè
dove passa lui non cresce nemmeno più l’erba. Ci penserà poco più avanti a
dimostrare la proprietà di quel soprannome, quando un gruppo di mafiosi
travestiti da agenti di polizia fa irruzione nel covo di una famiglia rivale in
Viale Lazio a Palermo. Devono uccidere tutti, recuperare dei documenti
compromettenti e poi dare fuoco a tutto l’appartamento. Vogliono giocare sulla
sorpresa, su quel travestimento, come Al Capone a Chicago nella strage di San
Valentino; ma uno dei mafiosi travestiti ha troppa fretta e si mette a sparare
subito bruciando l’effetto sorpresa e facendo saltare la trappola. In
quell’appartamento si scatena l’inferno: passano tre minuti in cui tutti sparano
contro
 tutti. Alla fine restano a terra cinque morti e tre feriti. Una strage
che passerà alle cronache come la strage di Viale Lazio. Nel gruppo dei mafiosi
travestiti c’era anche lui, Bernardo Provenzano. Gli altri vorrebbero scappare;
quelli della famiglia avversaria sono morti tutti. Anche il loro capo, Michele
Cavataio, e tra poco arriverà la polizia, quella vera... ma lui no. Provenzano
non vuole ancora andarsene perchè vuole controllare. Tira fuori il capo della
famiglia avversaria da sotto la scrivania sotto la quale è caduto e lo gira, ma
Cavataio si volta di scatto puntandogli in faccia una pistola. Spara; ma a
vuoto, perchè ha finito i colpi. Prova a sparare anche Provenzano ma la sua
mitraglietta si inceppa. Allora colpisce Cavataio alla testa con il calcio
dell’arma, prende un’altra pistola e lo finisce. Questo è Bernardo Provenzano,
Binnu u tratturi.
tutti. Alla fine restano a terra cinque morti e tre feriti. Una strage
che passerà alle cronache come la strage di Viale Lazio. Nel gruppo dei mafiosi
travestiti c’era anche lui, Bernardo Provenzano. Gli altri vorrebbero scappare;
quelli della famiglia avversaria sono morti tutti. Anche il loro capo, Michele
Cavataio, e tra poco arriverà la polizia, quella vera... ma lui no. Provenzano
non vuole ancora andarsene perchè vuole controllare. Tira fuori il capo della
famiglia avversaria da sotto la scrivania sotto la quale è caduto e lo gira, ma
Cavataio si volta di scatto puntandogli in faccia una pistola. Spara; ma a
vuoto, perchè ha finito i colpi. Prova a sparare anche Provenzano ma la sua
mitraglietta si inceppa. Allora colpisce Cavataio alla testa con il calcio
dell’arma, prende un’altra pistola e lo finisce. Questo è Bernardo Provenzano,
Binnu u tratturi.
Ma in quell’aula di tribunale
lui non c’è, c’è soltanto la sua foto segnaletica. E’ un vero e proprio mistero
Bernardo Provenzano, un fantasma che non c’è e di cui non si sa niente. Un
personaggio da romanzo, appunto.
Capitolo
3 – Gli altri personaggi.
In un romanzo, all’inizio, si
cerca ogni appiglio per presentare tutti i personaggi principali della storia.
Ma, oltre a Bernardo Provenzano, ce ne sono altri due, molto importanti per noi
che non erano in quel tribunale, a Bari, perche non ci potevano essere in quanto
appartengono tutti e due ad un altro ambiente. Uno si chiama Giuseppe Puglisi,
ma tutti lo chiamano Don Pino, e non perchè sia un Boss; è un prete. Un
 semplice
parroco di borgata che ha preso i voti nel 1960 e sta a sette cannoli, un
quartiere di Palermo che sta vicino a brancaccio, quello in cui è nato. Don
Pino, un prete, un semplice sacerdote di borgata. Il secondo invece è un uomo
politico. Si chiama Salvo Lima ed è un uomo politico molto importante. Deputato
alla camera nelle liste della Democrazia Cristiana, eletto con ottantamila voti,
da un anno ha lasciato la corrente di Amintore Fanfani per transitare in quella
di Giulio Andreotti. E’ un uomo imponenete, il fazzoletto candido sempre nel
taschino della giacca, le sigarette fumate con un corto
semplice
parroco di borgata che ha preso i voti nel 1960 e sta a sette cannoli, un
quartiere di Palermo che sta vicino a brancaccio, quello in cui è nato. Don
Pino, un prete, un semplice sacerdote di borgata. Il secondo invece è un uomo
politico. Si chiama Salvo Lima ed è un uomo politico molto importante. Deputato
alla camera nelle liste della Democrazia Cristiana, eletto con ottantamila voti,
da un anno ha lasciato la corrente di Amintore Fanfani per transitare in quella
di Giulio Andreotti. E’ un uomo imponenete, il fazzoletto candido sempre nel
taschino della giacca, le sigarette fumate con un corto bocchino nero sempre fra
i denti; Salvo Lima è un uomo che parla poco, che sembra chiuso perennemente in
un freddo assoluto distacco. In realtà, però, si tratta dell’uomo politico più
potente di tutta la sicilia. E’ un uomo chiacchierato l’onorevole Lima. Nella
relazione della prima commissione antimafia viene nominato ben 162 volte! Ha poi
ben due uomini d’onore all’interno della sua corrente nella DC di Palermo. Per
11 volte viene richiesta l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti; e per
quattro volte viene anche concessa... anche se, ovviamente, non si arriva a
nessun processo. Dal 1959 al 1963 Salvo Lima è il sindaco di Palermo ed ha un
assessore ai lavori pubblici che si chiama Vito Ciancimino. Magro, con i baffi
stretti sulle labbra e la voce roca per il fumo delle mille sigarette, quando
arriva a Palermo da Corleone, dove è nato, subito dopo la guerra, Vito
Ciancimino possiede soltanto il suo diploma di Geometra. Poi, all’improvviso,
vince un importante appalto per le ferrovie. Sono suoi i carrelli ferroviari,
quelli che
bocchino nero sempre fra
i denti; Salvo Lima è un uomo che parla poco, che sembra chiuso perennemente in
un freddo assoluto distacco. In realtà, però, si tratta dell’uomo politico più
potente di tutta la sicilia. E’ un uomo chiacchierato l’onorevole Lima. Nella
relazione della prima commissione antimafia viene nominato ben 162 volte! Ha poi
ben due uomini d’onore all’interno della sua corrente nella DC di Palermo. Per
11 volte viene richiesta l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti; e per
quattro volte viene anche concessa... anche se, ovviamente, non si arriva a
nessun processo. Dal 1959 al 1963 Salvo Lima è il sindaco di Palermo ed ha un
assessore ai lavori pubblici che si chiama Vito Ciancimino. Magro, con i baffi
stretti sulle labbra e la voce roca per il fumo delle mille sigarette, quando
arriva a Palermo da Corleone, dove è nato, subito dopo la guerra, Vito
Ciancimino possiede soltanto il suo diploma di Geometra. Poi, all’improvviso,
vince un importante appalto per le ferrovie. Sono suoi i carrelli ferroviari,
quelli che  trasportano le merci per la stazione di Palermo. Anche Vito
Ciancimino è un personaggio molto chiacchierato; la commissione antimafia lo
definisce “un personaggio simbolo della penetrazione mafiosa all’interno del
comune di Palermo”.
trasportano le merci per la stazione di Palermo. Anche Vito
Ciancimino è un personaggio molto chiacchierato; la commissione antimafia lo
definisce “un personaggio simbolo della penetrazione mafiosa all’interno del
comune di Palermo”.
Salvo Lima sindaco di Palermo,
Vito Ciancimino assessore ai lavori pubblici. Sono anni particolari per la
città, sono gli anni del “sacco di Palermo”.
Il sacco di Palermo fu la più
grande speculazione edilizia portata avanti dal sistema politico mafioso che
abbia conosciuto Cosa Nostra siciliana. In pochissimo tempo furono abbattute le
numerose ville liberty del Boulevard della Libertà di Palermo e sostituite con
enormi casermoni. L’operazione consisteva appunto in una joint venture tra mafia
e politica; soprattutto politica amministrativa. In sostanza si trattava di
cambiare la destinazione d’uso di alcuni terreni e di alcuni siti per fare
edilizia ad altissima densità. Operazione che fu resa possibile anche da un
atteggiamento compiacente di alcuni istituti di credito siciliani che
finanziavano gli imprenditori mafiosi a discapito di altri imprenditori che non
avevano, al contrario, amicizie “altolocate”. Nell’immaginario palermitano
questa grande operazione fu sintetizzata in una sigla, che era: VALIGIO. Data
dall’insieme delle iniziali dei tre protagonisti di questa speculazione che
erano il costruttore Francesco Vassallo, Salvo Lima (che era, in quel momento,
sindaco di Palermo), e l’ex ministro democristiano Giovanni Gioia.
Il sindaco Lima ed il suo
assessore Ciancimino hanno uno slogan: “Palermo è bella; facciamola ancora più
bella.”; ma chissà com’era quella Palermo bella?
Capitolo 4 – Lo scempio ed il patto scellerato.
Quella del centro! Perchè quella delle periferie, dei
quartieri ghetto come “Cortile cascino”, come “Brancaccio”, come “Sette
cannoli”, dove lavora Don Pino Puglisi; quelli, hanno il fango per le strade;
quelli, hanno le fogne a cielo aperto. In quelli i bambini si ammalano di
scabbia e di tubercolosi!
Chissà com’era bella la Palermo
bella di allora? Quella degli anni cinquanta. Nei quartieri residenziali del
 centro, in viale della Libertà, in mezzo alle ville liberty, c’erano grandi
cespugli di gelsomino. Che d’estate fiorivano e facevano di quello l’odore
caratteristico di Palermo. Proprio l’odore di Gelsomino. Il centro della vita
culturale della città era il Teatro Bellini, che aveva un ristorante all’aperto
dove, d’estate, si vendevano le “sponse”; piccoli bouquet di citronella e
gelsomino. Profumatissimi, naturalmente!
centro, in viale della Libertà, in mezzo alle ville liberty, c’erano grandi
cespugli di gelsomino. Che d’estate fiorivano e facevano di quello l’odore
caratteristico di Palermo. Proprio l’odore di Gelsomino. Il centro della vita
culturale della città era il Teatro Bellini, che aveva un ristorante all’aperto
dove, d’estate, si vendevano le “sponse”; piccoli bouquet di citronella e
gelsomino. Profumatissimi, naturalmente!
Adesso non ci sono più. In una
notte: brucia il villino Florio, un cottage all’inglese nel verde di Viale
Margherita; salta per aria con la dinamite villa Deleila, una palazzina liberty;
va in fiamme anche il teatro Bellini.
Questa città non è quella città.
Quella città non c’è più! Salvo Lima sindaco e Vito Ciancimino assessore
 ai
lavori publici sventrano il centro di Palermo. Abbattono i palazzi e li
sostituiscono con casermoni e grattaceli. Coprono di cemento le periferie.
Tolgono il vincolo ad aree adibite a verde pubblico e coprono di cemento anche
quelle. In quattro anni vengono concesse 4205 licenze edilizie, ma sono licenze
strane: 3011 licenze, circa l’80%, sono intestate sempre alle solite cinque
persone. Cinque semplici mastri muratori, sconosciuti e quasi nullatenenti, dei
prestanome insomma!
ai
lavori publici sventrano il centro di Palermo. Abbattono i palazzi e li
sostituiscono con casermoni e grattaceli. Coprono di cemento le periferie.
Tolgono il vincolo ad aree adibite a verde pubblico e coprono di cemento anche
quelle. In quattro anni vengono concesse 4205 licenze edilizie, ma sono licenze
strane: 3011 licenze, circa l’80%, sono intestate sempre alle solite cinque
persone. Cinque semplici mastri muratori, sconosciuti e quasi nullatenenti, dei
prestanome insomma!
E non ci sono soltanto le
licenze; ci sono i sub appalti per il cemento, per la manutenzione delle strade
e delle fognature, per la nettezza urbana, per la riscossione delle tasse
comunali. E’ qui che arriva la mafia! E’ qui, in questo enorme affare di potere
e di soldi, che arriva “cosa nostra”. E’ nell’edilizia, che comporta
necessariamente un rapporto molto stretto con l’amministrazione pubblica, che
inizia il legame fra mafia e politica.
Capitolo 5 – Il sesso debole.
Torniamo a quella donna, quella che sta attraversando la
strada tranquillamente nel quartiere che non è suo,
 ma che lo deve diventare.
Una bella serata di fine settembre, e magari sta pensando che compie gli anni:
quaranta e passa! Più della metà di una vita. Ma per una come lei ci sono ancora
un sacco di cose da fare. Se non si è guardata attorno non si è accorta che ci
sono due uomini che la stanno seguendo. Se non si è guardata attorno non si è
accorta che sono giovani e che camminano decisi, non come se stessero
passeggiando, ma come se volessero andare dove sta andando lei. Ma anche se si
fosse voltata a guardarsi attorno, come una volta era solita fare di abitudine,
quella donna difficilmente si sarebbe accorta che uno di quegli uomini, sotto il
giubbotto nasconde una pistola.
ma che lo deve diventare.
Una bella serata di fine settembre, e magari sta pensando che compie gli anni:
quaranta e passa! Più della metà di una vita. Ma per una come lei ci sono ancora
un sacco di cose da fare. Se non si è guardata attorno non si è accorta che ci
sono due uomini che la stanno seguendo. Se non si è guardata attorno non si è
accorta che sono giovani e che camminano decisi, non come se stessero
passeggiando, ma come se volessero andare dove sta andando lei. Ma anche se si
fosse voltata a guardarsi attorno, come una volta era solita fare di abitudine,
quella donna difficilmente si sarebbe accorta che uno di quegli uomini, sotto il
giubbotto nasconde una pistola.
Il giornalista, i mafiosi, gli
uomini politici. In questa storia, sino ad ora, eccetto per una sola, mancano i personaggi femminili. Questa è una storia di mafia. Di guardie e di ladri. E
fare la guardia o il ladro è sempre stato e, ai massimi livelli, dove si gioca
duro, lo è ancora, un mestiere da uomini. Però, in questo romanzo, ci sono anche
le donne; e, anche loro, sono personaggi da romanzo. Ce n’è una che si chiama
Francesca. E’ una bella donna; molto dolce
e riservata ma anche molto decisa. E’ una donna di legge. Viene da una famiglia
di magistrati ed è un magistrato anche lei; prima presso la procura dei minori e
poi come consigliere presso la corte d’appello di Palermo. Ma non è per questo
che è costretta a vivere blindata dietro la porta di una villetta che ha da una
parte una bellissima pianta di magnolia, e dall’altra una garitta con il vetro
antiproiettile e guardie armate dentro. E’ perchè è la compagna di una altro
magistrato, un giudice istruttore presso la procura di Palermo che si chiama
Giovanni Falcone. Quando lo conosce, Francesca ha trentacinque anni e lui ne ha
quarantadue. E’ una donna di legge Francesca e quindi sa come vanno certe cose,
e poi ama quell’uomo; e per lui è disposta a sopportare l’elicottero che gira
sopra il tetto della villa tutte le volte che lui torna a casa con tre uomini
armati dentro l’ascensore e altri due che salgono le scale, piano per piano, con
le pistole in mano. E’ disposta, Francesca, a sopportare il fatto di uscire da
sola per comprare le cose che a lui servono. Di uscire da sola con la sua
macchina per andare a casa di amici, quando escono la sera a cena, mentre
Giovanni Falcone arriva per un’altra strada, con quattro auto blindate con
dentro uomini armati con il mitra e che indossano i giubbotti antiproiettile.
personaggi femminili. Questa è una storia di mafia. Di guardie e di ladri. E
fare la guardia o il ladro è sempre stato e, ai massimi livelli, dove si gioca
duro, lo è ancora, un mestiere da uomini. Però, in questo romanzo, ci sono anche
le donne; e, anche loro, sono personaggi da romanzo. Ce n’è una che si chiama
Francesca. E’ una bella donna; molto dolce
e riservata ma anche molto decisa. E’ una donna di legge. Viene da una famiglia
di magistrati ed è un magistrato anche lei; prima presso la procura dei minori e
poi come consigliere presso la corte d’appello di Palermo. Ma non è per questo
che è costretta a vivere blindata dietro la porta di una villetta che ha da una
parte una bellissima pianta di magnolia, e dall’altra una garitta con il vetro
antiproiettile e guardie armate dentro. E’ perchè è la compagna di una altro
magistrato, un giudice istruttore presso la procura di Palermo che si chiama
Giovanni Falcone. Quando lo conosce, Francesca ha trentacinque anni e lui ne ha
quarantadue. E’ una donna di legge Francesca e quindi sa come vanno certe cose,
e poi ama quell’uomo; e per lui è disposta a sopportare l’elicottero che gira
sopra il tetto della villa tutte le volte che lui torna a casa con tre uomini
armati dentro l’ascensore e altri due che salgono le scale, piano per piano, con
le pistole in mano. E’ disposta, Francesca, a sopportare il fatto di uscire da
sola per comprare le cose che a lui servono. Di uscire da sola con la sua
macchina per andare a casa di amici, quando escono la sera a cena, mentre
Giovanni Falcone arriva per un’altra strada, con quattro auto blindate con
dentro uomini armati con il mitra e che indossano i giubbotti antiproiettile.
Anche Ninetta non può fare una
vita normale a causa del marito; ma la sua è una storia proprio diversa. Ninetta
si chiama Antonietta Bagarella e viene da una famiglia di mafiosi di Corleone.
Ha il padre al confino, un fratello ucciso nella strage di Viale Lazio, e
l’altro (l’altro fratello) è Leoluca Bagarella, e tanto basta. Ninetta fa la
maestra all’istituto privato del Sacro Cuore, e nel suo mestiere è preparata,
coscenziosa ed anche tanto devota. Nessuno si è mai lamentato di lei, anzi; ma a
dodici anni si è innamorata di un amico di Leoluca, un giovane robusto, appena
uscito di galera per aver ucciso un uomo, che si chiama Totò Riina. Si sono
fidanzati ufficialmente nel 1969, quando lui era ancora a piede libero per
essere stato assolto dal tribunale di Bari. Poi Totò Riina è scappato, è
diventato latitante. Dopo un pò è scoparsa anche lei, è entrata in
clandestinità. C’è un giornalista che riesce ad intervistarla poco prima che lei
svanisca. E’ il 1971 e siamo nel tribunale di Palermo, Ninetta è stata accusata
di favoreggiamento ed il pubblico ministero ha chiesto per lei quattro anni di
confino da scontarsi in una città del nord. Dopo l’udienza Ninetta è riuscita a
rifugiarsi negli uffici della cancelleria, al piano di sopra, per riuscire a
sfuggire ai fotografi ed ai giornalisti. E’ li, vestita con un abito a fiori,
con una borsa a tracolla bianca e scarpe con il tacco bianco, che viene sorpresa
da un altro giornalista: Mario Francese. “Lei”, dice Ninetta Bagarella a Mario
Francese, “mi chiederà perchè ha scelto come uomo della mia vita proprio Totò
Riina di cui sono state dette tante cose. Io l’ho scelto prima perchè lo amo, e
l’amore non guarda a tante cose!”. Per lei Totò Riina è l’uomo migliore di
questo mondo.
Capitolo
6 – Le guerre di mafia.
E’ una vera fissazione quella
di Mario Francese per i corleonesi; ma non è una fissazione gratuita, è una
fissazione da giornalista, da giornalista bravo che sa fare le cose. E qui ha
un’intuizione: sta succedendo qualcosa dentro la mafia e, nella fattispecie, sta
per scoppiare una nuova guerra.
Si parla spesso, infatti, di una
seconda guerra di mafia per distinguerla da una prima guerra di mafia che si è
svolta all’inizio degli anni sessanta. Ma la seconda guerra di mafia è molto
diversa dalla prima, perchè la prima fu uno scontro fra gruppi e fazioni
contrapposte, mentre la seconda non vide uno scontro di questo genere. La
differenza sta nel fatto che i morti ammazzati (come si suol dire) che, per
altro, furono numerosissimi, forse mille in un biennio soltanto a Palermo,
furono solo e soltanto da una singola parte. Per questa ragione, più che di una
vera e propria guerra, possiamo a ragion veduta parlare di una specie di
“golpe”; un colpo di stato fatto dalla “commissione” ed, all’interno della
commissione, da una fazione composta essenzialmente dai corleonesi. A questo
punto è necessario chiarire chi erano gli avversari dei corleonesi. Gli
avversari dei corleonesi erano quelle cosche, quei gruppi, legati a Stefano
Bontade soprattutto, ed anche agli Inzerillo, che avevano fatto una quantità
enorme di denaro con il commercio di droga con gli Stati Uniti, la cosiddetta
“Pizza connection”. In pratica la seconda guerra di mafia fu un feroce scontro
fra il denaro (gli Inzerillo ed i Bontade) e potere militare (i corleonesi).
Nell’immediato si risolse in una enorme vittoria di questi ultimi.
si è
svolta all’inizio degli anni sessanta. Ma la seconda guerra di mafia è molto
diversa dalla prima, perchè la prima fu uno scontro fra gruppi e fazioni
contrapposte, mentre la seconda non vide uno scontro di questo genere. La
differenza sta nel fatto che i morti ammazzati (come si suol dire) che, per
altro, furono numerosissimi, forse mille in un biennio soltanto a Palermo,
furono solo e soltanto da una singola parte. Per questa ragione, più che di una
vera e propria guerra, possiamo a ragion veduta parlare di una specie di
“golpe”; un colpo di stato fatto dalla “commissione” ed, all’interno della
commissione, da una fazione composta essenzialmente dai corleonesi. A questo
punto è necessario chiarire chi erano gli avversari dei corleonesi. Gli
avversari dei corleonesi erano quelle cosche, quei gruppi, legati a Stefano
Bontade soprattutto, ed anche agli Inzerillo, che avevano fatto una quantità
enorme di denaro con il commercio di droga con gli Stati Uniti, la cosiddetta
“Pizza connection”. In pratica la seconda guerra di mafia fu un feroce scontro
fra il denaro (gli Inzerillo ed i Bontade) e potere militare (i corleonesi).
Nell’immediato si risolse in una enorme vittoria di questi ultimi.
 Siamo alla fine degli anni
settanta. Il predominio su cosa nostra è conteso fra due frazioni: da una parte
quella delle famiglie Bontade, Inzerillo e Badalamenti (il cui capo è Stefano
Bontade, detto “il principe di Villa Grazia”); dall’altra i corleonesi.
Siamo alla fine degli anni
settanta. Il predominio su cosa nostra è conteso fra due frazioni: da una parte
quella delle famiglie Bontade, Inzerillo e Badalamenti (il cui capo è Stefano
Bontade, detto “il principe di Villa Grazia”); dall’altra i corleonesi.
Fino a quel momento (gli inizi
degli anni sessanta), i soldi grossi la mafia li faceva con il sistema
dell’edilizia e degli appalti; poi arriva la droga. La sicilia diventa un punto
di passaggio della droga che dall’asia va fino agli Stati Uniti. Non solo: in
sicilia, intorno a Palermo, nascono tanti laboratori clandestini per la
raffinazione della morfina base, trasformarla in eroina, e portarla a vendere
sui mercati americani. Tutto questo significa soldi, tantissimi soldi. Allora la
nuova necessità è data dal fatto che bisogna riciclare, ripulire ed investire i
proventi di questo traffico di stupefacenti. Ma questo vuol dire avere dei
contatti più stretti con gli imprenditori ed i politici. La cosa ci interessa
perchè è questo flusso enorme di denaro a significare una maggiore capacità di
conizionamento da parte della mafia sulla politica e sull’economia.
Quello dell’abbraccio fra la
politica, i soldi e la mafia è il più grosso buco nero della storia della mafia siciliana. Raramente le indagini erano riuscite ad entrare nei santuari dei
soldi mafiosi che erano gli istituti di credito siciliani. L’esplosione del
benessere di cosa nostra coincide con l’avvento degli stupefacenti. Cosa nostra
si fa insieme produttrice e grande distributrice dell’eroina in un primo tempo e
della cocaina in un secondo. Ovviamente tutto ciò porta ad avere una valanga di
soldi a disposizione. Che avevano bisogno di essere occultati dietro facciate
rispettabili o, più semplicemente, nascosti in luoghi sicuri. Tutto questo
avviene con la complicità più o meno cosciente degli istituti di credito
siciliani e con una sorta di inspiegabile cecità degli uffici investigativi che,
pur avendone gli strumenti, non riuscivano a penetrare in queste banche colluse
con il sistema di potere mafioso.
siciliana. Raramente le indagini erano riuscite ad entrare nei santuari dei
soldi mafiosi che erano gli istituti di credito siciliani. L’esplosione del
benessere di cosa nostra coincide con l’avvento degli stupefacenti. Cosa nostra
si fa insieme produttrice e grande distributrice dell’eroina in un primo tempo e
della cocaina in un secondo. Ovviamente tutto ciò porta ad avere una valanga di
soldi a disposizione. Che avevano bisogno di essere occultati dietro facciate
rispettabili o, più semplicemente, nascosti in luoghi sicuri. Tutto questo
avviene con la complicità più o meno cosciente degli istituti di credito
siciliani e con una sorta di inspiegabile cecità degli uffici investigativi che,
pur avendone gli strumenti, non riuscivano a penetrare in queste banche colluse
con il sistema di potere mafioso.
Tutti questi soldi cambiano i
rapporti di forza all’interno di cosa nostra, ed è in questo contesto che
avviene il “golpe” dei corleonesi. La famiglia di Totò Riina è la più feroce e
la più preparata dal punto di vista militare. Attacca gli uomini delle famiglie
Bontade, Inzerillo e Badalamenti sterminandoli praticamente tutti e trasformando
Palermo e la sicilia in un grande campo di battaglia. In due anni ci sono più di
mille morti: “la mattanza”, la chiamano. Muore anche Stefano Bontade, il
“principe di Villa Grazia”; fermo ad un semaforo rosso nella sua alfa nuova di
zecca, viene massacrato a colpi di AK47 da due killer in moto.
Alcune di queste cose Mario
Francese le scrive: la frattura all’interno di cosa nostra; gli interessi dei
corleonesi nelle opere pubbliche come la “diga garcia”, vicino a Corleone, i cui
territori vengono comprati da imprenditori vicino alla mafia con un investimento
di circa due miliardi di vecchie lire e poi rivenduti al comune per diciassette.
Francese scrive anche degli interessi dei corleonesi per società immobiliari
come la “Ri.Sa.” che altro non è che un acronimo rappresentante la contrazione
di Riina Salvatore!
comune per diciassette.
Francese scrive anche degli interessi dei corleonesi per società immobiliari
come la “Ri.Sa.” che altro non è che un acronimo rappresentante la contrazione
di Riina Salvatore!
E’ quindi evidente che Mario
Francese, con i suoi servizi, abbia rotto una prassi consoliata, abbia infranto
una tradizione. Quella su cui si fondava il giornalismo siciliano e che fa
fondare ogni cosa sulla cautela. Non è evidente quanto coscientemente questo sia
avvenuto nel ragionamento e nelle azioni di Francese ma ciò che è certo è che,
per la prima volta, su un giornale siciliano, finivano dei nomi che ai
palermitani erano sconosciuti. Avere portato sui giornali il nome di Totò Riina
è stata una enorme trasgressione da parte di Francese e, soprattutto, una grande
trasgressione per quell’epoca. Il grande “delitto” commesso da Francese contro
cosa nostra però fu soprattuto l’aver portato sul giornale il nome delle
imprese, riconducibili a Salvatore Riina ed ai corleonesi, che in quel periodo
popolavano le strade di quella zona che era al centro di una grandissima
speculazione che passerà alla storia con il nome della “speculazione sui
territori della diga di garcia”.
Mario Francese non lo sa, ma è
già morto. Lui cammina, mangia, respira, lavora, ride, ma è come se fosse già
morto. Da almeno due anni i corleonesi hanno deciso che deve essere messo a
tacere. A cosa nostra, ed in particolare a Totò Riina, i suoi articoli così ben
scritti e molto ben documentati, non sono proprio piaciuti. E’ un rompiscatole
quel giornalista che si ostina a scrivere la verità. Ed è anche bravo; così
bravo che un giorno, durante un processo ad un sacerdote, Don Agostino Coppola,
il parroco di Carini, implicato in una vicenda oscura di sequestri e i mafia;
durante quel processo, Francese si avvicina al pubblico ministero in difficoltà
e gli suggerisce le domande da fare. Don Agostino se ne accorge, si volta a
fargli un gestaccio, e gli sussurra “cornuto e sbirro” a mezza voce.
E’ anche testimone di un
delitto, il nostro Mario Francese. Un giorno si trova in una taverna vicino al
 mercato della Vucciria, a Palermo, quando entrano alcune persone che si mettono
a sparare e che uccidono tre uomini. Mario Francese ha il coraggio di uscire a
chiamare il 113! E, come se non bastasse, racconta anche tutto alla polizia e lo
scrive anche sul giornale! “Cosa vuole quel giornalista?”, “Perchè non si fa gli
affari suoi?”, “Perchè si ostina a scrivere la verità?”.
mercato della Vucciria, a Palermo, quando entrano alcune persone che si mettono
a sparare e che uccidono tre uomini. Mario Francese ha il coraggio di uscire a
chiamare il 113! E, come se non bastasse, racconta anche tutto alla polizia e lo
scrive anche sul giornale! “Cosa vuole quel giornalista?”, “Perchè non si fa gli
affari suoi?”, “Perchè si ostina a scrivere la verità?”.
Il 26 gennaio 1979 è sera e
Mario Francese sta uscendo dal giornale; ha salutato tutti nello stesso modo di
sempre: agitando un bracio e dicendo: “uomini del Colorado, vi saluto e me ne
vado!”, come tutte le sere. Sta tornando a casa con calma quando, al marciapiede
dove sta camminando, si accosta una macchina.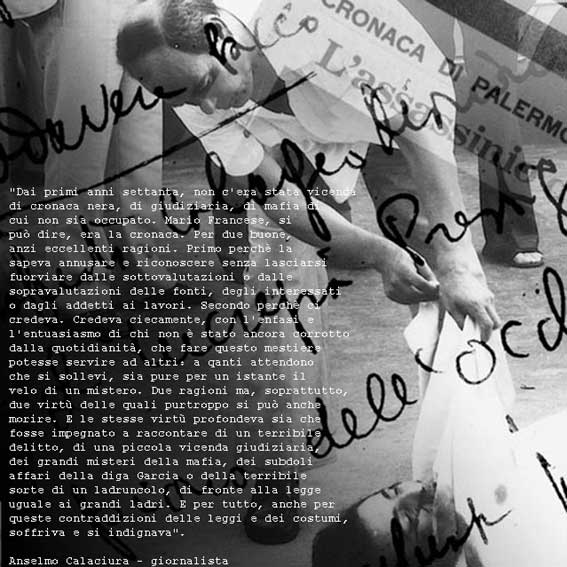 Ne discende un uomo che indossa un
elegante cappotto scuro. E’ Leoluca Bagarella che prende la mira e gli spara
quattro colpi in testa con una Smith e Wesson calibro 38. Poi si avvicina,
guarda se lo ha colpito, torna alla macchina, e si allontana lentamente; come se
non avesse nessuna paura di essere visto o riconosciuto da qualcuno. Così muore
Mario Francese.
Ne discende un uomo che indossa un
elegante cappotto scuro. E’ Leoluca Bagarella che prende la mira e gli spara
quattro colpi in testa con una Smith e Wesson calibro 38. Poi si avvicina,
guarda se lo ha colpito, torna alla macchina, e si allontana lentamente; come se
non avesse nessuna paura di essere visto o riconosciuto da qualcuno. Così muore
Mario Francese.
Quella sera Mario, prima di
lasciare il giornale telefonò al figlio, Giulio, che lavorava in cronaca, per
dargli appuntamento a casa. Così, semplicemente, gli disse: “Ci vediamo a
casa.”. Poco dopo anche Giulio va via e saluta i colleghi. Mentre si accinge ad
andare a casa, però, dalla radio della polizia, si apprende che c’è stata una
sparatoria. Tutti si fermano ad ascoltare e, poco dopo, viene dato il nome della
vittima. Ecco come si viene a sapere, nel giornale, che si tratta di Mario. Ci
si rende conto però che, nel frattempo, Giulio è uscito e quindi ha appreso del
fatto ma non sa che si riferisce a suo padre. Il primo pensiero di tutti è
quello di cercare di fermarlo per evitare che, arrivando a casa, possa vedere il
cadavere del padre riverso sull’asfalto apprendendo così la notizia nel modo
peggiore possibile. Nessuno però è riuscito in
quell’intento, come se ci fosse, in qualche modo , un sistema migliore di un
altro, per comunicare a qualcuno che il proprio padre è stato assassinato. Poi, e
fu proprio Giulio a raccontare di questo fatto in una intervista, anni dopo, il
figlio della vittima giunge sotto casa e scorge la folla, quella classica che fa
sempre da contorno ai fatti violenti; a quel punto è ovvio che è successo
qualcosa ed un presentimento si fa strada nella sua mente. Si mette a correre
incontro al cadavere anche se non riesce a scoprirlo perchè prontamente bloccato
da esponenti delle forze dell’ordine presenti sul luogo del delitto. Proprio in
quel momento il vicequestore Boris Giuliano lo vede, lo avvolge con il suo
braccio intorno alle spalle e, con grande cautela, amore ed umanita, gli dice
quello che è accaduto al padre.
Capitolo
7 – I soldi.
Mario Francese, però, non è
l’unico a parlare dei soldi di cosa nostra e dei suoi rapporti con gli
imprenditori ed i politici. C’è un poliziotto: si chiama Boris Giuliano ed è il
vice capo della squadra mobile di Palermo. Anche Giuliano è uno bravo, uno che
non molla, uno che vuole scoprire la verità. Indaga sul traffico di stupefacenti
che dalla sicilia arriva fino agli Stati Uniti e fa sequestrare un carico di
eroina, per un valore di tre miliardi delle vecchie lire, in un appartamento di
Palermo. Collabora con gli investigatori americani e fa sequestrare droga anche
a New York. Ma più che la droga, il vicequestore Giuliano, cerca i soldi! Vuole
trovare le banche ed i finanzieri che riciclano i soldi della mafia siciliana. E
quanche filo di questa compessa trama in mano lui ce l’ha. Ha in mano un giro di
assegni che da Palermo arriva a Milano e
Palermo. Anche Giuliano è uno bravo, uno che
non molla, uno che vuole scoprire la verità. Indaga sul traffico di stupefacenti
che dalla sicilia arriva fino agli Stati Uniti e fa sequestrare un carico di
eroina, per un valore di tre miliardi delle vecchie lire, in un appartamento di
Palermo. Collabora con gli investigatori americani e fa sequestrare droga anche
a New York. Ma più che la droga, il vicequestore Giuliano, cerca i soldi! Vuole
trovare le banche ed i finanzieri che riciclano i soldi della mafia siciliana. E
quanche filo di questa compessa trama in mano lui ce l’ha. Ha in mano un giro di
assegni che da Palermo arriva a Milano e

 poi passa in Svizzera attraverso
finanzieri come Michele Sindona prima e Roberto Calvi poi.
poi passa in Svizzera attraverso
finanzieri come Michele Sindona prima e Roberto Calvi poi.
Il vice questore Giuliano non lo
sa, ma è già morto. La mattina del 21 Luglio 1979 Giuliano è nel bar sottocasa e
sta prendendo un caffè perchè l’autista che viene a prenderlo tutte le mattine
per portarlo in questura, quel giorno, è un pò in ritardo. Il vice questore
Giuliano è un poliziotto in gamba, è armato e la sua pistola la sa usare bene,
ma Leoluca Bagarella (ancora lui!) entra nel bar, lo sorprende alle spalle, e
gli lascia appena il tempo di dire “No!” prima di sparagli parecchi colpi nella
schiena, a tradimento.
Anche il Giudice istruttore
Cesare Terranova è un uomo in gamba. E’ proprio quello del processo di Bari.
 Anche lui, non lo sa, ma è già morto. Luciano Liggio lo considera “il suo
peggior nemico”. La mattina del 25 settembre 1979 viene massacrato a colpi di
mitra mentre sta andando a lavorare, in macchina. Massacrano anche il suo
autista, il maresciallo Lenin Mancuso.
Anche lui, non lo sa, ma è già morto. Luciano Liggio lo considera “il suo
peggior nemico”. La mattina del 25 settembre 1979 viene massacrato a colpi di
mitra mentre sta andando a lavorare, in macchina. Massacrano anche il suo
autista, il maresciallo Lenin Mancuso.
Anche il procuratore capo della
Repubblica presso il tribuale di Palermo, Gaetano Costa, è un uomo in gamba.
Anche lui è un uomo morto. Lui non lo sa, ma mentre sta passeggiando tra le
bancarelle per le strade del centro è già morto. Lui cammina, pensa, respira, ma
è già morto. Era già morto sino da quando i sostituti procuratori incaricati
delle indagini si erano rifiutati di firmare alcuni ordini di custodia a carico
di alcuni boss del giro di Rosario Spatola, un costruttore che ricicla
nell’edilizia i soldi sporchi della mafia. Quegli ordini se li era dovuti
firmare tutti lui, il procuratore capo in persona, assumendosene tutta la
responsabilità; e non è di responsabilità legale o giuridica che stiamo
parlando. E’ il 6 Agosto 1980 ed il Dott. Costa sta curiosando in una bancarella
di libri usati, quando arriva un ragazzo in moto, scende, gli si avvicina, e gli
spara tre colpi. Fine della storia.
Quegli ordini se li era dovuti
firmare tutti lui, il procuratore capo in persona, assumendosene tutta la
responsabilità; e non è di responsabilità legale o giuridica che stiamo
parlando. E’ il 6 Agosto 1980 ed il Dott. Costa sta curiosando in una bancarella
di libri usati, quando arriva un ragazzo in moto, scende, gli si avvicina, e gli
spara tre colpi. Fine della storia.
C’è un altro magistrato, il capo
dell’ufficio istruzione del tribunale di Palermo; il suo nome è Rocco Chinnici.
Nel sistema processuale vigente all’epoca del fatti non c’erano delle
limitazioni per il magistrato che gli impedissero di entrare in quelli che erano
considerati dei veri e propri sacri templi: le banche. Difatti lui ci entrò. Il
punto è che lui ed i suoi uomini ci
 sono entrati proprio a Palermo. Ci entrarono
sia l’ufficio istruzione che la Procura. E, appunto, in questi templi sino ad
allora inviolati, venne fuori una verità, una realtà che nessuno facente parte
delle istituzioni sane avrebbe mai immaginato. Una realtà che nessuna persona
onesta conosceva. Cioè la ricchezza accumulata dalle “istituzioni mafiose”.
sono entrati proprio a Palermo. Ci entrarono
sia l’ufficio istruzione che la Procura. E, appunto, in questi templi sino ad
allora inviolati, venne fuori una verità, una realtà che nessuno facente parte
delle istituzioni sane avrebbe mai immaginato. Una realtà che nessuna persona
onesta conosceva. Cioè la ricchezza accumulata dalle “istituzioni mafiose”.
A seguito di questi fatti, anche
se nemmeno lui lo sa, il Dott. Chinnici è già morto. Il 28 Luglio 1983, pochi
minuti dopo le otto, come tutte le mattine, sta uscendo insieme a due
carabinieri di scorta dal palazzo in cui abita. Parcheggiata li davanti c’è una
autobomba che esplode uccidendoli tutti; ucidendo anche il portinaio del palazzo
e ferendo una ventina di passanti. Palermo come Beyruth, scriveranno i
giornali... ed è vero.
Capitolo
8 – Stili di vita.
Cosa fa Francesca, in quei
giorni in cui tutti, magistrati, poliziotti, giornalisti, chiunque si metta
contro la mafia viene ammazzato per la strada senza avere la minima possibilità
di difendersi? Anche lei è la moglie di un magistrato impegnato nella lotta alla
mafia, ed anche in prima linea, come Giovanni Falcone. Cosa fa Francesca? Ha
paura, sicuramente. Forse, quando lavora, non ci pensa. Ma quando è da sola a
casa ha paura che squilli il telefono o che suonino alla porta e che ci sia
qualcuno, che potrebbe essere un amico di famiglia o un altro magistrato, che è
venuto li a dirle che è successo qualcosa a Giovanni.
Anche Ninetta ha paura. Anche
lei sta a casa ad aspettare il marito. Lei non sa se tornerà o se dovrà
vederselo al telegiornale in manette tra i carabinieri. Oppure dentro un auto,
steso su un sedile, col vetro sfondato dai proiettili. Però la loro situazione è
oggettivamente diversa. E non solo per l’ovvia considerazione che Ninetta ha
sposato un mafioso mentre Francesca un uomo di legge. Loro due, è paradossale
perché sono due latitanti, riescono a condurre una vita molto più normale di
quella che conducono Francesca e Giovanni. E’ come se non li cercasse nessuno
ed, in un certo senso, è così. Di nascosto, da clandestini, loro si sono sposati
ufficialmente il 16 aprile 1974. Di nascosto però alla grande. In una villa
patrizia nei pressi di Capaci. Con tre sacerdoti a celebrare il matrimonio, di
cui uno è quel Don Agostino Coppola... quello di Mario Francese... quello di
quel gesto e di quell’insulto: “Cornuto e sbirro!”. I nostri due piccioncini
vanno in vacanza, vanno in viaggio di nozze a Venezia dove Totò Riina si fa
anche fotografare in piazza San Marco.
Vanno poi ad abitare a San
Lorenzo, poi traslocano alla Noce e poi traslocano ancora, sino ad arrivare in Via Bernini, nel quartiere dell’Uditore. Hanno quattro figli che Ninetta
partorisce nella Clinica Noto, una delle case di cura più importanti di Palermo,
e con il suo cognome: Bagarella Antonietta, detta Ninetta, in Riina!
Via Bernini, nel quartiere dell’Uditore. Hanno quattro figli che Ninetta
partorisce nella Clinica Noto, una delle case di cura più importanti di Palermo,
e con il suo cognome: Bagarella Antonietta, detta Ninetta, in Riina!
Ninetta, che magari sta a casa,
insieme ai figli piccoli, e aspetta che totò torni a casa per cena venendo da
una riunione dove, insieme ad altri boss di cosa nostra, ha deciso di far
ammazzare un rivale, o di far mettere una bomba sotto la casa di una magistrato.
Lo dice anche una delle figlie, durante un interrogatorio: “Mio padre non può
essere stato, perchè il giorno della strage era con me, sul divano, a guardare
la televisione.”.
Intanto il figlio Giovanni viene su bene. E diventerà uno dei
più potenti boss del corleonese. Viene finalmente arrestato molti anni più tardi
ma anche in carcere dimostra senza alcun dubbio di che pasta è fatto.
Il figlio del boss dei
''corleonesi'', Giovanni Riina, ha
continuato a comandare anche dietro le sbarre, come hanno dimostrato le
intercettazioni ambientali dei colloqui con i parenti nel 2006 e come hanno
indicato pentiti attendibili, dovrà rimanere nel regime di carcere duro del 41
bis mentre sconta la condanna all'ergastolo per omicidio aggravato ed altra
bella roba. E' abbastanza certo che non si tratti di "illazioni" o "teoremi" in
quanto questo è ciò che sottolinea la Cassazione nella
sentenza 35715/2006, che spiega le
motivazioni per le quali i supremi giudici - nella camera di consiglio svoltasi
il dieci ottobre - hanno deciso di dichiarare inammissibile il ricorso di
Giovanni Riina contro il decreto del dicembre 2005 che gli aveva prorogato il
"carcere duro".
In particolare la Suprema Corte ha mostrato di condividere quanto
già affermato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia (nel marzo 2006) sulla
pericolosità del detenuto Riina Giovanni che, anche durante la detenzione fra il
2000 ed il 2002, ha "saputo mantenere una posizione di comando nell'ambito della
consorteria criminale di Corleone". Giovanni Riina avrebbe dato prova di una
''non comune capacità di direzione di affari illeciti e di attività delittuose''
e di ''una determinazione di assoluto spicco ed una ferma volontà di svolgere un
compito di direzione anche in ordine alla destinazione pro quota dei profitti di
attività illecita, disponendo all'uopo di una ampia rete di persone e riuscendo
anche dal carcere a svolgere il proprio ruolo decisionale''.
Capitolo
9 – L’inizio della svolta.
Più di mille morti ammazzati,
bombe nelle auto, le più alte cariche dello Stato uccise per la strada nello
spazio di pochi anni: una mattanza! Che fare? Come uscirne? Se si fa un passo
avanti è solo perchè è successo qualcosa. La prima Commissione Parlamentare
Antimafia nasce dopo la strage di Ciaculli.
La strage era avvenuta il 30
Giugno del 1963. In un podere agricolo di Ciaculli, una borgata agricola alle
 porte di Palermo, un contadino trova una Giulietta ferma su un viottolo. E’
strana quella macchina: ha una bombola di Gas appoggiata sul sedile posteriore
con una miccia in parte bruciacchiata. Siccome, in quei giorni, è in corso una
guerra di mafia e di auto ne sono saltate parecchie, il contadino chiama i
Carabinieri. Arrivano due artificeri dell’Esercito, un ufficiale con tre
Carabinieri ed un m.llo di Pubblica
porte di Palermo, un contadino trova una Giulietta ferma su un viottolo. E’
strana quella macchina: ha una bombola di Gas appoggiata sul sedile posteriore
con una miccia in parte bruciacchiata. Siccome, in quei giorni, è in corso una
guerra di mafia e di auto ne sono saltate parecchie, il contadino chiama i
Carabinieri. Arrivano due artificeri dell’Esercito, un ufficiale con tre
Carabinieri ed un m.llo di Pubblica Sicurezza. Ma appena l’ufficiale dei
Carabinieri tocca la macchina la bomba salta per aria uccidendoli tutti. Sette
morti: una vera e propria strage.
Sicurezza. Ma appena l’ufficiale dei
Carabinieri tocca la macchina la bomba salta per aria uccidendoli tutti. Sette
morti: una vera e propria strage.
Muoiono però, in questa
mattanza, anche i politici. Tutti quelli che cercano di cambiare qualcosa. Di
rinnovare. Come il segretario provinciale della DC Michele Reina. Ammazzato il 9
Marzo 1979. O il presidente della regione sicilia Pier Santi Mattarella.
Ammazzato il 6 Gennaio 1980. Pio La Torre, segretario regionale del Partito
Comunista, lo ammazzano il 30 Aprile 1982, assieme al suo autista Rosario Di
Salvo.
Aveva un torto grande Pio la
Torre: aveva presentato in parlamento una proposta di legge che introduceva il
reato di associazione a delinquere di stampo mafioso che prevedeva il sequestro
dei patrimoni. Era andato a toccare i soldi Pio La Torre. Lui non lo sapeva, ma
era già morto.
Dopo la morte di Pio La Torre,
lo Stato manda a Palermo il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Colui che era visto da tutti come il vincitore della guerra al terrorismo.
Prefetto di Palermo con pieni poteri!
“Pieni poteri?” Il Generale
Dalla Chiesa lo dice al giornalista Giorgio Bocca durante un’intervista: “Sono qui, da solo, in quest’ufficio. Lo vede questo telefono? Non squilla mai! Dove
sono i pieni poteri?”. Lo ammazzano il 3 settembre 1982, in macchina, assieme
alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all’agente Domenico Russo che li segue con
l’auto blindata.
qui, da solo, in quest’ufficio. Lo vede questo telefono? Non squilla mai! Dove
sono i pieni poteri?”. Lo ammazzano il 3 settembre 1982, in macchina, assieme
alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all’agente Domenico Russo che li segue con
l’auto blindata.
In questa storia se si fa un
passo avanti è solo perché è successo qualcosa. Qualcosa di estremamete
spiacevole ed estremamante grave. Non ci si può fare nulla, lo Stato impara solo
così.
E’ solo dopo la morte del
Generale Dalla Chiesa che viene introdotto il 416bis: l’articolo del cosice
penale che punisce l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Prima, prima
del 1982, essere mafioso non era un reato. Bisognava uccidere, intimidire,
estorcere, mettere le bombe, sequestrare, ma essere mafioso non era un problema,
non più di tanto, almeno.
Capitolo
10 – Di nuovo i soldi.
Questo però è un romanzo fatto
di personaggi e non dobbiamo perderceli per la strada: dove sono e cosa fanno
Salvo Lima e Vito Ciancimino? Vito Ciancimino è responsabile degli enti locali
per la Democrazia Cristiana e membro del consiglio di amministrazione della
Cassa di Risparmio, la seconda banca siciliana. Aveva dichiarato che avrebbe
lasciato la politica per darsi alla finanza, ed alla metà degli anni settanta
fonda una serie di società in nord italia. Salvo Lima invece, dopo la morte di
Michele Reina, rilascia un’intervista al Corriere della Sera: dice che la mafia
non c’entra con quell’omicidio; dice che la mafia non si è mai occupata di
politica; dice che non sono mai state ricevute intimidazioni della mafia sulle
scelte politiche. Poi si fa eleggere deputato europeo e va a Strasburgo. Prende
più di trecentomila preferenze e questo è un vero record.
Torniamo alla nostra donna che
cammina, tranquilla, nel suo quartiere che non è suo. L’abbiamo lasciata ad un
passo da casa: pochi metri prima del cancello che immette nel viale che porta al
portone del palazzo dove si trova anche casa sua. Però non stavamo guardando
lei, c’eravamo concentrati sugli uomini che la stanno seguendo. Ce n’è uno più
vicino, alle sue spalle, con una pistola sotto la giacca, è un killer della
mafia uno della famiglia di Brancaccio, vicino ai Corleonesi, e sulla coscienza
ha almeno quaranta omicidi. L’altro uomo, quello che sta accelerando il passo
come se volesse superare la nostra donna che cammina, è di Brancaccio anche lui
e di omicidi ne ha commessi almeno cinquanta. Ci sono altri tre uomini che li
stanno seguendo, più lontani, sono tutti killer della mafia.
Capitolo
11 – Lo Stato si organizza.
Ma torniamo a Palermo. La
mattanza continua ma le cose, lentamente cominciano a cambiare anche a livello
della magistratura. Dopo la morte di Rocco Chinnici, a capo dell’Ufficio
Istruzione della Procura, viene messo un altro magistrato: Antonio Caponnetto.
Anche lui è un personaggio molto importante.
Non è un personaggio da tragedia
come Totò Riina o Leoluca Bagarella, è un eroe tranquillo, un eroe borghese. Un
uomo dello Stato che ad essere eroe, probabilmente, non ci teneva neanche, ma
che gli è toccato esserlo. Dopo la morte di Rocco Chinnici sente che deve fare
qualcosa e che deve farlo subito e proprio li dove lo Stato sta combattendo
quella vera e propria guerra: in Sicilia!
Antonino Caponnetto è anziano, è
vicino alla pensione e viene da Firenze anche se è siciliano d’origine. Sembra
che non c’entri niente con la lotta alla mafia; e invece no. Antonino Caponnetto
si chiude nel suo ufficio in tribunale e ne esce soltanto per andare a dormire
in una stanza nella caserma della Guardia di Finanza e comincia a lavorare.
Il giudice Caponnetto ha un’idea
maturata sull’esperienza che sta facendo, a Torino, un altro magistrato che si
chiama Giancarlo Caselli e che lotta contro il terrorismo. L’idea è molto
semplice: se ad occuparsi dell’indagine è un magistrato solo è facile
intimidirlo, farlo rimuovere o, meglio, ammazzarlo; invece per ragioni di
continuità, di sicurezza, di scambio di idee e di informazioni, il magistrato
che fa le indagini non deve essere solo, deve lavorare insieme ad altri, deve
far parte di un gruppo. Il gruppo di magistrati che si occupano di combattere la
mafia a Palermo ed in sicilia nasce il 16 novembre 1983. All’inizio ne fanno
parte tre magistrati, a cui poi si aggiungerà anche Leonardo Guarnotta: Giuseppe
di Lello, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Nelle loro indagini, Giovanni
Falcone ed i magistrati del gruppo, hanno in mano un’arma nuova per la lotta
alla mafia: i pentiti.
Capitolo 12 – I collaboratori di Giustizia.
Nella guerra di mafia degli anni
ottanta c’era stata una mafia vincente: quella di Totò Riina; ed una mafia
perdente: quella dei suoi avversari. Molti restano a terra coperti da un telo
insanguinato o finiscono sciolti nell’acido. Alcuni passano dalla parte
vincente, altri invece si pentono e accettano di collaborare con la giustizia.
In altre parole: per salvarsi la pelle si mettono sotto la protezione della
legge. Tra questi, il più grosso, il più importante, è Tommaso Buscetta. Lo
chiamano il boss dei due mondi perchè ha coordinato il traffico di stupefacenti
fra la Sicilia, gli Stati Uniti ed il Brasile. E’ anche lui un personaggio da
romazo: è inquieto, potente, attivo ed è anche uno di quelli che fanno parte del
gruppo dei perdenti. Come dirà lui stesso: “Sono un uomo che è semère salito sul
carro dei perdenti, quasi fosse una vocazione.”.
Don Masino Buscetta viene
arrestato a San Paolo del Brasile il 24 Ottobre del 1983. Estradato in Italia,
il 16 Luglio dell’anno successivo comincia a parlare. Prima con uno sbirro:
Gianni De Gennaro, che allora era capo della Criminalpol e poi capo della
Polizia, ed è il poliziotto che è stato dietro a molte delle indagini vincenti
di quegli anni; poi con Giovanni Falcone.
Buscetta è preciso e puntuale in
ogni spiegazione: “Il fenomeno mafioso non è la delinquenza comune, non è il
brigatismo, non è la solita criminalità. Perchè della solita criminalità la
polizia se ne intende, la conosce e la combatte bene. Il fenomeno mafioso è
qualcosa di più importante della criminalità comune: è la criminalità più
l’intelligenza e più l’omertà. E’ una cosa ben diversa.”
Giovanni Falcone dirà che
Buscetta è stato come un professore di lingue che ti permette di andare dai
Turchi senza essere costreto a parlare con i gesti. Racconta tutto di una mafia
di cui, sino a quel momento, non si sapeva quasi niente. Fin nei dettagli che
solo chi ha fatto parte attiva dei vertici di cosa nostra può conoscere: “La
commissione interprovinciale tratta gli interessi che vanno al di sopra dei
problemi della piccola borgata. Se si dovesse decidere... – è un esempio - ...
se si dovesse decidere un colpo di stato si riunirebbe la commissione
interprovinciale. La seduta è segreta.”
Parla però anche di politica Don
Masino, ne parla a poco a poco, nel corso degli anni. Inizia parlando di “Don
Vito Ciancimino”. Poi parla anche dei cugini Nino ed Ignazio Salvo; esponeneti
della Democrazia Cristiana. Che gestiscono la riscossione dei tributi in
Sicilia. Uomini d’onore della famiglia di Salemi, in provincia di Trapani. Parla
anche di Salvo Lima. Parla di politica ma non dice tutto e non subito il nostro
Don Masino. “Signor Giudice” dirà a Falcone “se io parlo di certe cose lei sarà
ucciso ed io sarò preso per pazzo!”. Non si fida Don Masino; si ricorda di
quello che è successo a Leonardo Vitale, forse l’unico vero pentito, nel senso
letterale del termine, nella storia dei pentiti di mafia.
Nel 1973 Leuccio Vitale parla:
racconta tutto della mafia; parla anche dei suoi referenti politici e fa i nomi
di principi ed assessori. Non viene creduto. Le sue dicharazioni vengono
ritenute attendibili ma lui finisce in un manicomio criminale e, quando esce,
naturalmente, lo ammazzano.
Questa è la trascrizione di uno
stralcio di una intervista rilasciata dal Vitale proprio pochi giorni prima di
essere ucciso:
“L’aver parlato le è costato molto? L’hanno isolata? L’hanno minacciata?”
“Sette anni di carcere e adesso sono quattro mesi che sto a soggiorno obbligato”
“Quando lei parlò e dichiarò tutto sulla mafia la reputarono pazzo, semi infermo
mentale, mi pare?” “Si”
“Lei invece è...”
“Perchè? Perchè mi hanno dichiarato semi infermo mentale? Lo sa che non è mai
stato detto? Ne al processo ne da altre parti!”
“Perchè lo fecero allora?”
“Mai detto il perché!”
“Si, dico, ma, secondo lei, perchè?”
“Perchè? Boh?”
“Per ritenerla meno attendibile? Meno credibile?”
“Eh.. ecco! Si, appunto!”
Ma adesso i tempi sono
cambiati. Don Masino, alla fine, parla; ed, insieme a lui, parlano anche boss
del calibro di Francesco Marino Mannoia, Salvatore Contorno e Antonino
Calderone.
Tutto questo: le rivelazioni dei
pentiti, le indagini dei magistrati del gruppo e degli sbirri di De Gennaro, le
intercettazioni, i pedinamenti, le carte; portano ad un a serie di
incriminazioni a carico di uomini di mafia; portano a centinaia di arresti in un
giorno solo. Il blitz di San Michele, lo hanno chiamato. Portano, infine, al
maxiprocesso.
Capitolo
13 – Il punto di non ritorno.
Come li vive quei giorni
Francesca? Cosa fa la moglie di un magistrato come Giovanni Falcone? Ci sono
tutti quei dati da raccogliere; tutte quelle carte da scrivere per l’ordinanza
di rinvio a giudizio; a volte Giovanni sparisce e con gli altri magistrati del
gruppo va nei luoghi meno probabili. Gran parte dell’ordinanza di rinvio a
giudizio, per esempio, viene scritta sul tavolo da Ping Pong del giudice Ayala,
nella sua villa a Mondello. Protetta, per quelle occasioni, dai Carabinieri.
Poi, un giorno, all’improvviso, Francesca è costretta a tornare di corsa a casa
dal lavoro. Perchè? Semplice: c’è un aereo militare che deve prendere lei,
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e la sua famiglia e portarli tutti quanti
nella foresteria del supercarcere dell’asinara. Ma perchè tutta quela fretta?
Perchè, nemmeno a dirlo, sono in grave, gravissimo ed estremo pericolo. Li,
chiusi li dentro assieme alle famiglie, i due magistrati del gruppo ci restano
settimane. Fino a che non arriva il momento di tornare a casa. Prima però devono
pagare di tasca loro le spese di alloggio all’Amministrazione Penitenziaria!
Il maxiprocesso inizia a Palermo
il 10 Febbraio 1986. 474 imputati! Tra questi ci sono nomi del calibro di
Luciano Liggio che si presenta in aula con un grosso sigaro cubano come i boss
dei film americani; Pippo Calò, detto il cassiere della mafia
... ... ... ... ... ...
 sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo
compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.
Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.
Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una
brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,
quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.
sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo
compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.
Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.
Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una
brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,
quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.
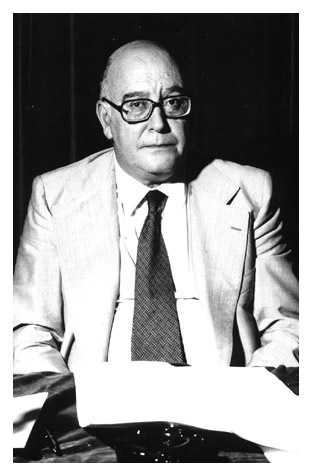 perchè
c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I
delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice
istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a
Corleone.
perchè
c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I
delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice
istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a
Corleone.  semplicemente un uscere. E’ un
giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e
meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a
capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di
nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una
passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e
ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere
al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato
responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,
solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.
Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava
solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle
taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei
mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di
Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,
come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,
lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i
corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,
Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne
vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.
Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto
prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi.
semplicemente un uscere. E’ un
giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e
meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a
capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di
nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una
passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e
ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere
al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato
responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,
solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.
Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava
solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle
taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei
mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di
Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,
come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,
lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i
corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,
Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne
vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.
Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto
prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi. processo: “Sono un
quinta elementare!”. Ma per fare carriera in Cosa Nostra non c’è bisogno di una
laurea. Lui comincia presto: uccide il suo primo uomo a diciannove anni in una
rissa; finisce in carcere, si fa sei anni, poi esce, torna a Corleone e continua
con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c’è un
aneddoto: Totò Riina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un
attentato, molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare,
rispettosamente e con molta cautela, perchè è difficile muovere un appunto a
Totò Riina, che per compiere quell’attentato bisogna sparare d’estate sulla
spiaggia e ci sono
processo: “Sono un
quinta elementare!”. Ma per fare carriera in Cosa Nostra non c’è bisogno di una
laurea. Lui comincia presto: uccide il suo primo uomo a diciannove anni in una
rissa; finisce in carcere, si fa sei anni, poi esce, torna a Corleone e continua
con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c’è un
aneddoto: Totò Riina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un
attentato, molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare,
rispettosamente e con molta cautela, perchè è difficile muovere un appunto a
Totò Riina, che per compiere quell’attentato bisogna sparare d’estate sulla
spiaggia e ci sono
 molti bambini. Potrebbero morire dei bambini. “E allora?”
dice Totò Riina. “Anche a Sarajevo muoiono i bambini!”. Ecco, questo è il modo
di concepire gli affari di Cosa Nostra che ha Totò Riina: come una guerra; una
guerra da vincere a tutti i costi e contro tutti. Questo è Riina Salvatore; e
Leoluca Bagarella è il suo braccio destro. E’ anche lui un personaggio da
romanzo; uno dei capi più sanguinari di Cosa Nostra. Per raccontare Luchino
Bagarella c’è una fotografia: Bagarella assieme a sette carabinieri che faticano
a tenerlo fermo. Siamo negli anni settanta: Leoluca Bagarella è all’inizio della
sua carriera nella mafia ma è già latitante. E’ stato fermato dai carabinieri
per un controllo casuale, insieme ad una ragazza, e poi portato in caserma ma
non è stato riconosciuto. Bagarella ha fretta di andarsene, non vuole farsi
riconoscere. Soprattutto non vuole compromettere la ragazza che è con lui e che
poi diventerà sua moglie. Ma proprio mentre sta uscendo dalla caserma, nel
corridoio, incontra un maresciallo dei carabinieri che lo riconosce. Ce ne
vogliono sette di carabinieri per bloccarlo, immobilizzarlo e riportarlo dentro.
molti bambini. Potrebbero morire dei bambini. “E allora?”
dice Totò Riina. “Anche a Sarajevo muoiono i bambini!”. Ecco, questo è il modo
di concepire gli affari di Cosa Nostra che ha Totò Riina: come una guerra; una
guerra da vincere a tutti i costi e contro tutti. Questo è Riina Salvatore; e
Leoluca Bagarella è il suo braccio destro. E’ anche lui un personaggio da
romanzo; uno dei capi più sanguinari di Cosa Nostra. Per raccontare Luchino
Bagarella c’è una fotografia: Bagarella assieme a sette carabinieri che faticano
a tenerlo fermo. Siamo negli anni settanta: Leoluca Bagarella è all’inizio della
sua carriera nella mafia ma è già latitante. E’ stato fermato dai carabinieri
per un controllo casuale, insieme ad una ragazza, e poi portato in caserma ma
non è stato riconosciuto. Bagarella ha fretta di andarsene, non vuole farsi
riconoscere. Soprattutto non vuole compromettere la ragazza che è con lui e che
poi diventerà sua moglie. Ma proprio mentre sta uscendo dalla caserma, nel
corridoio, incontra un maresciallo dei carabinieri che lo riconosce. Ce ne
vogliono sette di carabinieri per bloccarlo, immobilizzarlo e riportarlo dentro.  sanguinaria dei suoi compagni. Però lo chiamano anche “Binnu”, che significa
Bernardo, “u tratturi”, il trattore; per la sua volontà ferrea ma anche perchè
dove passa lui non cresce nemmeno più l’erba. Ci penserà poco più avanti a
dimostrare la proprietà di quel soprannome, quando un gruppo di mafiosi
travestiti da agenti di polizia fa irruzione nel covo di una famiglia rivale in
Viale Lazio a Palermo. Devono uccidere tutti, recuperare dei documenti
compromettenti e poi dare fuoco a tutto l’appartamento. Vogliono giocare sulla
sorpresa, su quel travestimento, come Al Capone a Chicago nella strage di San
Valentino; ma uno dei mafiosi travestiti ha troppa fretta e si mette a sparare
subito bruciando l’effetto sorpresa e facendo saltare la trappola. In
quell’appartamento si scatena l’inferno: passano tre minuti in cui tutti sparano
contro
sanguinaria dei suoi compagni. Però lo chiamano anche “Binnu”, che significa
Bernardo, “u tratturi”, il trattore; per la sua volontà ferrea ma anche perchè
dove passa lui non cresce nemmeno più l’erba. Ci penserà poco più avanti a
dimostrare la proprietà di quel soprannome, quando un gruppo di mafiosi
travestiti da agenti di polizia fa irruzione nel covo di una famiglia rivale in
Viale Lazio a Palermo. Devono uccidere tutti, recuperare dei documenti
compromettenti e poi dare fuoco a tutto l’appartamento. Vogliono giocare sulla
sorpresa, su quel travestimento, come Al Capone a Chicago nella strage di San
Valentino; ma uno dei mafiosi travestiti ha troppa fretta e si mette a sparare
subito bruciando l’effetto sorpresa e facendo saltare la trappola. In
quell’appartamento si scatena l’inferno: passano tre minuti in cui tutti sparano
contro
 tutti. Alla fine restano a terra cinque morti e tre feriti. Una strage
che passerà alle cronache come la strage di Viale Lazio. Nel gruppo dei mafiosi
travestiti c’era anche lui, Bernardo Provenzano. Gli altri vorrebbero scappare;
quelli della famiglia avversaria sono morti tutti. Anche il loro capo, Michele
Cavataio, e tra poco arriverà la polizia, quella vera... ma lui no. Provenzano
non vuole ancora andarsene perchè vuole controllare. Tira fuori il capo della
famiglia avversaria da sotto la scrivania sotto la quale è caduto e lo gira, ma
Cavataio si volta di scatto puntandogli in faccia una pistola. Spara; ma a
vuoto, perchè ha finito i colpi. Prova a sparare anche Provenzano ma la sua
mitraglietta si inceppa. Allora colpisce Cavataio alla testa con il calcio
dell’arma, prende un’altra pistola e lo finisce. Questo è Bernardo Provenzano,
Binnu u tratturi.
tutti. Alla fine restano a terra cinque morti e tre feriti. Una strage
che passerà alle cronache come la strage di Viale Lazio. Nel gruppo dei mafiosi
travestiti c’era anche lui, Bernardo Provenzano. Gli altri vorrebbero scappare;
quelli della famiglia avversaria sono morti tutti. Anche il loro capo, Michele
Cavataio, e tra poco arriverà la polizia, quella vera... ma lui no. Provenzano
non vuole ancora andarsene perchè vuole controllare. Tira fuori il capo della
famiglia avversaria da sotto la scrivania sotto la quale è caduto e lo gira, ma
Cavataio si volta di scatto puntandogli in faccia una pistola. Spara; ma a
vuoto, perchè ha finito i colpi. Prova a sparare anche Provenzano ma la sua
mitraglietta si inceppa. Allora colpisce Cavataio alla testa con il calcio
dell’arma, prende un’altra pistola e lo finisce. Questo è Bernardo Provenzano,
Binnu u tratturi. semplice
parroco di borgata che ha preso i voti nel 1960 e sta a sette cannoli, un
quartiere di Palermo che sta vicino a brancaccio, quello in cui è nato. Don
Pino, un prete, un semplice sacerdote di borgata. Il secondo invece è un uomo
politico. Si chiama Salvo Lima ed è un uomo politico molto importante. Deputato
alla camera nelle liste della Democrazia Cristiana, eletto con ottantamila voti,
da un anno ha lasciato la corrente di Amintore Fanfani per transitare in quella
di Giulio Andreotti. E’ un uomo imponenete, il fazzoletto candido sempre nel
taschino della giacca, le sigarette fumate con un corto
semplice
parroco di borgata che ha preso i voti nel 1960 e sta a sette cannoli, un
quartiere di Palermo che sta vicino a brancaccio, quello in cui è nato. Don
Pino, un prete, un semplice sacerdote di borgata. Il secondo invece è un uomo
politico. Si chiama Salvo Lima ed è un uomo politico molto importante. Deputato
alla camera nelle liste della Democrazia Cristiana, eletto con ottantamila voti,
da un anno ha lasciato la corrente di Amintore Fanfani per transitare in quella
di Giulio Andreotti. E’ un uomo imponenete, il fazzoletto candido sempre nel
taschino della giacca, le sigarette fumate con un corto bocchino nero sempre fra
i denti; Salvo Lima è un uomo che parla poco, che sembra chiuso perennemente in
un freddo assoluto distacco. In realtà, però, si tratta dell’uomo politico più
potente di tutta la sicilia. E’ un uomo chiacchierato l’onorevole Lima. Nella
relazione della prima commissione antimafia viene nominato ben 162 volte! Ha poi
ben due uomini d’onore all’interno della sua corrente nella DC di Palermo. Per
11 volte viene richiesta l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti; e per
quattro volte viene anche concessa... anche se, ovviamente, non si arriva a
nessun processo. Dal 1959 al 1963 Salvo Lima è il sindaco di Palermo ed ha un
assessore ai lavori pubblici che si chiama Vito Ciancimino. Magro, con i baffi
stretti sulle labbra e la voce roca per il fumo delle mille sigarette, quando
arriva a Palermo da Corleone, dove è nato, subito dopo la guerra, Vito
Ciancimino possiede soltanto il suo diploma di Geometra. Poi, all’improvviso,
vince un importante appalto per le ferrovie. Sono suoi i carrelli ferroviari,
quelli che
bocchino nero sempre fra
i denti; Salvo Lima è un uomo che parla poco, che sembra chiuso perennemente in
un freddo assoluto distacco. In realtà, però, si tratta dell’uomo politico più
potente di tutta la sicilia. E’ un uomo chiacchierato l’onorevole Lima. Nella
relazione della prima commissione antimafia viene nominato ben 162 volte! Ha poi
ben due uomini d’onore all’interno della sua corrente nella DC di Palermo. Per
11 volte viene richiesta l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti; e per
quattro volte viene anche concessa... anche se, ovviamente, non si arriva a
nessun processo. Dal 1959 al 1963 Salvo Lima è il sindaco di Palermo ed ha un
assessore ai lavori pubblici che si chiama Vito Ciancimino. Magro, con i baffi
stretti sulle labbra e la voce roca per il fumo delle mille sigarette, quando
arriva a Palermo da Corleone, dove è nato, subito dopo la guerra, Vito
Ciancimino possiede soltanto il suo diploma di Geometra. Poi, all’improvviso,
vince un importante appalto per le ferrovie. Sono suoi i carrelli ferroviari,
quelli che  trasportano le merci per la stazione di Palermo. Anche Vito
Ciancimino è un personaggio molto chiacchierato; la commissione antimafia lo
definisce “un personaggio simbolo della penetrazione mafiosa all’interno del
comune di Palermo”.
trasportano le merci per la stazione di Palermo. Anche Vito
Ciancimino è un personaggio molto chiacchierato; la commissione antimafia lo
definisce “un personaggio simbolo della penetrazione mafiosa all’interno del
comune di Palermo”.  centro, in viale della Libertà, in mezzo alle ville liberty, c’erano grandi
cespugli di gelsomino. Che d’estate fiorivano e facevano di quello l’odore
caratteristico di Palermo. Proprio l’odore di Gelsomino. Il centro della vita
culturale della città era il Teatro Bellini, che aveva un ristorante all’aperto
dove, d’estate, si vendevano le “sponse”; piccoli bouquet di citronella e
gelsomino. Profumatissimi, naturalmente!
centro, in viale della Libertà, in mezzo alle ville liberty, c’erano grandi
cespugli di gelsomino. Che d’estate fiorivano e facevano di quello l’odore
caratteristico di Palermo. Proprio l’odore di Gelsomino. Il centro della vita
culturale della città era il Teatro Bellini, che aveva un ristorante all’aperto
dove, d’estate, si vendevano le “sponse”; piccoli bouquet di citronella e
gelsomino. Profumatissimi, naturalmente!  ai
lavori publici sventrano il centro di Palermo. Abbattono i palazzi e li
sostituiscono con casermoni e grattaceli. Coprono di cemento le periferie.
Tolgono il vincolo ad aree adibite a verde pubblico e coprono di cemento anche
quelle. In quattro anni vengono concesse 4205 licenze edilizie, ma sono licenze
strane: 3011 licenze, circa l’80%, sono intestate sempre alle solite cinque
persone. Cinque semplici mastri muratori, sconosciuti e quasi nullatenenti, dei
prestanome insomma!
ai
lavori publici sventrano il centro di Palermo. Abbattono i palazzi e li
sostituiscono con casermoni e grattaceli. Coprono di cemento le periferie.
Tolgono il vincolo ad aree adibite a verde pubblico e coprono di cemento anche
quelle. In quattro anni vengono concesse 4205 licenze edilizie, ma sono licenze
strane: 3011 licenze, circa l’80%, sono intestate sempre alle solite cinque
persone. Cinque semplici mastri muratori, sconosciuti e quasi nullatenenti, dei
prestanome insomma! ma che lo deve diventare.
Una bella serata di fine settembre, e magari sta pensando che compie gli anni:
quaranta e passa! Più della metà di una vita. Ma per una come lei ci sono ancora
un sacco di cose da fare. Se non si è guardata attorno non si è accorta che ci
sono due uomini che la stanno seguendo. Se non si è guardata attorno non si è
accorta che sono giovani e che camminano decisi, non come se stessero
passeggiando, ma come se volessero andare dove sta andando lei. Ma anche se si
fosse voltata a guardarsi attorno, come una volta era solita fare di abitudine,
quella donna difficilmente si sarebbe accorta che uno di quegli uomini, sotto il
giubbotto nasconde una pistola.
ma che lo deve diventare.
Una bella serata di fine settembre, e magari sta pensando che compie gli anni:
quaranta e passa! Più della metà di una vita. Ma per una come lei ci sono ancora
un sacco di cose da fare. Se non si è guardata attorno non si è accorta che ci
sono due uomini che la stanno seguendo. Se non si è guardata attorno non si è
accorta che sono giovani e che camminano decisi, non come se stessero
passeggiando, ma come se volessero andare dove sta andando lei. Ma anche se si
fosse voltata a guardarsi attorno, come una volta era solita fare di abitudine,
quella donna difficilmente si sarebbe accorta che uno di quegli uomini, sotto il
giubbotto nasconde una pistola.  personaggi femminili. Questa è una storia di mafia. Di guardie e di ladri. E
fare la guardia o il ladro è sempre stato e, ai massimi livelli, dove si gioca
duro, lo è ancora, un mestiere da uomini. Però, in questo romanzo, ci sono anche
le donne; e, anche loro, sono personaggi da romanzo. Ce n’è una che si chiama
Francesca. E’ una bella donna; molto dolce
e riservata ma anche molto decisa. E’ una donna di legge. Viene da una famiglia
di magistrati ed è un magistrato anche lei; prima presso la procura dei minori e
poi come consigliere presso la corte d’appello di Palermo. Ma non è per questo
che è costretta a vivere blindata dietro la porta di una villetta che ha da una
parte una bellissima pianta di magnolia, e dall’altra una garitta con il vetro
antiproiettile e guardie armate dentro. E’ perchè è la compagna di una altro
magistrato, un giudice istruttore presso la procura di Palermo che si chiama
Giovanni Falcone. Quando lo conosce, Francesca ha trentacinque anni e lui ne ha
quarantadue. E’ una donna di legge Francesca e quindi sa come vanno certe cose,
e poi ama quell’uomo; e per lui è disposta a sopportare l’elicottero che gira
sopra il tetto della villa tutte le volte che lui torna a casa con tre uomini
armati dentro l’ascensore e altri due che salgono le scale, piano per piano, con
le pistole in mano. E’ disposta, Francesca, a sopportare il fatto di uscire da
sola per comprare le cose che a lui servono. Di uscire da sola con la sua
macchina per andare a casa di amici, quando escono la sera a cena, mentre
Giovanni Falcone arriva per un’altra strada, con quattro auto blindate con
dentro uomini armati con il mitra e che indossano i giubbotti antiproiettile.
personaggi femminili. Questa è una storia di mafia. Di guardie e di ladri. E
fare la guardia o il ladro è sempre stato e, ai massimi livelli, dove si gioca
duro, lo è ancora, un mestiere da uomini. Però, in questo romanzo, ci sono anche
le donne; e, anche loro, sono personaggi da romanzo. Ce n’è una che si chiama
Francesca. E’ una bella donna; molto dolce
e riservata ma anche molto decisa. E’ una donna di legge. Viene da una famiglia
di magistrati ed è un magistrato anche lei; prima presso la procura dei minori e
poi come consigliere presso la corte d’appello di Palermo. Ma non è per questo
che è costretta a vivere blindata dietro la porta di una villetta che ha da una
parte una bellissima pianta di magnolia, e dall’altra una garitta con il vetro
antiproiettile e guardie armate dentro. E’ perchè è la compagna di una altro
magistrato, un giudice istruttore presso la procura di Palermo che si chiama
Giovanni Falcone. Quando lo conosce, Francesca ha trentacinque anni e lui ne ha
quarantadue. E’ una donna di legge Francesca e quindi sa come vanno certe cose,
e poi ama quell’uomo; e per lui è disposta a sopportare l’elicottero che gira
sopra il tetto della villa tutte le volte che lui torna a casa con tre uomini
armati dentro l’ascensore e altri due che salgono le scale, piano per piano, con
le pistole in mano. E’ disposta, Francesca, a sopportare il fatto di uscire da
sola per comprare le cose che a lui servono. Di uscire da sola con la sua
macchina per andare a casa di amici, quando escono la sera a cena, mentre
Giovanni Falcone arriva per un’altra strada, con quattro auto blindate con
dentro uomini armati con il mitra e che indossano i giubbotti antiproiettile.  si è
svolta all’inizio degli anni sessanta. Ma la seconda guerra di mafia è molto
diversa dalla prima, perchè la prima fu uno scontro fra gruppi e fazioni
contrapposte, mentre la seconda non vide uno scontro di questo genere. La
differenza sta nel fatto che i morti ammazzati (come si suol dire) che, per
altro, furono numerosissimi, forse mille in un biennio soltanto a Palermo,
furono solo e soltanto da una singola parte. Per questa ragione, più che di una
vera e propria guerra, possiamo a ragion veduta parlare di una specie di
“golpe”; un colpo di stato fatto dalla “commissione” ed, all’interno della
commissione, da una fazione composta essenzialmente dai corleonesi. A questo
punto è necessario chiarire chi erano gli avversari dei corleonesi. Gli
avversari dei corleonesi erano quelle cosche, quei gruppi, legati a Stefano
Bontade soprattutto, ed anche agli Inzerillo, che avevano fatto una quantità
enorme di denaro con il commercio di droga con gli Stati Uniti, la cosiddetta
“Pizza connection”. In pratica la seconda guerra di mafia fu un feroce scontro
fra il denaro (gli Inzerillo ed i Bontade) e potere militare (i corleonesi).
Nell’immediato si risolse in una enorme vittoria di questi ultimi.
si è
svolta all’inizio degli anni sessanta. Ma la seconda guerra di mafia è molto
diversa dalla prima, perchè la prima fu uno scontro fra gruppi e fazioni
contrapposte, mentre la seconda non vide uno scontro di questo genere. La
differenza sta nel fatto che i morti ammazzati (come si suol dire) che, per
altro, furono numerosissimi, forse mille in un biennio soltanto a Palermo,
furono solo e soltanto da una singola parte. Per questa ragione, più che di una
vera e propria guerra, possiamo a ragion veduta parlare di una specie di
“golpe”; un colpo di stato fatto dalla “commissione” ed, all’interno della
commissione, da una fazione composta essenzialmente dai corleonesi. A questo
punto è necessario chiarire chi erano gli avversari dei corleonesi. Gli
avversari dei corleonesi erano quelle cosche, quei gruppi, legati a Stefano
Bontade soprattutto, ed anche agli Inzerillo, che avevano fatto una quantità
enorme di denaro con il commercio di droga con gli Stati Uniti, la cosiddetta
“Pizza connection”. In pratica la seconda guerra di mafia fu un feroce scontro
fra il denaro (gli Inzerillo ed i Bontade) e potere militare (i corleonesi).
Nell’immediato si risolse in una enorme vittoria di questi ultimi.  Siamo alla fine degli anni
settanta. Il predominio su cosa nostra è conteso fra due frazioni: da una parte
quella delle famiglie Bontade, Inzerillo e Badalamenti (il cui capo è Stefano
Bontade, detto “il principe di Villa Grazia”); dall’altra i corleonesi.
Siamo alla fine degli anni
settanta. Il predominio su cosa nostra è conteso fra due frazioni: da una parte
quella delle famiglie Bontade, Inzerillo e Badalamenti (il cui capo è Stefano
Bontade, detto “il principe di Villa Grazia”); dall’altra i corleonesi. siciliana. Raramente le indagini erano riuscite ad entrare nei santuari dei
soldi mafiosi che erano gli istituti di credito siciliani. L’esplosione del
benessere di cosa nostra coincide con l’avvento degli stupefacenti. Cosa nostra
si fa insieme produttrice e grande distributrice dell’eroina in un primo tempo e
della cocaina in un secondo. Ovviamente tutto ciò porta ad avere una valanga di
soldi a disposizione. Che avevano bisogno di essere occultati dietro facciate
rispettabili o, più semplicemente, nascosti in luoghi sicuri. Tutto questo
avviene con la complicità più o meno cosciente degli istituti di credito
siciliani e con una sorta di inspiegabile cecità degli uffici investigativi che,
pur avendone gli strumenti, non riuscivano a penetrare in queste banche colluse
con il sistema di potere mafioso.
siciliana. Raramente le indagini erano riuscite ad entrare nei santuari dei
soldi mafiosi che erano gli istituti di credito siciliani. L’esplosione del
benessere di cosa nostra coincide con l’avvento degli stupefacenti. Cosa nostra
si fa insieme produttrice e grande distributrice dell’eroina in un primo tempo e
della cocaina in un secondo. Ovviamente tutto ciò porta ad avere una valanga di
soldi a disposizione. Che avevano bisogno di essere occultati dietro facciate
rispettabili o, più semplicemente, nascosti in luoghi sicuri. Tutto questo
avviene con la complicità più o meno cosciente degli istituti di credito
siciliani e con una sorta di inspiegabile cecità degli uffici investigativi che,
pur avendone gli strumenti, non riuscivano a penetrare in queste banche colluse
con il sistema di potere mafioso.  comune per diciassette.
Francese scrive anche degli interessi dei corleonesi per società immobiliari
come la “Ri.Sa.” che altro non è che un acronimo rappresentante la contrazione
di Riina Salvatore!
comune per diciassette.
Francese scrive anche degli interessi dei corleonesi per società immobiliari
come la “Ri.Sa.” che altro non è che un acronimo rappresentante la contrazione
di Riina Salvatore! mercato della Vucciria, a Palermo, quando entrano alcune persone che si mettono
a sparare e che uccidono tre uomini. Mario Francese ha il coraggio di uscire a
chiamare il 113! E, come se non bastasse, racconta anche tutto alla polizia e lo
scrive anche sul giornale! “Cosa vuole quel giornalista?”, “Perchè non si fa gli
affari suoi?”, “Perchè si ostina a scrivere la verità?”.
mercato della Vucciria, a Palermo, quando entrano alcune persone che si mettono
a sparare e che uccidono tre uomini. Mario Francese ha il coraggio di uscire a
chiamare il 113! E, come se non bastasse, racconta anche tutto alla polizia e lo
scrive anche sul giornale! “Cosa vuole quel giornalista?”, “Perchè non si fa gli
affari suoi?”, “Perchè si ostina a scrivere la verità?”. 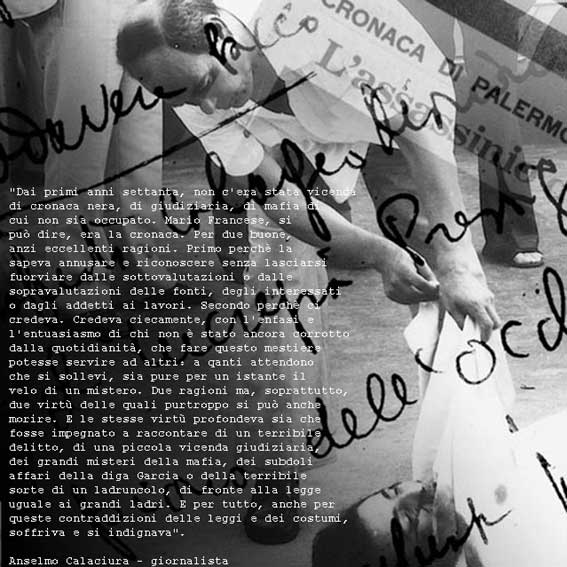 Ne discende un uomo che indossa un
elegante cappotto scuro. E’ Leoluca Bagarella che prende la mira e gli spara
quattro colpi in testa con una Smith e Wesson calibro 38. Poi si avvicina,
guarda se lo ha colpito, torna alla macchina, e si allontana lentamente; come se
non avesse nessuna paura di essere visto o riconosciuto da qualcuno. Così muore
Mario Francese.
Ne discende un uomo che indossa un
elegante cappotto scuro. E’ Leoluca Bagarella che prende la mira e gli spara
quattro colpi in testa con una Smith e Wesson calibro 38. Poi si avvicina,
guarda se lo ha colpito, torna alla macchina, e si allontana lentamente; come se
non avesse nessuna paura di essere visto o riconosciuto da qualcuno. Così muore
Mario Francese.  Palermo. Anche Giuliano è uno bravo, uno che
non molla, uno che vuole scoprire la verità. Indaga sul traffico di stupefacenti
che dalla sicilia arriva fino agli Stati Uniti e fa sequestrare un carico di
eroina, per un valore di tre miliardi delle vecchie lire, in un appartamento di
Palermo. Collabora con gli investigatori americani e fa sequestrare droga anche
a New York. Ma più che la droga, il vicequestore Giuliano, cerca i soldi! Vuole
trovare le banche ed i finanzieri che riciclano i soldi della mafia siciliana. E
quanche filo di questa compessa trama in mano lui ce l’ha. Ha in mano un giro di
assegni che da Palermo arriva a Milano e
Palermo. Anche Giuliano è uno bravo, uno che
non molla, uno che vuole scoprire la verità. Indaga sul traffico di stupefacenti
che dalla sicilia arriva fino agli Stati Uniti e fa sequestrare un carico di
eroina, per un valore di tre miliardi delle vecchie lire, in un appartamento di
Palermo. Collabora con gli investigatori americani e fa sequestrare droga anche
a New York. Ma più che la droga, il vicequestore Giuliano, cerca i soldi! Vuole
trovare le banche ed i finanzieri che riciclano i soldi della mafia siciliana. E
quanche filo di questa compessa trama in mano lui ce l’ha. Ha in mano un giro di
assegni che da Palermo arriva a Milano e

 poi passa in Svizzera attraverso
finanzieri come Michele Sindona prima e Roberto Calvi poi.
poi passa in Svizzera attraverso
finanzieri come Michele Sindona prima e Roberto Calvi poi. Anche lui, non lo sa, ma è già morto. Luciano Liggio lo considera “il suo
peggior nemico”. La mattina del 25 settembre 1979 viene massacrato a colpi di
mitra mentre sta andando a lavorare, in macchina. Massacrano anche il suo
autista, il maresciallo Lenin Mancuso.
Anche lui, non lo sa, ma è già morto. Luciano Liggio lo considera “il suo
peggior nemico”. La mattina del 25 settembre 1979 viene massacrato a colpi di
mitra mentre sta andando a lavorare, in macchina. Massacrano anche il suo
autista, il maresciallo Lenin Mancuso.  Quegli ordini se li era dovuti
firmare tutti lui, il procuratore capo in persona, assumendosene tutta la
responsabilità; e non è di responsabilità legale o giuridica che stiamo
parlando. E’ il 6 Agosto 1980 ed il Dott. Costa sta curiosando in una bancarella
di libri usati, quando arriva un ragazzo in moto, scende, gli si avvicina, e gli
spara tre colpi. Fine della storia.
Quegli ordini se li era dovuti
firmare tutti lui, il procuratore capo in persona, assumendosene tutta la
responsabilità; e non è di responsabilità legale o giuridica che stiamo
parlando. E’ il 6 Agosto 1980 ed il Dott. Costa sta curiosando in una bancarella
di libri usati, quando arriva un ragazzo in moto, scende, gli si avvicina, e gli
spara tre colpi. Fine della storia. sono entrati proprio a Palermo. Ci entrarono
sia l’ufficio istruzione che la Procura. E, appunto, in questi templi sino ad
allora inviolati, venne fuori una verità, una realtà che nessuno facente parte
delle istituzioni sane avrebbe mai immaginato. Una realtà che nessuna persona
onesta conosceva. Cioè la ricchezza accumulata dalle “istituzioni mafiose”.
sono entrati proprio a Palermo. Ci entrarono
sia l’ufficio istruzione che la Procura. E, appunto, in questi templi sino ad
allora inviolati, venne fuori una verità, una realtà che nessuno facente parte
delle istituzioni sane avrebbe mai immaginato. Una realtà che nessuna persona
onesta conosceva. Cioè la ricchezza accumulata dalle “istituzioni mafiose”.  Via Bernini, nel quartiere dell’Uditore. Hanno quattro figli che Ninetta
partorisce nella Clinica Noto, una delle case di cura più importanti di Palermo,
e con il suo cognome: Bagarella Antonietta, detta Ninetta, in Riina!
Via Bernini, nel quartiere dell’Uditore. Hanno quattro figli che Ninetta
partorisce nella Clinica Noto, una delle case di cura più importanti di Palermo,
e con il suo cognome: Bagarella Antonietta, detta Ninetta, in Riina!  porte di Palermo, un contadino trova una Giulietta ferma su un viottolo. E’
strana quella macchina: ha una bombola di Gas appoggiata sul sedile posteriore
con una miccia in parte bruciacchiata. Siccome, in quei giorni, è in corso una
guerra di mafia e di auto ne sono saltate parecchie, il contadino chiama i
Carabinieri. Arrivano due artificeri dell’Esercito, un ufficiale con tre
Carabinieri ed un m.llo di Pubblica
porte di Palermo, un contadino trova una Giulietta ferma su un viottolo. E’
strana quella macchina: ha una bombola di Gas appoggiata sul sedile posteriore
con una miccia in parte bruciacchiata. Siccome, in quei giorni, è in corso una
guerra di mafia e di auto ne sono saltate parecchie, il contadino chiama i
Carabinieri. Arrivano due artificeri dell’Esercito, un ufficiale con tre
Carabinieri ed un m.llo di Pubblica Sicurezza. Ma appena l’ufficiale dei
Carabinieri tocca la macchina la bomba salta per aria uccidendoli tutti. Sette
morti: una vera e propria strage.
Sicurezza. Ma appena l’ufficiale dei
Carabinieri tocca la macchina la bomba salta per aria uccidendoli tutti. Sette
morti: una vera e propria strage. qui, da solo, in quest’ufficio. Lo vede questo telefono? Non squilla mai! Dove
sono i pieni poteri?”. Lo ammazzano il 3 settembre 1982, in macchina, assieme
alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all’agente Domenico Russo che li segue con
l’auto blindata.
qui, da solo, in quest’ufficio. Lo vede questo telefono? Non squilla mai! Dove
sono i pieni poteri?”. Lo ammazzano il 3 settembre 1982, in macchina, assieme
alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all’agente Domenico Russo che li segue con
l’auto blindata.