Jean Montalbano
il sonno del farmacista
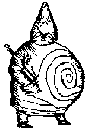
La pubblicazione di Batavia’s Graveyard da
parte di Mike Dash ha bruciato la gran mole di materiale che Simon Leys,
sinologo sui generis già autore di
scritti sul maoismo, Orwell e Gide, Malraux (accanto ad Omaggio alla Catalogna la prosa brumosa e flatulenta di L’Espoir
è solo “chiacchiera da caffè”) andava raccogliendo sul naufragio
“inaugurale” della nave olandese Batavia avvenuto nel 1629 lungo la nuova rotta
verso l’Indonesia. E’ lo stesso autore belga a ricordarlo nelle righe iniziali
di quello che presenta adesso come la traccia di un libro che avrebbe potuto
essere (Les naufragés du Batavia,
Arléa,2003): poche decine di pagine a ribadire la strana attrazione, anche
qui, non tanto per l’evento in sé (un naufragio al largo della costa
occidentale australiana non ancora colonizzata dai reietti britannici) quanto
per il dopo, ovvero la violenta istituzione e successiva (o contemporanea)
dissoluzione di una comunità di naufraghi. Tentativo reso possibile, e su questo
ormai molti concordano, dalla presenza a bordo di quel Jeronimus Cornelisz, già
farmacista, di ambiente anabattista e rosacrociano, pronto ad emulare, negli
stessi fallimenti, l’esperimento tentato un secolo prima da Giovanni di Leida a
Münster.
Critico delle icone che ci meritiamo e che
un’epoca finta e amnesiaca conserva nei suoi incasinati pantheon, Leys pare
essersi interessato alle vicende del Batavia per affinità marinaresche prima e
prossimità geografiche poi: ma nel trattamento severo del sogno dittatoriale di
Cornelisz ritorna lo spietato ed ironico osservatore che nel 1971 seppe rompere
l’incanto dei maolatri parigini che
ancora si affannavano a cercare significati “culturali” nelle stragi delle
bande maoiste.
Il racconto dell’antagonismo tra un commissario
della Compagnia delle Indie orientali deciso a salvare comunque i passeggeri
superstiti ed il suo vice, ex farmacista rovinato in cerca di rivincite (già
seguace di quel sulfureo Torrentius le cui opere pittoriche, in odore d’eresia,
furono distrutte per decreto nei tolleranti Paesi Bassi) viene scandito dalle
efferatezze “teatrali” montate da quest’ultimo che, rileggendo il copione
scritto dal re degli anabattisti, nei muri socializzati del crimine
prova a costringere la mercurialità nascente di una comunità altrimenti
sfuggente. Sotto la minaccia della penuria, ai trecento scampati, dispersi per
gradi di fedeltà nei poco più che scogli al largo della costa, uno psicopatico
sanguinario impone di rivivere per un centinaio di giorni, seguendo la nota
trafila di efferatezze, ricatti e abominii (non eccettuato un pizzico di
comunismo delle donne, invero poche già in partenza) l’incubo “comunitario”
della trasparenza assoluta, ravvivando il brivido inconsapevole ed estenuato
della fraternità del libero spirito.
Mentre in
Europa si consolidava la potenza assoluta dello Stato, agli antipodi lo
scellerato di turno provava ad elevargli un morente controcanto, ribadendo
nella carne di poche centinaia di sventurati (pur se il motto di Burke
ammonisce: “affinché il male trionfi tutto quanto occorre è che le brave
persone non facciano niente”) il ferro arrugginito dell’idea comunitaria:
quello che forse fu il primo insediamento europeo in terra australiana,
risultò, oltre le carte giudiziarie della spedita giustizia olandese (che al
criminale Cornelisz riservò, prima dell’impiccagione, il taglio delle mani) lo
stringato resoconto dell’inferno invocato e preparato da chi voleva offrirsi
paradisi in terra.