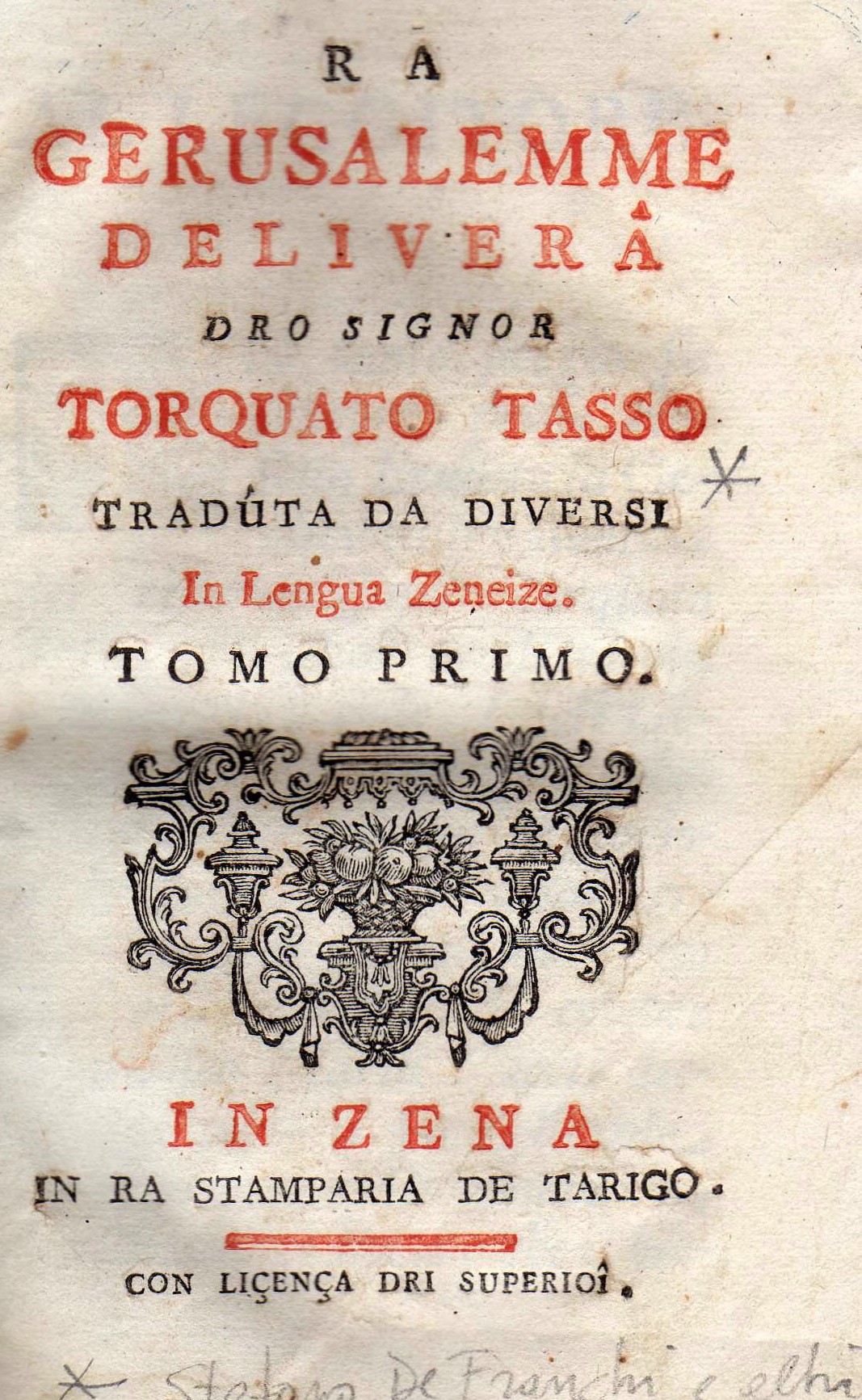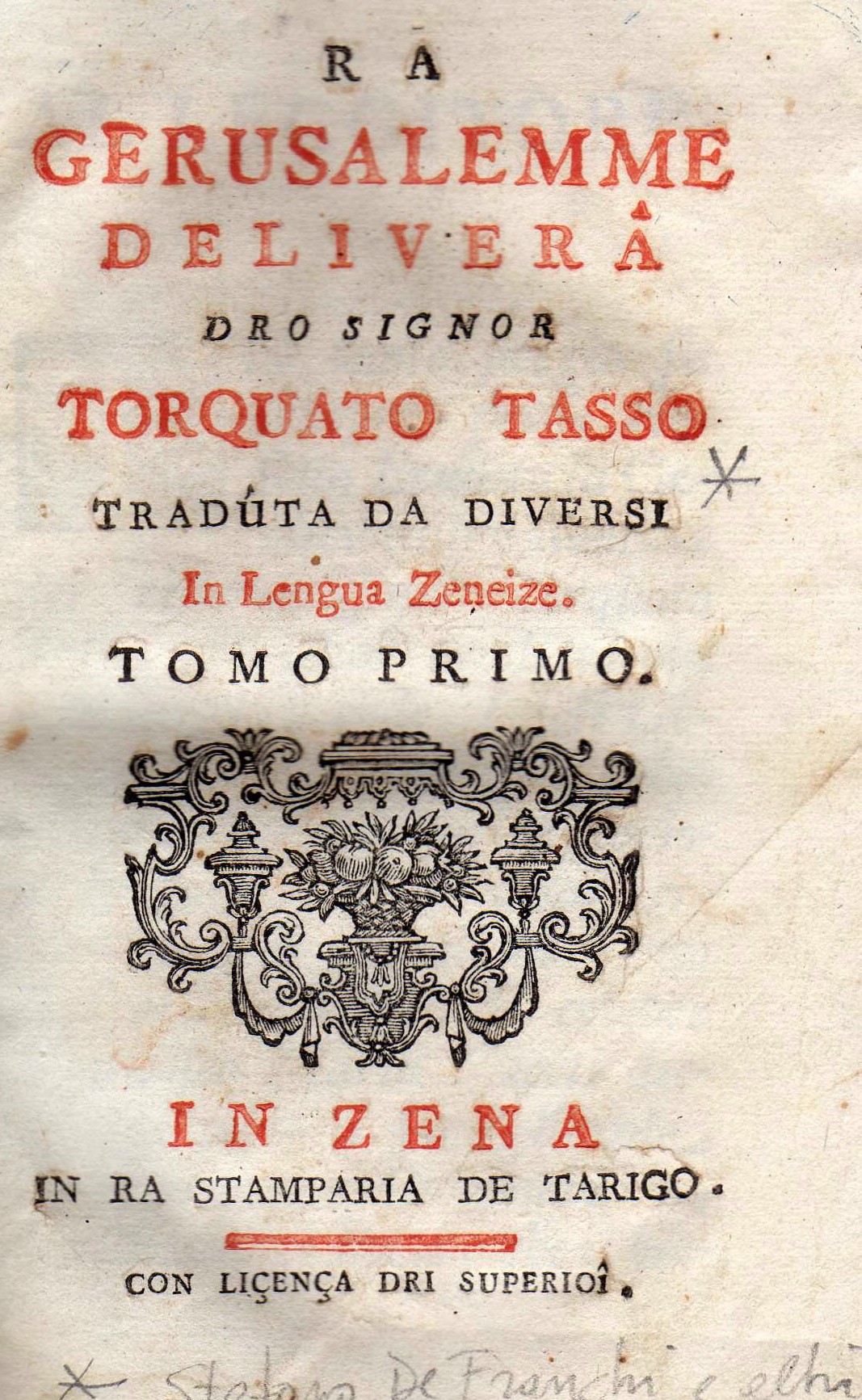
Nel 1755
compariva a Genova, in due volumi, "Ra Gerusalemme deliverà dro
Signor Torquato Tasso traduta in lengua zeneize", una versione in genovese
del capolavoro tassiano, ad opera di un'equipe di letterati cittadini,
diretti dal poeta Stefano De Franchi. Si tratta di un lavoro curioso ed
insolito, poiché gli autori non intesero eseguire una fedele traduzione
della Gerusalemme, come nel secolo successivo il Padre Federico Gazzo avrebbe
tradotto integralmente la Divina Commedia, ma neppure una parodia, un travestimento
burlesco, come già ne esistevano in vari dialetti italiani. I letterati
settecenteschi vollero invece rispettare sostanzialmente gli intendimenti
e la struttura narrativa dell'opera del Tasso, ma nello stesso tempo ri-crearla
da un punto di vista "genovese"; l'intero poema cavalleresco è così
riscritto come avrebbe potuto raccontarlo un genovese di allora. Nei traduttori
non mancò neppure l'intendimento di emulare e superare le traduzioni
già apparse fino ad allora in altri dialetti italiani, come si evince
da un sonetto prefatorio, che ad un certo punto afferma:
"Ro Dottô,
Pantalon, Xanni e Coviello
ro Tasso
han sbarattaòu tutti in buffon,
e son
stæti piaxùi da quest'e quello;
aoura se
à dî bon'ombre è bello e bon
ro Caporâ
Zeneize Darseniello
o starà
à vei chi passa à ro barcon?"
Come dire
che se le altre traduzioni, in bolognese (ro Dottô), in veneziano
(Pantalon), in bergamasco (Xanni ), in napoletano (Coviello), hanno cambiato
il Tasso in un buffone e hanno riscosso successo, la maschera genovese
del Caporale, non poteva rimanere indietro, capace com'è anche lui
di dire spiritosaggini. A dispetto di tale premessa, l'intonazione comica
affiora solo di tanto in tanto, nella Gerusalemme in genovese, restando
essa in genere molto al di sopra di altri tentativi analoghi, tipici di
un dialettalismo riflesso e tutto sommato poco interessante; infatti, si
può affermare che l'intera operazione si inscrive nel complesso
lavoro intrapreso dal De Franchi per arricchire la letteratura di espressione
genovese di opere valide e aggiornate, in un'ottica di esaltazione della
patria genovese. In un'epoca di sostanziale decadenza politica per la Repubblica
di Genova, quale fu il XVIII secolo, alcuni intellettuali avvertirono la
necessità di ricompattare le classi sociali attorno alla nobiltà,
rinfocolando il sentimento patriottico; a tale scopo, la letteratura in
genovese poté sembrare uno strumento particolarmente idoneo, per
l'uso identitario che ne era stato fatto nel corso dei secoli. Il De Franchi
volle così essere il poeta della "Naçion Zeneise", propugnando
tra l'altro moderate correzioni ad un assetto sociale e politico secolare
ormai sclerotico, cui rivolge moderatissime critiche nelle sue commedie.
Quella del De Franchi era certo una concezione dello Stato fortemente paternalista,
ma lo stile presuntamente popolare in cui la espresse non mancò
di influenzare numerosi autori, la maggior parte anonimi e di ispirazione
giacobina, che sarebbero apparsi alla fine del secolo.
Quanto
alla traduzione della "Gerusalemme", il movente politico è da ricercarsi
in particolare nell'esaltazione del fondamentale contributo recato a suo
tempo dai Genovesi alla riconquista della Terra Santa, su cui era già
fiorita tutta una serie di leggende e tradizioni, legate alla figura di
Guglielmo Embriaco, "il duce ligure, che pria / signor de' mari corseggiar
solìa."
Rispettando
rigorosamente lo stesso numero di ottave dell'originale, sette diversi
poeti, Stefano De Franchi, Ambrogio Conti, Gaetano Gallino, Paolo Toso,
Giacomo Guidi, Gian Agostino Gastaldi, Francesco Maria Viceti, diedero
la loro versione dei venti canti della "Gerusalemme Liberata", a volte
mantenendosi molti aderenti al testo, a volte abbassandone i toni per mantenersi
fedeli ad uno spirito ligure tutto concretezza e praticità, a volte
ancora creando momenti di poesia del tutto nuovi.
Si vedano
le ottave in cui viene rievocata la figura di Colombo (XV, 31-32) nella
versione di Ambrogio Conti:
Dal canto
XII (ott. 62-69) la morte di Clorinda, nella versione di Paolo Toso, dove
la drammaticità della situazione è resa correttamente, con
profondo sentimento:
Torna l'odio intr'i
coeu, e ri trasporta
senza poei ciù
stâ drïti à ra battaggia,
dove l'arte, e ra
forza è quæxi morta,
dove combatte in
loeugo sò ra raggia.
O quanto grande
e spaventosa porta
fa l'unna, e l'âtra
spâ, s'a ponze, o taggia
re arme, o pù
ra carne! e se non moeuran
l'é che ro
sdegno e ro venin non voeuran.
Comme ro mâ,
quando çessaòu ro vento,
che primma ro scommosse
in âto in basso,
non se queta però,
ma ro spavento
conserva ancon dro
moto, e dro fracasso;
così quantunque
con ro sangue spento
allò ghe
manche ro vigô dro brasso;
pù dall'ira
animæ tornan sti chìe
a refâ ciù
profonde re ferìe.
Ma zoeu moæ
arriva ro fatale fin
a ra brava Clorinda
destinaou.
Ra spâ ghe
ficca in mezo dri tettin,
che in passâri
se fa de sangue un sciaou,
e ro vestî
traponto d'oro fin
tutto resta de questo
imbernissaou.
Ra poveretta, che
sta in pê ciù appenna
ro coeu sente mancâse,
e ghe ven penna.
Lê segue ra
vittoria, e de tâ menna,
strenze Clorinda
senza usâ pietæ,
che ra meschinna
cazze, e poeu ciù appenna
l'ùrtima
profferî sò vorentæ,
che allora in mente
un bon penscêo ghe menna
de Fede, de Speranza
e Caritæ,
Virtù, che
Dio gh'infonde, e se unna liggia
fu mentre a visse,
ra voeu in morte figgia.
Te daggo ro perdon:
ti hæ vinto, amigo:
perdonname ti assì:
non ro demando
per questo corpo,
che n'importa un figo,
l'annima sola mi
te raccomando,
dagghe battæsmo,
e lévera d'intrigo.
In questa voxe,
che lê va formando
o sente un non so
che, che l'odio franze,
e fa che questo
se converte in cianze.
Poco lontan de lì
scorre da un monte
tutto fresco d'argento
un rianetto:
gh'andò Tancredi
e l'elmo impì intr'ro fonte,
e tornò a
fâ l'uffizio benedetto
sentì tremâ
ra man, mentre d'in fronte,
per battezzâra
ghe levò l'elmetto.
Ra vidde, ra conobbe:
ah, restò senza
e voxe e moto! Ah,
vista! Ah, conoscenza!
Non morì zà,
che tutta in quell'instante
ra forza addoeuverò
che ghe restava,
e se misse unna
vitta ciù constante
a dâ con l'ægua
a chi ra morte o dava;
mentre che o dixe
re parolle sante,
lê tutta d'allegrezza
giubbilava,
e pâ, che
tanto de morî ghe piaxe,
che a dixe, votta
in çê, mi vaggo in paxe.
Ra pallidezza sciù
ra gianca cera
pâ un intreçço
de livii, e viovetta.
In çê
a ten fissi ri oeuggi, e ra carera
ro Sô per
veira in poco manco affretta:
e verso quello alzando
in ra manera
che a poeu ra bella
man freida, e smortetta,
ghe dà pegno
de paxe, e in queste forme
passa ra bella donna
e pâ ch'a dorme.
Torna l'odio nei
cuori e li trasporta / anche se non si reggono più, alla battaglia,
/ dove l'arte e la forza son quasi morte / e al loro posto combatte la
rabbia. / O quanto grande e spaventosa porta / fa l'una e l'altra spada,
se punge o taglia / le armi, o la carne! e se non muoiono / è perché
lo sdegno e l'ira non vogliono. // Come il mare, quando cessa il vento,
/ che prima lo sconvolse in alto e in basso, / non s'acquieta però,
ma lo spavento / conserva ancora del moto e del fracasso; / così,
quantunque con il sangue spento / prima che gli manchi il valore del braccio;
/ pur dall'ira animati tornano costoro 7 a rifare più profonde le
ferite. // Ma ormai arriva la fatale fine / destinata alla brava Clorinda.
/ La spada le ficca in mezzo alle mammelle, / e trapassandole si fa un
fiotto di sangue, / e il vestito trapunto d'oro fino / ne rimane tutto
insudiciato. / La poveretta, che si regge appena, / sente che il cuore
le manca e soffre. // Lui persegue la vittoria e in tal modo / stringe
Clorinda senza usare pietà, / che la misera cade, e può solo
più / esprimere la sua ultima volontà, / poiché allora
in mente un buon pensiero le porta / di Fede, Speranza e Carità,
/ Virtù, che Dio le infonde, e se scapestrata / fu mentre visse,
la vuole in morte innocente. // Ti dò il perdono: hai vinto, amico:
/ perdonami anche tu: non lo domando / per questo corpo, che non conta
nulla, / l'anima sola io ti raccomando, / dalle il battesimo e liberala.
/ In questa voce, che lei va formando, / lui sente un non so che, che infrange
l'odio, / e fa che questo si converta in piangere. // Poco lontano
da lì scorre da un monte / tutto fresco d'argento un ruscelletto:
/ vi andò Tancredi e l'elmo riempì nel fonte / e tornò
a compiere l'ufficio benedetto / sentì tremare la mano, mentre dalla
fronte / per battezzarla le levò l'elmetto. / La vide, la riconobbe:
ah, restò senza / voce e movimento! Ah, vista! Ah, conoscenza! //
Non morì già, che tutta in quell'istante / adoperò
la forza che gli restava, / e si mise una vita più costante / a
dare con l'acqua a colei cui dava la morte; / mentre dice le parole sante,
/ lei giubilava tutta d'allegrezza, / e sembra che tanto le piaccia di
morire, / che dice rivolta al cielo: io vado in pace. // La pallidezza
sul viso bianco / sembra un intreccio di gigli e di violetta. / In cielo
tiene fissi gli occhi, e la strada / il Sole per vederla in poco meno affretta;
/ e verso quello alzando, nel modo / che può, la bella mano fredda
e palliduccia, / gli dà pegno di pace, e in queste forme / trapassa
la bella donna e sembra che dorma.