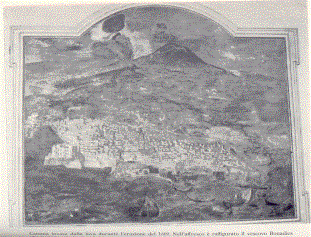
Catania 1669
Il
mio quattordicesimo componimento è dedicato ad uno degli eventi più
significativi della storia catanese, cioè all’eruzione dell’Etna avvenuta
nel 1669, che ricoprì Catania modificandone in modo sostanziale la topografia.
Il vulcano squarciò un fianco il giorno 11 Marzo: i paesi di La Guardia, di
Malpasso e Mompileri furono sommersi. Gli abitanti dei paesini etnei coinvolti
si rifugiarono a Catania, dove furono ospitati in parte dal vescovo Bonadies nel
palazzo episcopale ed in parte alloggiati, a spese del senato, nell’Ospedale
di San Marco. Più tardi, quando l’eruzione ebbe fine, si decise di insediarli
nella zona del Borgo, che allora non faceva parte del territorio urbano. La
minaccia della lava scosse i Catanesi, i quali si appellarono alla protezione di
Sant’Agata: il vescovo portò in processione fuori delle mura un braccio della
Santa per respingere il magma che si dirigeva verso la città. Il giorno
seguente il santo velo della Patrona fu trasportato fino alla chiesa di
Mascalucia, dove fu celebrata una messa. In quest’occasione il gesuita Grillo
Cassia pronunciò un’omelia tanto efficace sugli animi degli astanti che le fu
attribuito l’allontanamento improvviso della lava; il velo proseguì il suo
giro in vari altri paesi della zona registrando ancora inaspettati successi a
Camporotondo e a San Pietro. La sacra reliquia fece ritorno a Catania tra le
acclamazioni dei devoti e fu ricollocata nella Cattedrale. I Benedettini
tirarono fuori dalla loro sagrestia il Santo Chiodo con cui fu crocifisso
Cristo, donato loro dal re Martino nel 1393 (cfr. Vito
Maria Amico, pp. 163-4), e lo esposero fuori della cinta muraria nel
tentativo di stornare le fiamme. Ma nondimeno il pericolo non cessò e non fu
sufficiente a scongiurarlo neppure il ricorso all’intera salma di
Sant’Agata: la lava, dopo avere ricoperto il lago di Nicito, che infatti da
allora non esiste più, entrò attraverso il Bastione degli Infetti fino alla
Porta dei Canali, ad ovest di Catania, occupando i fossati del Castello Ursino.
Il magma si diresse verso il mare seminando intorno a sé sgomento e
distruzione: solo un rozzo altare con l’effigie di Sant’Agata si salvò
galleggiando integro sul fiume lavico. La massa infuocata si addentrò per un
miglio nel mare ed infatti da quel momento il Castello non si affacciò più a
strapiombo sul golfo. Molti Catanesi fuggirono via in cerca di
salvezza e tutte le suore abbandonarono i propri conventi rifugiandosi nei paesi
limitrofi. Il viceré, duca di Alburquerque, mandò a Catania come vicario
generale il principe Stefano Riggio di Campofranco: a costui, a causa
dell’ingente scorta di soldati che l’accompagnava, dapprima fu impedito
l’ingresso in città dal popolo catanese, poiché si temeva che volesse
portare a Palermo le spoglie di Sant’Agata; successivamente, quando
l’equivoco si chiarì, il principe fu ricevuto a Catania con tutti gli onori
dovuti. Egli cercò di porre rimedio ai mali presenti con una politica di
sgravio fiscale e di distribuzione pubblica di viveri e frenò la fuga dei
Catanesi con incentivi di diversa natura. Il senato intese elogiare
l’abnegazione del vicario con una lettera inviata al viceré per ringraziarlo
di avere scelto l’uomo idoneo a fronteggiare il difficile stato di cose. Tuttavia
l’eruzione continuò il suo corso e perciò fu stabilito che il senato ed il
vescovo si ritirassero ad Ognina, dove furono trasferite anche le reliquie di
Sant’Agata. Le vettovaglie pervenivano via mare: a tale scopo era stato eretto
un ponte di legno sulla spiaggia di Ognina. Inoltre, si lastricò una strada
sulla lava consolidata in superficie. La Settimana Santa di quell’anno fu
assai triste perché la calamità aveva svuotato Catania e reso fuori luogo i
consueti festeggiamenti della Pasqua. Molte città siciliane, udita la notizia
della sventura toccata a Catania, espressero pubblicamente la loro solidarietà:
si distinse Messina, che inviò il chierico minore Giuseppe Loredano con un
messaggio che fu letto nel senato catanese: oltre alle affermazioni di commossa
partecipazione alle sciagure occorse a Catania, si offriva a numerosi artigiani
catanesi l’opportunità di un lavoro e di un alloggio a Messina, insieme con
la promessa di barche per agevolare un eventuale ritorno. Il discorso fu spesso
interrotto dagli applausi e dal pianto dei senatori. Verso la fine di maggio, i
fenomeni eruttivi cominciarono a poco a poco a cessare e la vita riprese
nell’intera provincia: la città fu illuminata per tre notti di seguito in
segno di festa. Il viceré, a Palermo, fece cantare il Te
deum in tutte le chiese cittadine e ordinò
al vicario di elargire del denaro al vescovo Bonadies per comperare un
candelabro da tenere sempre acceso nella cappella di Sant’Agata nel Duomo.
Inoltre, il senato spedì a Madrid Vicenzo Paternò, barone di Raddusa e
Mirabella, il quale ottenne da re Carlo II l’esonero da ogni tributo per dieci
anni. Il vescovo fece dipingere al pittore catanese Mignemi un affresco nella
sagrestia della Cattedrale, tuttora esistente e proposto qui di seguito, in cui
furono ritratti quei luttuosi avvenimenti. Per chi voglia saperne di più:
Vito
Maria Amico, Catana illustrata
sive sacra et civilis urbis Catanae historia,
traduzione di Vincenzo di Maria, vol. II, Catania 1989, pp. 342-354;
Francesco
Ferrara, Storia di Catania
sino alla fine del secolo XVIII, Catania
1829, pp. 192-202;
Tino
Giuffrida, Catania, dalla dominazione sveva alla dominazione spagnola,
Catania 1981, pp. 165-74.
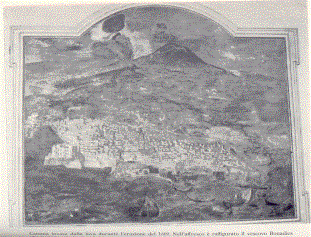
Catania
1669
Si squarciò l’Etna presso Nicolosi
formando su quel fianco ampi crateri,
piogge frequenti di lapilli esplosi
s’aggiungono nel cielo a nembi neri
e rivoli di magma minacciosi
convergono a Malpasso e Mompileri:
dopo il tramonto nei villaggi attorno
la notte appare illuminata a giorno.
Rapido un mare incandescente avanza
che ciò che trova innanzi a sé distrugge
e, vomitando ancora ignea sostanza,
da scosse attraversato il suolo mugge;
la gente, non serbando altra speranza
che della vita, verso valle fugge
e, lasciata ogni cosa più diletta,
coi propri cari come può s’affretta.
Discendono a Catania i montanari,
in parte nel palazzo episcopale
ricoverati ed in misura pari
accomodati dentro un ospedale
dal senato con pubblici denari:
come compenso del passato male,
quando avrà fine il furibondo sgorgo,
saranno accolti nell’odierno Borgo.
Nella città profondamente affranta
fra la plebe imperversa la paura
del vasto rogo che le valli ammanta;
il presule dispone con premura
che sia portato un braccio della Santa
in grande pompa fuori delle mura;
nobili e volgo senza differenza
vengono appresso e fanno penitenza.
Il giorno dopo, alla pietà del cielo
la folla un’altra volta s’abbandona
ed il vescovo etneo con santo zelo
a farsi forza i suoi fedeli sprona
portando in giro il portentoso velo
della Celeste Vergine Patrona:
poi verso il tempio di Mascalucia
con la reliquia il popolo s’avvia.
Il velo sacro fra la fitta ressa
di quanti gli si fanno incontro a gara
avanza ed alla meta ormai s’appressa;
in chiesa è collocato sopra l’ara,
mentre il curato celebra la messa:
un gesuïta d’eloquenza rara
pronuncia con fervore l’omelia
contro le fiamme per cacciarle via.
Esorcizzato dal sermone ardente,
il fuoco dal villaggio si ritira
e stupefatto il popolo plaudente
l’avvenimento inusitato ammira;
accolto con gran festa dalla gente,
per borghi e ville il santo resto gira
ed a Camporotondo ed a San Pietro
la lava si ritrae di nuovo indietro.
Il sacro velo, dopo qualche giorno,
tra cittadini subito all’ingresso
acclamanti a Catania fa ritorno
ed un sonoro “evviva” echeggia spesso;
per salutarlo, le campane intorno
risuonano, finché non è rimesso
a posto, fra la gioia generale,
dentro il sacrario della Cattedrale.
I monaci seguaci del Norcino
traggono dalla propria sagrestia
il Santo Chiodo del buon re Martino,
che trafisse la destra del Messia,
Gesù Cristo, Unigenito divino,
insieme con il cuore di Maria,
per opporlo alla vampa oltre la cinta
delle mura, perché ne sia respinta.
Ma non pertanto il Mongibello cessa
di minacciare i miseri villaggi
della provincia dalle fiamme oppressa:
nella città confusa e nei paraggi
non pure il velo, ma la salma stessa
della Patrona sfila tra gli omaggi
dei Catanesi ed in eguale modo
s’inchinano i fedeli al Santo Chiodo.
Le suppliche non giungono stavolta
al cielo, che dispensa un’altra sorte
e la pietà dei voti non ascolta
quasi a provare la virtù del forte.
L’ardente massa lavica raccolta
senza contrasti supera le Porte,
avendo invaso il lago di Nicito
coll’ampia valle che ne cinge il sito.
Attraverso il Bastione degli Infetti,
entra fino alla Porta dei Canali
e sommerge ogni cosa coi suoi getti
di lava inarrestabili e fatali;
i cittadini fuggono, costretti
dalla portata dei presenti mali,
mentre il magma continua il suo cammino
coprendo i fossi del Castello Ursino.
Avanza la colata senza sosta
nella sua lunga corsa verso il mare
e prima d’occupare anche la costa
cosparge il suolo di roventi sciare
stendendo intorno la sua calda crosta.
Tutto è rovina, salvo un rude altare
con su l’effigie d’Agata celeste,
che fluttua intatto fra le fiamme infeste.
A prodigio s’aggiunge altro prodigio:
nel mare oltre la riva per un miglio
s’addentra, infine, l’ampio strato grigio
venato in superficie di vermiglio.
Ne serberanno i secoli un vestigio:
il Castello non sorge più sul ciglio
d’un dirupo che domina la costa,
perché la terra innanzi ora si sposta.
Per il terrore, dopo quest’evento,
fuggono da Catania i cittadini
e sgombrano le suore ogni convento,
accolte nei paesi qua vicini.
Sovrano intorno regna lo sgomento:
mentre molti s’accalcano ai confini
della città, sui tetti e sulle strade
la cenere dal cielo intanto cade.
Giunge il Principe Riggio da Palermo
in veste di vicario generale
ed un’ampia milizia gli fa schermo:
la sua presenza è interpretata male
dal popolo che, presso i varchi fermo,
impedisce il passaggio all’ufficiale,
poiché nutre il sospetto che si voglia
mandar lontano d’Agata la spoglia.
Ma tra l’informe, diffidente massa
cessano presto le paure vane
ed il vicario finalmente passa
tra mille inchini e suoni di campane;
per prima cosa, elimina ogni tassa
distribuendo a mani larghe il pane,
quindi la gente in vari modi alletta
perché la fuga da Catania smetta.
Da tutti l’operato del vicario
per la cura sollecita è lodato
con la quale provvede al necessario:
per questo d’una lettera il senato
si fa concordemente firmatario,
in cui s’esprime un sentimento grato
al viceré, che l’uomo adatto elesse
perché l’arsa città non soccombesse.
Ma nondimeno ancora non s’arresta
l’incendio che rïoni e vie devasta,
perché nell’ora tragica e funesta
la volontà del Principe non basta;
e, mentre fuma l’infuocata cresta
che mormorando la città sovrasta,
si decreta lo sgombro del senato,
con l’alto clero ed ogni magistrato.
Sfilano a frotte i senatori al porto,
in compagnia del loro patrïarca,
che s’allontana pieno di sconforto
recando i resti d’Agata in un’arca;
quindi, poggiando sul bastone attorto,
in grande fretta il presule s’imbarca
sopra un battello ed Ògnina raggiunge
che da Catania non si trova lunge.
Qui vengono dal mare le vivande,
poiché non offre vie sicure il suolo,
sul quale il fiume lavico si spande;
a questo scopo è stato eretto un molo,
ma giacché la richiesta è troppo grande
perché possa bastare un varco solo,
si lastrica una strada che ricopra
la lava scura ed indurita sopra.
Per quest’anno la Santa Settimana
trascorre triste nelle chiese vuote,
il lutto, che la festa rende vana,
nega le gioie abitüali e note,
sui campanili tace ogni campana
che non tintinni al vento che la scuote
né s’ode altro rumore per le strade
che quello del pulviscolo che cade.
Corre per tutta l’isola la fama
della sventura che Catania opprime
ed al pensiero gli uomini richiama
che può cadere giù quant’è sublime;
attesta ogni città con un proclama
la sua pietà fraterna e fra le prime
si distingue la nobile Messina,
che manda un messaggero alla vicina.
Giunge infatti a Catania il primo maggio
il chierico Giuseppe Loredano,
che non temette i rischi del vïaggio
e le flüenti fiamme del vulcano;
con sé reca il magnanimo messaggio
del suo senato: il sentimento umano
che proprio è della gente dello Stretto
vi pervade ogni frase, ogni concetto.
In curia si fa pubblica lettura
del documento, che di plauso è degno,
perché vi si compiange la sventura
dei conterranei e si rinnova il pegno
d’un’amicizia che da tempo dura
per via del vicendevole sostegno
e grazie al culto d’Agata divina,
patrona di Catania e di Messina.
E non si tratta dei conforti vani
d’un bel discorso di figure adorno,
il messo garantisce agli artigiani
catanesi un lavoro ed un soggiorno
dignitoso a Messina ed un domani
le barche per un facile ritorno:
risuonano gli applausi ed ogni tanto
cedono alcuni senatori al pianto.
Cominciano a cessare a poco a poco
per la provincia sul finir di maggio
i flussi occulti del furente fuoco;
riprende la sua vita ogni villaggio
e si rivolge la paura in gioco
tra vocii di speranza e di coraggio:
dall’incubo Catania si ridesta
e si rischiara d’altre fiamme a festa.
Ecco a Palermo il viceré comanda
che lode in ogni tempio a Dio sia resa,
quindi al vicario il compito demanda
di regalare alla maggiore Chiesa
catanese una lampada che spanda
i propri raggi e resti sempre accesa
nella cappella d’Agata divina,
che scampò la città dalla rovina.
Accorrono a Catania i forestieri
per visitare la città fumante,
sommersa dalla furia dei crateri;
viene un vescovo greco da levante
per tutelarla con i suoi poteri,
ed esorcismi ed orazioni sante,
facendo mostra d’intenzioni serie,
mormora qua e là fra le macerie.
Da Madrid l’esenzione d’ogni imposta
per due lustri concede il re di Spagna.
Risorgono le case in ogni costa
di questa terra che di qua si bagna
nel mare Ionio e dalla parte opposta
ombra riceve dalla sua montagna,
fonte di lutti e di letali ambasce
per la città, che tuttavia rinasce.
Marco Tullio Messina