|


(55 d.C.? ca – 120 ca)
Origini nobili. Molto incerti e lacunosi sono i
dati biografici di T. (a partire già dai suoi "tria nomina"):
nacque probabilmente nella Gallia Narbonese (ma forse a Terni, o
addirittura nella stessa Roma), da una famiglia ricca e molto
influente, di rango equestre. Studiò a Roma (frequentò probabilmente
anche la scuola di Quintiliano), acquistò ben presto fama come
oratore (dovette essere anche un valentissimo avvocato), e nel 78
sposò la figlia di Gneo Giulio Agricola, statista e comandante
militare.
La fortunata carriera politica e letteraria.
Iniziò la carriera politica sotto Vespasiano e la proseguì sotto
Tito e Domiziano; ma, come Giovenale, poté iniziare la carriera
letteraria solo dopo la morte dell'ultimo, terribile, esponente
flavio (96 d.C.), sotto il cui principato anche il nostro autore,
come altri intellettuali del resto, non dovette vivere momenti certo
tranquilli. Questore poi nell’81-82 e pretore nell'88, T. fu per
qualche anno lontano da Roma, presumibilmente per un incarico in
Gallia o in Germania. Nel 97, sotto Nerva, fu console (anche se in
veste di supplente) e pronunciò un elogio funebre per Virginio Rufo,
il console morto durante l'anno in carica.
Gli ultimi anni profusi negli studi storici.
Abbandonò poi decisamente oratoria e politica (ebbe solo un
governatorato nella provincia d’Asia, nel 112-113), per dedicarsi
totalmente alla ricerca storica. Fu intimo amico, nella vita e negli
studi, di Plinio il Giovane.
Opere
- "Dialogus de oratoribus", dell’ 80 ca o di poco
successivo al 100; d'incerta attribuzione (ma oggi si propende
sull'attribuzione dell'opera a T.), è comunque dedicato a Fabio
Giusto;
- "De Vita Agricolae", pubblicato nel 98;
- "De origine et situ Germanorum" o "Germania",
dello stesso anno?;
- "Historiae", composte tra il 100 e il 110, in
12 o 14 libri di cui però ci sono pervenuti solo i primi 4 e metà
del V;
- "Annales" o "Ab excessu divi Augusti", del
100-117?, comunque successivi alle "Historie", in 16 o 18 libri, di
cui ci rimane, però, l'opera incompleta: i primi 4 libri, alcuni
frammenti del V e del VI (mancante forse del principio) che trattano
del regno di Tiberio; infine, gli ultimi 6, concernenti Nerone, ma
per lo più lacunosi.
Contenuti e commenti delle opere
- Dialogus de oratoribus: le cause della decadenza
dell'oratoria.
Incertezza di paternità e di stesura. Il "Dialogus
de oratoribus" non è probabilmente la prima opera di T., se pure è
davvero sua (come accennato, la paternità è incerta): la tesi che
oggi prevale è che essa sia stata comunque composta dopo la
"Germania" e dopo l' "Agricola". Il periodare presente in tale opera
- e la stessa forma dialogica - ricorda, infatti, il modello
neociceroniano, forbito ma non prolisso, cui si ispirava
l'insegnamento della scuola di Quintiliano: per questo, c'è chi
suppone che l'opera sia stata appunto scritta quando T. era ancora
giovane e legato alle predilezioni classicheggianti proprie di
quella scuola. Anche se questa ipotesi fosse vera, resta il fatto
che l'opera fu pubblicata solo in seguito, dopo la morte di
Domiziano.
La decadenza dell'oratoria. Ambientata nel 75 o
nel 77, il "Dialogus" si riallaccia alla tradizione dei dialoghi
ciceroniani su argomenti filosofici e retorici: riferisce di una
discussione avvenuta a casa di Curiazio Materno fra lui stesso,
Marco Apro, Vipstano Messalla e Giulio Secondo. In un primo momento,
si contrappongono i discorsi di Apro e Materno (che forse è la
maschera dietro cui si nasconde lo stesso T.), in difesa -
rispettivamente - dell'eloquenza e della poesia. L'andamento del
dibattito subisce però una svolta con l'arrivo di Messalla,
spostandosi sul tema della decadenza dell'oratoria, la cui causa è
individuata essenzialmente nel deterioramento dell'educazione e,
soprattutto, nel clima di "censura" di parola e di pensiero vigente
nella stessa età imperiale. Il dialogo, infatti, si conclude con il
discorso di Materno, il quale sostiene, più specificamente, che una
grande oratoria forse era possibile solo con la libertà, o piuttosto
con l'anarchia; diviene invece anacronistica e noiosa - strumento al
servizio del servilismo e dello sterile accademismo culturale,
piuttosto che della lotta politica e civile - in una società
(forzatamente) "tranquilla", come quella conseguente
all'instaurazione dell'Impero, caratterizzata dalla degenerazione
sociale, politica e culturale. L'opinione attribuita a Materno, come
detto, rispecchia molto probabilmente il pensiero di T.: ma egli,
nonostante tutto, sente la necessità dell'Impero - come vedremo del
resto nelle opere successive - come unica forza in grado di salvare
lo stato dal caos delle guerre civili, di garantire insomma la pace,
anche se il principato restringe lo spazio per l'oratore e l'uomo
politico.
- Agricola e la sterilità dell'opposizione.
Un'opera composita, tra biografia etnografia e
politica. Verso gli inizi del regno di Traiano, T. approfittò del
ripristino dell'atmosfera di libertà dopo la tirannide per
pubblicare il suo primo opuscolo storico, la sua prima monografia
(ma il carattere di quest'opera "sui generis" è decisamente
ibrido: oscilla tra etnografia, storia, panegirico e biografia,
mentre l'impronta è marcatamente politica), che tramandi ai posteri
la memoria del suocero Giulio Agricola, valente generale del tempo
di Domiziano e conquistatore della Britannia (o meglio, della parte
settentrinale dell'isola). Per il suo tono encomiastico, lo stile di
quest'opera si avvicina a quello delle "laudationes" funebri,
integrate con materiali storici ed etnografici; notevole è anche
l'influenza di Cicerone, soprattutto nella perorazione e
celebrazione finale, che assume toni particolarmente commossi e di
intensa e personale partecipazione.
La trama e il personaggio di Agricola, esempio di
libertà ed onestà politica. Dopo una trattazione sommaria della vita
del protagonista (incentrata esclusivamente sulla sua figura di uomo
pubblico, mentre soltanto accennati, quando non taciuti, sono gli
episodi relativi a vicende private e di vita quotidiana), T. si
sofferma proprio sulla conquista della Britannia, lasciando un certo
spazio alle digressioni geografiche ed etniche. Egli, tuttavia, non
perde mai di vista il proprio personaggio: la Britannia è
soprattutto un campo in cui si dispiega la "virtus" di
Agricola, il teatro delle sue magnifiche imprese. T. mette in
risalto come il suocero avesse saputo servire lo Stato con fedeltà e
onestà, anche sotto un pessimo principe come Domiziano (si lascia
trapelare anche il sospetto che proprio questi avesse fatto
avvelenare, per invidia, il famoso generale): anche nella morte,
tuttavia, Agricola mantiene la sua rettitudine: egli lascia la vita
in silenzio, senza andare in cerca della gloria di un martirio
ostentato. L'esempio di Agricola, insomma, indica come anche sotto
la tirannide sia possibile percorrere la via mediana (la vera virtù
consiste appunto nella "moderazione") fra quelle del martirio e
dell'indecenza.
- Germania: virtù dei barbari e corruzione dei
Romani.
Opuscolo etnico-geografico di "attualità". Gli
interessi etnografici sono al centro della "Germania", non a caso
scritta in quel particolare momento storico-politico, quando
l’agitarsi delle popolazioni ultrarenane indusse Traiano ad
affrontare decisamente il problema germanico: unica testimonianza,
comunque, di una letteratura specificatamente etnografica che a Roma
doveva godere di una certa fortuna.
[A tal proposito, non è certo se T. abbia ideato
quest'opera come una composizione a sé stante o se l'abbia pensata
come una parte, un "excursus", da inserire successivamente
nelle "Historiae": invero, però, la critica odierna sembra
agevolmente acquietarsi sulla prima ipotesi].
I contenuti e le fonti. L'operetta è divisa in 2
parti: nei primi 27 capitoli è descritta la Germania in generale,
condizioni del suolo e del clima, abitanti, loro costumi, religioni,
leggi, divertimenti, virtù e vizi; la II parte, invece, contiene un
catalogo con le notizie particolari dei diversi popoli, in ordine
geografico, da occidente ad oriente.
Le suddette considerazioni etnogeografiche (sui
popoli e sui luoghi appunto tra Reno e Danubio) non derivano
tuttavia da una visione diretta, ma da fonti scritte, e soprattutto
dai "Bella Germaniae" di Plinio il Vecchio, che aveva prestato
servizio nelle armate del Reno. T. sembra aver seguito la sua fonte
con fedeltà, aggiungendo qua e là pochi particolari per ammodernare
l'opera: ciò nonostante, rimangono alcune discrepanze, poiché la
"Germania" sembra descrivere abbastanza spesso la situazione come si
presentava, invero, prima che gli imperatori flavi avanzassero oltre
il Reno e oltre il Danubio.
Visione "manichea": barbari sani e Romani
corrotti. E' possibile notare (ed anzi non è rilievo secondario),
nell'opuscolo di T., l'esaltazione di una civiltà ingenua e
primordiale, non ancora corrotta dai vizi raffinati di una civiltà
decadente: in questo senso, tutta l'opera sembra percorsa da una
vena implicita di contrapposizione dei barbari, ricchi di energie
sane e fresche, ai romani, contrapposizione evidentemente frutto di
un filtro etico attraverso il quale lo storico scandaglia
osservazioni e descrizioni. E molto probabilmente, al di là di ogni
"idealizzazione", T. intendeva sottolineare la pericolosità di quel
popolo per l'Impero: i Germani potevano davvero rappresentare una
seria minaccia per un sistema politico basato sul servilismo e sulla
corruzione (ovviamente, T. parla anche dei molti difetti di un
popolo che gli appare comunque come essenzialmente barbarico). Un
accorato invito, dunque, a raccogliere le residue forze contro il
potente e minaccioso nemico.
- Historie: i parallelismi della storia.
Dal 69 al 96 d.C. . Il progetto di una vasta
opera storica era presente già nell'Agricola, ma nelle "Historiae"
tale progetto appare modificato: mentre la parte che ci è rimasta
contiene la narrazione degli eventi dal regno di Galba fino alla
rivolta giudaica, l'opera nel suo complesso doveva estendersi fino
al 96, l'anno della morte di Domiziano: nel proemio, T. afferma di
voler trattare durante la vecchiaia dei principati di Nerva e di
Traiano.
Le "Historiae" descrivono quindi un periodo cupo,
sconvolto dalla guerra civile e concluso con la tirannide:
Il I libro parla del breve regno di Galba;
seguono l'uccisione di questo e l'elezione all'Impero di Otone. In
Germania le legioni acclamano però come Imperatore Vitellio. In
particolare, il 69, anno in cui si aprono le "Historiae", vede
succedersi 4 imperatori: questo perché il principe poteva essere
eletto anche fuori da Roma, e la sua forza si basava principalmente
sull'appoggio delle legioni di stanza in paesi più o meno remoti.
Nel II e III libro si parla della lotta tra Otone
e Vitellio, con la sconfitta del primo, e tra Vitellio e Vespasiano.
Quest'ultimo, eletto imperatore in Oriente, lascia il proprio figlio
Tito ad affrontare i giudei e fa dirigere le sue truppe a Roma dove
si era rifugiato Vitellio, che viene ucciso.
Nel IV libro si parla dei tumulti ad opera dei
soldati flaviani, e dei tumulti contro Vespasiano scoppiati in
Gallia e in Germania.
Il V libro parla degli avvenimenti di Germania e
dei primi segni di stanchezza mostrati dai ribelli.
Il significato di "historiae". Come già si evince
dallo stesso titolo, nonché dal breve sommario proposto qui sopra,
T. vuol soddisfare un desiderio di ricerca e di comprensione dei
fatti che va al di là della pura e semplice raccolta di
testimonianze: ciò in piena rispondenza e fedeltà al significato
stesso che il termine "historiae" rivestiva nella lingua
latina, mutuandolo strettamente dal greco "historìa"
(indagine, ricerca storica), ovvero come esposizione sistematica
della storia, sia come racconto storicamente attestato dei singoli
avvenimenti sia come sguardo d'insieme retrospettivo sul passato.
Parallelismi storici. Così, T. scrive a distanza
di 30 anni dagli avvenimenti del 69, ma la ricostruzione di quell'anno
avveniva nel vivo del dibattito politico che aveva accompagnato
l'ascesa al potere di Traiano. A tal proposito, è stato notato un
certo parallelismo tra questa e gli avvenimenti del 69: il
predecessore di Traiano, Nerva, si era trovato come Galba ad
affrontare un rivolta di pretoriani che faceva traballare le basi
del suo potere, e come Galba aveva designato per "adozione" un suo
successore. L'analogia però si ferma a questo punto: mentre Galba si
era scelto come successore Pisone, un nobile di antico stampo poco
adatto, Nerva aveva invece consolidato il proprio potere
associandosi nel governo Traiano, un capo militare autorevole,
comandante dell'armata della Germania superiore. Con il discorso di
Galba in occasione dell'adozione di Pisone, lo storico ha inteso
mostrare nella figura dell'imperatore il divario fra il modello di
comportamento rigorosamente ispirato al "mos maiorum" e la
reale capacità di dominare e controllare gli avvenimenti. Solo
l'adozione di una figura come quella di Traiano placò i tumulti fra
le legioni e pose fine a ogni rivalità.
La necessità del principato. Come già detto, T. è
convinto che solo il principato sia in grado di garantire la pace e
la fedeltà degli eserciti: già il proemio delle "Historiae"
sottolinea come - dopo la battaglia di Azio - la concentrazione del
potere nelle mani di una sola persona si rivelò indispensabile, o
quantomeno ineluttabile: ovviamente il principe non dovrà essere uno
scellerato tiranno come Domiziano, né un inetto come Galba;
piuttosto, dovrà invece assommare in sé quelle qualità necessarie
per reggere la compagine imperiale, e contemporaneamente garantire i
residui del prestigio e della dignità del ceto dirigente senatorio.
Quindi, per T. l'unica soluzione sembra consistere nel principato
moderato degli imperatori d'adozione.
Lo stile. Lo stile delle "Historiae" ha un ritmo
vario e veloce, che richiede da parte di T. un lavoro di
condensazione rispetto ai dati forniti dalle fonti: a volte qualcosa
è omesso, ma più spesso T. sa conferire efficacia drammatica alla
propria opera suddividendo il racconto in più scene. Lo storico è
poi molto bravo nella descrizione delle masse, da cui traspare il
timore misto a disprezzo del senatore per le turbolenze dei soldati
e della feccia della capitale.
Tra storiografia tragica ed abilità
ritrattistica. Le "Historiae" raccontano, del resto, per la maggior
parte, fatti di violenza e di ingiustizia: ciò non toglie che T.
sappia tratteggiare in modo abile i caratteri dei propri personaggi,
alternando notazioni brevi a ritratti compiuti come quello di
Muciano o di Otone. Lo storico, ad es., insiste sulla consapevolezza
di questo personaggio, della sua subalternità nei confronti degli
strati inferiori urbani e militari: forse Otone deve proprio a
questo servilismo la sua capacità di incidere nelle cose. Egli è
dominato da una "virtus" inquieta, che all'inizio della sua
vicenda lo porta a deliberare, in un monologo quasi da eroe tragico,
una scalata al potere decisa a non arrestarsi. Ma Otone è un
personaggio in evoluzione e decide così di darsi una morte gloriosa.
Nella sua descrizione T. si affida alla "inconcinnitas", alla
sintassi disarticolata, alle strutture stilistiche slegate per
incidere nel profondo dei personaggi. Egli ama ricorrere a costrutti
irregolari e a frequenti cambi di soggetto per dare movimento alla
narrazione.
- Annales: le radici del principato.
Da Augusto a Nerone. Nemmeno nell'ultima fase
della sua attività T. mantenne il proposito di narrare la storia dei
principati di Nerva e Traiano: anzi egli, negli "Annales",
intraprese il racconto solo della più antica storia del principato,
dalla morte di Augusto (il giudizio su questo primo principe non può
essere che negativo, viste le nefaste conseguenze - anche se nei
tempi lunghi - della sua "rivoluzione" politica) a quella di Nerone.
Come del resto già si arguisce dallo stesso titolo, continuò il
metodo degli annalisti, giacché lo schematismo dei fatti non urtava
con la sua funzione critica, che tendeva (come abbiamo visto e come
ancora vedremo) prevalentemente allo studio dei caratteri e dei
moventi psicologici e morali delle azioni. Probabilmente, T.
intendeva la sua opera anche come un proseguimento di quella di
Livio: in effetti, già il "sottotitolo" presente nei manoscritti ("Ab
excessu divi Augusti") sembra ricordare proprio quello liviano, "Ab
urbe condita".
I libri sopravvissuti. Come accennato, degli "Annales"
sono conservati i libri I-IV, un frammento del V e parte del VI,
comprendenti il racconto degli avvenimenti dalla morte di Augusto
(14) a quella di Tiberio (37); inoltre sono conservati i libri
XI-XVI, col racconto dei regni di Claudio e di Nerone.
Ancora sulla necessità del principato. Negli "Annales"
T. sembra mantenere la tesi della necessità del principato: ma il
suo orizzonte sembra essersi notevolmente incupito, o comunque fatto
più amaro (nonostante egli si trovi a vivere in un secolo definito
unanimemente, da storici e studiosi di età successive, come il
"secolo d'oro" dell'impero: ma che si tratti di una mera, crudele,
illusione?). La storia del principato è, infatti, anche la storia
del tramonto della libertà politica dell'aristocrazia senatoria,
anch'essa coinvolta in un processo di decadenza morale e di
corruzione, e sempre più incapace - per colpe dirette o per cause
indirette - di giocare ancora un ruolo politico significativo.
Scarsa simpatia lo storico presenta anche nei confronti di coloro
che scelgono l'opposta via del martirio, sostanzialmente inutile
allo Stato, e continuano a mettere in scena suicidi filosofici.
T. sembra condurre insomma il lettore attraverso
un territorio umano desolato, senza luce o speranza; ma forse, a ben
vedere, un barlume di speranza rimane: la parte sana dell'élite
politica, infatti, continua a dare il meglio di sé nel governo delle
provincie e nella guida degli eserciti (ad es., l'opera bellica di
Germanico risulta grandiosa rispetto alla meschina politica urbana
di Tiberio). E' proprio su questi uomini che, secondo il nostro
autore, bisognerebbe puntare per la ricostruzione politica e morale
di Roma.
Ancora storiografia tragica. T. alla forte
componente tragica della sua storiografia assegna soprattutto la
funzione di scavare nelle pieghe dei personaggi per sondarli in
profondità e portarne alla luce le ambiguità e i chiaroscuri. Lo
storico, infatti, sa bene <<che né la volontà degli dèi, né la
Provvidenza o la Fatalità sono cause immediate del divenire storico.
Le azioni umane, che sono le più visibili, le più immediatamente
percepibili, in questo divenire, dipendono dal libero arbitrio>> [P.
Grimal]. Le conseguenze, quindi, delle opinioni e soprattutto delle
passioni che scatenano i comportamenti umani ricadono sul divenire
storico e ne determinano il corso: ciò è tanto più vero, poi, se il
protagonista di tale divenire è un principe investito, per la durata
del suo regno, di un potere illimitato. Per T. è indispensabile,
quindi, per comprendere la trama della storia, analizzare la
personalità di colui dal quale dipende il destino dell'impero. Ecco,
così, spiegato come mai, soprattutto negli "Annales", si perfezioni
ulteriormente la tecnica del ritratto e si accentui la componente
"tragica" del racconto.
I "ritratti" degli imperatori. Ad es., Claudio è
rappresentato come un imbelle che, dopo la morte della prima moglie
Messalina, cade nelle mani del potente liberto Narciso e della
seconda moglie Agrippina, che alla fine fa avvelenare il marito e
mette sul trono Nerone, il figlio avuto da un precedente matrimonio.
Quindi, è narrato il regno di Nerone, nella giovinezza influenzato
dalle figure della madre, del filosofo Seneca e del prefetto del
pretorio Burro. Poi acquista indipendenza e cade sempre più nella
pazzia: instaura quindi un regime da monarca ellenistico e si dedica
soprattutto ai giochi e ai spettacoli. Riesce a far uccidere la
madre Agrippina mentre Seneca si ritira a vita privata. Nerone si
abbandona a eccessi di ogni sorta, ma intorno a Gaio Pisone si
coagula un gruppo di congiurati che si propongono di uccidere il
principe. La congiura di Pisone viene scoperta e repressa.
Ma il vertice dell'arte tacitiana è stato
individuato nel ritratto di Tiberio, del tipo cosiddetto indiretto:
lo storico non dà cioè il ritratto una volta per tutte, ma fa sì che
esso si delinei progressivamente attraverso una narrazione
sottolineata qua e là da osservazioni e commenti. Un certo spazio è
anche dato al ritratto del tipo paradossale: l'esempio più notevole
è la descrizione di Petronio. Il fascino del personaggio sta proprio
nei suoi aspetti contraddittori: Petronio si è assicurato con
l'ignavia la fama che altri acquistano dopo grandi sforzi, ma la
mollezza della sua vita contrasta con l'energia e la competenza
dimostrate quando ha ricoperto importanti cariche pubbliche. Egli
affronta la morte quasi come un'ultima voluttà, dando
contemporaneamente prova di autocontrollo e di fermezza.
Lo stile. Nello stile degli "Annales" si assiste
ad un allontanamento dalla norma e dalla convenzione, ad una ricerca
di straniamento che si esprime nel lessico arcaico e solenne: è a
partire dal libro XIII che quest'involuzione verso modelli più
tradizionali, meno lontani dai dettami del classicismo, sembra
assumere una importante consistenza: forse il regno di Nerone,
abbastanza vicino nel tempo, richiedeva una trattazione con minore
distanziamento solenne.
Comunque, in linea di massima, gli "Annales"
risultano meno eloquenti, più concisi e austeri delle opere
precedenti. Si accentua il gusto della "inconcinnitas",
ottenuta soprattutto grazie alla "variatio", cioè allineando
un'espressione a un'altra che ci si attenderebbe parallela, ed è
invece diversamente strutturata.
Considerazioni conclusive.
Storico impegnato e partecipe… Come si vede,
l’opera di T. è tutta sostenuta da un’esplicita e tesa passione
etico-politica e dalla con-partecipazione alle sorti della Roma a
lui contemporanea: è il corrosivo e dettagliato bilancio
(soprattutto nelle opere maggiori) del primo secolo di esperienza
monarchica dal punto di vista di un intellettuale, il quale - benché
proclami di voler fare storia in modo imparziale ("sine ira et
studio", ovvero "senza risentimento e senza partigianeria") -
esprime tuttavia, giocoforza, il punto di vista della "sana"
opposizione senatoriale alla pratica imperiale (leitmotiv ne
è l’inconciliabile tensione tra "libertas" e "principatus").
Evidentemente, <<T. non sarebbe mai giunto alla
storia, se al fondo di tutta la sua esperienza politica e forense
non ci fosse stato un forte disinganno>> [F. della Corte]: quello
sulla vera natura e sulle reali conseguenze del principato.
Ecco perché la sua visione della storia risulta
in definitiva, come già detto, fortemente impregnata dell'elemento
morale (anche se non legata a credenze, filosofiche o religiose,
preconcette) ed essenzialmente individualistica (come tipico della
storiografia antica), facendo discendere la dinamica degli eventi
dalla personalità e dalle scelte dei "grandi".
… e grande. Il nostro autore, anche dal punto di
vista artistico, rappresenta forse il momento davvero più importante
della storiografia romana, superiore - volendo - allo stesso momento
liviano. Proprio di contro a Livio, in particolare, egli - scrittore
veramente profondo ed informato sugli avvenimenti - è storico
"contemporaneo", sia nel senso preciso del vocabolo, sia perché ha
saputo rendere contemporanea anche l'età che non aveva vissuto.
Anche il suo stile - volutamente controllato, rapido e conciso - è
un aspetto fondante di questa sua concezione della storia, <<storia
di idee più che storia di fatti>> [F. della Corte].
La decadenza di Roma. Di quest'ultima
affermazione, è una testimonianza lampante il fatto che T. individui
il "peccato originale" della decadenza di Roma nella svolta
anticostituzionale operata da Augusto, dietro una formale facciata
repubblicana, e denunci le conseguenze nefaste del sistema
dinastico, pur senza rifiutare totalmente l’istituzione – oramai
(come più volte ripetuto) necessaria per l’unità, l’ordine e la pace
dell’Impero – del "principato" stesso.
Le fonti. Ancora aperto è, infine, il "problema
delle fonti" di T.. Alcuni punti sono comunque assodati: lo storico
consultò la documentazione ufficiale ("acta senatus", più o
meno i verbali delle sedute; "acta diurna", contenenti gli
atti del governo e notizie su quanto avveniva a corte a Roma) ed
ebbe inoltre a disposizione raccolte di discorsi imperiali. Il tutto
vagliato con uno "scrupolo" inusuale tra gli storici antichi.
Numerose anche le fonti storiche (Plinio, Vipsiano Messala, Pluvio
Rufo, F. Rustico…) e letterarie (epistolografia, memorialistica,
libellistica ["Exitus illustrium virorum"]…).
Così, dopo il mito dell’utilizzo di un’unica
fonte (almeno per ciascuna sezione delle opere maggiori), si è
sempre più sostenuta piuttosto l’idea di una molteplicità di fonti,
per giunta talune anche di opposta tendenza, ed utilizzate con una
certa libertà.
N. Castaldi

III
|
Poi Nerone evitava di incontrarsi con lei in
luoghi appartati, la lodava quando si ritirava nei suoi giardini
o nella ville di campagna al tuscolo o nelle terre di Antonia,
perché si prendeva un po' di riposo. Alla fine, pensando che
ella sarebbe stata insopportabile ovunque si trovasse, decise di
ucciderla, esitando solo su questo punto, e cioè se ucciderla
tramite il veleno, un'arma o qualche mezzo violento. In un primo
tempo decise per il veleno, ma se il veleno fosse stato dato al
principe durante un banchetto non si sarebbe potuto attribuirlo
al caso, poiché tale era stata la mortae di Britannico; e
sembrava difficile corrompere i servi della donna, vigile per
l'esperienza che aveva di delitti e, d'altra parte, assumendo
preventivamente deglia ntidoti, proteggeva il corpo. Nessuno
sapeva escogitare in che modo nascondere un delitto a mano
armata,e in più Nerone temeva che colui che fosse stato scelto
per un delitto così grande, si rifiutasse di eseguire gli
ordini. Un piano geniale lo propose il liberto Aniceto,
comandante della flotta presso Miseno, precettore dei figli di
Nerone e e con reciproci sentimenti d'odio verso Agrippina.
Dunque spiegò che era possibile allestire una nave, una parte
della quale, staccata ad arte in mare aperto, scaraventasse in
acqua Agrippina senza che se ne accorgesse.: argomentò che non
c'e niente tanto capace di apportare disgrazie quanto il mare; e
se fosse stata inghiottita da un naufragio, chi sarebbe stato
tanto malevolo da attribuire ad un delitto ciò che i venti i
flutti avevano causato? Il principe avrebbe poi innalzato un
tempio in onore della defunta per fare bella mostra del suo
affetto filiale. |
IV
|
L'idea geniale fu accolta, favorita anche
dalle circostanze, dal momento che Nerone celebrava presso Bala
le feste quinquatrie. Qui attese Agrippina, mentre andava
ripetendo a tutti che si dovevano tollerare i malumori della
madre, e che gli animi si dovevano rappacificare; da ciò sarebbe
sorta la voce di una riconciliazione, ed Agrippina l'avrebbe
accolta con la facile credulità delle donne per le cose che
suscitano piacere. Nerone, poi, sulla spiaggia, mosse incontro a
lei che veniva dalla sua villa di Anzio, ed avendola presa per
mano l'abbracciò e la condusse a Bauli. Questo è il nome di una
villa che è lambita dal mare, nell'arco del lido tra il
promontorio Miseno e l'insenatura di Baia. Era là ancorata, fra
le altre navi una più fastosa, come se anche ciò volesse
rappresentare un segno d'onore alla madre; Agrippina, infatti,
era solita viaggiare su una trireme con rematori della flotta
militare. Fu allora invitata a cena, poiché era necessario
attendere la notte per celare un misfatto. È opinione diffusa
che vi sia stato un traditore e che Agrippina, informata della
trama, nell'incertezza se prestare fede all'avvertimento , sia
ritornata a Bala in lettiga. Qui le manifestazioni d'affetto del
figlio cancellarono in lei ogni paura; accolta affabilmente fu
fatta collocare al posto d'onore. Coi più svariati discorsi, ora
con tono di vivace famigliarità, ora con atteggiamento più
grave, come se volesse metterla a parte di più serie faccende,
Nerone trasse più a lungo possibile il banchetto; nell'atto poi
di riaccompagnare alla partenza Agrippina, la strinse al petto,
guardandola fisso negli occhi, o perché volesse rendere più
verisimile la sua finzione o perché guardandola per l'ultima
volta il volto della madre che andava a morire sentisse
vacillare l'animo suo, per quanto pieno di ferocia.
|
V
|
Quasi volessero rendere più evidente il
delitto, gli dei prepararono una notte tranquilla piena di
stelle ed un placido mare. La nave non aveva percorso ancora un
lungo tratto; accompagnavano Agrippina appena due dei suoi
famigliari, Crepereio Gallo che stava presso il timone e
Acerronia, che ai piedi del letto ove Agrippina era distesa
andava rievocando lietamente con lei il pentimento di Nerone, e
il riacquistato favore della madre; quando all'improvviso ad un
dato segnale, rovinò il soffitto gravato da una massa di piombo
e schiacciò Crepereio che subito morì. Agrippina ed Acerronia
furono invece salvate dalle alte spalliere del letto, per caso
tanto resistenti da non cedere al peso. Nel generale scompiglio
non si effettuò neppure l'apertura della nave, anche perché i
più, all'oscuro di tutto, erano di ostacolo alle manovre di
coloro che invece erano al corrente della cosa. Ai rematori
parve opportuno allora di inclinare la nave su di un fianco, in
modo da affondarla; ma non essendo possibile ad essi un così
improvviso mutamento di cose, un movimento simultaneo ed anche
perché glia altri che non sapevano facevano sforzi in senso
contrario, ne venne che le due donne caddero in mare più
lentamente. Acerronia, pertanto, con atto imprudente, essendosi
messa a gridare che lei era Agrippina e che venissero perciò a
salvare la madre dell'imperatore, fu invece presa di mira con
colpi di pali e di remi e con ogni genere di proiettile navale.
Agrippina, in silenzio, e perciò non riconosciuta (aveva avuto
una sola ferita alla spalla), da prima a nuoto, e poi con una
barca da pesca in cui si era incontrata, trasportata al lago di
Lucrino, rientrò nella sua villa. |
VI
|
Qui ripensando alla lettera piena d'inganno
colla quale era stata invitata, agli onori coi quali era stata
accolta, alla nave che, vicino alla spiaggia e non trascinata da
venti contro gli scogli, s'era abbattuta dall'alto come fosse
stata una costruzione terreste, considerando anche il massacro
di Acerronia e guardando la sua propria ferita, comprese che il
solo rimedio alle insidie era fingere di non aver capito. Mandò
perciò, il liberto Agermo ad annunciare a suo figlio che per la
benevolenza degli dei e per un caso fortunato , si era salvata
dal grave incidente; lo pregava, tuttavia, che, per quanto
emozionato per il grave pericolo corso dalla madre, non pensasse
per ora di venirla a trovare, perché per il momento lei aveva
bisogno di tranquillità. Frattanto, affettando piena sicurezza,
si prese cura di medicare la ferita e di riconfortare il suo
corpo; un solo atto non fu in lei ispirato a simulazione,
l'ordine di recare il testamento di Acerronia e di porre i beni
di lei sotto sequestro. |
VII
|
Nerone, intanto in attesa della notizia che
il delitto era stato consumato, apprese che invece (Agrippina)
aveva corso un pericolo così grande da non farla dubitare
intorno all'autore dell'insidia. Allora Nerone, morto di paura,
cominciò ad agitarsi gridando che da un momento all'altro
Agrippina sarebbe corsa alla vendetta, sia armando gli schiavi,
sia eccitando alla sollevazione i soldati, sia appellandosi al
senato ed al popolo, denunciando il naufragio, la ferita e gli
amici suoi uccisi. Quale aiuto contro di lei egli avrebbe avuto
se non ricorrendo a Burro e Seneca? Perciò fece subito chiamare
l'uno e l'altro che forse erano già prima al corrente della
cosa. Stettero a lungo in silenzio per non pronunciare vane
parole di dissuasione o forse perché pensavano che la cosa fosse
giunta ad un punto tale che se non si fosse prima colpita
Agrippina, Nerone avrebbe dovuto fatalmente perire. Dopo qualche
momento , Seneca in quanto soltanto si mostrò molto più deciso,
in quanto, guardando Burro, gli domandò se fosse mai possibile
ordinare ai soldati l'assassinio. Burro rispose che i
pretoriani, troppo devoti alla casa dei Cesari e memori di
Germanico non avrebbero osato compiere nessun atto nefando
contro la prole di lui; toccava ad Aniceto di assolvere le
promesse. Costui senza alcun indugio chiese per sé l'incarico di
consumare il delitto. A questa dichiarazione Nerone si affrettò
a proclamare che in quel giorno gli era conferito veramente
l'impero e che il suo liberto era colui che gli offriva dono sì
grande: corresse subito via e conducesse con sé i soldati,
deliberati ad eseguire gli ordini. Egli, poi, saputo dell'arrivo
di Agermo messaggero di Agrippina, si preparò ad architettare la
scena di un delitto e nell'atto in cui Agermo gli comunicava il
suo messaggio, gettò tra i piedi di lui una spada e, come se lo
avesse colto in flagrante, comandò subito di gettarlo in
carcere, per poter far credere che la madre avesse tramato
l'assassinio del figlio e che, poi, si fosse data la morte per
sottrarsi alla vergogna dell'attentato scoperto. |
VIII
|
Frattanto essendosi sparsa la voce del
pericolo corso da Agrippina, come se ciò fosse avvenuto per
caso, man mano si diffondeva la notizia, tutti accorrevano sulla
spiaggia. Gli uni salivano sulle imbarcazioni vicine, altri
scendevano ancora in mare per quanto consentiva la profondità
delle acque. Alcuni protendevano le braccia con lamenti e con
voti; tutta la spiaggia era piene delle grida e delle voci di
coloro che facevano domande e di quelli che rispondevano; un
gran moltitudine si affollò sul lido coi lumi, e come si seppe
che Agrippina era incolume, tutti le mossero in contro per
rallegrarsi con le, quando all'improvviso ne furono ricacciati
dalla vista di un drappello di soldati armati e minacciosi.
Aniceto accerchiò la villa con le sentinelle ed abbattuta la
porta e fatti trascinare via gli schiavi che gli venivano
incontro, procedette fino alla soglia della camera da letto di
Agrippina, a cui solo pochi servi facevano la guardia, perché
tutti gli altri erano stati terrorizzati dall'irrompente
violenza dei soldati. Nella stanza vi erano un piccolo lume ed
una sola ancella, mentre Agrippina se ne stava in stato di
crescente allarme, perché nessuno arrivava da parte del figlio e
neppure Agermo: ben altro sarebbe stato l'aspetto delle cose
intorno se veramente la sua sorte fosse stata felice; non v'era
che quel deserto rotto da urli improvvisi, indizi di suprema
sciagura Quando anche l'ancella si mosse per andarsene Agrippina
nell'atto di rivolgersi a lei per dirle: "anche tu m'abbandoni?"
scorse Aniceto in compagnia del triarca Erculeio, e del
centurione di marina Obarito. Rivoltasi allora a lui gli
dichiarò che se era venuta per vederla annunziasse pure a Nerone
che si era riavuta; se poi fosse lì per compiere un delitto,
essa non poteva avere alcun sospetto sul figlio: non era
possibile che egli avesse comandato il matricidio. I sicari
circondarono il letto e primo il triarca la colpì con un bastone
sul capo. Al centurione che brandiva il pugnale per finirla
protendendo il grembo gridò: "colpisci al ventre" e cadde
trafitta da molte ferite. |

La Germania di Tacito come fonte di studio per la
mitologia nordica
L'opera etnografica di Tacito, scritta con ogni
verosimiglianza intorno al 98 dc. , costituisce, come è noto, una
miniera di notizie riguardo la società germanica antica: le
principali istituzioni socio- politiche, come pure gli usi e i
costumi dei "barbari," vengono per la prima volta prese in esame con
una certa attenzione senza particolari condizionamenti ideologici,
conducendo anzi in più di una occasione ad un giudizio positivo sul
valore e sull'integrità morale del "nemico", soprattutto in
contrapposizione alla dissolutezza dei costumi della Roma imperiale.
Per quel che riguarda la religione, nel capitolo IX, sulla scia di
Cesare e secondo la tecnica dell'interpretatio romana, vengono
nominati come divinità comuni a tutta l'etnia germanica Mercurio
Marte e Ercole. L'assimilazione di Odino a Mercurio segue due
diverse linee interpretative: in primo luogo Mercurio, in qualità di
"psicopompo", ha il compito di accompagnare le animi dei defunti nel
loro viaggio verso l'Ade, così come <Odino.htm> riceve nella
Valhöll le anime dei caduti in battaglia; in seconda istanza la
tradizionale astuzia del Dio romano, spesso tendente alla malizia,
(tanto da farlo diventare nell'immaginario classico protettore dei
ladri), ben si riconosce nella divinità capo del Pantheon nordico
che, tra i suoi innumerevoli nomi, annovera anche quello di Bolverkr,
"malfattore". L'affinità Ercole- Thor, riposa evidentemente sulle
caratteristiche positivamente eroiche di entrambe i personaggi, sul
loro continuo vagare alla ricerca di avventure, sulle numerose
"prove" che entrambi debbono sostenere. Meno sicura
l'identificazione di Marte con Tyr, che nelle stesse fonti nordiche
è figura piuttosto evanescente: Snorri, ad esempio, nel capitolo
XIII della Gylfaginning, ne parla come di un Dio non certo pacifico
"che possiede la vittoria", narrando poi la sua prova di coraggio
con il lupo Fenrir, in cui egli perse la mano ( per i poeti runici
norvegesi Tyr è hinn einhendi áss, "il dio dall'unica mano"), ciò
nondimeno il culto di questa divinità fu assai diffuso in tutto il
mondo germanico, anche in area anglosassone. Le notizie più
originali che Tacito fornisce sulla mitologia germanica sono
contenute tuttavia nel capitolo XL della Germania e riguardano la
Dea Nerthus e il suo culto, diffuso tra le sette tribù di stirpe
sueba (Longobardi, Reudigni, Avioni, Angli, Varini, Eudosi, Suardoni
e Nuitoni). Lo storico racconta diffusamente le pratiche rituali che
le erano dedicate, senza peraltro tentare alcuna assimilazione con
nessun corrispettivo romano: la descrizione del cerimoniale che
accompagna in estate l'uscita della statua della Dea dal santuario
che sorge su un isola, e la visita che ella compie per le campagne,
riconduce chiaramente ad una figura di nume tutelare del raccolto,
una divinità dal forte legame con la terra, certamente parte della
tribù dei Vani. L'annegamento sacrificale degli schiavi che ne
avevano lavato il simulacro prima del rientro nel santuario,
richiama alla memoria il racconto di Adamo di Brema sui sacrifici
umani che si svolgevano nel grande tempio di Uppsala, ove esisteva
un pozzo sacro deputato a tale pratica. Il Turville-Petre ritiene
che Nerthus non sia altro che il corrispettivo femminile,
cronologicamente più antico, del più noto Njord, il capostipite dei
Vani nonché padre di Freyr e Freya, la coppia divina tutelare della
fertilità umana e terrestre.
F. Liuti
[18]
Eppure il matrimonio da loro è cosa molto
seria, né potresti maggiormente lodare altro aspetto dei loro costrumi. Unici infatti tra barbari, si accontentano di una sola
moglie, fatta eccezione di pochi, che hanno più mogli non per
capriccio, ma perché ricercati da molti a causa della loro nobilità.
Non la moglie al marito, ma il marito porta la dote alla moglie.
Genitori e parenti intervengono al contratto nuziale e fanno la
stima dei doni: non doni scelti a soddisfare la vanità femminile e
ornare la novella sposa, ma una coppia di buoi, un cavallo bardato e
uno scudo con lancia e spada. In cambio di tali donativi si acquista
la sposa, la quale offre a sua volta qualche arma al marito: questo
scambio è per essi massimo vincolo, rito e religioso e protezione
divina. Perchè la moglie non creda di essere estranea a pensieri di
ardimento e ai casi della guerra, dagli stessi riti iniziali del
matrimonio è avvertita che sarà compagna al marito nelle fatiche e
nei pericoli e insieme a lui sopporterà ed oserà ogni cosa: questo
simboleggiano i buoi aggiogati, il cavallo bardato e il dono delle
armi. Così dovrò vivere, così morire, e i doni che ella riceve li
trasmetterà inviolati e degni ai figli; e le nuore, ricevendoli, li
trasmetteranno a loro volta ai nipoti.
[19]
Perciò trascorrono la vita in sicura
pudicizia, non corrotte da allettamenti di spettacoli o da
eccitamenti di banchetti. Uomini e donne ignorano del pari i segreti
delle lettere. Rarissimi in tanta moltitudine sono gli adulterii, e
le punizione è immediata e affidata al marito: alla presenza dei
parenti egli cacciadi casa la moglie ignuda con i capelli tagliati,
e la sferza per tutto il villaggi. Non vi è perdono per la donna
disonorata: anche se bella, giovane e ricca, non troverà marito. Il
vizio là non è materia di riso e non si chiama moda il corrompere e
lasciarsi corrompere. Meglio ancora quelle tribù, dove si sposano
soltanto le fanciulle e una volta sola si concede ad esse di
aspirare al matrimonio. Hanno così un unico marito, come un sol
corpo ed una sola vita, perché alla sua morte non sopravviva altro
pensiero o desiderio d'amore,e non avvenga che esse amino non il
marito, ma il matrimonio. È delitto limitare il numero dei figli o
uccidere i nati dopo il primogenito e più valgono là i buoni costumi
che altrove le buone leggi.
[20]
In ogni famiglia, ignudi e senza cura, essi crescono con quelle
membra vigorose e con quei corpi che noi guardiamo con ammirazione.
Ogni madre allatta i propri figli, né mai li affidano ad ancelle o
nutrici. Nessuna mollezza d'educazione distingue il padrone dal
servo: vivono insieme tra lo stesso bestiame, sulla stessa terra,
fino a che l'età separi i liberi e il valore li distingua. Tardi
conoscono l'amore, e perciò più vigorosa si mantiene la loro
virilità. Né le fanciulle si sposano prima dell'età conveniente:
hanno la stessa robustezza dei giovani, simile statura; vanno a
nozze quando i loro corpi sono ugualmente forti e sviluppati, e i
figli rispecchiano la vigoria dei genitori. Egualmente cari allo zio
materno come al padre sono i figli della sorella. Alcuni anzi
giudicano più sacro e più stretto questo vincolo di sangue e nel
ricevere ostaggi preferiscono i nipoti, come se vincolino più
saldamente l'animo dello zio e più largamente la famiglia. Ma
ciascuno ha come eredi e successori i figli propri, né vi sono
testamenti. Se non vi sono figli, l'eredità spetta ai parenti più
prossimi, i fratelli, gli zii paterni e materni. Quanto più numerosi
sono i consanguinei e gli affini, tanto più onorata è la vecchiaia:
nessun vantaggio arreca la mancanza di prole.

L'incendio di Roma
38
- Il centro di Roma è in fiamme
Segue poi un disastro
(non si sa se dovuto al caso o alla malvagità del principe,
poichè gli scrittori tramandarono entrambe le versioni),
che fu più grave e più spaventoso di tutti quelli
che accaddero a questa città per la violenza degli incendi.
L’inizio
si verificò in quella parte del circo
che è vicina ai colli Palatino e Celio, dove, a motivo delle
botteghe piene di merci infiammabili, il fuoco, appena scoppiato,
si fece subito violento e, mosso dal vento, afferrò il circo in
tutta la sua lunghezza.
Infatti
non c’erano palazzi cinti da ripari o templi circondati da mura
o qualche altra cosa che valesse ad arrestare il flagello.
Dilagando
quindi con impeto prima nei luoghi bassi e piani, poi slanciandosi
verso quelli alti e di nuovo portando la devastazione nei
quartieri bassi, l’incendio, con la velocità del male, superava
ogni possibilità di rimedio, tanto più che la città lo favoriva
con le sue strade anguste e tortuose e con i quartieri irregolari,
come aveva l’antica Roma.
Si
aggiungevano a tutto ciò
gli strilli delle donne spaventate e l’impaccio dei vecchi e dei
bimbi, quelli che cercavano di salvare se stessi e quelli che
cercavano di salvare gli altri, sia trascinando infermi che
fermandosi ad attenderli.
Indugiassero
o si precipitassero, tutto provocava ingombro, impedimento.
Spesso,
mentre si guardavano alle spalle taluni venivano investiti dall’incendio
ai fianchi o di fronte; oppure, se riuscivano a fuggire nei luoghi
vicini, anche questi subito venivano assaliti dal fuoco e quei
quartieri che avevano creduto lontani dalle fiamme li trovavano
avvolti nella stessa rovina.
Da
ultimo, non sapendo più che cosa dovessero evitare e cercare,
ingorgavano le strade, si gettavano sfiniti per i campi; alcuni
avendo perduto tutti i loro beni, perfino il vitto quotidiano,
altri per l’amore verso i loro cari che non avevano potuto
strappare all’incendio, si lasciavano morire, anche se avevano
una via di scampo.
D’altra
parte, nessuno osava combattere l’incendio per le continue
minacce di coloro che impedivano di spegnerlo; altri, addirittura,
lanciavano apertamente qua e là tizzoni ardenti e gridavano che
ne erano stati autorizzati, sia che volessero attuare più
liberamente le loro rapine, o che avessero veramente ricevuto
degli ordini.
39
- Primi provvedimenti di Nerone e prime accuse
Nerone, che in quel
momento si trovava ad Anzio,
non rientrò a Roma se non quando l’incendio si avvicinò alla
sua casa, che egli aveva costruito per congiungere il Palatino
con i giardini di Mecenate.
Tuttavia
non si potè impedire che sia il Palatino, sia la sua casa e tutto
ciò che vi era intorno fossero inghiottiti dal fuoco.
Ma,
per andare incontro al popolo scacciato dalle sue case ed
errabondo, Nerone fece aprire il Campo di Marte ed i monumenti di
Agrippa
ed anche i suoi giardini; furono costruiti edifici improvvisati
per accogliere la moltitudine senza mezzi; furono trasportati
generi di prima necessità da Ostia e dai vicini municipi, mentre
il prezzo del grano fu ridotto fino a tre sesterzi il moggio.
Sebbene
questi provvedimenti avessero come scopo la popolarità, tuttavia
cadevano nel vuoto, perchè si era sparsa la voce che, proprio nel
momento in cui la città era in preda alle fiamme, egli era salito
sul palcoscenico di casa sua e vi aveva cantato la distruzione
di Troia,
paragonando il disastro presente a quella antica sciagura.
40
- Scoppia un altro incendio, nuove dicerie
Finalmente, il sesto
giorno si pose fine all’incendio alle falde dell’Esquilino,
perchè furono abbattuti gli edifici per un tratto molto largo,
affinchè all’incessante violenza delle fiamme si opponesse lo
spazio libero e, per così dire, il vuoto del cielo.
Ma
il timore non si era ancora quietato e non ancora era tornata
nella plebe la speranza, che di nuovo il fuoco si riaccese
minaccioso nei quartieri cittadini più aperti: per questo, le
perdite umane furono minori;
i templi degli dei e i portici, riservati al pubblico svago,
lasciarono invece più vaste rovine.
Questo
secondo incendio
diede luogo a più sinistre dicerie, perchè era divampato da una
proprietà di Tigellino
nel quartiere Emiliano e si credeva
che Nerone cercasse la gloria di fondare una città nuova e di
chiamarla con il proprio nome.
Effettivamente,
dei quattordici quartieri, in cui Roma si divide, quattro soli
rimanevano intatti, tre erano stati rasi al suolo e gli altri
sette presentavano qua e là pochi resti di case sbrecciate e
mezzo bruciate.
41
- La rovina delle opere d’arte
Quante furono le case
signorili, gli isolati popolari
ed i templi che andarono perduti?
Non
sarebbe agevole enumerarli: certo è che i più antichi monumenti
della religione, il tempio che Servio Tullio aveva consacrato alla
Luna, la grande ara
ed il tempietto
che l’Arcade Evandro
aveva dedicato ad Ercole protettore e presente, il tempio di Giove
Statore
ed il santuario di Vesta,
con i Penàti del popolo romano, furono distrutti dal fuoco.
Senza
contare le ricchezze conquistate con tante vittorie e le
meraviglie delle arti greche e infine i monumenti antichi, e
ancora intatti, del genio letterario;
sicchè, pure in tanta bellezza della città che risorgea dalle
macerie, gli anziani ricordavano molti tesori che non si potevano
più recuperare.
Alcuni
osservarono che quell’incendio aveva avuto inizio il
quattordicesimo giorno prima delle Kalende Sestili,
il giorno stesso, cioè, in cui i Senoni avevano dato alle fiamme
Roma, dopo averla espugnata.
Altri
spinsero il loro zelo del calcolo fino a determinare un numero
uguale di anni, di mesi e di giorni.
42
- La splendida “Domus
aurea”, un canale rimasto incompiuto
Comunque sia, Nerone
approfittò delle rovine della sua patria e si costruì una dimora,
nella quale non tanto destavano meraviglia le pietre preziose e l’oro,
che il lusso, da tempo ormai, ha reso comuni e banali,
quanto i campi coltivati, gli specchi d’acqua e, come nei luoghi
solitari, da una parte boschi, dall’altra spianate aperte a
belle prospettive, disegnate e costruite da Severo e Celere,
il cui audace estro pretendeva dall’arte di realizzare anche
quello che la natura aveva proibito e si valevano delle risorse
del principe come per un gioco.
Infatti
avevano promesso di scavare un canale navigabile dal lago Averno
fino alle foci del Tevere, lungo il litorale arido o attraverso i
monti sovrastanti, poichè, tranne le paludi Pontine, non si
trovava in quella zona altro luogo acquitrinoso che potesse
alimentare il canale: tutto il resto è terreno secco e scosceso
e, anche se si fossero potuti vincere gli ostacoli, la fatica
sarebbe stata eccessiva e sproporzionata allo scopo.
Nerone,
tuttavia, siccome era smanioso di tutto ciò che sembrasse
incredibile, tentò di far scavare i monti più vicini all’Averno
e rimangono ancora le tracce di quella speranza andata delusa.
43
- Roma più grande e più bella
Frattanto quelle parti
della città che restavano oltre la casa di Nerone non furono
ricostruite senza un piano regolatore o a caso;
ma la disposizione dei quartieri fu misurata a fil di squadra, con
belle strade spaziose; fu ridotta l’altezza degli edifici,
mentre si aprivano piazze e si aggiungevano portici per proteggere
la facciata degli isolati.
Questi
portici Nerone promise di costruirli a sue spese e di consegnare
ai proprietari i terreni sgombri dalle macerie.
Aggiunse
anche dei premi, secondo le condizioni e le possibilità
economiche di ciascuno, fissando un termine entro il quale, dopo
aver ricostruito le case e gli isolati, li avrebbero ricevuti.
Per
lo scarico delle macerie aveva stabilito le paludi di Ostia e dato
ordine che le navi che avessero risalito il Tevere per portare
frumento lo discendessero cariche di detriti.
Dispose
poi che gli edifici stessi in certe loro parti non fossero
sostenuti da travi di legno, ma rafforzati con pietra di Gabi o di
Albano, perchè è inattaccabile dal fuoco; e, siccome l’acqua
veniva intercettata per abuso di privati, vi pose dei custodi
perchè più abbondante e in più luoghi scorresse per i bisogni
di tutti.
Ordinò
che ognuno avesse in un luogo di facile accesso ciò che poteva
servire a soffocare un incendio e che le case non avessero pareti
in comune, ma ogni edificio fosse circondato da muri propri.
Tali
provvedimenti, accettati per la loro utilità, contribuirono anche
ad abbellire la nuova città.
C’erano
tuttavia di quelli che pensavano che l’antica disposizione di
Roma era stata più utile per la pubblica salute, perchè le vie
strette con le case alte non lasciavano penetrare così i
raggi ardenti del sole; ora invece le strade larghe e spaziose,
non protette da ombra alcuna, sono bruciate da un calore più
insopportabile.
44
- Sacrifici espiatori e martirio dei cristiani
Tali
furono i provvedimenti suggeriti dalla prudenza umana, ma subito
si fece ricorso agli dei con riti espiatori: furono interpellati
i libri della Sibilla
e, secondo il loro responso, si rivolsero pubbliche preghiere a
Vulcano, a Cerere e a Proserpina; fu propiziata Giunone ad opera
delle matrone, prima sul Campidoglio, poi sulla riva del mare più
vicino, da cui si attinse l’acqua per aspergere il tempio e la
statua della dea; infine sellisterni
e veglie sacre
vennero celebrate dalle donne che avevano ancor vivi i mariti.
Ma
nessun mezzo umano, nè largizioni del principe o sacre cerimonie
espiatorie riuscivano a sfatare la tremenda diceria per cui si
credeva che l’incendio fosse stato comandato.
Per
far cessare dunque queste voci, Nerone inventò dei colpevoli
e punì con i più raffinati tormenti coloro che, odiati per le
loro nefande azioni, il popolo chiamava Cristiani.
Il
nome derivava da Cristo, il quale, sotto l’imperatore Tiberio,
era stato condannato al supplizio dal procuratore Ponzio Pilato:
soffocata per il momento, quella rovinosa superstizione dilagava
di nuovo, non solamente attraverso la Giudea, dove quel male era
nato,
ma anche in Roma, dove tutto ciò che c’è al mondo di atroce e
di vergognoso da ogni parte confluisce e trova seguito.
Dunque,
prima furono arrestati quelli che confessavano la loro fede; poi,
dietro indicazione di questi, una grande moltitudine di gente fu
ritenuta colpevole non tanto del delitto di incendio, quanto di
odio contro l’umanità.
E
non bastò farli morire, che fu aggiunto anche lo scherno; sicchè,
coperti da pelli di fiera, morivano straziati dal morso dei cani o
venivano crocefissi o dovevano essere dati alle fiamme perchè,
quando la luce del giorno veniva meno, illuminassero la notte come
torce.
Per
questo spettacolo Nerone aveva offerto i suoi giardini, intanto
che dava un gioco circense, mescolandosi al popolino vestito da
auriga e partecipando alla corsa ritto su un cocchio.
Per
questo, sebbene essi fossero colpevoli e meritassero le punizioni
più gravi, sorgeva verso di loro un moto di compassione,
sembrando che venissero immolati non già per il pubblico bene, ma
perchè avesse sfogo la crudeltà di uno solo.
45
- Il tentativo di “suicidio”
di Seneca
Frattanto, per
accumulare denaro, fu devastata l’Italia, furono sconvolte le
province, i popoli alleati e quelle città che vengono chiamate
libere: sotto tale rapina caddero anche gli dei, poichè furono
spogliati i templi della città e fu portato via l’oro che il
popolo romano in tutta la sua storia, per trionfi o per pubbliche
preghiere, aveva consacrato nei momenti felici o nei pericoli.
Ma
ben altra cosa avveniva in Asia e in Grecia, dove non ci si
accontentava di portar via i doni, ma si asportavano addirittura
le statue degli dei, ad opera di Acrato e Secondo Carrinate, che
erano stati inviati in quelle province.
Il
primo era un liberto rotto a qualsiasi nefandezza; l’altro,
della filosofia greca aveva soltanto sulla bocca i precetti, ma
non ne aveva assorbito nell’animo le virtù.
Si
raccontava che Seneca, per allontanare da sè l’odio del
sacrilegio, avesse supplicato di potersi ritirare lontano, in
campagna; ma, non avendone ottenuto il permesso, si diede per
ammalato e, come se avesse una crisi di nervi, non uscì più
dalla sua stanza.
Alcuni
autori hanno tramandato che un suo liberto, di nome Cleonico, gli
preparò il veleno per ordine di Nerone; ma Seneca evitò il
pericolo, sia che il liberto avesse tradito il segreto, sia che
egli stesso ne avesse il sospetto; tanto è vero che viveva con la
più grande frugalità, sostenendosi con frutti selvatici e
bevendo acqua di fonte, quando la sete si faceva sentire.
46
- Disastri
In quel tempo stesso un
certo numero di gladiatori che erano a Preneste tentarono di
fuggire; ma furono bloccati dal presidio dei soldati di guardia.
E
già il popolino parlava di Spartaco e ricordava gli antichi
malanni, perchè il popolo è bramoso e al tempo stesso timoroso
di novità.
Poco
dopo un disastro colpisce la flotta, non già per azioni di guerra
(poichè mai come allora c’era stata una pace così stabile), ma
Nerone aveva ordinato che la flotta dovesse tornare in Campania un
determinato giorno, qualunque fosse stata la condizione del mare.
Dunque
i timonieri, sebbene infuriasse la tempesta, mossero da Formia e,
mentre cercavano di doppiare il promontorio Miseno, dalla violenza
dell’àfrico furono spinti contro le spiagge di Cuma e
perdettero un gran numero di triremi ed una quantità di
naviglio minore.
47
- Prodigi
Alla fine dell’anno si
parla dovunque di prodigi che annunciano mali imminenti: colpi di
fulmine più numerosi che mai e l’apparizione di una stella
cometa, fenomeno che Nerone espiò sempre con sangue illustri;
feti a due teste, di uomini o di altri animali, gettati sulla
pubblica via o trovati nei sacrifici, nei quali era di rito
immolare vittime gravide.
Inoltre
nel territorio di Piacenza, lungo la strada, era nato un vitello
che aveva la testa nella coscia e gli indovini ne davano questa
interpretazione: si stava preparando un altro capo per l’impero,
ma non sarebbe stato solido il capo, nè occulto il complotto,
perchè il vitellino era stato ostacolato nel suo sviluppo nel
ventre della madre ed era stato partorito lungo la strada.
L’anno 64 d.C. inizia al cap. 33 e termina al cap. 47.
Cannata:
Tacito parla del
grande incendio di Roma, il più grave dopo altri due incendi recenti, che
si verificò il 18 luglio del 64 d.C.. Scoppiato improvviso in
sei giorni distrusse completamente tre dei quattordici rioni
della città, mentre sette di essi rimasero con pochi ruderi e
solo quattro rimasero intatti. Le fiamme si svilupparono nei
pressi del Circo Massimo, tra il Celio ed il Palatino, dove si
ammassavano botteghe ed “insulae” malsane in cui erano
addensati i cristiani. Di qui le fiamme si diffusero
rapidamente verso il Palatino, distrussero alcuni dei
monumenti più antichi, quali il tempio di Servio Tullio alla
Luna, l’ara ed il santuario di Evandro ad Ercole, il tempio
di Giove Statore, la reggia di Numa, il santuario di Vesta;
crollò anche la “Domus transitoria” che Nerone aveva
fatto costruire per congiungere il Palatino con gli orti di
Mecenate. Nerone, che si trovava ad Anzio, venne a Roma solo
quando le fiamme minacciarono il suo palazzo, dopo di che
prese provvedimenti. Ma chi provocò l’incendio? Il caso,
Nerone o i cristiani? Lo storico non seppe decidere, ma
sospettò (e non solo Tacito, ma anche Plinio il V., Svetonio,
Giovenale, Dione Cassio, Eutropio e Paolo Orosio) di Nerone
che forse si servì di tale incendio per soddisfare un’aspirazione
segreta (ricostruire il centro di Roma, divenuto indegno di
una metropoli potente) e poi riversare la responsabilità sui
cristiani, che avevano fama di nefandezze. Nerone,
ricostruendo la città, avrebbe riaffermato le sue capacità
di imperatore geniale e generoso e avrebbe allontanato nel
popolo il ricordo del suo recente matricidio.
Tacito offre l’alternativa tra il caso e la malvagia
volontà del principe, escludendo i cristiani, anche se ne
parla con indifferenza quando descrive la feroce persecuzione
di Nerone.
Lo storico non decide per nessuna delle due ipotesi: l’incendio
avrebbe potuto aver inizio per caso, ma Nerone non fece niente
per fermarlo.
Gli incendi erano frequenti a Roma, dove le case dei poveri
erano in gran parte di legno, strette le une alle altre; si
ricordano numerosi incendi anche sotto Cesare e Pompeo, due
sotto Tiberio.
Il Circo Massimo comprendeva fino a 350.000 spettatori ed era
circondato da numerosissime botteghe e baracche
Alla descrizione dell’incendio si aggiunge ora quella della
tragedia umana: si mescolano lamenti, grida, il vociare di chi
dà e chiede consigli, il tutto creando solo confusione ed
impedimento.
La scena ricorda la peste di Atene descritta da Lucrezio, per
quel senso di straziante disperazione che alla fine porta al
rifiuto della vita.
Tacito sembra attribuire il motivo di quelle azioni delittuose
ai teppisti e ai disonesti, più che ad un ordine vero e
proprio ingiunto da Nerone; ma “iussu”,
posto nell’ultima sede del capitolo, fa riaffiorare il
dubbio sulle responsabilità dell’incendio.
Colle che domina il Foro romano e sul quale oggi si ammirano
le rovine dei palazzi dei Cesari.
Erano i giardini che Mecenate aveva lasciato ad Augusto sull’Esquilino;
il palazzo che congiungeva il Palatino con questi giardini,
detto “Domus transitoria”, dopo l’incendio fu ricostruito e chiamato
“Domus aurea” (Svetonio,
Ner. 31)
Agrippa, genero di Augusto, aveva eretto edifici monumentali
nel Campo di Marte; tra gli altri le Terme, il Pànteon ed il
Portico degli Argonauti.
Questo aneddoto è raccontato anche da Dione Cassio (LXII, 18)
e da Svetonio (Ner. 38).
De Bernardis: E’ un’ulteriore conferma della mania di grandezza di Nerone, di quella sua esasperata volontà di
raggiungere cose mai raggiunte da nessuno, tanto che,
qualsiasi cosa facesse nel bene e nel male, volle essere
sempre il più grande di tutti gli uomini del passato e del
presente. La sua fantasia fervida, spesso esaltata da ideali
di suprema grandezza, gli aveva ispirato un poema sull’incendio
di Troia dopo un baccanale, in cui era apparso, mutato in
Diòniso, su un carro gemmato e tirato da due leoni, fra uno
stuolo di coribanti, di satiri e di mènadi. Quindi, esaltato
dal pensiero di rifondare la città e ritenendosi un artista
di valore, non è improbabile che davvero Nerone salisse sul
palcoscenico del suo palazzo per cantare quei versi che egli
stesso aveva composto sull’incendio di Troia: credeva così
di emulare un antico evento e che, come dalla Troia distrutta
dalle fiamme era sorta per opera di Enea e dei suoi
discendenti la grande Roma, così dalle ceneri di Roma egli
avrebbe fatto sorgere un’altra città. Il megalomane si
congiunge all’esteta, che, decadente e pervertito, gode
dell’incendio come di uno spettacolo grandioso e
irripetibile.
Una contraddizione:
infatti in quei luoghi aperti e più lontani dal rogo isolato
furono distrutti più monumenti con minore strage di uomini; a
meno che tali monumenti, templi e portici, non fossero poco
frequentati proprio perchè si trovavano in zone più aperte e
quindi lontane dal centro della città.
Il popolo esasperato non riesce più a tollerare il nuovo
incendio ed essendo corsa voce che fosse stato ordinato,
formula varie ipotesi sulle intenzioni di Nerone, che lo
avrebbe favorito.
D’Ambrosio: Tigellino,
che fu prefetto del pretorio nel 62 succedendo a Burro, aveva
vasti possedimenti tra il Campidoglio ed il Quirinale.
Nerone lo nominò perchè Burro era morto ed aveva bisogno
di un uomo fidato. Tigellino ebbe da giovane varie avventure
con le sorelle di Caligola, per cui Claudio, loro zio, relegò
Tigellino nell’Acaia, dove l’esule si dedicò ai cavalli e
alle corse del Circo. Ottenuto l’alto incarico di prefetto
del pretorio, influì negativamente su Nerone, al quale
consigliò di condannare con processo sommario chiunque fosse
accusato o calunniato, così da poter confiscare i suoi beni
dopo averlo costretto a darsi la morte: in tal modo l’imperatore
avrebbe potuto reintegrare le casse dello Stato, dilapidate
dalle spese abnormi che ordinava a suo capriccio. Tuttavia
anche Tigellino fu colpito dalla stessa legge perchè, dopo la
fine di Nerone, fu costretto da Galba a darsi la morte.
Cannata: Vero o falso che ciò fosse, certo l’iniziale incuria di Nerone e le splendide costruzioni che dopo l’incendio
egli fece innalzare su un’area di 120 iùgeri confiscati
dopo l’incendio tra il Palatino e l’Esquilino,
confermarono i sospetti che avesse voluto tale incendio. Si
ricorda che nella zona tra il Palatino e l’Esquilino Nerone
fece costruire, in un grande parco ricco di monumenti, il suo
palazzo, cui fu dato il nome di “Domus aurea” per le
statue e gli ornamenti d’oro che l’abbellivano.
Grandi case d’affitto, dove si ammucchiavano i poveri, quasi
prive d’igiene perchè occorreva portare l’acqua dal pozzo
ai piani superiori, tanto che i piani bassi costavano molto di
più di quelli alti.
Era detta “Ara Maxima”,
si trovava presso il Circo Massimo ed era dedicata ad Ercole.
Era il tempio più antico di Ercole, posto sotto l’Aventino,
ma ce n’erano molti altri dedicati ad semidio.
Il tempietto fu dedicato ad Ercole da Evandro, mitico re
giunto dall’Arcadia che mandò in aiuto di Enea il figlio
Pallante ucciso da Turno, quando Ercole passò per il Lazio di
ritorno dalla Spagna dove aveva preso i buoi di Gerione.
Livio (I, 12, 6) narra che Romolo, combattendo contro i Sabini,
fece voto di costruire un tempio a Giove Statore (= “che
raccoglie gli eserciti e ferma la fuga”) in caso di
vittoria, ma il tempio fu costruito solo nel 264 a.C. dopo
la battaglia di Lucèra.
La dea Vesta trovò in Roma ed in Italia un grande culto, sia
perchè era la dea della santità domestica, sia perchè
Romolo, fondatore di Roma, era nato da una Vestale. Questo
santuario di Vesta era di pianta circolare e si trovava nel
Foro romano presso la “Regia”,
sede del Pontefice Massimo.
Si tratta dei manoscritti latini e greci custoditi nelle
biblioteche pubbliche e private.
Molti hanno notato che questo incendio di Roma corrispondeva a
quello provocato in Roma dai Galli Sènoni nello stesso giorno
di 418 anni prima, cioè nel giorno della battaglia dell’Allia,
che tuttavia cadde nel 18 e non nel 19 luglio del 390 a.C..
De Bernardis: E’ la “Domus aurea”
costruita da Nerone nella zona centrale della città devastata
dalle fiamme; era formata da una successione di edifici che
chiudevano ad anello la zona ed erano dotati di ogni conforto
e ricchi di ornamenti d’oro e di pietre preziose. Svetonio (Ner.
31) ricorda il suo vestibolo maestoso, i portici che si
estendevano per tre miglia, un lago centrale vasto come il
mare e poi, all’interno degli edifici, ori e gemme e nei
triclini soffitti con tavole girevoli d’avorio che
spargevano sui convitati fiori e profumi; tra un palazzo e l’altro
c’erano prati, vigneti, pascoli, selve con ogni specie di
animali. Anche Marziale (Spect. 2, 4) ricorda lo splendore di
tale città.
Roma era davvero “caput
mundi” e ad essa affluivano merci e denaro da ogni parte
del mondo, tanto che vi era una sovrabbondanza indicibile di
ogni genere di lusso; a ciò si aggiungeva la mania di
grandezza di Nerone, uomo di apprezzabili doti volte tuttavia
allo spreco e alla costruzione di opere tanto grandiose,
quanto impossibili.
I due architetti avevano progettato di congiungere il lago di
Averno con Ostia per mezzo di un canale lungo 160 miglia e
largo tanto da consentire il passaggio di due grosse
quinqueremi in senso contrario (Svetonio, Ner. 31); Plinio il V. (Nat.
Hist. XIV, 61) riferisce che per la costruzione di questo
canale andarono distrutti i vigneti del famoso vino Cecubo,
senza peraltro ottenere i risultati promessi.
In Campania, vicino Cuma; il canale sarebbe stato lungo circa
km. 250 e largo tanto che vi potessero passare due
quinqueremi procedenti in senso opposto.
La città fu quindi
ricostruita secondo criteri di regolarità e funzionalità
degni dell’architettura moderna, segno della solida
organizzazione di un impero che, dovunque andasse, lasciava i
segni di un’operosa attività civile ed efficiente; si nota
il velato compiacimento dello storico che pure aveva tante
volte accusato Nerone per le nefandezze e le follie,
dimostrando, così, oltre ad un giustificato orgoglio di
romano, anche una grande imparzialità nei confronti del
principe.
De Bernardis: Affiorano, dopo i provvedimenti di demolizione e di riedificazione, i
problemi più ardui e più nascosti, quelli della responsabilità dell’incendio e quelli più comuni in tali
circostanze, se cioè gli dei abbiano voluto punire colpe
rimaste nascoste agli uomini, se vogliano un maggior tributo
di sacrifici o se non convenga tornare ad una maggiore
castigatezza di costumi e alla fede dei padri, per evitare il
ripetersi di tali sciagure. Lo storico riassume tutto ciò in
poche righe, in cui “et” e poi “mox” contrappongono i
provvedimenti umani ai riti espiatori, rivelando un acume
psicologico oltre che critico degno di un grande
pensatore.
Narra la leggenda che questi libri furono consegnati al re
Tarquinio dalla Sibilla Cumana e che in essi fosse racchiusa
la storia di Roma. Custoditi nel tempio capitolino, dopo l’incendio
gallico furono ricostruiti da un’apposita commissione.
Difficili da intendersi, si prestavano a simulazioni, così
che talvolta furono manipolati dal Senato o dagli imperatori
per motivi politici: lo stesso Augusto fece coincidere il
decimo anniversario del suo trionfo con la fine del secolo.
Cerimonie religiose durante le quali alle immagini delle dee,
poste sopra dei seggi, veniva offerto un solenne banchetto.
Sono i riti sacri consegnati alla tradizione a cui si voleva
restare ancora fedeli per timore di altre punizioni divine.
In questo capitolo di immenso valore storico Tacito fa una
rapida descrizione di coloro che da Cristo venivano detti
cristiani, aggiungendo un giudizio affrettato e negativo,
dovuto al suo forte senso di romanità ed alla scarsa
conoscenza di questa nuova religione.
Cannata: Tacito non vuole nemmeno essere garante del nome di questi prosèliti e
riferisce solo una voce popolare, quindi accoglie, senza
verificarle, le voci di tali nefandezze. Che ci fosse incomprensione
tra il popolo romano e i cristiani ed i giudei, è
testimoniato non solo da Pilato, che non capiva davvero i capi
d’accusa dei sacerdoti ebraici contro Cristo, ma anche dal
giudizio di Plinio il G. (Epist. X, 96). Perciò non deve
sorprendere che Tacito esprima qui un giudizio
complessivamente negativo su quei cristiani di cui si diceva
ogni male, anche se li scagiona indirettamente dall’accusa
di incendiari.
Tacito aveva una profonda avversione
per gli ebrei, tanto che nel V libro delle “Storie”
(V, 4) lo storico accomuna cristiani ed ebrei, ritenendoli
superstiziosi e facinorosi e quindi esclusi dallo spirito di
romanità che invece pervadeva il suo animo e la sua opera.
Lo stesso giudizio negativo espresso da Tacito nei confronti
degli ebrei è ripetuto qui nei confronti dei cristiani,
aggravato da una condanna morale; forse lo storico, che andava
cercando i motivi più remoti della corruzione del suo popolo,
li ravvisa anche nel miscuglio di genti e di culti che
venivano soprattutto dall’Oriente, verso cui i Romani
avevano sempre nutrito una diffidenza motivata non solo dalla
grande lontananza di quei popoli così diversi, ma anche dalle
insidie che venivano dagli Arabi ìnfidi e dai Parti
invincibili.
Tale odio era motivato dal rifiuto dei cristiani a partecipare
alle cerimonie religiose pagane, alle feste ed anche alla vita
pubblica, come afferma ancora Tacito in “Hist.
V, 5”.
|
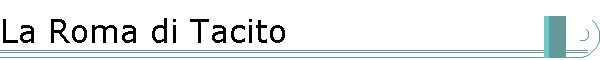
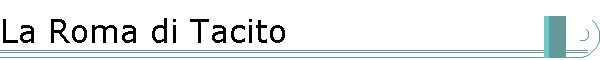
![]()
![]()